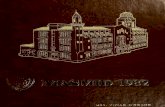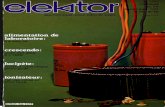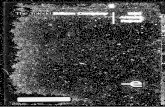1982 - M. PAOLETTI, Arule di Medma e tragedie attiche
Transcript of 1982 - M. PAOLETTI, Arule di Medma e tragedie attiche
-~ .
r .-r··· .. ~: .
' ~ :
' . . -
i l
:_ . ... r··_· , ~ '-.. ~ ~-
~. - · .. t . t 4:: ·' t ì i ·. -~ ,; • ·>
k
Nuove ricerche e studi sulla Magna Grecia e la Sicilia antica
in onore di Paolo Enrico Arias
· PromoSsi da L. Beschi, O. Pugliese Carratelli, G. Rizza, S. Settis
e pubblicati per cura di M. L. Gualandi, L. M assei, s~ Settis
ESTRATIO
li . . .
GIARDINI EDITORI
E STAMPATQRI
IN PISA ifi'L
.·.A···-x·· .... · .. : ' ·~. . . . " ..
. .
MAURIZIO PAOLETTI
ARULE DI MEDMA E TRAGEDIE ATTICHE
l. Negli ultimi anni sono apparsi alcuni studi che stanno ad indicare una maggiore attenzione nei confronti delle arule intese come classe di materiale. Infatti dopo il catalogo di E. D. van Buren, jn cui erano or· dinati circa 300 esemplari \ e le anticipazioni di E. Jastrow sul suo lungo lavoro di raccolta purtroppo rimasto interrotto 2, per un quarantennio non vi erano state ricerche di una certa ampiezza 3• Si era preferita piut-
Questo 14voro è 14 rie/4borazione del/4 tesi J.i laMeo Jimma nell'ottobre 1977 presso 14 F~Uoltà di Lettere dell'Universi1'Q J.i Pisa, relatori i proff. S. Settis e P.B. Arilu. Ringrazio il SoPrintendente dott. Gr. Foti Per il permesso a1l4 pubblicazione del materiale, i proff. L . Be· schi e A. CtJrlini per 'aver letto il dattiloscritto; inoltre A. Alessio, O. Pancrazzi, D. Ricciotti e Cl. Sabbione per j frequenti ed amicbefJoli scambi J.i Uee. Le fotografie sono dofJUte al/4 Direziane del Museo di Storia e Ar· cheologit:J di Kerc, alla Fototeca dell'Istituto Archeologico Germaniço di Roma, a Cl. Mlggit:Jno della Saprinlendenza Archeologica della Calabria e a P. Gabrielli JeJJ'btitt#o di Archeologia di Pisa; i lu&W dei disegni a ?d. Epifani del medesimo Istituto. 1. E.D. van Buren, Te"~Uotta Aru/4e, in « Mem. Am. Aè. Rome ~ Il, 1918, pp. 15-33 e tavv, 16-22; il rife· rimento bibliografico a quest'articolo rimane ancora oggi · canonico per i confronti; ma è ovvio che il commento al catalogo è ormai superato, in quanto non tiene sufficientemente conto della distribuzione per località, delle circostanze di rinvenimento (abitazioni, necropoli, santuari), del procedimento di riproduzione per la decorazione, della cronologia. 2. Accenni positivi ad esso sono frequenti anche da parte di chi ebbe occasione allora di venirne a conoscenza, v. G. Pesce, Due monumenti arcaici del Museo Jj Crotone, in « Boll. d'Arte~ XXIX, 1935, p. 231; perciò la tragica scomparsa della Jastrow nel corso della seconda guerra mondiale dà un motivo in più per . rimpiangerne la mancata pubblicazione. Rimangono e sono alla base di ogni ricerca sull'argomento E. Jastrow, Tonaltarchen aus den westgriechischen Kolo~ nien, in « Arch. Anz. » 1920, cc. 102-104; successi· vamente su temi specifici E. Jastrow, Ab/ormung und Typenwandel in der antiken Tonplastik, in « Opuscula Arch. ~ II, l ( = Acta lnst. Rom. Regni Sueciae, V), 1941, pp. 1-28 e tavv. I-XI; E. Jastrow, The Great Goddess of Nature in Funeral Art o/ Magna Graecia, in « Aro. Journ. Arch. » XLVI, 1942, p. 119 che è il riassunto di una relazione congressuale poi confluita in E. Jastrow, Two Terracotta Relie/s in American llfu.seums, in « Am. Jouro. Arch. » L, 1946, pp. 67-80. 3. Se si eccettuano P. Wuilleumier, BriJle-par/ums en terre-cuite, in « Mél. &. Fr. ~ XLVI, 1929, pp. 43-76 e tavv. I-III, e C.G. Yavis, Greek Altars, St. Louis 1949. Quest"ultimo preoccupandosi soprattutto di stabilire l'effettivo uso degli altarj greci distingue tra arulae e « full-sized rectangular terracotta altars » : le prime
tosto la pubblicazione di singoli pezzi, che sembravano interessanti da un punto di vista artistico e dei quali magari veniva risolto in ·maniera persuasiva il problema esegetico: come nel caso della scena sull'arula di Medma collegata al mito di Tyro 4•
Un riesame di quanto noto sulle caratteristiche di questa classe è stato compiuto da P. Orlandini nel commentare alcune arule arcaiche di Gela, tra le quali assai famosa è quella con il momento culminante della lotta tra Eracle e il gigante Alcioneo 5• Le sue conclusioni sono interessanti e generalmente da accettarsi 6• Recentemente D. Ricciotti ha analizzato le caratteristiche tipologiche delle arule romane, che sono parzialmente diverse da quelle magnogreche e siceliote 7• I pochi esemplari noti di VI-IV sec. a. C. rivelano un'apertura alle influenze laziali, fa lische . ed anche etrusche, mentre per il N-III sec. a.C. il materiale molto più
troppo piccole per sopportare il fuoco di un sacrificio, ma adatte per bruciare qualche grano di· incenso o ricevere offerte simboliche e libagioni; i secondi invece con un piano superiore grande abbastanza per veri e e propri sacrifici. Però non ritiene oppo~~o introd?-r~ re una qualche separazione tra arule fittth e altartm portatili in pietra, mentre è discutibile che il significato e l'uso fossero i medesimi. 4. La soluzione raggiunta da C. Robert ·e G.E. Rizzo, l'uno indipendentemente dall'altro, è contemporanea alla pubblicazione della yan Buren che registra una p~a erronea interpretazione, v. E.D. van Buren, art. CII.,
p. 35. 5. P. Orlandini, Arule arcaiche a rilievo nel Museo Nazionale di Gela, in « Rom. Mitt. » LXVI, 1959 (abbr. P. Orlandini, Arule), pp. 93-103 e tavv. 28·32. 6. Ha bisogno, però, di maggiori prove l'ipotesi che tre piccoli rilievi dall'acropoli di Gela (P. Orlandini, Arule cit., p. 101, n. 8-10 e tavv. 31, 1-2 e 32,1) costituiscano ... « l'espressione simbolica e compendiaria di un· arola ridÒtta al suo lato principale e a un formato minimo ~. Per il momento, di un tipo c;osì identificato non si conoscono altri esempi. -7. D. Ricciotti, Le arule romane, in R oma Medio Repubb.lkana (Catalogo della mostra), Roma 1973, pp. 72-96 e tavv. XVI-XXII; sul medesimo argomento cfr. I. Scott Ryberg, An Archaeological Record of Rome !rom the Seventh to the Second Century B .C., LondonPhiladelphla 1940, pp. 154-176 e tavv. 36-44 e F. Castagnoli, Sulla tipologia degli altari di Lavinio, in « Bull. Com. ~ LXXVII, 1959·1960 (ma 1962), pp. 162,163 e fig . . 21.
372 MAURIZIO PAOLETII
numeroso attesta un'affinità stilistica e di repertorio decorativo con l'Italia meridionale: particolarmente sentita è ·quella con la ceramogra:fia apula. Inoltre, è stata accertata una provenienza oltre che da stipi votive (Satricum) anche dall'area della necropoli romana dell'Esquilino (più volte con sicurezza dai corredi tombali). le arule siceliote d'età .arcaica raggiungono facilmente dimensioni notevoli, in alcuni casi presentando sulla fronte una scéna a soggetto mitico. T. Fi~ scher-Hansen, da ultimo, ha cercato di spiegame il signUjcato sulla base di un loro specifico impiego nel culto 8
• . Quest'ultima idèa, che era s~ta in precede~a di altri studiosi, è plausibìle nella sua formul~ione, per?> manca ·sinora di prove ineccepibili fç>ndate SJ..llle circostanze di rinvenimento o sull' ~soci azione con altro materiale. Perciò è difficilmente dimostrabile, anche se affascinante per le implicazioni chè ne deriverebbero, l'altra ipotesi avanzata di volta in volta con maggiore o minore cautela nel corso dell' articolo, che le raffigurazioni sulle arule indichino precisamente la divinità o l'eroe per le quali esse erano impiegate. In altri termini, certi soggetti sarebbero stati scelti per motivi di ordine politico (lotte di Eracle) oppure perché connessi con il culto del defunto ( < Tierkampfbilder ») oppure perché legati
. al culto di un eroe (suicidio di Aiace, Dioscuri ecc.). Ma, per la verità, non appare sufficiente la raffigurazione di Odisseo e di un suo compagno legati sotto due caproni, quale si ha - con un richiamo preciso all' episodio omerico - sulla fronte di un' arula di Megara Hyblaea 9, per supporre un impiego di questa in funzione di un culto locale dell'eroe, altrimenti non attestato. Neppure la scena già ricordata del suicidio di
8. T. Fischer-Hansen, Some Sicilia-n A,-ulae and theif" Significance, in c Analecta Rom. Inst. Danici :. Vlli, 1917 (abbr. F.ischer-Hansen, Sicilian At"Uiae), pp. 7-18 : gli esemplari qui ricordati erano già stati panialmente descritti in T. Fischer-Hansen, T o Siciliske A,-ulae, in c Meddelelser NCG ~ XXX, 1973 (abbr. T. FischerHansen, Siciliske Af'fllae), pp. 61-88 e T. Fischer· Hansen, T e1Y'akottakunJI f,-a Sicilien, in c Meddelelser NCG ~ . XXXI, 1974 (abbr. T. Fischer-Ha.nseo, Terrakottakunst), pp. 22-58. 9. T. Fischer-Hansen, Ter,-akottakunst, cit., pp. 43-52 e figg. 15-23; T. Fischer-Hansen, Sicilia-n Af'Ulae, cii. p. 13 e nota 72; cfr. A,-cheologia nella Sicilia ;#d-orientale (Catalogo della mostra), Napoli 1973, p. 169, n. 480.
Aiace su di un'arola ora a Copenhagen offre un sostegno a questa tesi, in quanto si ha qualche notizia di un culto di Aiace nella madrepatria, però mai in Magna Grecia 10
•
Il significato delle arule rimane dunque non chiarito, anche se la proposta è degna di attenzione. D'altra parte, come sottolinea lo stesso Fischer-Hansen, soprattutto la puh· blicazione di altro materiale potrà offrire elementi utili per spiegare i vari aspetti di questa classe. · A~almente è in corso · lo studio - non parziale come sinora, ma sistematico - di tutti gli esemplari rinvenuti in alcune importanti località 11
• Soltanto cataloghi di questo tipo permetteranno di chiarire l'uso delle arule: questione assai dibat~ tuta e spesso male impostata, che ha visto la formulazione di tesi contrastanti e persino inverosimili. .. .
2. Un ulteriore contributo può venire dall' esame delle arule di Medma, che s~no sta.tè. ricordare da S. Settis in un articolo non spe• cificamente dedicato ad esse 12
• Rispetto ·ad altri esemplari precedentemente noti 13 costi· tuiscono un gruppo ben distinto e caratterizzato per le dimensioni, per il tipo di soggetto e per la cronologia. Se si ecceciua l'arula di Tyro ricordata all'inizio, non hanno ricevuto l'attenzione che meriterebbero e neppure è stata verificata l'esegesi che i primi editori di questi singolari monumen~i proposero 'per le complesse scene presenti sulla fronte. Tuttavia, da qualche anno esiste un rinnovato interesse per Medma, che ha prodotto da un lato ricerche su problem~
10. T. Fischer-Hansen, Siciliske A,-u/as, cii., pp. 72·82 e figg. 14-22; T. Fischer-Ha.nsen, S;c;lian A.NIIas, cit., pp. 12-13 e fig. 4. 11. Sono a conoscenza in particolare della ricerca sulle arule di Gela e di Agrigento che è condotta con risul· taci molto interessanti da A. Alessio; ma è avviato anche lo srudio di quelle di Naxos e di altre zone ancora. Inoltre è ormai concluso · a cw:a di D. R.icciotti un catalogo· delle arule, per· la maggior parte inedite, conservare presso l'Antiquarium Comunale di Roma. [Nel frattempo sono apparsi M.J. Strazzulla Rusconi, Af'Uie fittili di Aquileia, in < Arch. Class. :1> XXIX, 1977 (ma 1979), pp. 86.113 e tavv. XX-XXXI; e finalmente D. Ricciotti, T erf"ecolte vot,ve dell' Amiqtklf'ium comunale di Roffl4: l . Le at"Ule, Roma 1978]. 12. S. Settis, Belleropbpn m Medtn4, in c Arch • .Anz.:. 1977 (abbr. Settis, Be'llerophon), pp. 183-194. 13. P. Orsi, Ro1arno tMedma?). Scoperla di t61Tecol· l e, in c Not. Se. :. 1902, p. 48; dr. E.D. van Buren, a,-1. cit., pp. 19 e 39.
~ -
ARULE DI MEDMA E TRAGEDIE ATTICHE 373
storici e topografici e su materiale inedito 14,
dall'al'tro la ripresa di saggi di scavo ad opera della Soprintendenza 15
•
L'importanza di questo centro della costa tirrenica è nota; specialmente nel quadro dei
14. S. Settis, Fonti lettHarie per la !t01'ia e la topografia di Medma, in c Athenaeum ~ n.s., XLIII, 1965 (abbr. Settis, Fonti), pp. 111-141; S. Settis, Su un koMos da Medma in « Arch. Class. :& XXIII, 1971 (abbr. Settis, Kouro!), pp. 52-76 tavv. XV-XXII; S. Sertis, Medma. An Ancient Graek City of Southem Italy, in cArchaeology:& XXV, 1972, pp. 26-34; A. Maggiani, S. Settis, Nuove note medmee, in cK.learchos:& XIV, 53-56, 1972 (abbr. Sertis, Nuove note), pp. 29-81; F. Moltrasio, Profilo storico di Medma, in c Atti · Ce.S.DJ.R. :& IV, 1972·1973, pp. 173-189; Fl. Cantarelli, Introduzione .ambie,stale alla tradizione geografica di Medma, · ii;t -«Atti Ce.S.D.I.R. :& VI, 1974-1975, pp. 31-54; S. Settis, MetaMo, TaMiana, Medma, in c: Magna Graecia » XI, 5-6, 1976, pp. 12-13; M. Paoletti, A proposito di uno .strigile bronzeo da Medma, in c Arch. $tor. Cal. Luc. :&
XLIV-XLV, 1977-1978, pp. 43-59 e tav. I. 15. Benché non sia stato ·messo . ancora a punto un piano organico, gli . interventi dettati dall'urgenza di di tutelare alcune . ar.ee di · notevole importanza archeologica hannò" a~to risÙltati molto significativi. Le prime brevi campagne nel 1964 e 1966 t.rono dirette da Settis in contrada Calderazzo: v. per notizie preliminari G. Foti, Attività della Soprintendenza alte Ant~ chità dslla Calabri.~ nal 1964, in c Kleacchos:. VI, 23-24, 1964, p. 106 e G. Foti, La documentazione archeologica in Calabria, in c: Atti Taranto .1964 ,, Na· poli 1965, pp. 146-147; quindi G. Foci, Attiflità della Soprintendenza alle Antichità della Calabria nel 1966, io c Klearchos » VIII, 29-32, 1966, p. 225 e G. Foci, La documentazione archeologica m Calabria, in «Atti Taranto 1.966 :o>, Napoli 1968, pp. 233-234; ma cfr. anche S. Senis, Kouros, cii., p . 53 nota 3. In varie date successive sono state effettuate, sotto la direzione
- di Cl. Sabbione, ricerche in più zone dell'attuale centro abitato: particolarmente interessante quella del 1977 che -ha rivelato a ridosso del Cimitero comunale alcune strutture con presenza di ceramica acroma e a vernice nera, portando inoltre al r~pero dei frr., purtroppo non in situ, di una specie di modello fittile di ;q:n)VT} Gal significato ed uSo incerti. Infine, il saggio di scavo da me diretto od settembre 1978 sul Pian delle Vigne {contrada Favara) per conto della Soprintendenza ha portato in luce una struttura abitativa con muretti di ciottoli per basamento e alzato in mattoni crudi. Una analoga situazione e datazione (metà V - metà. IV sec. a. C.) ho potuto constatare in altri saggi del maggio 1979 condotti a breve distanza dai precedenti. n materiale recuperato in gran quantità (ceramica a vernice nera ed acroma, pithoi, pesi da telaio, alcune statuette fittili ecc.) sarà restaurato dalla medesima Soprintendenza. [Tra novembre e dicembre 1979 la Soprintendenza Archeologica mi ha affidato l'esecuzione di un nuovo scavo d'c urgenza» a Rosarno, sul Pian delle Vigne, a ridosso del Campo sportivo dove pur~ troppo si sta espandendo l'abitato moderno. I saggi hanno portato all'identificazione di una struttura con un pozzo da acqua e un pozzetto dalle pareti traforate, la cui funzione è molto incerta; inoltre a poca distanza da . questi è venuto in luce un lastricato di pietre granitiche delimitato da un cordolo posto sull'asse E-W (basolato stradale e .l)larciapiede?). E' stato anche possibile individuare tracce di una frequenta%ione d'età arcaica nello strato di paleosuolo; invece tutte le strot• ture ora ricordate sono pressappoco coeve a quelle dei precedenti saggi 1978·79].
rapporti intercorsi tra Locri e le sue colonie; ma le testimonianze· letterarie ed epigrafiche sono scarse ed assolutamente insufficienti a documentarli 16
• I rinvenimenti archeologici forniscono ulteriori indicazioni, come la presenza a Medma, nella favissa di contrada Calderazzo, di pinakes simili a quelli locresi 17
• Altre terrecotte in collezioni di museo non provengono da scavi regolari 18
•
Viceversa, tra quanto recuperato da Orsi a locri nello scavo dell'area sacra della Mannella c'è un'arula di prodQ.Zione certamente medmea per il tipo della terracotta, assai diversa da .quella giallo-pallida e ben depurata propria della produzione locrese 19
• Ma, a parte questo caso di circolazione, le arule di Medma non trovano confronti neppure nella
. metropoli e rimangono - almeno per adesso - un unicum.
3. L'arula con la raffigurazione del mito di Tyro fu rinvenuta nello scavo della tomba 19, durante l'esplorazio-9-e della necropoli di Medma condotta da ·p: Òrsi nel 1914 20
• La -, .
16. Vedi S. Settis, Fonti, &it., p . 111 e D. Musei, Sviluppo e crisi di un'oligarchia greca: Locri Ira VI ~ IV sec. a. C., in «Studi Storici :.:> XVlll, 2, 1977, pp. 76-81. 17. P. Orsi, Rosarno-Medma. EsplMazione di un gf'tmàe deposito di le"ecotte ief'atiche, in c Not. Se. :& 1913 suppl. (abbr. P. Orsi, Rosamo-Medma), p. 130. 18. Reggio Calabria, Museo Nazionale: N. Putortl, Rilievi fittili di Locri e di Medma nel Musao Civico d; Reggio-Cala!ffia, in c Riv. Indo-Greco.ltalka:. X, 2-4, 1926, p. '116 e nota 2, pp. 121-124 e figg. 7-9 (= L'Italia Antichissima, III, 1930-1931, p. 125 e nota l, pp. 131-134 e figg. rell.); Rovereto, Museo Civico: G. Ciurletti, Un pinax locrese nella colleziotw di c Paolo Orsi:& del Museo Civico di Rovereto, io « St. Trentini di Se. Storiche -.., sez. II, LV, 1976, p. 77 (testine inedite); Miinchen, Sraatliche Museen: H. Priickner, Die lokriscben Tonrelie/s, Mainz 1968, p. 116, n. l e tav. l, l; S. Settis, Nuove nole, cit., p . 34; Adolphseck, &hloBfasanerie : H. Priickner, op. cit., p . 100, n. l e tav. 10, 2; S. Settis, Bellerophon, cit., p. 186 QOta 7. Questo pinax è in un c: Ton gelbliches Ziegelroc, stark glimmerhaltig :& ; al riguardo vale la pena· di ricordare che anche ad Hipponion è stato recuperato un pinax frammentario plasmato in un'argilla qalle medesime caratteristiche, perciò sembrano essere ambedue medmei, v. M. Schia.ko, Pinakes di Jipo locrese nel MtHeo Archeologico di Vibo Valentia, in c K.learchos ~ XV, 57-60, 1973, pp. 68-70 e 86-87 e fig. 3. 19. A. De Franciscis, Un /rammento di at'tlla da Locri, in « Atti Soc. Magna Grecia :& n.s., II, 1958, pp. 37-49 e tavv. XI-XII; G. Foti, Il Mweo Nazionale di Reggio Calabria, Cava dei Tirreni-Napoli 1972 (abbr. G. Foti, Museo Nazionale), p. 71 e tav. 20. 20. P. Orsi, Rosarno. Ca1!1Pagna del 1914, in c: Not. Se. :t 1917 (abbr. P. Orsi, Rosamo), pp. 37·67, part. pp. 39-40.
Tav. 95,
374 MAURIZIO PAOLETrl
tomba aveva direzione NNE-SSW ed era del uipo «a cappuccina» con tre paia di tegole per la copertura ed altre a formare il letto per la deposizione. L'unico dato presente nella relazione di scavo circa lo sc,heletro si riferisce al cranio posto a SSW; anche il cor-
FiJ. t. redo è enumerato senza descrizione. In pra-
tica esso è inedito, mentre fornisce una cronologia di raffronto a quella comunemente attribuita all'arula (fine V sec. a. C.). in base a criteri stilistici. Attualmente è conservato nei magazzini del M. Nazionale di Reggio Calabria.
Fig. 1,1.
1
1 l
a
Fig. l • Reggio Calabria, Museo Nazionale. Corredo della sep. 19. (Dis. M. Epifani).
l) Inv. n. 2703 : lucerna monolychne a vernice nera. Lungb. cm. 9; largh. cm. 6,2; alt. cm. 2,6; diam. foro del beccuccio cm. l; diam. foro dd serbatoio cm. 3,2. Terracotta nocciola, fine, omogenea. Vernice nera, con tracce d i arrossamento, quasi completamente desquamata. Esecuzione al tornio; orlo piatto e parete arrotondata, ·base leggermente concava e piede appena distinto. II beccuccio è parzialmente annerito.
Stato di conservazione mediocre : superficie abrasa, però ·conservati gli attacchi dell'ansa orizzontale.
2) Inv. n. 2702 : oinochoe acroma miniaruristica. F Alt. cm. 6,8; diam corpo cm. 4,2; spess. cm. 0,2- 1
0,3. Terracotta marrone bruciato con presenza di inclusi scuri e brilland. Bocca trilobata e Ì;>ase piana con piede troncoconico.
Stato di conservazione mediocre: incompleta al
ARULE DI MEDMA E TRAGEDIE ATTICHE 375
labbro e priva dell'ansa, di cui rimane il segno d'attaa:o sulla spalla.
Fig. 3) Inv. n. 2704: skyphos ingubbiato miniaturil,J. stico.
Alt. cm. 2,8; diam. vasca cm. 5,5; diam. comprese le anse cm. 7,6; spess. cm. 0,1-0,2. '
., Terracotta arancione con numerosi inclusi brillanti; tracce di ingubbiatura bianca all'interno e sotto il piede. Base piana con piede a disco, anse a sezione rotonda. Stato di conservazione mediocre: ricomposto J:ia più frammenti e labbro parzialmente incompleto.
Fig. 4) lnv. n. 2705: oinochoe acroma miniaturistica. 1,4. Alr. corpo cm. 3,3; alt. con l'ansa cm. 3,6; diam.
cm. · 3,9; diam. bocca cm. 3. Terracotta marrone bruciato con presenza di in-clusi .scuri e· brillanti. · Base piana con ,piede a disco, ansa leggermente sopradevata · e a sezione rotonda. Stato di conservazione buono.
... Per tutti sono possibili confronti ... con esem· plari appartenenti agli altri corredi della necropolì. In particolare, la lucerna è simile a quella di dimensioni poco più grandi della tomba 55 e ad una sporadica (inv. n. 2861); le. due oinochai sono identiche a qùelle presenti nella tomba 48 21
• Inoltre, la composizione di quello descritto si ripete in alcuni corredi provenienti dagli scavi che P. E. Arias effettuò successivamente nella medesima zona 22
•
Al di sotto della tomba 19 ve n'era un'altra di bambino (sep. 24), ma l'assenza di oggetti in essa toglie la possibilità di wi tef'minus post · quem 23
• Lo skyphos ingubbiatO e i due vasetti acromi non consentono una datazione precisa per i caratteri della loro tipologia 24
; la lucerna è perciò l'unico elemento utile al riguardo. Essa appartiene
21. P. Orsi, RosMYJo cit., p. 55 e ng. 17. 22. P.E. Arias, SC<~vi t# Cal4bri4 (1939-1942). RosdfflO. SC<Ivi del/4 necropoli di conwilda Nolio·Carrozzo, in c Not. Se. :. 1946 (abbr. P.E. Arias, Rosllf"ffD), pp. 133·144 e fig. l (lucerna). 23. P. Orsi, Rosarno cii., p. 41 e ng. 2. 24. Tuttavia per skyphoi assai simili, datati fine V -metà IV sec. a. C., v. P. Orlandini, Vlllsal/4ggi (S. Ca-
""- laUo). Scavi 1961. I. La 'fle&ropot; m61itUonaie, in c Not. Se. :. 1971 suppl. (ma · 1974), p. 70 e fig. lOO, b (= sep. 35), p. 113 e fig. 117,b (= sep. 73), p. 143 e fig. 229, b (= sep. 101); inoltre più gene. ricamente D.M. Robinson, Mosaics, V llJes ~md Lamps from 0/-y'flthus, (Olynlhus, V), Baltimore·London 1928, p. 247, n. 993 e tav. 186 (IV sec. a. C.).
ad un tipo . noto - e soprattutto ben studiato - a Corinto ed Atene, ma anche dif · fuso in ambiente magnogreco. Il confronto più vicino si ha con una lucerna da Hipponion in una tomba « a cappuccina » della fine V - inizi IV sec. a. C. 25
• Appunto a questi anni è databile approssimativamente . il corredo della tomba 19.
Chi si è interessato all' aru1a di Tyro da un punto di vista esegetico non ha mai discussd la sua collocazione rispetto. alla deposizione, privilegiando il valore . artistico della scena al sigruficato che la presenza dell' oggetto aveva nel rito funebre. Se la notizia che i frammenti furono rinvenuti sparsi « al di sopra di questo povero sepolcro in un'area di mq. 1- 1/2 » è vera 26
, non necessariamente prova che essa anche in origine fosse disposta sopra la tomba .
Per le arule di Gela si è sostenuto l'uso, oltre che nei santuari e nelle case, pure nelle necropoli per offerte propiziatorie e libagioni in onore dei defunti 21
• Ma lascia perplessi il fatto, come avverte giustamente anche Fischer-Hansen, che il rinvenimento sia avvenuto tra il ·materiale di reimpiego per muri ellenistici oppure nel terreno sconvolto delle aree sepolcrali; manca cioè la certezza del
25. Vedi T . Szendeleky, Ancient Lamps, Amsterdam 1969, pp. 3941 e figg. 20·29 (4: padlock Lam.pn); G. Heres, Die pt~nischen tmd griechischen Tonlampe" der SsaaJlichen M~seen zu Berlin, Berlin-Amsterdam 1969, pp. 26-27, n. 35 e tav. 4 (magnogreca, V-IV sec. a. C.); D .M. Bailey, A Catalogfle of lhe Lamps ;., the Brilish Museflm, I, Lqndon 1975, p. 45, n. Q55-Q56 e tavv. 12-13; quindi O. Broneer, Temzcotta Lamps, (Corinth, IV, 2), Cambridge Mass. 1930, pp. 43-44 e fig. 14 còn i profili 28-30 e tav. lii (tipo VI, V sec. a. C.); R.H . Howland, Greek Lamps tmd lheir Survivals, (A!henilm Agora, IV), Princeton N.J. 1958, pp. 56-57 e tavv. 7 e 36 (tipo 23, part. 23A, fine del terzo qu. V - primo qu. IV sec. a. C.); I. Scheibler, Griechische Lampe11, (Kerameikòs, XI), Berlin 1976, pp. 18-21 e tavv. 8-13 (c knickschulterlampen mit glattem Rand :t, spec. tipi della seconda m. V sec. a. C.); L. Bernabò Brea, M. Cavalier, Meligums Lipàra, Il, Palermo 1965, p. 79 e tav. XC, 3 (::: sep. 230); G. Foti, G. Pugliese Carratelli, Un sepolcro di Hipponion e 11n nflovo Jeslo or{ico, in c Par. Pass. :t CLIV-O. V, p. 101, n. lO e fig. 15. 26. P. Orsi, Rosarno, cii., p. 39; cfr. P. Orsi, RosamoAiedma, cii., p. 59. 27. P. Orlandini, Amu, ·cii., p. 102; precedentemente P. Orsi, Locri Epizephyrii. Campagne di scavo nella necropoli !Aci/ero negli armi 1914 e 1915, in c Not. Se. :t 1917 (abbr. P t Orsi, LotN), ·p. 149, aveva creduto ad una .decorazione dei sepolcri o all'impiego durante riti funebri al di sopra della fossa ancora aperta.
376 MA URI ZIO PAOLETTI
dato stratigrafico 28• Per un motivo analogo,
le arule reimpiegate in aggiunta alle tegole a formare la parete di tombe infantili a Locri non possono dimostrare un precedente loro uso cultuale all'interno della necropoli 29
•
Piuttosto, se è vero che la maggior parte degli esemplari provenienti da aree sepolcrali è stata raccolta nel terreno rimosso -cosa che potrebbe indicare una effettiva collocazione fuori, della tomba -, vi sono proprio a Locri esempi sicuri di appartenenza al corredo 30
; inoltre la ·medesima cosa è stata accertata per le arule romane. Perciò è ragionevole supporre che a Medma esse fossero collocate dentro la sepoltura vicino al defunto oppure costituissero un corredo esterno. Infatti Orsi registra nella necropoli il rinvenimento di pochi frammenti d' arula connesso~ ad un'altra tomba «a cappuccina» (sep. 39); ma anche in questo secondo caso sembra che gli oggetti recuperati nel terreno esternamente alle tegole di copertura facessero parte del corredo 31
•
28. P. Orlandini, Gela. I.N.A. Casa. Sepolture greche di VI-V secolo av. Cr. e rinvenimenti vari, in «N et. Se. :~> 1956, pp. 363-365 e fig. 10; P. Odandini, Gela. Rinvenimrmto di fHl4 casa o bottega ellenistica presso t'ospedale, in c Not. Se. » 1960, p. 165 (per il fr. d'a.rula e un fr. di sima-grondaia reimpiegati possibile
• esistenza in età arcaica di sacelli collegati forse al culto dei ~·defunti); cfr. T. Fischer-Hansen, SiciU.an Arnlae, cit., p. 10. · 29. Di avvisò contrario è T. Fischer-Hansen, Sicitian Arulae, cit., p. 10; per i rinvenimenti v; P. Orsi, Locri, cit., p. 115 e fig. 17 ( = sep. 1224) e pp. 119-120 e fig. 24 (= sep. 1347); I. Novaco Lofaro, Arule loçfesi con Eracle ed Acheloo, in « Klearchos ~ VIII, 29~32, 1966, pp. 131-140. Un riutilizzo è attestato anche nella necropoli di Gioia Tauto, v. G. Foti, Attivittl della Soprintendenza alle Antichit4 della Calabria nel 1975, in « Klearchos-,, XVII, 65-68, 1975, 'P• 189 e fig. 3. [Notizia più . precisa delle arule nella necropoli di G ioia è ora data da Cl. Sabbione, L'attiVità archeologica nelle provincfJ di Reggio Calabria e Catanzaro, in « Atti Taranto 1975 », Napoli 1976 (ma 1979), pp. 576·579: si tratta di tre casi di reimpiego]. 30. Si tratta ancora di tombe infantili, v. P. Orsi, Scavi di Calabria nel 1913. (Relazione preliminare). Locri Epizephyrii, in « Not. Se. » 1913 suppl., p. 33 e fig. 39 ( = sep. 800); e soprattutto P. Orsi, Scavi di Calabria nel 1911. (Relazione provvisoria) . Locri Epizephyrii, in « Not. Se. :~> 1912 suppl., pp. 5-6 e fig. 2 ( = sep. 275). 31. P. Orsi, Rosarno cit., p. 45 e fig. 12 invece pensa che il fr. angolare dell'a.rula trovato all'interno vi fosse penetrato per la compressione della terra. Nonostante le ricerche fatte nei magazzini del M. Nazionale di Reggio Calabria per il momento non mi è stato possibile rintracciare il materiale della tomba 39.
Oltre all'arula di Tyro, divenuta famosa dopo l'identificazione raggiunta da Robert e da Rizzo 32
, conosciamo da Medma un frammento di matrice fittile che ne replica esattamente il soggetto 33
• Non esiste un' rapporto di derivazione diretta tra l'una e l'altra, quale si potrebbe credere a prima vista, ma risalgono ad un archetipo comune. La matrice, che sembra essere stata ottenuta da un positivo «stanco», appare anch'essa «stanca» per lungo uso, come è riscontrabile dal confronto di alcuni particolari con i corrispondenti sul rilievo.
Questo fatto va sottolineato perché prova che a .Medma per un periodo di tempo non calcolabile, ma ragionevolmente limitato, furono prodotte e circolarono repliche di un soggetto che altrove è assolutamente ignoto. Infatti tutte le rappresentazioni del mito si riferiscono ad un momento della vicenda anteriore a quello sull'arula 34
• Questa è l'unica
32. È raffigurato il momento successivo all'uccisione della matrigna di Tyro da parte dei due figli giunti alla sua ricerca e riconosciuti grazie ad alcuni oggetti infantili ( "f\IWpiaJLa:ta.), sulla dx. è il re Sa!moneo che fugge atterrito: C. Robert, T yro, in « Hermes ~ ll, 1916, pp. 273-302; G.E. Ri:z.zo, U bassorilievo fittile di Medma e Ja tragedia di Sofocle, in « Mem. Ace. Napoli ~ IV, 1919 (abbr. Rizzo, Bassorilievo), pp. 127-158 e tavv. I-II; cfr. L. Séchan, Étflties Stlf' la tragédie grecque dans ses rapports avec la céramique, Paris 1926, pp. 225-230 e fig. 70 e tav. IV, inoltre p. 585 (App. III) e pp. 600-602 (App. IX); G. Foti, Must~o Nazionale, cit., p. 62 e tav. XIX a col. 33. Collezione Colloca di Mileto. Alt. cm. 42,5, largh. cm. 43,5, spess. max. cm. 10 ca. Terracotta brunorossastra con presenza di numerosi inclusi e particelle brillanti. Sulla faccia a stampo, ricavati in negativo, rimangono il re Salmoneo, Tyro, il figlio stante di cui sorregge il braccio e parzialmente il secondo che le siede accanto. È interessante notare, perché invisibile nelle fotografiè sinora pubblicate, che lo stampo continua sulla base della matrice, per imprimere quella che sul positivo è la cornice aggettante del rilievo. Il retro, non descritto da Rizzo, presenta una struttura « a cassettoni » • Sono conservate sei cavità rettangolari (cm. 16 x 13), la cui intelaiatura è costituita da grosse costolature. Un simile accorgimento ·permette solidità e leggerezza insieme. Un particolare insolito è la presenza di un foro (prof. cm. 4, dìam. cm. 2 ca.) all'incrocio ·. delle due costo!ature mediane, cioè proprio al centro della matrice supposta integra. Per esempi di grosse dimensiÒni, v. I. Marconi Bovio, Agrigento. ·Scoperta di tniZtrici fittili e di terrecotte figurate, negli anni 1926-1927, in « Not. Se. », 1930, p. 74 e figg, 2-3; B. N eutsch, Der Heros auf der Kline. Zur einer Terracottd-Matrize im National Museum von Tarent, in « Rom. Mitt. » LXVIII, 1961, pp. 150-151 é tav. 64, l. Ringrazio l'avV-ocato S. Colloca di Mileto e la prof.ssa R. Naccari COlloca di Palmi per la cortesia più volte dimostrata. 34. Alla situla bronzea e ai cinque specchi etruschi
...
ARULE DI MEDMA E TRAGEDIE ATTICHE 377
a mostrare in stretta aderenza con la tragedia di So'focle l'avvenuta liberazione di Tyro e l'uccisione della matrigna 35
•
Per spiegare tale concordanza veramente sorprendente e anche l'inquadramento archi~ tettonico uguale a quello del rilievo votivo attico della fine V sec. a. C., Rizzo, propose di riconoscere nella scena dell'arula la copia dell'&:ll&.1huJ.a. offerto per la vittoria nell'agone tragico. PeFÒ egli non poteva por~ tare nessuna prova a sostegno della sua ipotesi.
L'allusione a Tyro presente in Aristoph. Lys., vv. 137-139 (F657 Radt) indica che il ricordo della tragedia era ancora vivo nel 411 a. C., mentre una parodia di F654 Radt riconoscibile in Aristoph. Av.1 v. 275 fa su~ porre che essa fosse anteriore al 414 a. C. 36
•
Può forse~risolvere la questione il frammen~ to di iscrizione che riporta l'elencò di alcune tragedie rappresentate in quegli anni alle Lenee. Sotto l'arconte corrispondente al 418 a. C. è segnata la vittoria di una Tyro:
IG, W 2319~2323 a. 418 È1t~ 'Apx[!ou ~-
1.78 Tupo~T~[~-
Manca il nome dell'autore per la lacuna esistente sul lato dx.; però tenendo conto dei richiami in Aristofane e del fatto che le uniche altre tragedie dal medesimo titolo a noi note sono dei più tardi Astydamas e Carci-
noti a Robert e Ri:ao (cfr. G.A. Mansuelli, Sttdi sugli specchi etmscbi, in « St. Etc.» XX, 1948-1949, p. 88) è da aggiungere lo specchio edito da L. Curcius, T :yro, in Festscbrift E. Pretorius, Wiesbaden 1953, pp. 53-66 e il fr. di oinochoe policroma attica (400-390 a. C.) di M. Crosby, Five Comic Scenes !rom Athem, in « Hesperia » XXIV, 1955, pp. 78-79 e cav. 34, a; cfr. A.D. Trendall, Phlyax Vases, Il ed., in « BuJ!. Inst. O. Stud. Suppl. > XIX, 1967, p. 24, n. 10. La statuetta tanagrina di G.E. Rizzo, BrissoriJiez•o, cit., p. 136 e fig. 9 è stata temporaneamente nesposta al M. Nazionale di Atene durante la mostra « Il bambino nell'antichità » (sett.-ott. 1978). 35. V. la re<:entissima edizione di St. Radt, Sophocles, (TrGF, IV), Gi:ittingen 1977, pp. 463-472 (F648-669a). Lo Schol. Aesch. Prom. , v. 128 (F656) attesta la composizione di due tragedie dal titolo Tyro .. Non è chiaro quanto si differenziassero nell'argomento, ma di quella che qui interessa è ricostruibile in maniera sufficiente la trama. 36. Vedi St. Rade, op. cit., p. 464 e il commento al frammento.
nus (?), è plausibile la proposta di H. Hoffmann, ripresa poi da C. F. Russo, di integrare appunto con l:ocpoxÀ:ijç dopo il nome dell'arconte 37
•
La raffigurazione sull' arula medmea, così elaborata nel soggetto e di impronta attica nello stile, si collega strettamente in questo modo alla tragedia di Sofocle che vinse nei medesimi anni alle Lenee e riportò un certo successo a giudicare proprio dagli accenru presenti nelle commedie 38
•
4. Nel 1939 la Soprintendenza poté recu~ perare del materiale archeologico di notevole valore, proveniente dall'area della necropoli di Medma e sino ad allora posseduto . da privati. Una notizia dei pezzi più interessanti (due arule frammentarie, figurine fittili, ceramica a vernice nera) venne pubbli~ cata da Arias insieme al· corredo di alcune tombe scavate nei terreni della famiglia Mal~ vaso che aveva consegnato quel materiale 39
•
La più interessante e meglio conservata delle due arule fu contemporaneamente esamina~ ta in un breve articolo a sé -10. Appunto questa è presa qui di nuovo in considerazione.
Reggio Calabria, Museo Nazionale, inv. n. 3382. Alt. cm. 31; largb. cm. 30,5; spess. cm. l ca c cm. 4,7 al listello posteriore. Terracotta rosso bruno scuro con presenza di numerosi inclusi bianchi e neri e di minuscole particelle brillanti. Stato di conservazione mediocre : ricomposta da numerosi frammenti e incompleta su tutti i lati. Retro : sul margine sin. vi è una striscia abrasa (largh. cm. 3,5-4} che corrisponde alla traccia lasciata dall'attacco della parete laterale. A una distanza di cm. 16,5 dal medesimo margine è con-
37. C.F. Russo, Euripide e i concorsi tragici len4ici, in « Mus. Helveticum » XVII, 1960, p. 166 nota 2 (ivi è citata la dissertazione inedita di H. Hoffmann, Chronologie der atlischen Tragodien, Hambutg 1951); dr. anche· B, Snell, Didascaliae lragicae ecc., (TrGF, 1), Gottingen 1971, p. 27 che con molta prudenza non accetta la congettura. 38. Anche il fr. di oinochoe polìcroma si riferisce probabilmente ad una parodia basata su di una commedia, v. T .B.L. Webster, Monuments lllustrating Tragedy rmd Satyr Play, Il ed., in « Bull. Inst. Cl. Stud. Suppl. » XX, 1967 (abbr. T .B.L. Webster, Mo-numents), p. 153. . 39. P.E. Arias, Rosarno, cit., pp. 133-138. 40. P.E. Arias, A1'ula frammentaria di Medma, in « Arch. St. Cal. Luc. » XV, 1946 (abbr. Arias, Arula), pp. 1-8.
Tav. 96
Fig. 2.
Tav-. 96,1.
378 MAURIZIO PAOLETII
. · . .. . ;.'. • • , r
. . · .. l .. . '• .· . . : ' : 1 ·. . . ..
~ ' .. . .• . • · ~ ... ·t •. , ..
. : .. l . · . .• ·l
..
' ..
.· '• j ~
• ••
o l 3
. l 6 l
9 l
12 l
15cm l
._.;~ •
.-.. · ..
Fig. 2 • Reggio Cal!!-hria, Museo Nazionale. Retro del frammento dell'arola di Piritoo. (Dis. M. Epifani).
' . servato quast mtegro un listello verticale (largh. cm. l circa), che diviene più spesso verso la base; esso ha funzione di rinforzo della .lastra. Fronte: il listello pUò essere un indizio utile. ,Per ca!colarne la larghezza originaria. Data la sua po~ sizione quasi centrale esistono due possibilità: a) il fr. conserva quasi per intero la scena . e nella parte maneante a sin. vi era una sola .fi.gurà stante, come indica lo sguardo del personaggio seduto; b) il fr. è àbbastanza piccolo e a sin. vi era sparlo adeguato per una o anche due .figure. Questo caso presuppone però un secondo listello e tra questo e il limite sin. ·della fronte una distanza di altri cm. 15-17 .La pri-ma soluzione è meno verosimile, perché il braccio disteso all'indietro della figura seduta non lascia quasi posto per quella a lato, che avrebbe dovuto almeno sovrapporsi alla cornice. Invece la seconda risolve questo problema di proporzioni e trova un confronto pertinente nei tre listelli di rinforzo, all'incirca equidistanti, dell' arula di Tyro '11•
41. Tale accorgimento tecnico è visibile it1 S. Ferri,
L'inquadramento architettonico non è ricosi:ruibile; in basso è conservata una ·semplice modan~ttura J)ijlt~; ai lati probabilmente erano semplici pi-lastn. . A dx. è seduta una figura femminile purtroppo acefala. Priv(!. di calzari, indossa un chitone senza maniche e un himation, di cui regge un lembo con la mano sin. Nonostante la frattura sembra che sedesse sulla nuda roccia, perché non vi è traccia di spalliera tra la schiena e il pilastro cui è appoggiata. Sembra inoltre dal gesto della mano che stesse indicando il personaggio mancante a sin. Dinà~zi a lei, su di una sporgenza rocciosa è seduto ' un giovane nudo. Egli indossa soltanto un himation, che è agganciato sul petto da una grossa fibbia rotonda e di cui qualche lembo spunta da sotto la coscia. Le sue gambe sembrano quasi intrecciarsi con quelle della figura femminile, ma non è a lei che indirizza la sua attenzione. Con
,·, Il supplemtmto t# bu~ti fiuiU .,;,agnogreci. (Tappi eJ arule), in « Klearchos • VII, 25·28, 1965, p. 47, fig. 10.
..
ARULE DI MBDMA B TRAGEDIE ATTICHE 379
una violenta torsione del busto risolta con difficoltà 4v. la posizione innaturale e un po' goffa del braccio che regge il bastone nodoso), volge indietro la testa e il braccio disteso verso il personaggio (o i personaggi?) che stava immedia- · tamente alle spalle. Indubbiamente, questi era una figura importante, determinante per la comprensione della scena, se proprio a lui guardano le altre due figure. A occupare una buona parte dello spazio tra le teste dd giovane e della figura femminile è una specie di «riquadro », anch'esso irrimediabilmenre interrotto dalla fràttura. E' un pinax, appeso un po' storto, di cui si riconosce la cornice e nell'interno la figura più a sin. Questa è nuda con le braccia rigidamente distese lunga il corpo; accanto ha qualcosa (animale? o forse un oggetto). R rilievo è assai basso, accentuato in alcuni punti dal ritocco a stecca (ad. es. per meglio distinguere la figurina del pinax). Inoltre sono interessanti due notazioni : le gambe dei personaggi seduti sono sovrapposre secondo uno schema usuale, · ma con una certa ingenuità di risultati, così che il pied~ sin. della donna è' ben visibile, mentre il piede dx. del giovane spunta ·1nverosirnilmente da dietro le pieghe del chitone femminile. Secondariamente, la mano della donna con le dita raccolte e l'indice levato tocca per mancanza di spazio il bastone del giovane 42•
Il rilievo pone nella sua frammentarietà numerosi interrogativi; Arias avanzò con prudenza l'ipotesi di riconoscervi un momento della prigionia di Piritoo all'Ade: quest'idea, che è stata successivamente respinta 43
, merita· di essere ripresa e sviluppata.
Il nucleo del mito è costituito dalla decisione di Teseo, presa dopo il ratto di Elena, di scendere con Piritoo all'Ade per impadro-
. nirsi di Persefone. Tuttavia nella tradizione letteraria sono individÙabili diverse stratificazioni intervenute durante l'elaborazione del mito 44
• L'episodio seguì l'evolversi della leg-
42. Della prima osservazione non posso dirmi del tutto sicuro per la vicinanza della frattura e la consunzione . del rilievo; però il particolare ·è notato anche da Arias. Non mi sento invece di concordare nel ritenere voluto, come egli dice, il dettaglio della mano che tocca il bastone. Per il q: deiktische Geste :e v. G. Neumann, Gesten und Gebarden in der grùJchischen Kunst, Berlin 1965, pp. 17-22 e figg. 7-8. 43. Da E. Langlotz, L'arte della Magna Grecia, (fotografie di M. Hirmer), nuova ed., Roma 1968 (abbr. Langlotz, L'arte della M. Grecia), p. 296, n. 125 in basso e fig. rei., che dubita della pertinenza del frammento ad un"arula e descrive diversamente la scena. 44. Le fonti sono state raccolte da J . Fontenrose, in « Real Enc. » XIX, l , 1937, cc. 122-129, .s.v. Peirithoos, e da H. Herter, in « Real Enc. » suppl. XIII, 1973,
genda di Teseo, divenuto in epoca clistenica l'eroe nazionale ateniese. Infatti, colui che inizialmente appariva terminare la sua vita nell'Ade ad espiazione dell'empio tentativo, fu assunto a modello delle più alte virtù e ad organizzatore del sinecismo ateniese 45
•
Se si escludono poche attestazioni precedenti, questa xa"t"&.~acn.; è . nota soprattutto dal V sec. a. C., quando divenne anche soggetto di tragedie. Del Pìritoo di Achaios abbiamo solo un frustolo insignificante 46
, men~ tre dell'omonima tragedia attribuita variamente ad Euridipe o a Crizia, ma con tutta probabilità scritta da quest'ultimo, sono conservati un certo numero di frammenti 47
•
L'anno di rappresentazione è ignoto, ma è stato supposto che la tetralogia di cui faceva pane (Tennes, Rt!damante, Piritoo e Sisi/o) sia stata composta anteriormente al ;A07 a. C 48
• Per quanto breve ed al tempo stesso inquinata da particolari estranei alla tragedia l' v1t6DEo-tç ricordata da due tardi commentatori del 1tEpt ~68ov 8Etv61h}"t"oç di Ermogéne conserva quella che era l'importante innovazione di Crizia rispetto· alla più nota versione « attica » del mito: « ; .. Te-
. seo, convinto che fosse turpe abbandonare l'amico, preferì alla vita (se. sulla terta) l'esistenza nell'Ade. Ma Eracle, inviato da Euristeo a catturare Cerbero, superò con ' la forza la fiera e con il favore degli dei ctoni
cc. 1173-1180, s.v. Theseus. V. anche B. Petersen, Theseus und Peirithoos im Htdes, in c Arch. Zeit. • XXxVIII, 1877, pp. 119-123 e tav'. 12; Weitsiicker, ·in Roscher, Lexikon, 111, 2, 1902-1909, cc. 1768-1769, s.fl. Peirithoos; Stèuding, in: Roscher, Lexikon, V, 1916-1924, cc. 718-719, { . fl. Theseus. 45. Plutarque, Vies. l, a cura di R. Flacelière, · Paris 1957, p. 4; più in generale· Ch. Dugas, L'év(fltiJion de la légenile de Thésée, in c Rev. Et. Gr.~ LVI, 1943, pp. 1-24 e tàvv. I-IV (= Recueil Ch. Dugas, Paris 1960, pp. 93-107 e tavv. XX-XXVI); Ch. Dugas, R. Flacelière, T hésée. lmages et recits, Paris 1958. 46. B. Snell, op. cit., p. 125. 47. La questione della paterf)ità è riassunta da G. Arrighetti, Satiro. Vita di Etwipide, in c St. Class. Or. :. Xlll, 1964, ·pp. 108-109. Per i frammenti v. A. Battegazzore, M. Untersteiner, Softsti. Testimonianze e frammenti. IV, Firenze 1962, pp. 280-304; H.J. Mette, Fttripides (insbesondere fiir die ]ahre 1939-1968), in c Lustcum ~ XII, 1967 (abbr. Mette, Euripides 1939-1968), pp. 203-207; B. Snell, op. cit., pp. 171-178 (Fl-14). · 48. Vedi U. W ilamowitz-Mç>ellendorff, AnaJecta Euripidea, Beclin 1875, p. 166. e M. Raoss, Anassagora e Crizia, in « Rivista Rosm'iniana di Filosofia e Cultura , XLV, 1951, p. 256 nota 38; cfr. A. Battegazzore, M. Untersteiner, op. cii., p. 275 e 287-288.
380 MA URI ZIO PAOLETII
liberò Teseo e i suoi compagni dalla necessità presente ... » 49
• La scena era situata certamente nell'Ade; ma molto più problematico è riconoscere i personaggi che partecipavano all'azione. All'inizio ,Pella tragedia appartiene con probabilità il dialogo tra Eracle ed Eaco, che viene informato dell'identità dell'interlocutore e del motivo del suo arrivo (Fl Snell). In un successivo momento, non precisabile, va collocato il soliloquio (?) di Piritoo, nel quale egli sembra alludere alle colpe di Issione suo padre e le pone a confronto delle proprie (F5 Snell). Ad un altro ancora, di grande effetto dram8
matico e determinante per il successivo svolgimento della vicenda, appartiene lo scambio di battute tra Eracle e Teseo (F7 Snell): « ...
T ese-2. [Non] ti biasimo, Eràcle, [ma debbo restare ] , perché è [ tur:ge] tradire u:n amico fidato irilp,rigì<?nato coh ~riste animo.
Eracle Quello che hai detto è degno [di te] e della città di Atene, perché sei alleato
. sempre degli sventurati, ma se devo scusarmi, tornare in patria per me è un'infamia. Non credi che Euristeo, se saprà che in tal modo mi sono comportato con te, con piacere dirà che la mia fatica fu intra-. ') ~ presa mvano .... » .
49. Il testo completo è il seguente: « lli~pii}o~ Èm 'tij lltpcrtq>6vnc; ~VI10'-.e~ ~e-.à 9T}crt~ e~ "A~5ou xa~a~àc; i~.~Wp(aç Jt-.vxe -.i}c; 'lt~OuaT}c; • àv-.òc; JlÈ\1 yrìp bd 'ltÉ'>~ àx~vi)-.ctJ xai)i5~ 'ltEli1)&:~ 5pax6v-.wv ttppOVpE~'>O XtX~~\1 ' 81)crruc; liÈ -.Ò'II cpfì,ov Éyx:cr.-.r.r.À.~'ltE~'\1 r.r.tO"xpÒ'II i)youp.E'IIac; ~Lou EtÀ.E-.o -.i)'ll t'li "A~5ou ~w'l'j'll. -'E1tL -.òv Ktp~Epo'll Sè 'Hpr.r.xÀ.i}c; à'ltOCT-.r.r.À.Eì.ç imò E\lpuai)twc;, "':OU JlÈ\1 '1}1Jp,ov ~~ mp~')'E'IIE't'o, "':oùç liè mp~ 91)crtcr. xarx-"1:~ -.w'll x~(ùo -yfhlv {)EW'II -.fiç 'ltàpouaT}ç à'llti')'XTJc; t~)..vcrEV, w4 'ltpli.~E~ xr.r.L 't'Ò\1 à'l/ih.CT't'lip.E\10'11 )CE~r;<ùCTii~E\IOç XIX~ 'ltapà ~\1 xtipw À.cr.~W'\1 m~ OVCT't'V)COU'II'>r.tc; ÈÀ.djCTr.r.c; cp'À.ouç "· (Fl Snell) cfr. A.M. Battegazzore, Il tMmine xlii}e5pa: nel/4 hypothesis del Phitoo di Crizu, in Mythos. Scripta M. UntersteinM, Genova 1970, pp. 73-79.
50.<9H~Yl:>... , .]:oç, 'HptixÀ.E~, [ai:] 1-L~-I!Jo~~
. . Jn. mCT'ltÒ'II ràP fi-y5pa. . xr.r.t cp'À.OV
, , , 'ltp)OOOV\Icr.~ OV~[E'Y]Wc;, E~ • À.1)1JP.ÉVO'II.
< HPAKAHl:> crav't'w~ -.e,] 81jCTEu, 'tij -.· 'Ai}1)'llr.r.,wv 1t6 [À.E~
-,tprno'll-.' Eì..El;r.r.c; • -.oi:CT1. ovcr[ 't'V 1-xoucr~ yàp
Vi è infine un ultimo frammento recente~ mente edito, che è utile ricordare perché Persefone (identificabile dalle parole 't'ÒV
È!J.ÒV EUVÉ't''J}v) vi annuncia a qualcuno la prossima liberazione ad opera di Eracle 51
,
L'interlocutore è stato variamente identifi.~
cato: potrebbe essere Teseo oppure Eaco che compare all'inizio, ma non si può escludere lo stesso Piritoo 52
•
Rispetto a questa versione ne esisteva poi un'altra che ebbe minor fortuna, ma con caratteri di alta drammaticità: Eracle di sua iniziativa, senza rivolgersi agli dei inferi, strappava Teseo dal suo sedile. Apollodoro vi aggiunge il particolare prodigioso dell'insuccesso dell'eroe quando tentò di far alzare anche Piritoo, perché la terra cominciò a tremare 53
•
Infine, in età ellenistic~romana il mito fu oggetto di un processo di razionalizzazi<r ne (v. Plut. Thes., XXXI), che non interessa direttamènte qui.
Mentre il complesso delle testimonianze letterarie è stato più volte esaminato - da ultimo ottimamente ad opera di H. Herter !l*
- manca uno studio puntuale sull' « ima-
an '11:0"1:' El: O'Ù CTUIJ.I.l.r.r.xoc; • axiii!Jw [5' ~]o~
tiE~xtç ècr-c' l!xov-.a. 1tpòc; 'ltli.-.p~v (l.OÀ.Ei: v.
Eòpvrnli!i -yò:p 7tWç liox:t'i"ç ii.>J, è1o}.t.Evgy
d ~o~ 'ltU~O~'t'o 't'r.tU't'r.t CTV~'ltptÌ!;r.t'll· ._a_ CTE,
ÀÉ1;EL'II 6.'11 Wç lixpr.r."Y'toc; i}-1})..1)-.w. 1tovoç;
(F7 Snell, vv. 5-14). 51. A. Carlini, Un nuovo frammento di tragedia greca, in « Ann. &. Norm. Pisa » XXXVII, 1968, pp. 163-171 e tav. f.t.; ~ Kolner Papyri » vol. I, bearbeitet von B. Kramer, R. Hubner, Opladen 1976, pp. 14-18. B. Snell, op. cit., p. 178 in apparato non include questi versi nella sua raccolta; ma l'attribuzione a Criria mi sembra possibile. [A correzione di quanto vi è affermato v. W. Luppe, Dk Papyri am d81' HMakles·Tf"agodie: P. Colon. inv. 263 unrJ PSI inv. 3021, in Miscellimea Papyrologica, a cura di R. Pinraudi, Firenze in corso di stampa, che esclude la possibilità di un riferimentO al Piritoo di Crizia. (Ringca2io il prof. Carlini e soprattutto il prof. Luppe per quanto mi ha comunicato con una sua lettera del 13-2-1980)], 52. V. il commento ai vv. 1-3 di A. Carlini, art. cit., p. 168 . 53. Schol. Apoll. Argon., I, vv, 101-104; Apollod. Bibl., II, v, 12; con la variante di Suida, s.v. À.LO"'ltOL e di Schol. Aristoph. Eq., v. 1368: ~ (gli Ateniesi) 'ltÀ.<i't-.OV't'llL 't'Ò\1 'ltEpL 9T)aiwc; ~v~ov, ~"!:~ ÈÌ .. x6p.E'IIoc; Ù'ltÒ "':oU 'Hpcr.xì..fout; r xa't'EÀ.~'ltEV Èm 'tij m't'pq. -.i)v 'ltUYI'Jv »; cfr . H . Hecter, art. cii., c. 1178. 54. Vedi sufWa nota 44
ARULE DI MEDMA E TRAGEDIE ATIICHE 381
.,.
· gerie ) · della X<X"t'd~txcnc; di Teseo . è Piritoo all~ Ade. Gli elenchi sinora compilati, in modo più o meno esauriente, non permettono di seguire cronologicamente l' evoluzione della tradizione figurata e vede!e se al-l' adozione o all'abbandono degli schemi iconografici corrispondono effettivamente modifiche del mito secondo la tradizione scritta, cosa che è di notevole interesse. Il catalogo completo delle rappresentazioni note comprende i seguenti monumenti 55
:
1) Lamina bronzea di scudo, da Olimpia. Olim. . pia, Museo 56•
2) Nèkyia di Polignoto nella Lesche degli Coidi a Delfi (non conservata) !il.
Tav. 3) Lekythos del P. di Alkimachos, da Taranto. 97
J1•2· Berlino, Staatliche Museen 58•
4) . Cratere a calice del P. dei Niobidi, da Or. vieto. Parigi, Louvre s9. ·
..5) Cratere a calice del P. della Nekyia, prov. · scon. New York, Metropolitan Museum 60.,
6) Kylix del P. di Xenotimos, da Sorrento. BOston, M. of Fine Arts61• •
Tav. · 7) Kylix del P. di Londra E 105, dall'Etruria. 98.2· Parigi, Louvre 62•
55. Per essi viene data la sola bibliografia essenziale; inoltre per la ceramica apula le attribuzioni ai singoli Pittori sono quelle di A.D. Trendall in M. Pensa, Rfi/>Pt'eJensaziom tleJl' òhretomb11 nellll çerdmiCIS tlf111Ù, R.oma 1977. 56. E. Kurue, Arch4i.sche SchUtlbiintlH, (Olymp. Forschuogen, II), Berlin 1950, pp. 30-31, 111-112, 213, O< 6 e tav. d'agg. 7, 4; K. Schefold, Priii?grichiscbe Sigenbi/.der, Miinchen 1964, pp. 64-65 e fig. 24. 57. })aus. X, 29, 9; H. Hetter, liri. cit., c. 1180; W. Felten, Attische Untef'Weltstltwstellungen tles VI. 11ml V. Jh. v. Cb., Miinchen 1975, pp. 65·85 e fig. 36. 58. Stepbàn<Js Th. Wiegdnd, Berlin 1924, p. 11 e tav.
. VI; J.D. Beazley, Attk Red-Pigtwe V ase-PIIinters, II ed., Oxford 1963, (abbr. Beazley, ARJI2), pp. 532·533, n. ~7; F. Brommer, Vasenlùten zur griechischen HelàenJdge, III ed., Marburg 1973 (abbr. Brommer, V asenJ.isten'), pp. 220, n. Bl. 59. E. Simon, Polygnotan Plliting and the Niobid Pllinter, in c: .A.m. Joum. Arch. :t LXVII, 1963 (abbr. Simon, Polygnotan Pailmg), pp. 43-62 e tavv. 7·12; Bqzley, ARV', p. 601, n. 22 e p. 1661; contrd questa interpretazione K. Jeppesen, 'E~EoxÀlo~ :l:vp.~~ Nochmdls z11r Deutung tles NwbiJtmk,.mers, L()UfJf'e G 341, K0benhavn 1968; Brommer, VIISenli· Jterr, pp. 27, n. ~l e 491, n. B2. 60. P. Jacobstahl, The Nekyia Krater m New York, in c: Metr. Mus, St. :t V, 1934-1936, pp. 117-145; P .. Friedlander, Zur New Yo,-ker Nekyia, in « Arch . .Anz. :t 1935, cc. 20·33; Beazley, ARV2, p. 1086,
~ o. l j Brommer, V asenlùten1, p. 221, n. B4.
61. L.D. Caskey, }.D. Beazley, Atti& VIISe Paintmgs in the Museum o/ Pine Arts, Boston, III, Boston 1963, pp,. 69-~4, n. 163 e tav. XCIX; Beazley, ARJ!l, p. 1142, n. l; Brommer, Vasenlùten1
, p. 221, n. B3. 62. E. Pottier, V aseJ dntiques tlu LollfJf'B. III, Paris 192~, p. 295 e tav. 158; Beazley, ARJ!l, pp. 1293·
8) Pelike del P. di Eracle, da Kerc. Kerc, M. Tav. 97,; di Storia e Archeologia 63•
9) Cratere a volute del P. dell'Ilioupersis, prov. scon. Ruvo, coll. }atta 64•
1 O) Cratere a volute del P. seguace del Pittore di Licurgo, da Ruvo. Karlsruhe, Badisches Landesmuseum 65•
11) Fr. di cratere a volute, prov. scon. Karlsruhe, Badisches Landesmuseum 66•
12) Cratere a volute del P. degli Inferi, da Canosa. Miinchen, Antikensamnù 67•
13) Cratere a volute del P. di Baltimora, prov. scon. Basilea, Antikemmuseum 68.
14) Cratere a volute di un P. vicino al Pittore Tav. 98;J
di Baltimora, da Armento. Napoli, M. Nazio-nale{/}. ·
15) Stamnos del « Funnel Group,, da Orbetello (? ). London, British Museum 70.
16) Cratere a campana del « Funnel Group , , da Aléria. Aléria, M. Archéologique 11.
17) Pittura della . Tomba dell'Orco II, Tarquinia 72 •
1294, n. 10; Brommer, Vasenlislen', p. 220, n. B2; A. Greifenhagen, Zeichnungen nach atlisch ro1fig11rigen V asen im d.e~Jschen archiiologischen lmtillll, io c: Arch. Anz. ~ 1977, p. 245, n. 71 e figg. 90-94. 63. A.I. Boltounova, Un pétik.é du .rl#l de KerJsch représenlantla scène tle la tl6Jivrence tle Thésée, in Méldnges Mich.dowski, Warsawa 1966, pp. 287-292; A. Greifenhagen, recensione a L.D. Caslc:ey, ]. Beuley op. cit., in c: Gnomon ~ XLI, 1969, p. 181; Brommer, Vasentisten3, p. 221, n. B5. 64. H. Sichtermann, Griechùche V asen in UnterilaUen MI! Samml11ng ]dll4 in Rllvo, Tiibingen 1966, pp. 33-34, n. 36 e tavv. ~2-~4; M. Pensa, op. cii., p. 29 e tav. XIII. 65. (!. Hafner, CV A, Delltschkmd, 8, Karlsruhe, 2, Miinchen 1952, pp. 29-30 e tavv. 61, 5-63; Brommer, Vasentisten3
, p. 221, n. 01; M. Pensa, op. cii., p. 24 e fig. l tav. V; e ora A.D. Trendall, A. Cambitoglou, The Red-Piguretl V111e1 of Ap11lia, vol. I, Oxford 1978, p. 431 e tav, 160, l. . 66. G. Hafner, op. cii., pp. 30-31 e tav. 64, 7; Brommer, VasenliJten', p. 221, n. D3; M. Pensa, op • cii., p. 25 e tav. XIV, a. . 67. H.R..W. Smith, PunerM, Symbotism in Apu/Um Vase-Pfli.nting, Bcrkley 1976, pp. 248-257 e tav. l; M. Pensa, op. ciJ., p. 23 e fig. 5. 68. M. Scbni.idt, A.D. Treodall, A. Cambitoglou, Eme Gruppe .11/JIIlischer Grt~bv111en in B~Uel, Basel-Mainz 1976, pp. 57-77 e tav. 15-18; M. Pensa, op. eit., p. 29 ·e tav. XV. · 69. K Schauenburg, Dk Totengotlef' in der llf'lleNJalischen V asenmalerei, in c Jarb. d. Inst. :t 1958, p. 64 nota 79 e 'fig. lO; M. Pensa, op. cii., p. 27 e fig. 10. 70. }.D. Beazley, Etr~~scan V.:~se-Pfli.Jmg, Oxford 1947, p. 142, n. 8 e tav. XXXII, 3; M.A. Del Chiaro, The Etruscan Punnel Group, Firenze 1974, pp. 41-42, n. 3 e tavv. XL VI-XVIII. 71. J. et L. Jehasse, Un mztèf'e étrusque d'Alérid: PeirithofiJ aw: En/ers, in « Corse Historique ~ III, 11, 1963, pp. 5-21; ]. et L. Jehasse, lA nécropole prérom4ine d.'Aléria (1 960-1968), («Gallia•, suppl :XXVe) Paris 1973, pp . . 185-186, n. · 318 e tav. 87; M.A. Del Chiaro, op. cii., pp. 40:41, o. l e tavv. XLI- XI.ill. 72. M. P allattino, T ~~rquinia, in « Mont. An t. Lin. :t
XXXVI, 1937, c .. 411; M. Pallottino, Ùl pemt11re étrN-
382 MAURIZIO PAOLBTII
Tav. 96,2. 18) Rilievo ~a tre figure ~ noto da più repliche. Berlino, Sraatliche Museen; Parigi, Louvre; Roma, M. Nazionale Romano e coll. Torlonia; coli. privata 73•
19) Vaso marmoreo, cd. « Tazza Albani~. prov. scon. Roma, Villa Albani 74• ,
20) Rilievo del monumento funerario di Hieronymos, da Rodi. Berlino, Staacliche Museum 75•
21) Miniatura del codice di Othea. Erlangen, Universitatsbibliothek 76•
Vi sono, inoltre, alcune raffigurazioni di cui l'interpretazione è ancora incerta ed altre che, inizialmente ritenute pertinenti al ciclo, hanno poi ricevuto una diversa spiegazione:
a) Kylix del P. di Telefo, dall'Etruria. Boston, M. of Fine Arts 77.
b) Cratere a volute del P. di Bologna 279. Ferrara, Museo 78,
c) Cratere a campana del P. di Enomao, prov. scon. Madrid, M. Arquel6gico 79.
d) F.!. à f.r.,. da Kerc. Leningrado? so.
• sque, Génève 1952, p. 111 e fig. rèl.; R. Herbig, GoiiH tmd Damonen dH EsruskH, Mainz 1965, p. 21, fig. 6, pp. 45-46 e tav. 41; la possibilità della recezione di un modello greco (Nekyia di Nicia?) è ammessa anche da M. Cristofani,. L1arte degli Ekuscbi, Torino 1978, p. 174. 73. li. Gotze, Die atti.schen Dreifigurenreliefs, in cRom. Min. :. LUI, 1938, pp. 189-280 e tavv. 32-38 (part. pp. 207-220); E. Paribeni, Museo Nazionale Rof!Uflo. Sculture greche del V ree. Originali e 1'1/fJlicbe, Roma 1953, p. 67, n. 121 e fig.; U. Hausmann, Griechische WehkeJie/s, Berlin 19~0, pp. 48-50 e fig. 25; E. Lan· glotz, Ein neugefundene Replik des Theseusrelie/s, in « Ant. Plastik:. XII, 1973, pp. 91-93 e figg. 1-4 e
- tavv. 27-28. 74. E. Petersen, art. c#., p. 122; G. Lippold, Herakles· Mosaik 11on Linia, i~ c Jahrb. d. Inst. :. XXVII, 1922, p. 9 .e note 5-6; U. Hausmann, op. ciJ., pp. 125-126. 75. F . . Hiller von Gaetringen, C. Robert, Relief 11om dem Grabmal eines rbodiscben SchulmeistHs, in c Hermes :t XXVII, 1902, pp. 122-143 e tav. f.t.; M.P. Nilsson, Geschicbte des griecbischen Religion, II, II ed., (« Handbuch d. Altertumswiss. :t, V, 2), Miinchen 1961, pp. 234-235 e tav. 4, l. , 76, W. Zii~kner, . O~er die Abbildung, io c: Berl. W. Pr. » 1959, pp. 6-8 e fig. 2. 77. L.D. Caskey, ].D. Beazley, op. cii, pp. 54-57, n. 154 e tav. LXXXVIII; Beazley, ARV~, p. 482 n. 33 ; E. Paribeni, in c Enc. Arte Ant. » , VII, 1966: s.v. Teseo, p. 751. L'interpretazione rnigli9re è quelJa del re Teuthras che tenta di interrogare Telefo senza ricevere risposta. 78 .. ~eazley, ARV', p. 612, n. l; E. Simon, Polygnotan Pamtmg, p. 56 e rav. 10, 5; ].D. Beazley, Paralipomena,. Oxford 1971 (abhr. Beazley, Paralipomena) p. 397. Probabilmente, il personaggio maschile seduto che si regge il . ginocchio è Piritoo come sul cratere a calice del · P. dei Niobidi, di cui il P. di Bologna 279 è un immediato seguace. .
79. K. Schauenburg, Pluton und Dionysos, in c Jahrb. d. Inst. ~ LXVIII, 1953, p. 4~, n. 9 e nota 15 e fig. 6; Beazley, ARV', p. 1440, n. 2. ll giovane seduto vicino Eracle è Iolao. go. E. Petersen, art. cit., p. 123, n. 10; Steuding,
e) Fr. (di cratere a campana?), da Taranto. Ta-ranto, M. Nazionale 81• .
f) Cratere a volute del Gmppo di Grasmere, precursore del P. di Dario, da Altamura. Na.poli, M. Nazionale 82•
g) Fr. del fregio marmoreo del tempio dell'Ilisso ad Atene. Berlino, Staatliche Museen 83•
h) Rilievo marmoreo, dalla Grecia (?) Liverpool, City Museum 84•
i) Rilievo in calcare, da Taranto. Taranto, M. Nazionale 85
•
l) Specchio etmsco, prov. scon. Bologna, M. Civico 86•
art. cit., c. 719 e fig. 9; E. Paribeni in « Enc. Arte Ant. ~ cii., p. 751. Si tratta del colloquio tra Teseo stante ed Eracle seduto; mentre Petersen credeva che il fr. conservasse di Eracle soltanto il nome e il personaggio seduto fosse Piriroo secondo lo schema dei c Dreifigurenteliefs :. . · . 81. G. Bendinelli, Un frammento di cratere da Taranto con rappresentazione degli Inferi, in « Ausonia :. VII, 1902, pp. 109-115; M. Pensa, op. cit., p. 28 e fig. 2. L'esiguità del frammento non permette di riconoocere nella scena Teseo (o Piritoo) custodito da un serpente; cfr. però Cat. 16-17 e l' Ù1t6~E(1t.ç del Piri1oo di Crizia. 82. L. Séchan, op. ·&il., p. 453, n. E e nota 3; C. Robert, Ermenemica archeologica, (trad. it.), Napoli 1976, pp. 490-496 e figg. 246 e 248; M. Pensa, op. cit., p. 24 e tavv. l-IV; e ora A.D. Trendall, A. Cambitoglqu, op. ci~., p. 430 e tav. 160, 2. Robert ha riconosCiuto nei personaggi di Pelope, Mii:tilo e lppodamia, che compaiono in alto a dx . . del nai,kos le figure malamente restaurate di Pititoo, TeseO e Dike. Un erroneo resrauro ha falsato anche, trasfot~ mandola in Nereide, l'Erinni dinanzi ad Eracle' 4te ha catturato Cerbero. ' · 83. A. Briick:ner, Ein attiscbe Theseui-Fries in Ber/m und W ien, in « Jahr. <:>st. Inst. lt .XIII, , 1910,. pp. 50~ 62; L. Curtius, Zum Sarkophag 11on To"e No11a, ·in c: Athen. Mitt. » XLVIII, 1923 .• pp. 47-50 e tav. I; H. Mobius, Das Metf'oon in Agiai tmd sein Fries, in « Athen. Min.:. LX-LXI, 1935-1936, pp. 239-241; C.A. Pic6n, The Ilissos Tempie Rewmidered, in « A~. Joucn. Arch.:. LXXXII, 1978, pp. 51-52 e 62 e fig . .2. Nessuna identificazione è sufficientemente confermata dai confronti forniti. '' 84. E. Pete.csen, ari. cii., pp. 122-123 e tav. 12; B. Ashmole, A Catalogue of tbe AncknJ Marbles ·;,t lnce Bltmdell Hall, Oxford 1929, p. 112, n. 310 e tav. 42; C.A.. Pic6n, art. cit., pp. 60-61 e note 48-49. Il fr. conserva tre figure, di cui quella centrale è seduta su di una roccia; ma il rilievo continuava sicuramente a dx., cosl che ogni interpretazione rimane dubbia. ·. 85. E. Langlott, L'arie della M. Gf'ecits, cii., p. 301, ·~;
136 in basso e fig. rei.; ]. Coleman Carter, Tbe Sclilpttlre of Taras, in « Trans. Am. Philos .. Soc.> LXV, 7, 1 975~ p. 52, n. 76 e tavv. 14 b e 15 b. Delle tre figure sedute su differenti rocce, quella c~ntrale è identificabile con Eracle per la leonté, quella di dx. che si appoggia ad un bastone è forse Teseo, l'altra a sin. non ha particolari attributi. 86. E. Gerhard, A. Kliigffiann, G. Kort~, Ekuskiicbe Spiegel, voli. I-IV, Berlin 1840-1897 (abbr. Gerhard, ES), li, 131; T. Dohm, Die Fi&ot'onircbe Ciste in d61' Villa Giulia in Rom, Berlin 1972 (abbr. T. Dohm, Die Picoroniscbe Ci.fte), p. 24 e tav. 27; E. Simoo, re&ensjone al volume, in c: Gymnasium > LXXX, 1973, pp. 409-410; M. Pensa, op. cit., p. 52 nota 156.
ARULE DI MEDMA E TRAGEDIE ATTICHE 383-
m) Specchio etrusco, prov. scon. Londra, British . Museum 87•
n)· Piede della cista Ficoroni, da Palestrina. Roma, M. di Villa Giulia 88
•
Sulla base del catalogo delle raffigurazioni certe sono possibili alcune considerazioni circa il processo di elaborazione iconografica del 'mito.
La lamina di Olimpia (Cat. l) ha una notevole importanza, ' perché il gesto delle br~ccia l~vate in segno di gioia da parte di T~seo e Piriçoo. dimostra probabilmente che già. nella prima m. VI sec. a. C. era diffusa la versione del mito secondo la quale ambedue gli eroi venivano liberati. Al contrario il distacco tra Piritoo e Teseo, al momento della sua partenza con Eracle, compariva sul rilievo « a tre figure » degli ulti-
. ... .
Car. 9 cratere. a volute a Ruvo 1 O cratere a volute a Kadsruhe 11· fr. ·di cratere a volute a Karlstuhe 12 cratere a volute a Miinchen
; ' : , 13 cratere a volute a Basilea . 14 cratere a volute a Napoli
f cratere a volute a Napoli
Nonostante il numero limitato degli esèmpi si individuano due gruppi di figure che in~ tendono significare i diversi momenti del c~mmiato di Teseo, e di Piritoo rimasto prigioniero di Dike. In questo secondo caso l'essere egli legàto con le mani dietro la schiena si spiega bene • con la scena· del cratere a volute di Ruvo; mentre sul cratere a volute di Basilea il gruppo di Hekate e J>iritoo legato all'albero, apparentemente ~nomalo perché posto alla sin. del naiskos, ,,
87. Gerhard, ES, IV, 359; A. Rallo, Lasa, Firenze 1974 pp. 18-19 e tav. l; M. Pensa, op. cit., p. si nota 156 che cita questo specchio come pertinente al mito; in realtà esso reca le figure di Anfiarao, una Lasa e Aiace come specificato dalle iscrizioni. 88. T. Dohrn, Die Picoronirche Ciste, ca., p. 24 e tav. 26; G. Foerst, Die Gt'avwungen det' priinestinischen Cisten, Roma 1978, p. 195; contra E. Simon, Polygnotau Pamting, cit., pp. 409-410 che riconosce Hermes tra Pititoo e Teseo nelle tre figure, poste in un identico schema ·sia sullo specchio etrusco Cat. l sia sul piede della cista; ma l'identificazione non è convincente . .
mi anni del V sec. a. C. (Cat. 18), noto da più repliche 89
• Da questa versione « calma » si differenzia decisamente quella «dramma-· tica » dell'ihtervento violento di Eracle presente sulla lekythos del P. di Alkimachos (Cat. 3) e ·successivamente, nel secondo qu. IV sec. a. C., sulla pelike del P. di Eracle (Cat. 8). Sui vasi apuli la rappresentazione dell'oltretomba è organizzata secondo una iconografia che varia solo ·nelle figure secon ... darie. All'interno di questo « Bildtypus » Piritoo e Teseo sono posti sempre in alto à dx. del naiskos; ma accanto ad essi è Dike indicata con il suo nome sul k di cratere a volute di Karlsruhe (Cat. 11). Questa' personificazione parrebbe introdotta per caratterizzare meglio la loro condizione di prig10men. Può essere utile lo schema che segue:
Teseo e Piritoo legati da un'Erinni Teseo e Piritoo a colloquio Piritoo legato e Dike con spada
. • i•
Teseo e Piritoo a colloquio. e Dike con spada Piritoo legato ad un albero e custodito da Hekate Piritoo legato e Dike con spada nel fodero, ma gesto della· mano · ' Teseo e Piritoo a c~lloq\Jio e Dike (?)
ha la sua ragione del differente contesto: v. l'assenza· nel registro inferiore di Eracle che ha catturato Cerbero. E' interessante notare che il medesimo gruppo riappare, ma scisso ad occupare le opposte facce, sul cratere del « Funnel Group » (di produzione · tacqui• niese) rinvenuto 'ad Aléria. Il confronto ddla kylix del P. di Londra E 105 (Cat. 7), mostra come ùike non sia casuale nelle rappresentazioni di « Unterwelt >> della produzione ceramica apula. All'interno della ky~ lix è raffigurato Teseo, che dinanzi alla ma-
89. Per i problemi cqncernenti il restauro, la datazione e la collocazione originaria di questo e degli altri « Dreifigurenreliefs » v. H.A. Thompson, The· Altar o/ Pity in the Athenian Agora, in « Hesperia » XXI, 1952, pp. 47-82 e tavv. 14-19; E.B. Harrison, Hespmdes ami. Heroes. A Note on Thf'ee-Pigure Reliefs, in « Hesperia » XXXIII, 1964, pp. 76-84 e tavv. 11·14; H. Mobius, Die Reliefs der POrllandf!ase und das antike DreifigurenlJ;Jd, in « Abhandl. Bayer. Ak. Wiss. » LXI, 1965, pp. 13·31 e figg. 2-3 e tavv. 3-5.
384 MAURIZIO PAOLETII
dre trae da sotto il masso le armi che divertanno sue 90
; esternamente vi sono due scene sull'interpretazione delle quali E. Pottier rimaneva molto perplesso 91
• Egli collegava anche queste a Teseo, proponendo dubitativamente di vedere in (a) un momento della Xct'trtf~ctc:Tt~ 1gli Inferi; invece in (b) un episodio non ben determinabile. Nonostante il distacco di vernice e lo stile un po' trascurato della cop1posizione (i caratteri fisionomici sono indiffereòziati) è possibile una più attenta lettura delle figure e dei gesti. Infatti partendo proprio dall'intuizione di Pottier, ambedue le scene sono da connettersi strettamente e da localizzare agli Inferi.
• Tav. 98,2. In (a) a sin. Piritoo, nudo ed imberbe, è seduto sull' himation che copre il masso sul quale posa anche la mano dx.; il gomito sin. è appoggiato sul ~inocchio, mentre la mano serra un lungo nodoso bastone. A colloquio, è dinanzi Teseo nudo, ma con l' himation retto dietrò le gambe. All' estrema dx. è Dike, seduta su di un masso e avvolta nell' himation che cade a pieghe sul dorso e sul braccio sin. distèso. La mano indica verso Teseo (qualora il pittore sia stato preciso nel particolare del dito); certo il gesto non è casuale. In (b) la scena si riferisce ad un precedente momento e la figura nuda seduta sulla roccia è Piritoo o più probabilmente Teseo, perché la figura rispètto a quella di (a) assume una differente posizione e regge un bastone molto sottile e più corto. Dinanzi è una figura femmi-
- nile stante, vestita di un chitone con maniche e di un himation,' le braccia lungo il corpo, ha le mani intrecciate sul ventre in atteggiamento. di meditazione 92 mentre ascolta - come indica la direzione della testa - la figura femminile di sin. Questa, abbigliata in maniera simile e stante, legge da un grosso dittico aperto che sostiene con la sin. 93. Indubbiamente è il personaggio principale e dalla sua lettura dipende, forse, la sorte di Piritoo (o Teseo). In assenza tuttavia di qualsiasi confronto, questa che è la spi~gazìone cor-
90. Cfr. Ch. Sourvinou-Inwood, ThererJr Lifting the ~ock .md a Cup N eM the Pilhos Painter, in « Journ.
Hell. Smd. ~ XCI, 1971, pp. 94-109 e tav. XII. 91. Anche Greifenhagen è incerto: « Fiir die Deutung der Darstellung kann nur auf die Bemerkungen Pot· tier's verwiesen werden » . 92. Secondo Pottier la donna nasconde un qualche Qggetto nel kolpos della tunica; cfr. invece S. Settis, immagini della mediiiiZione, dett'ince1'Jezza ·e del penJimenso nell'Mie antiCA, in c Prospettiva ~ li, 1975, pp. 4-10 e figg. 1-16. 93. Per raffigurazioni di BO.,-tot. aperte v. F.A.G. Beck, Album o/ & eek &Jt~clllion, Sidney 1975, e.g. figg. 42, 54 ecc.
retta degli atteggiamenti propri alle varie figure non . può portare sino alla comprensione della scena nei suoi dettagli.
Dopo quanto detto, il frammento dell' arula di Medma può essere aggiunto con sufficiente certezza alla « imagerie » della xa't6:.{3ac:T&~ :li Teseo e Piritoo. Solo il pinax crea qualche difficoltà perché è inidentificabile per le sue condizioni. Ma non costituisce un elemento che disturba la collocazione della scena nell'oltretomba, in quanto già prima sul cratere a calice del P. della Nekyia (Cat. 5) è presente una partizione architettonica ad indicare il palazzo di Ade. In proposito si ricordi l'ipotesi di Arias di individuare all'interno del pinax Ade e, forse, Cerbero.
Per il resto, l'identificazione è coerente con tutti i confronti desunti dalla serie di raffigurazioni certe del mito. Il personaggio femminile, di cui va notata la compostezza e il gesto preciso della mano, può ben identificarsi con Dike 94 presente a custodia di Piritoo (e di .Piritoo e Teseo su Cat. 12) nell'« Unterwelt:. della produzione ceramica apula. Inoltre, il suo gesto e tutta la composizione trova un confronto stringente sulla kylix del P. di Londra E 105 nella scena del lato (a).
La figura maschile, come già Arias aveva sottolineato, è identica nella torsione del bu~ sto e della testa al Piritoo del rilievo Torlonia (Cat. 18), mentre si differenzia per la resa dei capelli e il gesto del braccio levato. Il richiamo è assai interessante dal punto di vista iconografico e soprattutto cronologico. Infatti, a partire dall'ultimo qu. V sec. a. C. vi sono due possibilità di rappresentazione del braccio in primo piano di una figura seduta di profilo e che si volge indietro: o il braccio è abbassato con la mano a fianco della gamba oppure, seguendo la torsione del busto, è levato dietro la testa. Però in questo caso a giustificare la posizione, la mano impugna o regge un qualche oggetto (lancia, scettro ecc.), mentre l'altra in se-
94. Cfr. Soph. Antig., v. 451 T) ;vvo~xoç -twv x1hw ~EW\1 .:1ix1'); inoltre vbn Sybel, in Roscher, Lexikon, l,
·1884-1890, cc. lll8·1120, r.v. Dike; W aser, in c Real Enc. ~. V, l, 1903, cc. 574-578, s.v. Dike, l .
Tav. 99,1.
ARULE DI MEDMA E TRAGEDIE ATIICHE 385
condo piano è posata quasi generalmente sulla ·g.unba 95
• La frattura ha danneggiato· il rilievo medmeo in maniera cruciale, permettendo di completare solo idealmente la figura di Piritoo; ma egli per il bastone che ha già nella sin. e per la torsionè obliqua del busto sembra che con la dx. non reggesse niente. Quindi, il gesto del braccio levato potrebbe assumere il valore di un saluto particolarmente drammatico, in quanto Dike si oppone alla sua liberazione: sarebbe cioè il momento del commiato da Teseo ed Eracle (tutti e due possono occupare lo spazio a sin. secondo la ricostruzione proposta in base alla conformazione del fr. sul retro). ·L'altra ipotesi è che il coroplasta - o il « cartone :. che egli seguiva - abbia adat
tato il gesto già diffuso nell'iconografia, modificandolo e attribuendogli un diverso significatQ. Mi sembra infatti che, essendo esclusa la versione « calma » del mito, vi sia anche la possibilità che il rilievo · rappresentasse un intervento di Eracle in qualche maniera simile a quello sulla lekythos di Berlino e sulla pelike di Kerc e come è ricordato da alcune fonti 96
• Fa ostacolo il fatto che in questo caso Eracle faccia alzare l'eroe standogli di lato; certamente però questa interpretazione ha il vantaggio di spiegare il rapporto non casuale esistente fra il braccio le~ato e la figura stante a sin. e purtroppo perduta 96
b; •• Ammesso questo schema, esso è applicabile anche a Piritoo, se si tiene conto del fatto che quando è raffigurato un solo eroe è assai difficile distinguere quale dei due si tratti 97
•
Inoltre l' arula e la tragedia di Crizia sono pressappoco contemporanee. Ad una prima lettura l'ù1t6ih:cn.ç sembra riassumere una vi-
95. E.g. ].N. Svoronos, Das athene-r Nationalmuseum, Athen 1908, pp. 333·334, n. 1388 e tav. LIII (= U. Hausmaim, op. cit., p. 69 e fig. 3 7) : rilievo di Asclepio sull'omphalos (il bastone nella dx. era lavorato a parte, come indicano le tracce per il fissaggio alla mano e sulla base). 96. V. supra nota 53. 96 bis. Cfr., indicativamente, questa possibilità realizzata su di un chous apulo del secondo qu. IV sec. a. C., v. A.D. Trendall, T.B.L. Webster, Jltustrations of greek Drama, London 1971, p. 140, n. IV, 32. 97. Esiste una notevole incertezza nell'identificazione della figùra barbata di Cat. 3 e 8: da ultimo Teseo secondo Greifenhagen; Piritoo secondo Beazley e Felten; incerto Herter.
cenda assai diversa; ma quello che va enucleato al di là di certi particolari che inducono alla cautela (serpenti a guardia dei prigionieri, Eracle che libera i compagni (?) di Teseo) è il momento nodale della tragedia: la liberazione di Piritoo. A questa si riferisce il F7 Snell in cui Teseo, ormai sottratto alla pena, spiega ad Eracle come egli non possa abbandonare l'amico. Lo svolgersi della vicenda viene così a chiarirsi. L'intervento di Eracle è duplice e portato ad effetto in due momenti successivi, separati dallo scambio di battute con Teseo. Non siamo informati su come egli riuscisse una seconda volta nel suo intento, soddisfacendo così alla condizione posta dal suo interlocutore. Le parole :x&.p~-.~ -.w" xitovlwv 1kw" dell' ~DEu~c; sono generiche, ma forse fanno propendere per ·una nuova richiesta ad Ade e Persefone. In ogni maniera era proprio la liberazione di Piritoo, in contrasto con la versione del mito più diffusa ed accettata, a costituire l'episodio di maggior rilievo. Altrimenti non .si spiega perché la tragedia traesse jJ titolo . proprio dal suo nome e non da quello di Teseo.
A questo punto, anche sulla base del precedente stabilito dall'arula di Tyro si deve coi?siderare possibile una corrispondenza tra -il Piritoo di Crizia rappresentato ad Atene sul finire del V sec. a. C. 98 e il rilievo dell' arula, che risente direttamente - o tramite il « cartone ~ utilizzato - di un'impronta attica. È significativo che essi datino ai medesimi anni come per il rilievo conferma stilisticamente, nella completa assenza ·di notizie sul rinvenimento, l'impianto delle due figure e la caratteristica chioma « a fiamme >> di Piritoo, che ha numerosi confronti ·tra la fine V e soprattutto l'inizio IV sec. a. C. 99.
99. Vedi f.E. Arias, ANI/a, cit., p. 6; inoltre A. bra - è una parodia della tragedia, la data di rappresentazione della commedia o~nee del 40.5 a. C.) fornisce un importante terminus ante quem, cfr. L. Radermacher, Ariseophanes' Fro;che, II ed., Wien 1954, pp. 213-214 e supra nota 48. 99. Vedi P.E. Arias, Arula, cii., p. 6; inoltre A. Rumpf, Relief in Villa Borghese, in « Rom. Mitt. >, XXVIII-XXIX, 1923-1924, . pp. 446-478 e tavv. X· XIII, in particolare figg. 2-6 e tav. X, e sul medesimo rilievo e la sua datazione G. Schneider-Hermann, Raub der KtZSsandra, in « BaBesch » XLI, 1966, pp. 28-33,
386 MAURIZIO PAOLETI'I
5. Il M. Nazionale di Reggio Calabria con$erva nei suoi magazzini le collezioni archeologiche dell'ex M. Civico locale e, tra queste, nu1neroso materiale medmeo che l'allora direttore N. Putortl, aveva acqUistato a più riprese, pubblicandolo in riviste da lui dirette e di scarsa diffusione. Questo materiale nel suo complesso può dirsi tuttora inedito; non fanno eccezione alcune arule fittili recuperate nell'area della necropoli di Medma 100
•
Particolarmente una si presenta assai interessante per la sua integrità e per la scena che ne decora la fronte. Il frammento di un identico esemplare, acquistato nella medesima occasione, dimostra la diffusione del tipo.
Presento qui di seguito le loro schede : ' Tav. 100,1-J. 1} Reggio 'Calabria, Museo. Nazionale, inv. n.
4083 c. Alt. cm. 29,5; largh. cm. 40; lungh. cm. 21,5; spess.., cm. 2,6~2,8. Pannello decorato: alt. cm. 21; .Jargh. cm. 3 5. Tmacotta arancione con presenza· di numerosi inclusi bianchi e di minuscole particelle brillanti. Stato di conservazione buono: l' aru1a è presso~hé integra; ·il retro e la faccia sin. sono ricom
:poste da frr., mentre quella dx. non è completa. ti aperta sotto e cava internamente. n retro presenta un grosso foro di cottura ( 0 cm. 16,5-17,5), un altro di minori dimensioni è su ciascuna faccia laterale (sin. 0 cm. 9-9,5, dx. non calcolabile). La modanatura inferiore è costituita sulle quattro facce da un semplice listello piatto, molto aggettante e smussato agli angoli; sul retro, dove ora
part. p. 31; G. Schneider-Hermann, N~~ehtrag ZM
Datierung des Kassandra-Relie/, in « BaBesch » XLII, 1967, p. 84. 100. La prima notizia e un tentativo di esegesi è in N. Putortì, Due arule fittili di Medma nel Museo Ch'ico di Reggio, in « L'Italia Antichissima» XI, 193 7 (abbr. Putortì, Due Mule), pp. 13-39 e tavv. I-II; mentre un accenno è in H. von Hiilsen, Punde in der Magna Graecia, Gottingen 1962, p. 124 (= trad. it. Ritrova· menti in Magna Grecia, Roma -1964, pp. 126-127) e S. Ferri, art. cit., p. 45 e figg. 11-14. Da ultimo ha richiamato l'attenzione su di esse S. Settis, Betlerophon, cit., pp. 191-192 e figg. 9-11 e 14. La provenienza, benché presunta, sembra certa: v. N. Putortì, Due M'file, cit., p. 13 '!: acquistare in Rosarno [ ... ] da tal Spadaro, contadino di quel paese, che ha dichiarato d'averle ritrovate presso tombe ed insieme con altri piccoli oggetti in contrada Nolio » . Il fatto trova conferma nelJa notizia di P. Orsi, Ro111mo tit., p. 57 che la necropoli .si estendeva oltre la zona da lui esplorata nei terreni di un certo Dom. Spadaro, . il quale aveva distrutto parecchie decine di tombe ·« a . cappuccina », riutilizzandone le tegole. Degli altri piccoli oggetti, venduti assieme alle arule come ricorda Putortì, non ho trovato traccia nei magazZini del M. Nazionale e neppure negli inventari del •M. Civico, per altro compilati in maniera assai · generica.
manca, è visibile in corrispondenza di esso una striscia abrasa. La modanatura superior~ è iden-. tica, ma arricchita sulla fronte da una · gola rovescia e da un listello più piccolo. La scena figurata, che non è inserita tra due pilastri come sulle arule di Tyro e di Pir.itoo, è ottenuta a matrice con successivi ritocchi a stecca. (ad es. per sottolineare le pieghe dei panneggi). Il rilievo non è ben leggibile in alcuni punti (vol~ to del personaggio seduto ecc.}: questo fatto, dovuto forse all'impiego di una matrice «Stanca », è stato accentuato da un restauro troppo energico. .·. La rappresentazione è abbastanza complessa: dei quattro personaggi che vi compaiono, certamen~ te i due al centro sono i più importanti e il loro gesto (una stretta di mano) il più rilevante. Ma sono proprio i personaggi c secondari » ad attribuire per l'atteggiamento dell'uno o i tratti somatici dell'altro un significato univoco alòd;toOai}~~. che altrimenti non si distinguerebbe da quello di saluto, di congedo, di generico segno di amicizia (101). La figura maschile seduta di profilo su di un trono ricoperto da una pelle ferina è un re. Infatti, i piedi poggiati su di un basso sgabello, indossa un chitone e un himation che, parzialmente tirato sul capo, lascia scoperti il petto e il braccio dx. Con l'altra mano regge un lungo scettro, a bassissimo rilievo, sormontato da un uccello (certamente un'aquila}. La sua testa è leggermente piegata all'indi erro per ricambiare lo sguardo della figura .stante cui stringe la dx. Questi è di profilo, la gamba sin. flessa, la mano corrispondente poggiata su di un corto bastone. Indossa chitoniskos, corazza ed un himation, che avvolto intorno al braccio sin. scende sin quasi a terra. Un balteo diagonale sul petto sorregge tra il braccio e il fianco una bisaccia da cui pendono delle frange. Completa il suo abbigliamento un cappello conico dalla punta ripiegata in avanti, dal quale fuoriescono i capelli ondu1ati, come indicano sul collo due brevi incisioni del ritocco a stecca. Dietro di iui è . una figura di pieno prospetto e nuda, salvo un himation affibbiato sulla spalla dx. La testa è lievemente inclinata di lato a sottolineare lo sforzo che egli sta compiendo. Infatti con il braccio dx. regge sulla spalla opposta un sacco (m)p~), mentre çon l'altra mano impugna uno scudo ovale dall'episema di grifon,e e una lancia di cui si intravvede solo la mei:à. inferiore. Dai tratti somatici si riconosee in llii un negro, la cui figura ha ricevuto un attento ritocco a stecca che ha evidenziato la linea alba, il solco inguinale, le rughe della fronte e la caratteristica stempiatura. All'estremità sin. è un altro personaggio stante e di pieno prospetto;
101. G. Neumann, -.rop. cit., pp. 49-5~ e figg. 23-27; C. Sittl, Die Gebiirden der Gmchen und R omer, Leipzig 1890, pp. 27-31 e 135-137 e .fig. 10.
·ti
.': .... ':'
. - .
ARULE DI MEDMA E TRAGEDIE ATIICHE 387
egli indossa chitoniskos, corazza e un berretto (1tlÀ.o~ o à.À.W'ItEid~), mentre regge l'arco con la sin. portata sull'addome e trattenuta per il polso dall'altra mano. Una sottile linea intisa diagonalmente sul petto sta ad indicare il balteo, cui corrisponde dietro la spalla sin. verosimilmente la faretra.
2) Reggio Calabria, Museo Nazionale, inv. o. 4085 c.
Alt. cm. 30; largh. cm. 29,5 spess. cm. 2,3-2,6 Terracotta arancione con presenza di numerosi inclusi bianchi e minwcole particelle brillanti. Stato di conservazione mediocre: resta la sola fronte ricomposta da tre frammenti ed incompleta. Le modanature, parzialmertte conservate, sono ùguali a quelle di l). La scena figurata è identica a quella di l): rimangoflo un piede della figura stante a sin., il perso" naggio seduto, quasi completamente quello che gli è dinanzi, la parte inferiore della figura di negro. · n :rilieyo. è assai corroso, perché la terracotta si sgretola fdtilmente; tuttavia è riconoscibile in alami punti l'intervento del .ritocco a ~ecc.a.
La scena come io l'ho descritta si differet,lzia notevolmente da quella che Putortì avev~ inteso vedere: figura seduta femminile, accanto alla sua testa una cicogna ecc.102
• Ma anche se egli conobbe le due arule prima che venissero sottoposte al restauro e ad una integrazione in gesso tol, nondimeno la sua descrizione è sicuramente errata. la cicogna appollaiata sulla spalliera del trono è un particolare fantastico . che trae origine forse da un errore di restauro: il solco esistente tra lo schienale e la figura di sin. è stato prolungato in alto, separando la faretra · dalla spalla. Così l'uccello .ha acquistato un collo e un becco, indispensabile complemento al corpo costituito dall'elemento superiore dello schienale non compreso da Putortì. In realtà, il trono è del tipo con le gambe « a tavoletta :. (o « thron with reetangular legs •) che ha uno schienale molto
102. Inoltre il fr. presenterebbe alcune varianti di dettaglio, che sebbene comuni nella produzione a macrice qui vanno escluse. Nonostante la corrosione dei rilievi, una serie di misurazioni delle figure per· mette di aHermare che essi . sono stad plasmati · da « parallel moulds :. , cioè su . . matrici derivanti dallo stesso archetipo, oppure più semplicemente dalla medesima matrice.
. 103. Al momento attuale essa manca, però è dOOlmentata proprio . nella foto qui riprodottll (1st. .Atch. Germ. di Roma, Neg. lnst. 38.533).
alto, talvolta ornato agli spigoli superiori da palmette: come è su di un fr. di arula (?) Tav. 95
locrese, dove una figura femminile con velo e polos, e seduta su di un trono riccamente ornato, sta .filando con la conocchia 10~. Il coroplasta, volendo rappresentare questo tipo di trono ha cercato di superare la difficoltà della prospettiva ingrossando in due punti la spalliera; forse il ritocco a stecca e il co-lore, ora scomparsi, facilitavano la compren-sione del particolare. Inoltre, il personawo seduto è sicuramente maschlìe (barbato?, il petto nudo ha tracce della partizione anatomica).
A causa di questi ed altri errori di lettura, è sufficiente un rapidissimo accenno all'interpretazione che Putortl aveva proposto: Elena in trono accoglie Pariqe . accompagnato da un servo negro e da Enea. Essa è ovviamente inaCcettabile. · · · · · . . . ~
Per la formulazione di una nuova ed appropriata esegesi del rilievo è necessario fare attenzione all'unica figura caratterizZata nei tratti somatici, cioè il negro. Egli regge p.n sacco, la lancia e lo scudo. Questo è ornato da un grifone alato volto a sin., . una zampa levata e la coda piegata a seguire il contorno ovale dell'episema; la testa, sebbene. corrosa,
105 . sembra di rapace non crestato . Da questo personaggio, chiaramente secondario come si vede anche dalla sua altezza rispetto ag•i
104. Vedi e.g. G.M.A. Richter, The FurnitfH'e of lhe G1'eek.s, Etf'Uscans and Romans, London 1966, pp. 23· 28 e ligg. 84·122 (part. 99, 117-118). e H. Kyrieleys, Thf'one una Klinen, (« Jahrb. d. lnst. :t , ErgiJ1Zh. 24), .Berlin 1969, pp. 154·167 e tavv. 20-21. 11 fr. di rilievo, forse di arula, da Locri· è inedito · se oon per una mediocre fotogtafia nell'opuscolo L'Anliqua-1'ium di Loro, a cura della Sopr. alle .Andchità e dell'E.P.T. di Reggio Calabria, Locri s.d. (1971?) e una notizia in S. Settis, Be/Jnophon, cit., p. 191 nota 38. tJn secondo frammento identico, ma più piccolo, sempre nei magazzini. deli'Antiquarium proviene dagli scavi Oliverio della Scuola Nuionale di Archeologia a Locri (anni 1950·1956). 105. Cfr. l;,'esempio citato da Ch. Delplace, A fJ1'opos de noilvelles isppliques en teff'e-euite tl01'ée 1'épresentilnt des griffons, trouvées à TMente; in c Bull. Iost. Beige Rome :. XXXIX, 1968, p. 46 nota 2; per un elenco, non più aggiornato ma sempre utile, di scudi con l'epitoma di grifone, v. G.H. Chase, The Shklà Devices of the &eeks, in c Harvard St. Cl. Philol. • XIII, 1907, p. 108. t assai interessante il caso di una lekythos da Cuma, nella te.pùca di Six, sulla quale uno scudo così decol:llto è pertinente proprio a un guerriero negro, v. F.M. Snowden Jr., Blacks in An#quity • EJ.hiopillns in tbe &eco·Roman Expef'iance, Cambridge · Mass. 1970, p . 26 e fig. 21.
388 MAURIZIO PAOLETTI
altri, s1 ncava un'importante indicazione ettÌica e geografica.
Non sono molti i miti localizzati in Etiopia o in cui compaiono Etiopi; tuttavia l'ass.enza di un'esatta conoscenza geografica dell' Africa e dell'Asia e il fatto che il nome di Etiopi fosse attribuito a chiunque avesse la pelle scura erano causa per i Greci di una p~fonda confusione in proposito 106
• Eschilo fiì il primo a çollocare gli Etiopi definitivamente in Africa; questa scelta si spiega con il notevole interesse nel V sec. a. C. per le sue regioni costiere originato dall'attivo commercio con l'Egitto, dall'insediamento di Naucratis e dal precedente intervento dei mercenari greci che avevano seguito Psammetico II. Dati questi interessi reali, non sorprende che in Attica anche i poeti tragici rivol&essero la loto attenzione: a miti di cui i '*p~ctpor. erano protagonisti 1~. Tuttavia né alle Danaidi descritte da Eschilo come « nel:e per i raggi del sole» (Suppl., vv. 154-155) né alla vicenda di Busiride può riferirsi il soggetto dell'arula. A prima vista sembrerebbe interessante la storia di Memnone, che fu ucciso da Achille dinanzi a Troia. Questo re degli Etiopi è raffigurato con le fattezze di un greco, mentre negro è il servo che talvolta lo accompagna; al contrario non è identificabile con sicurezza nel personaggio
- dai tratti negroidi talvolta presente, ma privo di iscrizione, nelle scene del ciclo troiano. Però iconograficamente è ricordato solo il dUello con Achille, cui assistono a volte le r~ttive madri divine, o il recupero del suo c~avere da parte di Eos.
Rimane il mito di Andromeda per il quale sono note due versioni, che si differenziavano nella localizzazione della vicenda. Nel primo caso le fonti preferendo J ope o J oppa, città
106. G.H. Beardsley, The Negro m Greek and Roman Ciflilisation, N ew Y ork 1967 ( = Baltimore-London 1929), pp. 1-9 e soprattutto F.M. Snowden }r., op. c:it., pp. 101-120 e 144-155; dr. anche A. Peretti, Eschilo ed Anassagora sulle piene del Nilo, in « St. lt. Filol. Cl. » n.s., XXVII-XXVIII, 1956, pp. 394-409. 107. Una concisa messa a punto in F.M. Snowden Jr., · op. c:it., pp. 156-160; v. anche H.H. Bacon, Barbarianr m Greek Tragedy, New Haven 1961, la cui lettura è da integrare con la recensione critica di G:. Paduano in « Ann. Se. Norm. Pisa :t XXXVIII, 1968, pp. 203-210.
fenicia sul mare, conoscono la tradizione- secondo la quale Andromeda era legata ad uno scoglio ed esposta al ketos proveniente dal mare; nell'altro seguono la versione in cui Cefeo, padre di Andromeda, era re degli Etiopi 108
• Comunque, le versioni si confusero presto l'una con l'altra. La vicenda è narrata estesamente da Apollod. Bibl., II, iv, 3, ma il passo interessante per la scena dell' arula è il seguente:. «Perseo, avendola (se. Andromeda) guardata e innamoratosene, promise a Cefeo di uccidere il mostro, se quando era salva gliela avesse data in moglie. Dopo che ci fu un giuramento a queste condizioni, assalì il mostro, l'uccise e liberò Andromeda. Allora tramò contro di lui Fineo, che era fratello di Cefeo e il primo fidanzato di Andromeda, ma Perseo scoperta l'insidia mostrò la ,,9prgon: ,e pietrificò sull'istante lui e .<
quelli che gli erano stati compagni nella trama » 109
•
Sono stati fatti numerosi tentativi per risalire dalle rappresentazioni vascolari di V e IV sec. a. C. alle tragedie attiche che trattavano il tema, ma distinguerne l'influenza dalle varianti di repertorio è impresa non facile 110
• Recentemente K. Schauenburg ha
108. Non aggiornati sono Wernike, in « Real Enc. :. , I, 2, 1894, cc. 2154-2159, 1.11. Andromedt~; Latte, in « Real Enc. » , XI, l , 1921, cc. 223-224, s. v. Kepheùs; Catterall, in « Real Enc. », XIX, 1, 1937, cc. 982-991, s.v. Perseus, l; Latte, in c: Real Enc. :t, XX, l, 1941, cc. 246-247, s.v. Phineus, 2, cfr. anche F.M. Snowden Jr., op. cit., p. 154. La più completa trattazione, per la ricchezza di informazione e l' ela· borazione dei dati, è in K. Schauenburg, Perseus in der Kunst des Altertums, Bonn 1960 (abbr. Schauen· burg, PerslltiS), pp. '55·77 e tavv. 23·29; cui è seguito K.M. Phillips • Jr., PMseus and Andromeda, in c Arn. Journ. Arch. ~ LXXII, 1968, pp. l-23 e tavv. 1-20 particolarmente interessante sulla tradizione medienle delle raffigurazioni di Perseo e Andromeda in rapporto alle costellazioni astronomiche che hanno preso il loro nome. 109. Apollod. Bibl., II, iv, 3: « -ra.lh'l'lv 9erur<ip.evoc; ò IIepae\lc; xa;l ~pa.allelc; à:va.~p1}aew Ù1tÉa'XE'tO K'l'l<pe.i: 'tÒ xij't'oç, e~ pi).)..e~ a'w9ei:cra.v a.ò"t'i}v a.ò-r<i> &:la'ew yuva.i:xa.. 'E1tl 'tOV't'O~ YEVO{lÉvtùV opxwv, Ù1tOCT"C~ 't'Ò xii't'oc; Ex't'EWE xat •t"ÌJV 'Avopo~lìa.\1 I:!J.uae\1. 'E1t~~OU· ÀEVOV'tOç lì è av-r<i> CllwÉwc;, o c; tiv à:oe)..<pòc; 't'OU K 'l'l· q~Éwc; ÉyyEyiJTI(livoc; 1tp6hoç -r'Ìjv 'Avopo!J.ÉOa.\1, !J4· ewv 't''Ìj'll Èm~ouì..1}v, "t'ÌjV ropy6va. OE,!;a.ç {U!'tà 'tW'\1
a'UVE1tL~OUÀ.Eu6v't'WV ctU't'ÒV ÈÀ.l6wCTE 1ttXPctXPii!J.ct. 110. Le teorie contrastanti di R. Engelmann, Archiiologische Studien zu den Tragiidien, Berlin 1900, pp. 63-76 riprese in R. Eqgelmann, A ndromeda, in « Jahrb. d. lnst. :t XIX, 1904rrPP· 143-151 e tav. 9, e di E. Petersen, Andromeda, in « Journ. Hell. Stud. l) XXIV, 1904, pp. 99-112 e tav. V riprese in E. Petersen, Die attische Tragiidie als Bildrmg und Biihnenkunst, Bonn
ARULE DI MEDMA E TRAGEDIE ATIICHE 389
connesso all'Andromeda di Sofocle quattro vasi databili intorno agli anni 450-440 a. C. e perciò sicuramente anteriori alla tragedia euripidea 111
• Per spiegare l'affinità esistente fra tutti, ad esclusione di uno, egli ha sup-
! posto una loro dipendenza da un comune « Vorbild », che potrebbe essere un quadro, forse il pinax dedicato per la vittoria della
. Tav.. hydéia a Londra, British Museum 99,2. cratere a campana a. Gela, M. Nazionale
pelike a Boston, M. of Fine Arts
L'ipotesi, affinché rimanga valida, deve presupporre l'intervento di importanti variazioni nella . trasmissione iconografica dall'iniziale
·· .. , · ptnax;. pe.~· questo · motivo mi sembra meno complicato pensare all'elaborazione indipen· dente del medesimo tema, alla « combinai· son des souvenirs ,. lasciati - non lo si può esçludere - dalla tragedia di Sofocle m. L'assenza, poi, di ogni notizia circa un' even· tuale vittoria è un argumentum che impone la massima cautela 113
• Se la conclusione di &hauenburg rimane indimostrata, è interes· sante la ·presenza da lui rilevata su queste rappresentazioni vascolari di servi negri. Un alt.r:.o è sul cratere a calice, di produzione at· tica della fine V sec. a. C., ora a Berlino, Staadiche Museen 114
• Successivamente, nelle scene della liberazione di Andromeda sulla ceramica apula compaiono servi o figure se·
1915, pp. 606-617 sono accuratamente esaminate e discusse da L. Sécban, op. cii., pp. 148-155 e 2.56-27~, 586-587 e 602; e da W . ]obst, Die Hohle im griech. Tbe/Jier des 5. N. 4. ]ahrb. fJM Cbr., Wien 1970, pp. 37-38, 46-48, 125-132 e figg. 19-24. 111. K. &hauenburg, Die BostonM Andromeda-Pelike unti Sophokles, in « Ant. u. Abendl. ~ XIII, 1967, pp. 1-7 e fìgg. 1-10. 112. L. Séchan, op. cii., p. 155 . 113. Cfr. già P.E. Arias, Te/Jit'o e arti figurlllifle f'l6l· J' tmtìchità ckmica, in Il problema del Mamma tmtico oggi, Atti IV Coogr. Intecn. St. Dramma Antico, = «Dioniso» XLV, 1971-1974, pp. 161-162. 114. K.A. Neugebauer, StaatlUhe Mtueen Ztl Berlin. Fuhr91' dtlfch d.as Antiquarium (li: V asen), Berlin 1932, pp. 126-127 e tav. 68. Secondo K.M. Phillips ]c., at't. cit., p. 7 e tav. 16, fig. 17 Andromeda vi appare già liberata; ma le linee bianche dietro le sue spalle, indicanti genericamente la roccia, e la po
. s1zwne a croce delle braccia dimostrano inequivocabilmente che è rappresentato il momento dell'arrivo di Perseo. .
tragedia sofoclea. Sono noti infatti casi di influenze di questo tipo. Ma una derivazione siffatta necessita di analogie più omogenee; mentre, se è indubbia quella dell'ambientazione (le vesti orientali di Andromeda, i pali, i servi negri), sono evidenti anche di
scordanze non secondarie:
Andromeda condotta dai servi, Cefeo, Perseo Andromeda già legata, tra un servo e Cefeo Andromeda mentre viene legata da un servo, assenza del padre e di Perseo
condarie vestite, come Cefeo, in abiti orientali (lunga veste, cappello frigio ecc.).
Per l'interpretazione che intendo propor· re a proposito dell'arula di Medma devono essere preliminarmente considerate alcune rappresentazioni apule. Una oinochoe molto restaurata a Napoli, M. Nazionale, presenta a sin. della figlia liberata (?!) Cefeo, lo scettro a terra, le braccia levate verso Perseo davanti al quale è prostrato 115
• Lo st~o atteggiamento di supplica è tenuto su di una lekanis a Taranto, M. Nazionale, assai discussa e importante perché forse testimonia un'influenza orfica 116
• Invece una situazione meno patetica, senza la richiesta di aiuto da parte del re, ma anzi con la promessa del· l'intervento si può riconoscere su di un'hydria lucana (&hauenburg, Bieber) o apula (Phillips Jr.) a Londra, · British Museum.: qui Andromeda è legata a due colonne sca· nalate e con capitello Ionico, ma emergenti
llS. L. Séchan, op. cii., p. 263 e fig. 83; K Schauenburg, Perseus, cii., p. 58 e nota 386, pp. 61-62; K.M. Phillips }r., 41'1. cit., p. 9 e nota 66 e tav. 9, fig. 21. Andromeda regge in mano una patera e una benda, ma la figura è pesantemente restaurata : jn origine doveva apparire legata ai pali, come sulla Jekams di cui alla nota seg. Perciò il con· fronto stabilito da Phìllips con la scena sul cratere di Berlino è ancor più inammissibile. 116. K. Schauenburg, PMseus, cit., p. 60 e tav. 25, l; K.M. Phillips Jr., art. cit., p. 9 e tav. 10, fig. 23; sul.possibile significato v. M. Schmidt, Orfeo e orfirmo nella pittura 1Jascolal'e itaJiota, in < Atti Ta· canto 1974 :t, Napoli 1975:. (ma 1978), pp. 136-137 e tav. XVII, b; sulla figura dj. Niobe solo recentemente identificata nel regisuo infériore della lekanis, v. A • Kossatz-Deissmann, Dramen des Aischylos asl/ weslgriechischen Vasen, Mainz 1978, pp. 87·88 e tav. 12, l.
Tav. 99,
390 MAURIZIO PAOLETTI
da un cespo d'acanto, e volge la testa alla sua dx. all'indirizzo di una giovane donna che sta recando un'hydria. Dall'altra parte, l'eroe, con lancia ed harpe, è a colloquio con Cefeo, seduto ad un livello s&periore 117
•
Un altro richiamo, per altri versi- necessario, va poi fatto agli affreschi pompeiani con Perseo ed Andromeda: ne sono noti numerosi esempi, distinti in cinque tipi secondo i vari moment;i della liPerazione che vi sono raffigurati. Nel primo tipo - conservato nella « Villa di Agrippa Postumo ; a Bo-
Tav. 101. scotrecase, nella « Casa del sacerdos Amandus)) (Reg., I, 7, 7,), in Reg. VII, 15, 2 e forse in Reg. l, 8, ? 118
- Andromeda è legata alla roccia, mentre Perseo giunge in volo con l' harpe e la testa delle Medusa; sullo scoglio è seduta Cassiopea (?) e tal-
.. - • ., .. ... ' " •· · . volti,, altre figure secondarie; in basso · il ketos sta · u$cendo dal mare. Ma accanto alla azione centrale che non si differenzia nel soggetto dagli altri tipi compositivi, si svolge a dx. su di un piano arretrato e con dimensioni ridotte l'antefatto : Perseo, che ha solo il mantello e l' harpe posata sulla spalla, è raffigurato nell'atto di prendere congedo da Cefeo, dopo essersi accordato con lui. l'eroe stringe la mano al re vestito alla maniera orientale, attorniato dai suoi· soldati dinanzi alla reggia, di cui si intravvedono le mura. Il gesto sancisce al · momento della partenza il patto avvenuto 119
•
117. K. Sch:iuenburg, PwseMS, cit., p. 62 e nota 412; M. Bieber, The History of tbe Greek. and Roman Tbeater, Princeton 1961, p. 32 e fig. 112; K.M. Phillips Jr., Mt. cii., p. 9 e t:lv. 8, fig. 19. 118. M . Della Corte, Pompei. Rt~l4zione dei ltwori di sca11o tLd Marzo 1924 al Mano 1926, in c Not. Se.~ 1927, p. 24 e tavv. IV; A. Maiuri, Le pitture del/4 casa dì c M. Fabius Amandio ~ , del c Sacwàos Am.m'Put ~ e dì c P. Comelius Teges ~. Reg. l, Ins. 7, (Mon. Pitt. Ant. Italia, JII, Pompei, 2), Roma s.d. (ma 1938), pp. 8-9 e tav. B; K. Schefold, Die Wande Pompeiis, Bedin 1957, pp. 31 e 206; P.H. von Blanckenhagen, Ch. Alexander, The Pamtings /rom Bosco~tecase, (c Rom. Mitt. ~ , Brgiinzh. 6), Heidelberg 1962, pp. 43-46 e tavv. 44-46; P.H. von Blanckenh:igen, Daedalus and lcarus on Pompeian W alls, in «Rom. Mitt., LXXV, 1968, p. 138 e tavv. 42, 1 e 44. K.M. Phillips Jr., art. cit., pp. 3 e 6 e tav. l, fig. 2 ritiene che la scena principale derivi da una precedente pittura ellenistica riflessa in Re g. IX, 7, 6 ( tav. l, fig. 3) e che la composizione nel suo complesso sia stata creata intorno al' 11 a.C. proprio per la Villa di Bo
. scotrecase. 119. Non vi sono dubbi su ciò, benché Blanckenhagen in P. H. Blanckenhagen, Cb. · Alexander, op. &il.,
In un oecus della « Casa del Menandro » all'affresco con la liberazione di Andromedà (secondo il quarto tipo della classificazione di Phillips) fa riscontro sulla parete accanto quello di Perseo all'interno del palazzo di Cefeo 120
• la scena interessantissima non è altrimenti nota nell'iconografia del mito, ma per le sue condizioni precarie al momento del rinvenimento è rimasta priva di una riproduzione fotografica pubblicata: sorte comune a molte pitture pompeiane. Secondo la descrizione di Maiuri, Perseo nudo se non per il petaso e i calzari alati con la sin. regge la testa della Medusa e una spada, mentre tende la dx. verso una figura femminile stante, con il capo coperto da un risvolto del mantello. Alla sin. di lei sono due figure maschili, la prima ammantata e con un ba~ stone nella mano tende la.sire verso.la -:dQA• na; l'altra « risi:à immobile in atto di spettatore » ». Sullo sfondo cortine distese indi~
cano che la scena si svolge all'interno di un edificio. l'interpretazione che si tratti di Cefeo e di Perseo che si rivolgono a Cassiopea è corretta; ma l'altro personaggio, per il quale Maiuri non avanza ipotesi, è certamente Fineo m.
A questo punto credo siano stati raccolti sufficienti elementi per collegare la scena sull' arula medmea con il mito in questione. Preliminarmente, l'assenza di Andromeda~ il personaggio intorno a cui ruota la vicenda, non costituisce un probléma. Come sottolinea giustamente Schauenburg a proposito degli affreschi pompeiani, « daB die Szene vor der Befreiung Andromedas spielt, ergibt sich daraus, daB Andromeda nicht anwesend ist :. 122
• Si ricordi la rappresentazione sull'hydria di londra, dove Andromeda è sì legata
p. 44 riferisca l'episodio all'c happy ending of the tale ~; più c:luto Phillips che esita a pronunciarsi sul rapporto temporale tra le due scene. 120. Oecus 16, p:itete N: A. Maiuri, La Casa del Memmdro e il suo tesoro di argenteria, Roma 1932, pp. 162·163; Ch. Dawdson, Romtmo-Campanitm Mythological Landsc/lf1e Painting, New Haven 1944, p. 113, n. 70; K. Schefold, op. di., p. 42. 121. V. il passo di Apollodoro citato . supra nella nota 109; Ov. Met., V, 1~235 e F. Bomer, P. OviJius Naso. Buch 4-5: K ommemat, Heidelberg 1976, pp. 2t9-232; in generale anche Latte, in c Real Boe. :t, cii., s.fl • PhineMS, cc. 246-247. . 122. K. Schauenburg, Perset~s, cii., p. 62.
ARULE DI MEDMA E TRAGEDIE ATTICHE 391
accanto a Perseo e Cefeo a colloquio, ma guarqa verso l'hydrophora. Questo fatto indica che i due gruppi sono per così dire giustapposti, affinché il primo chiarisca senza lasciare dubbi il significato dell'altro: Perseo si sta accordando sulla liberazione della fanciulla.
Esaminando poi il rilievo dell' arula, ogni figura può essere identificata in relazione al mito. Putord attribuiva le armi impugnate dall'etiope al personaggio che gli sta accanto; ma se questi è Perseo ciò non è plausibile. Si tratta invece di un etiope armato, posto all'estrema dx. della scena (e non vicino al re) per simmetria rispetto alla figura di sin. La 1t1)pa. recata in spalla è verosimilmente quella contenente gli oggetto da deporre come offerte funebri vicino ad Andromeda. Perseo è caratterizzato dal cappello frigio e dalla k.ybisis, oon altrimenti può spiegarsi l' oggetto appeso al suo fianco (se infatti fosse una faretra--- come sostiene Putortì ·_egli
_dovrebbe portare . anche l'arco). Per la forma ._può richiamarsi quella che Perseo ha sul çratere a calice di Berlino già citato. Il bastone cui egli si appoggia trova confronto su di un rilievo in terracotta a Berlino, Staatliche Museum, di poco posteriore all'arula 123~ All'estrema siò.. si colloca Fineo, 'il pretendente di Andromeda; la frontalità dèlla figura sta a significare la non-partecipazione, l'ovvio rifiuto del consenso al patto che vicino a lui Cefeo stipula con l'eroe giunto inatteso a concludere felicemente la vicenda.
L'arula è databile, soltanto in base a criteri stilistici, intorno alla fine V sec. a. C., cioè agli stessi anni degli altri esemplari
123. Sugli attributi di Perseo v. il capitolo relativo di K. &hauenburg, Perseus, cit., pp. 11 7-125 (la kybisis può essere grande o piccola, a forma di « fiasca da pellegrino :t o mancare del tutto; Perseo può avere l'harpe, la spada, le !ance o essere privo di armi). Il rilievo frammentario di Berlino fu acquistato sul mercato antiquario e quindi la sua provenienza attica non è sicura, v. M. Friinkel, Eme Te-rrakotta und ein Spiegel des berliner Museums, in « Arch. Zeit » XXXVII, 1879, pp. 99-100 e tav. XI; R.. Zahn, Perseus und AndromedP, in « Die Antike :t I, 1925, pp. 80-85 e tav. V; L. Séchan, op. cit., l'P, 263-264 e fig. 84; F. Brommer, Die Koningstochter und dar UngeheuM, in « Marb· W. Pr. » 1955, p. 12, n. l e tav. l; K.M. Phlllips ]r., art. cit., l'P· 14-15 e tav. 15, _figg. 45-46 il quale dubita senza ragione dell'autenticità del J>CZZO.
medmei. La possibilità di un rapporto tra la scena che. ne decora la fronte e un precedente testo tragico costituisce un problema per il momento privo di sicura soluzione. Solo il titolo si è conservato dell'Andromeda di Frinico, figlio di Melanthas 124
; mentre abbiamo pochi frammenti della omonima tragedia di Sofocle, così che non è possibile ricostruirne con certezza la trama 125
• Probabilmente si basava sui medesimi dati fondamentali della successiva Andromeda di Euripide. Questa, rappresentata nel 412 a. C., riscosse un enorme successo 126
, tanto che la totalità delle posteriori raffigurazioni del mito risentono in qualche maniera del racconto euripideo, che esaltava gli elementi patetici della vicenda m. Secondo la ricostruzione più attendibile, Andromeda era presentata sin dal prologo sulla scena e Perseo, che arrivando se ne innamorava immediatamente, uccideva il ketos senza incontrare prima il padre di lei. La conclusione è invece più incerta: non è chiaro se, dopo la liberazione, l'opposizione alla partenza di Andromeda venisse da parte di Cefeo e Cassiopea (Séchan) oppure del precedente fidanzato (Webster) 128
• Infatti
124. Voo Blumenthal, in c ReaJ Enc. ~ XX, l, 1941, cc. 917·918, s.v. Phrynichos, 5; B. Snell, op. eit., p. 323 (Phrynichus Il). 125. Nulla aggiunge a quanto precedentemente noto ].M. Marijoan, La « Andròmeda » de Sòfocles. Intentos de 1'ecostrucciòn, in « Actas l Simp. Soc. Esp. Est. Cl.: Tragedia Clàsica » = « Bol. Inst. Est. Hel. », Il, 2, 1968, pp. 65-67; invece G.M. Rispoli, Pe-r l'Andro· meda di Sofocle, in « Rend. Ace. Napoli» n.s., XLVII, 1972, pp. 187-210 e tav. I da un uso acritico della documentazione iconografica deduce una- ricostruzione erronea dell'Andromeda, riconoscendovi un dramma satiresco. Per la più recente edizione dei frr. v. St. Radt, op. cit., pp. 156·160 (F 126-136). 126. Cfr. Aristoph. Ran., v. 53 ·che ne fa la lettura preferita di Dioniso e la parodia di Thesm., vv. 1008-1012 e p4Ssim. Per il testo v. A. Nauck, Tragicorum Graecorum Fragmenta. (Supplementum... adiecit B. Snell), Hildesheim 1964, pp. 392-404 (F 114-156} e 1028-1029; H.J. Mette, Euripides, 1939-1968, cit., Pi'· 47-57 (F 161-208); H.J. Mette, Euripides (1).1968-1975, in « Lustium » XVII, 1973·1974 (ma 1976), pp. 7·8. 127. V. gli ·elenchi di F. Brommer, op. cit., pp. 10-12; T.B.L. Webster, Monuments cit., pp. 154-155, dr. p. 147; F. Brommer, Denk-miiler UN griechischen Heldemage, val 111 Obrige Helden, Marburg 1976, pp. 380-387; e v. da ultimo V. SaJadino, Nuovi vari apuli con temi eu-ripidei (Alcesti, Crisippo, Andromeda), in « Prometheus » V, 1979, pp. 104-116 e figg. 7 ·9, con ·ampia discussiòne sull'iconografia del soggetto. : 128. L. Séchan, op. cit., pp. 264-273 (part. p. 271 nota 7); T .B.L. W ebster, The Tragoedies o! Euripides, London 1967, pp. 192-199 (part. pp. 197-198).
392 MAURIZIO PAOLBTTI
Tav. 94,1.
F188 e F208 Mette non seno decisivi per :mpporre la partecipazione di Fineo 129
• Comunque, l'assenza di un colloquio e un patto iniziale esclude per l'arula di Medma ogni raffronto con la tragedia di Euripide. Inoltre, le rappresentazioni vascolari che da questa sono per così dire « influenzate ~ non presentano mai un tale momento della vicenda: questo è un argttmentum ex silentio che può avvalorare l'esclusione. Rimarrebbe la possibilità · che la. scena si .avvicini alla versione dell'Andromeda di Sofocle, se come sembra il passo citato di Apollod. Bibl., II, iv, 3 ne ricorda alcuni particolari 130
; ma Je scarse testimonianze e quanto conservato del testo sono troppo poco per offrire prove al riguardo.
6. Oltre agli esemplari qui esaminati, da Medma provengono altre arule simili che attestwo una loro rilevante ed inattesa presenza nella necropoli. Si traata per lo più di frammenti, le cui dimensioni · impediscono l'identificazione del soggetto 131
; ma vi è anche la fronte completa di un' arula che presenta tre personaggi (un vecchio seduto, un giovane nudo e una figura femminile) all'interno di un inquadramento architettonico con colonne doriche 132
• Putortì, credendo di riconoscervi il distacco di ·Neottolemo da Licomede e Deidamia, ha connesso· la seena
_ con gli Skyrioi di Sofocle. L'ipotesi non è affatto provata; tuttavia non mi è possibile per adesso avanzarne una migliore . . Un altro frammento, pubblicato da Arias, reca un soggetto quanto mai enigmatico: un leo-
129. H.}. Mette, Eu,-ipide!, 1939-1968, cit., p. 57. · 130. V. supra nota 109 e L. Séchan, op. cit., p . 148 uota 5. 131. Dalla sep. 39 un fr. con la parte inferiore di una figura feminHe e il piede di un altro personaggio, v. JUfJ,.~ a nota 31 e E.D. van Buren, Mt. ciJ., p. 39; fr. angolare con una testa giovanile con pileo (?) vicina al resto di un capitello, v. P. Orsi, Rosarno, cit., p. 53 e fig. 27 e E.D. van .Buren, art. cit., p. 40; testa femminile con orecihini accanto ad un capitello e alla sommità della colonna scanalata, v. N. Putortì, Due arule, ci.t,, p.- 18 e fig. 4 e S. Settis, Bellerophon, cit., p. 192 e fig. 14. 132. Reggio Calabria, Mus. Naz., inv. n. 4086 C che trova riscontro io un altro fr. della ex coli. Carboni Grio, inv. n. 3677 C, v. N . Putortì, Due arulfl, #1., pp. 16-18, 29-34 e fig. 2 e tav. Il; S. Settis, BeJlero- · phon, cit., p. 192 e figg. 10-11; T. Fischer-Hansen, Sicilùm Arulae, cii., p. 10 (dove è fatta confusione sulla provenienza).
ne (?) di enormi proporzioni avanza alle spalle di una figura femminile seduta, in ~ez-' ... , zo tra loro è un basso pilastro con sfinge ~~3 • Ulteriori ricerche riusciranno a spiegare queste raffigurazioni, che sinora hanno resistito ad ogni esegesi plausibile; però già si possono trarre due conclusioni del massimo interesse 134
•
Innanzirutto la decorazione di queste arule medmee sembra risentire l'« influenza :. di alcune tragedie attiche della fine V sec. a. C., mentre è accertato che successivamente trova rari e solo parziali confronti iconografici. Significative sono a questo riguardo le arule che illustrano i momenti essenziali dei miti di Tyro e di Andromeda. Questa produzione è un dato sorprendente che non trova riscon
tro in nessuna città dell'Italia meridionalet neppure nella madrepatria Locri. Infatti le
arule siceliote, ricordate al principio, con il
suicidio di Aiace oppure Odisseo e un_ compagno legati sotto due caproni recano soggetti ben noti e con una lunga tradizione iconografica; mentre il fr. d'arula (?) locrese
con una figura femminile Èpya'VT) non ha neS
suna caratterizzazione precisa 135•
Inoltre, tale produzione è attestata soltanto tra la fine V - inizi IV sec. a. C. e, benché
sia arduo specifiçare i nessi con le vicende
storiche della città, è naturale pensare ad una data successiva alla spedizione in Sicil~a intrapresa da Atene nel 415 a. C. e antece
dente, forse, al trasferimento nel 396-395 a. C. di quattromila (?) medmei a Messina 136
•
133. Reggio Calabria, Mus. Naz., inv. n. 3383, v. P.E. Arias, Arula, c#., pp. 135-136 e fig. 3; S. Settis, Bellerophon, cit., p. 192 e fig. 13. 134. Vedi S. Settis, Bellerophon, cit., pp. 192-194. 135. Cfr. K. Schauenburg, Die Giittin mit dem Vogels• zepter, in cRom. Mitt. :& LXXXV, 1975, p. 208 e tav. 57,2 a proposito dt.' A.D. Trendall, The Red-Pigureà. Vase! of Luc~nia, CiJmjJania tmd Sicily, Oxford 1967, p. 145, n. 792 e tav. 67, 4. 136. S. Settis, Fonti, cit., pp. 125-127.
i . .,
Tav. 94 • Reggio Calabria, Museo N azionale. l . Arula da Medma. 2 -3 .Bassorilievi fittili da Locri.
3
Tav. 93 · l . N apoli , Museo Nazionale. Anfora apula, part icolare. 2. Berlino, Staa tl. Museen. Plac
chetta per fu sione. 3. Catani a, Castel Urs in o. Manico d i specchio .
2
Tav. 95 • 1-2. Reggio Calabria, Museo Nazionale. Arula di Tyro da Medma, lato anteriore e lato
breve. 3. Locri, Antiquarium. Bassorilievo fittile da Locri.
2
Tav. 96 · l. Reggio Calabria, Museo Nazionale. Arula di Piritoo da Medma, frammento. 2. Roma, Collezione T orlonia . Rilievo con comm iato di Teseo a Pi ri too (secondo il restauro ottocentesco).
T av. 97
1 .2
1-2 . Berlino, Staatl. Museen. Lekythos. 3. Kerc, Museo di Storia e Archeologia. Pelike,
particolare.
2
Tav. 98 · l . Napoli, Museo Nazionale. Raffigu razione su cratere a volute da Armento. 2. Parigi, Musée du Louvre. Kylix dall'Etruria, particolari.
2 3
Tav. 99 • l. Atene, Museo Nazionale. Rilievo dall'Asklepieion . 2 . Londra, British Museum. Hydria lucana, particolare. 3. Londra, British Mnseum. Hydria lucana, particolare.
1
Tav. 100 Reggio Calabria, Museo Nazionale. Arula di Perseo da Medma. 1. Lato anteriore. 2 . Lato breve. 3. Lato posteriore.











































![Frank Sargeson [Norris Frank Davey], 1903 – 1982](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6322013728c44598910594c2/frank-sargeson-norris-frank-davey-1903-1982.jpg)