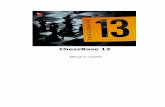13 - Cella Lucceiana
Transcript of 13 - Cella Lucceiana
Presso privati, e precisamente sotto al portico di un villino situato in via Limbara 10, alla periferia di Roma, si trova con altre epigrafi che commenterò altrove, la piccola stele sepolcrale che presento alla fi g. 1. Proviene, come pare, da sterri compiuti qualche decennio fa nella zona sepolcrale che si estendeva subito fuori la città tra le vie Salaria e Nomentana1. Il monumentino marmoreo, oggi alto cm 49,5, largo cm 29,2, spesso cm 5 (sul lato destro), 8 (sul sinistro), si presenta, per così dire, suddiviso in quattro zone. Nella prima, in alto, è incisa la consacrazione agli Dei Mani ed il nome del defunto; nella seconda si leggono un carmen sepolcrale costituito da tre distici elegiaci disposti in sette righe nonché, fuori metro, l’indicazione della | età; nella terza si ha una raffi gurazione a rilievo del defunto; la quarta, infi ne, è costituita da un tratto di superfi cie liscia cui si aggiungeva, in origine, una parte semplicemente sbozzata che è stata tagliata. Da questo fatto e dall’esistenza, nella parte superiore, di due fori passanti obliqui si desume che la piccola stele era interrata inferiormente e, superiormente fi ssata con grappe o chiodi ad una parete cui era addossata.
Il testo, fortunatamente quasi integro, non presenta diffi coltà di lettura (le lettere sono alte in media cm 1,2) e suona:
Dis Man(ibus). / Sex[t]o Vetulêno Lavica[n]o. /
Delicium populi, circi quoque nuntiu(s) / ampli,septima quem regio sextaqu(e) / 5 amavit idem.Hunc mihi coniuvenes / titulum posuere sepultoet / scalpsere sua nomina nostra fi de. /Di, tales servate, diu servate sodales,qui / nostri memores quique fuere sui. / 10
V(V(V ixit) a(nnos) ((quattuor et quadraginta)).
Il breve componimento poetico, che costituisce la parte centrale dell’epigrafe è sostanzialmente corretto e non privo di una qualche eleganza. L’iscrizione è posta al defunto, che era stato in vita benia-mino del popolo, nuntius del vasto circo e prediletto in egual misura dalla sesta e settima circoscrizione cittadina, da parte di certi coniuvenes ai quali va pertanto la gratitudine del defunto che invoca su di loro la protezione divina.
* Tra epigrafi a e topografi a, I, 3, in Arch. Class., 22, 1970, pp. 151-163.1 Devo la segnalazione della piccola raccolta al laureando Giulio Molisani, mio ottimo collaboratore per i lavori pre-paratori del nuovo supplemento a CIL, VI, nonché sagace ricercatore e scopritore, anche per la sua tesi, di materiale
epigrafi co inedito di primaria importanza. Ai Signori Curzi, attuali proprietari, vanno i miei più vivi ringraziamenti per la squisita cortesia con cui hanno collaborato al lavoro di schedatura, fornendo utili informazioni e provvedendo essi stessi a far smurare il pezzo qui studiato per favorirne un più compiuto esame.
II,7 - REGIONES, VICI E IUVENTUS*
<151>
<152>
174 II – URBS ROMA
Quantunque, in questa sede, l’interesse prevalente dell’epigrafe sia altro, ritengo non dover trala-sciare alcune osservazioni e riscontri sulla parte metrica2.
Osservo così che l’unica scorrettezza, se così si può dire, si ha al v. 2 del componimento ove idem è chiaramente usato per item, con il senso di eodem modo. È tuttavia confusione che si registra abbastanza spesso, soprattutto in epigrafi a ed in età relativamente tarda3. Meritano attenzione anche altre partico-larità.
V. 1: Delicium populi riferita a personaggi del mondo dello spettacolo o altrimenti noti e particolar-mente graditi alla cittadinanza è espressione non ignota; un confronto letterario particolarmente calzante si ha in Priap., 27, 1-2: Deliciae populi, magno notissima circo, / Quintia, vibratas docta movere nates,ma si veda già PLAUT. Mostell., 15: Tu urbanus vero scurra, deliciae popli. Per attestazioni epigrafi che: CIL, VI 10151a cfr. p. 3492 = ILS 5222 Cn. Pompeius / ((mulieris)) l(ibertus) Astipa / deliciae / populi Ro(mani) (l’attività del personaggio è posta in relazione con i ludi scenici); Suppl. Pap. Am. Sch. Rom,2, 1908, p. 270 nr. 6, fi g. 8 = CLE 1961 = ILS 9346 = LUGLI, Fontes, IV p. 181 nr. 10a cfr. H. ARMINI, in Eranos, 34, 1936, pp. 112 sg. Delicius Matris Matutae / ((sextae)) regionis Eucerus hic situs est. / Auletio cantor ubique / [-- Ti]tulum fecit Iulius / [--]ilius papati suo. Ricordo anche, per inciso, il ben noto appellativo di amor et deliciae generis humani attribuito, per concorde testimonianza degli autori (vd., per tutti, SUET., Tit., 1) all’imperatore Tito.
V. 2: septima quem regio sextaqu(e) amavit idem non vuole far rilevare soltanto il particolare favore goduto in vita dal personaggio, ma, insieme, la partecipazione corale al dolore per la sua scomparsa, altrove espressa più apertamente, ad es. CLE 104 v. 3 quem cuncta fl evit turba; CLE 213 = CIL, X 1275 v. 4 quem fl evit omnis planctibus novis turba; CLE 526 = CLE 526 = CLE CIL, VIII 9519 c. 10 Hunc fl evit populus pius hunc miseri ingemuere parentes.
V. 3: Su coniuvenes, parola di cui non sembra si abbia testimonianza, né letteraria né epigrafi ca, si tornerà più sotto. Ponere titulum od espressione analoga con il dimostrativo in positio princeps è espressione frequente, ad es. CLE 1028 = CIL, VI 8703; CLE 1029 = CIL, VI 24807/8; CLE 1208 = CIL, III 3241; CLE 1536 = CIL, III 2722 cfr. 9729; CLE 1550 = CIL, XI 1209; CLE 2026 = CIL, XI 4339; Bull. Comm. Arch. Roma, 1926 p. 257 cfr. Acta Inst. Rom. Regni Sueciae, s. in 4°, 21, 1961, p. 195 nr. 6, tav. V, 6.
V. 4: et scalpsere …nomina nostra. È noto il grande valore che si attribuiva alla presenza del nome sul sepolcro4. Non stupisce quindi di trovare anche in altre occasioni espressioni di gratitudine del morto per la lealtà dei sodales che curarono la costruzione del sepolcro e l’incisione dell’epigrafe: CLE 572 = CIL, VIII 369 cfr. 11549, vv. 2-3 et sum post obitum felix cui | cari sodales / hoc titulo fi xerunt nomen aeternum; CLE 802 = CIL, VI 30124, vv. 4-6 haec postquam posuere / sepulchrum,kari / scripsere sodales; vd. inoltre, per l’uso di scalpere e sodales nei carmina epigraphica: CLE 537 = CIL, V 5824; CLE 587 = CIL, VI 30135; CLE 1191 = CIL, XII 5811; CLE 1537 = CIL, VI 25703; CLE 2055.
2 Di alcune di queste osservazioni sono debitore alla Dott.ssa Fiorella Martorelli, eccellente conoscitrice dei carmina Latina epigraphica, particolarmente di Roma, al cui studio si sta dedicando da tempo con notevole profi tto.3 Secondo E.H. STURTEVANT, Some Unfamiliar Uses of idem and isdem in Latin Inscriptions, in Class. Philol., 2. 1907, p. 323, il primo esempio databile si ha in CIL, XIV 2112, cfr. p. 486 ed Eph. Epigr., 9, 1903, p. 381 col. 1, r. 9, del 136 d.C.
Su questo scambio vedi anche E. LÖFSTEDT, Philologischer Kommentar zur Peregrinatio Aetheriae. Untersuchungen zur Geschichte der lateinischer Sprache, Oxford-Uppsala 1936, pp. 294-296 e Thes. Ling. Lat., VII, 1, 1964, col. 194.4 Si vedano, da ultimo, le felici pagine scritte a questo ri-guardo, prendendo le mosse dalla tecnica e dal signifi cato dell’acrostico, da J.W. ZARKER, Acrostic Carmina Latina Epigraphica, in Orpheus, 13, 1966, pp. 138-150.
<153>
<154>
7 - REGIONES, VICI E IUVENTUS 175
Chiusa questa parentesi, vengo ora ai maggiori motivi d’interesse ed ai veri problemi sollevati da quest’epigrafe. Mi pare che gli interrogativi che si presentano siano sostanzialmente tre, strettamente connessi tra loro e riguardanti i seguenti punti: 1) quale fosse la professione del defunto; 2) come si debbano defi nire i coniuvenes che si sono presa cura del suo sepolcro; 3) quale connessione avessero il morto ed i suoi amici con l’ordinamento regionale cittadino.
La prima domanda potrebbe sembrare a prima vista oziosa poiché una professione del defunto è indicata proprio all’inizio del carmen: Delicium populi circi quoque nuntiu(s) ampli. Sesto Vetuleno La-vicano5 fu dunque nuntius del circo, verosimilmente del circo per eccellenza, cioè del Circo Massimo6
che diede il nome all’XI circoscrizione cittadina. Ma già il termine usato non è tale da defi nire con as-soluta chiarezza la professione del defunto, che poté essere tanto quella di annunciatore (praecosoluta chiarezza la professione del defunto, che poté essere tanto quella di annunciatore (praecosoluta chiarezza la professione del defunto, che poté essere tanto quella di annunciatore ( ) quanto quella di messo (viator, cursor)7. Inoltre che questa non fosse l’unica sua attività, e forse nemmeno quella che più importava a lui ed ai suoi amici, si ricava da vari | indizi. Anzitutto sembra sproporziona-to per un annunciatore, e ancor più per un messo, l’appellativo di delicium populi. In secondo luogo il quoque del primo verso sembra avere una funzione nettamente disgiuntiva, il che rafforza la precedente osservazione. Infi ne l’accenno alla predilezione nei suoi confronti da parte di due intere circoscrizioni cittadine, la regio VI (Alta Semita) e la VII (via Lata), rinvia chiaramente al mondo dello spettacolo e presuppone che il defunto ne facesse parte in qualche modo come protagonista e non come fi gura di secondo piano.
Queste osservazioni vengono confermate, mi sembra, dal piccolo rilievo (solo 23 cm) in cui Sesto Vetuleno Lavicano è rappresentato sotto l’epigrafe. Egli vi fi gura di tre quarti, gradiente a destra. In-dossa una corta tunica senza maniche con un’alta fasciatura intorno alla vita. Sul capo porta una calotta liscia, verosimilmente di cuoio, che gli scende sulla nuca. Con la sinistra regge un vexillum, con la destra l’impugnatura di una frusta, la cui correggia non è visibile nella foto per il gioco delle ombre, ma si scorge chiaramente sull’originale tra le pieghe della tunica. Non v’è dubbio che il defunto, se pur con qualche semplifi cazione, sia qui rappresentato in veste d’auriga8 e sembra ovvio che a questa sua attività e non a quella di nuntius fosse legata la sua fama tra la cittadinanza.
5 I Vetuleni a Roma sono numerosi (CIL, VI index). Da no-tare l’omissione del patronimico che, insieme con la profes-sione, potrebbe indicare origine libertina. Un Sex. Vetulenus (Vettulenus) Civica Pompeianus fu console ord. nel 136 ed altri membri della stessa famiglia furono consoli nel 106, prima dell’82 e prima del 78 (A. DEGRASSI, I Fasti Conso-lari dell’Impero Romano, Roma 1952, ad annos). Del co-gnomen etnico Lavicanus/Labicanus (da Labici) si hanno altri due esempi a Roma (CIL, VI 16368, 37852) ed uno a Marruvium (CIL, IX 3748). Un Vetulenius Praenestius, v(ir) p(erfectissimus), corrector Venetiae et Histriae nell’anno 362, si ha in CIL, V 8987 = ILS 755.6 Non mi risulta che per indicare questo circo sia mai usa-to l’aggettivo amplus, ma, dato il contesto metrico, questo non mi sembra un impedimento troppo grave: magnus è detto da OV. Fast., 6, 477; Priap. 27, 1; PLIN. HN, 36, 71; MART. 6, 64, 12; 7, 7, 9; capax populi da OV. Ars. am., 1, 136. Altri aggettivi usati per defi nire i circhi: ingens (STAT. Theb., 6, 932; CORIPP. Iust., 1, 330), latus (CORIPP. Iust.,
2, 361), longus (VERG. Aen., 5, 551; MANIL. Astron., 5, 89). Documentazione in Thes. Ling. Lat., III, coll. 1184, rr. 39-46 e 1187, rr. 53-58 e in LUGLI, Fontes, VIII, pp. 383-412.7 Anche l’uso di nuntius, che non è termine tecnico, è forse dovuto a ragioni metriche ed al tono generale dell’epigrafe. Sull’uso di praecones nel teatro ed, in genere, nei pubbli-ci spettacoli: E. SAGLIO, in Dict. Ant. Gr. Rom., IV, p. 610 con le fonti ivi citate; vedi anche TH. MOMMSEN, Le droit public romain, trad. Girard, 12, Paris 1893, pp. 416-420; J. MARQUARD, Le culte chez les Romains, trad. Brissaud, II, Pa-ris 1890, p. 258 nt. 2; ID., La vie privée des Romains, trad. Henry, I, Paris 1892, p. 411 nt. 4. Un viator è incluso nella familia quadrigaria di T.T.T At(eius) Capito (CIL, VI 10046 = ILS 5313). Sui cursores del circo, che non sempre intenderei come corridori: G. CICOLINI, in Diz. Epigr., II, 2, 1910, pp. 1403-1404.8 Sul costume degli aurighi, ed in particolare sui vari tipi di protezione, fasciature in primo luogo, adottati per proteggersi
<155>
176 II – URBS ROMA
Si tratta di vedere peraltro in quale contesto vada inserita questa sua attività, cui non si fa aperto riferimento nell’epigrafe e che diffi cilmente, pertanto, sembra rapportabile al gran mondo dei ‘divi’, per così dire, cioè degli aurighi professionisti del Circo Massimo.
Per questo sarà opportuno passare al secondo dei punti sopra enunciati e cercar di stabilire chi siano i coniuvenes, i sodales di Lavicano. Come si è già detto, il sostantivo coniuvenes sembra non esser mai stato usato altrove, | né da autori, né epigrafi camente: non appare comunque nel Lexicon del Forcellini, né lo si trova nel Thesaurus Linguae Latinae o nel Dizionario Epigrafi co del De Ruggiero. La sua com-posizione, il successivo riferimento ai sodales, lo stesso carattere generale dell’epigrafe lasciano comun-que chiaramente intendere che si tratta dei componenti di un sodalizio e precisamente di un collegium (corpus, ordo, sodalicium, studium, thiasus) iuvenum.
La constatazione mi sembra di notevole importanza. L’istituzione della iuventus, la sua organizza-zione in età imperiale, le sue caratteristiche e fi nalità (sportive, pre- o paramilitari, politiche, sociali, re-ligiose e funeraticie) sono state fatte oggetto di studio più volte ed, in maniera complessiva, anche assai recentemente9. Sempre però l’analisi è stata rivolta in maniera pressoché esclusiva alle caratteristiche ch’essa presentava nei municipi italiani, ove massimamente fi orì, e delle province occidentali10, sem-
nelle frequenti cadute: H. SCHONE, Statue eines römischen Wagenlenker im Vatikan, in Jahrb. Deut. Arch. Inst., 18, 1903, pp. 68-71 con i passi di Galeno ivi citati. Tra le più celebri fi gurazioni di aurighi a Roma, accenno appena ai sette busti dal tempietto di Ercole in Trastevere (NASH, Dictionary2, I, pp. 462-470, fi gg. 571-577) ed al mosaico delle fazioni dalla via Cassia (R. WIRTH, Römische Wandmalerei, Berlin 1934,tav. 12). Per le scene di circo in generale, innumerevoli ovun-que e sempre di notevole interesse anche per il costume degli aurighi, mi limito a rinviare ad alcuni repertori ed a qualche contributo recente ove potrà essere trovata una bibliografi a completa ed ampio materiale illustrativo: H.B. WALTERS, Ca-talogue of the Greek and Roman Lamps in the British Mu-seum, London 1914, nrr. 626, tav. XV, 671-674, 1095, 1398 fi g. 330; S. REINACH, Répertoire de peintures grecques et romaines, Paris 1922, pp. 290-296; M. LAWRENCE, The Cir-cus Relief at Foligno, in Ricerche sull’Umbria tardo-antica e preromanica. Atti del II Convegno di Studi Umbri, Gubbio 1964 (1965), pp. 119-135; R. HANOUNE, Trois pavements de la maison de la course de chars à Carthage, in Mél. Éc. Fr.Rome, 81, 1969, pp. 218-256.9 Mi limito alla bibliografi a essenziale: R. CAGNAT, De municipalibus et provincialibus militiis in imperio Roma-no, Paris 1880; M. ROSTOWZEW, Étude sur les plombs anti-ques, in Rev. Num., ser. 4, 2, 1898, pp. 271-286, 457-466;H. DEMOULIN, Les collegia juvenum dans l’empire romain.Leur nombre, leur organisation, leur situation légale, in Mus. Belge, 1, 1897, pp. 114-136, 200-217; 3, 1899, pp. 177-192; J.P. WALTZING, Étude historique sur les corpora-tions professionnelles chez les Romains, IV, Louvain 1900, pp. 216-222; J.-A. HILD, in Dict. Ant., III, 1900, pp. 782 e 785-786; C. JULLIAN, ibid., pp. 782-785; M. ROSTOWZEW,
Pinnirapus juvenum, in Mitt. Deutsch. Arch. Inst. (Roemi-sch.), 15, 1900, pp. 223-228; ID., Tesserarum urbis Romae et suburbi plumbearum sylloge, Pétersbourg 1903; ID., Rö-mische Bleitesserae (Klio, Beiheft, 3), Leipzig 1905; W. KROLL, in RE, X, 2, 1919, coll. 1355-1356; E. ZIEBARTH, ibid., coll. 1357-1358; M. DELLA CORTE, Iuventus, Arpino 1924; S.L. MOHLER, The Iuvenes and Roman Education, in Trans. Proc. Am. Philol. Ass., 68, 1937, pp. 442-479; DE RUGGIERO – LO BIANCO, in Diz. Epigr., IV, 10, 1942, pp. 317-320; P. GINESTET, Collegia iuvenum. Les associations de la jeunesse dans l’Occident Romain (Thèse pour le doctorat d’Université), Toulouse, ined.; M. JACZYNOWSKA, Collegia iuvenum. Le rôle et l’activité des associations de la jeunesse romaine au temps du Haut-Empire (in polacco con sunto francese ed Appendix epigraphica), Torun 1964; EAD., Les collegia iuvenum et leurs liaisons avec les cultes religieux au temps du Haut-Empire romain, in Zes. Nauk. Uniw. M. Kopern., Nauki Human. Spol., Seszyt, 32 (Histo-ria 4), s.d., pp. 23-44; EAD., L’organisation des iuvenes à Trebula Mutuesca, in Eos, 57, 1967/8, pp. 296-306; EAD., L’organisation intérieure des collegia iuvenum au temps du Haut-Empire romain, in Gesellschaft und Recht im grie-chisch-römischen Altertum (Deut. Ak. Wissensch. Berlin.Schrift. Sekt. Altertumswis., 52), 2, 1969, pp. 95-119 (devo alla congiunta cortesia dell’autrice, Maria Jaczynowska e dell’amico Prof. Mario Torelli, se ho potuto prendere visio-ne di questi ultimi, importanti contributi, irreperibili nelle biblioteche romane, compresa quella dell’Accademia Po-lacca); J.-P. MOREL, Pantomimus allectus inter iuvenes, in Homm. Renard, II, Bruxelles 1969, pp. 525-535.10 Secondo un computo della Jaczynowska, Organisation des iuvenes, cit. (nt. 9), pp. 296-297 si hanno 166 iscrizioni
<156>
7 - REGIONES, VICI E IUVENTUS 177
brando che la iuventus assumesse a Roma tutt’altro signifi cato ed aspetto come quella che raggruppava dal tempo di Augusto in sei turmae, ciascuna capeggiata da un sevir, tutto (ed esclusivamente) il corpo degli equites Romani sotto la presidenza onoraria del princeps iuventutis, titolo che Gaio e Lucio Cesari assunsero per | primi11. Quale che sia la maniera in cui ci si confi gura la struttura sociale della iuventus municipale (relativamente aristocratica secondo alcuni, piuttosto aperta secondo altri)12, in ogni studio si avverte un salto di valutazione ogni qualvolta nella trattazione di questa iuventus viene inserito un accenno a quella romana13. Il carattere aristocratico, nel senso ristretto del termine, di quest’ultima è dato per scontato o si appoggia su un certo numero di fonti letterarie, più o meno completamente citate, dalle quali risulta la partecipazione ad attività spettacolari di cavalieri, senatori e, addirittura, membri della famiglia imperiale14.
Resta da vedere, tuttavia, se questi esempi di alta partecipazione a spettacoli che, fatta eccezione per il lusus Troiae, con la iuventus in quanto tale (aristocratica o meno) non hanno per lo più nulla a che fare, presentati inoltre dagli autori quasi sempre con carattere di eccezionalità non esente da biasimo (talora si parla anche d’esibizioni imposte)15, siano gli elementi più idonei a restituirci l’aspetto reale di questa istituzione a Roma.
Se così fosse, viene da chiedersi d’altra parte come, in presenza di una iuventus a carattere tanto chiuso ed aristocratico, certamente non paragonabile neppure a quanto di più chiuso si potesse attuare nei municipi, potessero | soddisfare le loro esigenze sportivo-spettacolari, ritenute in passato ed anche da ultimo preminenti in questo tipo d’organizzazione16, le decine di migliaia di giovani che a Roma ne restavano forzatamente esclusi.
italiane relative alla iuventus contro 48 delle province oc-cidentali dell’Impero; le prime appartengono soprattutto al I-II sec., le seconde al II-III sec. d.C.11 Sulla composizione delle turmae equitum: J. GAGÉ, Les classes sociales dans l’Empire romain, Paris 1964, p. 106 con nt. 3; NICOLET, Ordre, I, pp. 123 e 177-188; ID., La ti-tulature des chevaliers romains à l’époque impériale. I, La Gaule Cisalpine (CIL, V), V), V in Homm. Renard, II, Bruxelles 1969, pp. 547-565.12 Per le due tesi contrapposte, vedi da ultimo GINESTET, op.cit. (nt. 9), p. 34: ‘‘Ainsi, par le rang social, le Collegium Juvenum était-il le plus aristocratique de tous ceux de la cité’’, JACZYNOWSKA, Collegia iuvenum, cit. (nt. 9), p. 86 “il est diffi cile de saisir la ligne exacte du développement, mais la participation des affranchis aux associations des iuvenes,à partir du Ierà partir du Ierà partir du I siècleer siècleer , marque en tout cas le caractère peu exclusif de ces organisations”. Lo stesso concetto è ripetuto dalla JACZYNOWSKA in L’organisation des iuvenes, cit. (nt. 9), pp. 298-299. Diversamente tenta di spiegare la presen-za, ritenuta affatto eccezionale, di due pantomimi, liberti imperiali, nei collegia iuvenum MOREL, art. cit. (nt. 9), che non conosce però i lavori né di P. Ginestet, né della Jaczy-nowska.13 Vd., per tutti, MOHLER, art. cit. (nt. 9), pp. 449-450: “In-deed the institution of the iuvenes developed along such in-dipendent lines in those towns [i. e. municipia] that we will
fi nd it diffi cult to equate them with those of the city”.14 Ne do un elenco, sostanzialmente limitato al I sec. e fondato principalmente su uno spoglio di Suetonio e Cas-sio Dione. Per antecedenti d’età cesariana: SUET. Iul., 39, 1-2 cfr. DIO CASS. 43, 23, 5-6. Per l’età postcesariana: SUET. Ner., 4 (L. Domitius Ahenobarbus, cos. a. 16 a.C.); SUET. Aug., 43, 2-3 cfr. DIO CASS. 48, 20, 2; 48, 43, 3; 51, 22, 4; 53, l, 4; 54, 26, 1; 56, 25, 7 (Augusto); SUET. Tib., 6, 4 cfr. DIO CASS. 57, 14, 3 (Tiberio); SUET., Calig., 18, 3 cfr. 54, 1-2 e DIO CASS. 59, 7, 4; 59, 8, 3; 59, 10, 1-2; 59, 11, 2 (Caligola); SUET. Claud., 21, 3 cfr. TAC. Ann., 11, 11, 2 (Claudio); SUET. Ner., 7, 1; 10, 2; 11, 1-2; 12, 20-24. 53-54 cfr. TAC. Ann., 14, 14-15; 15, 33, 1; 16, 21, 1; Hist., 3, 62 cfr. DIO CASS. 61, 9, 1; 61, 17, 3-5; 61, 19-21 e PLIN. HN, 37, 19 (Nerone); SUET. Vit.,4 (Vitellio); SUET. Tit., 8 cfr. DIO CASS. 66, 15, 2 (Tito); SUET. Dom., 8, 3 (Domiziano). Vedi anche per l’età succes-siva, GAL. 14, p. 212 (ed. Kühn).15 Impossibile riportare i singoli brani, ma si vedano, ad esempio, SUET. Aug., 43, 2-3; Ner., 11, 1-2; 12; Dom., 8, 3; DIO CASS., 48, 43, 3; 57, 14, 3; 59, 8, 3; 59, 10, 1-2; 61, 17, 3-5; 61, 19, 2-3; TAC. Ann., 14, 3-4; 14, 15, 1; 14, 20, 1; 16, 21, 1; Hist., 3, 62. Sul signifi cato politico di queste coercizioni vedi ora Z. YAVETZ, Plebs and Princeps, Oxford 1969, pp. 128-129.16 DEMOULIN, art. cit. (nt. 9), pp. 214-217; MOHLER, art. cit. (nt. 9), pp. 442 sg.; G. FORNI, Il reclutamento delle legioni
<157>
<158>
178 II – URBS ROMA
C’è infi ne il problema di sistemare un gruppo di testimonianze che, come la nostra, pur essendo inequivocabilmente connesse con l’istituzione della iuventus a Roma, non rientrano affatto nel quadro di una iuventus di tipo aristocratico e chiuso. Ad esempio, Sesto Vetuleno Lavicano, vissuto verosimil-mente verso la fi ne del II sec. d.C., non fu sicuramente personaggio di privilegiata condizione17, né lo furono, con tutta verosimiglianza, i suoi coniuvenes.
In questa prospettiva potrebbero considerarsi anche un gruppetto di tessere plumbee o bronzee, di certa o probabile origine urbana, attribuibili in genere alla prima età imperiale, su cui fi gurano dei nomi di magistri iuvenum18 altrimenti sconosciuti e che nulla hanno di aristocratico come C. Mitreius L.f.f. .f.f 19,C(aius) (et) M( M( M arcus) Pompei20, P. Petr(onius) Sabi(nus)21, Pedo (et) Paetus22.
Soprattutto vanno esaminate altre due iscrizioni romane, fi n qui non sempre rettamente intese, co-munque non adeguatamente commentate.
La prima fu pubblicata dal Marucchi nel 1926, quando fu acquistata per il Museo Lateranense “da un fabbro che la teneva da molti anni in una sua bottega presso il Gianicolo”23. Si tratta di una dedica ad Ercole Augusto (base di statua) letta così: Herculi August(o) sacrum. / C. Istimennius Felix, quinquen-nalis perpetuus, / collegio iuvenum Racillanensium / dignissimis sua pecunia d(ono) d(edit). In realtà, come appare dalla fotografi a, data in sede di edizione e ripetuta altrove24, alla riga 3 non si deve leggere
da Augusto a Diocleziano, Roma 1953, pp. 74-75; GINESTET, op. cit. (nt. 9), p. 48; JACZYNOWSKA, Les collegia, cit. (nt. 9), pp. 66-69 cfr. p. 87; EAD., L’organisation des iuve-nes, cit. (nt. 9), p. 300; MOREL, art. cit. (nt. 9), in part. p. 528.17 Per la condizione, vedi sopra nt. 5. La datazione è sug-gerita, oltre che dalla presenza di idem per item (vedi sopra, nt. 3) dalla paleografi a e dal piccolo rilievo che, pur tenendo conto della sua fattura artigianale, sembra presentare carat-teri all’incirca di età preseveriana o severiana. La correttez-za e l’eleganza del carmen è d’altra parte elemento che scon-siglia un abbassamento della datazione oltre i limiti indicati, come pure il modo in cui è abbreviata la formula iniziale Dis Man(ibus): in base ad un’indagine, già ricordata in II, 5 nt. 24, su 3010 iscrizioni funerarie latine di Roma sicuramente datate, essa non compare mai infatti dopo l’età di Antonino Pio e dei suoi liberti, vale a dire dopo il 200 circa, essendo stato calcolato intorno ai 40 anni il limite di sopravvivenza di un liberto al suo patrono (vedi, ad es., P.R.C. WEAWER, The Status Nomenclature of the Imperial Freedmen, in Class. Quart., 13, 1963, p. 272).18 Sull’organizzazione di questo tipo di collegi: JACZY-NOWSKA, L’organisation intérieure, cit. (nt. 9). Alle testimo-nianze di praetores e quaestores iuvenum ivi raccolte se ne può forse aggiungere un’altra da Velitrae: S. PANCIERA, Sulla pretura in Velitrae, in Epigraphica, 22, 1960 (1961), pp. 9-13, cfr. 24, 1962 (1963), pp. 78-79.19 ROSTOWZEW, Étude, cit. (nt. 9), p. 281 nr. 36 = Blei-tesserae, cit. (nt. 9), pp. 59-60 nr. 3, tessere bronzee. Sul recto: testa o busto di tipo augusteo e scritta L. Mitreius L.f.f. .f.fmag(ister) iuvent(utis); sul verso: rappresentazione d’edifi -
cio (anfi teatro?) con scritta sull’epistilio L. Sextilius s(ua)p(ecunia) e numero variabile (VIII, XI, XII).20 ROSTOWZEW, Sylloge, cit. (nt. 9), p. 102 nr. 835, tav. V, 71 C Suppl., I, 1905, p. 4 nr. 835a = Bleitesserae, cit. (nt. 9), p. 60 nr. 5, tav. II, 7 cfr. CIL, XV 995, 4 (dal Tevere). Sul recto: C(aius) (et) M( M( M arcus) Pompei mag(istri); sul verso: Iu/(v)enta(s) ed immagine di Marte.21 ROSTOWZEW, Étude, cit. (nt. 9), p. 280 nr. 32 = Sylloge,cit. (nt. 9), p. 101 nr. 834, tav. V, 70 cfr. Bleitesserae, cit.(nt. 9), p. 59 nr. 2. Sul recto: testa d’imperatore (Caligola?) e l’iscrizione P. Petronius Sabi(nus); sul verso: mag(ister)iuv(enum) - VIII.22 ROSTOWZEW, Étude, cit. (nt. 9), p. 281 nr. 34 = Sylloge,cit. (nt. 9), p. 102 nr. 836 = Bleitesserae, cit. (nt. 9), p. 60 nr. 4. Sul recto: busto laureato di Nerone e scritta, Neronis invicti; sul verso: Pedo (et) Paetus mag(istri). Solo le iniziali dei nomi dei magistri forse in ROSTOWZEW, Sylloge, cit. (nt. 9), p. 102 nr. 837. Per altre tessere provenienti da Roma e attribuite alla iuventus, senza però i nomi dei magistri: RO-STOWZEW, Sylloge, cit. (nt. 9), p. 101 nr. 833, tav. V, 66, p. 102 nr. 838, tav. V, 72 (Bleitesserae, cit., p. 60 nr. 6). p. 102 nr. 839, tav. V, 67, p. 102 nr. 840, p. 103 nr. 841, tav. V, 69, p. 103 nr. 842, p. 103 nr. 843, tav. VIII, 53, p. 103 nr. 844, tav. VIII, 58, p. 103 nr. 845-846. Le tessere con i nomi dei magistri e quelle con fi gurazioni di divinità sono ricordate anche da JACZYNOWSKA, L’organisation intérieure, cit. (nt. 9), p. 98 e Les collegia, cit. (nt. 9), pp. 34-36.23 Rend. Pont. Ac. Arch., 4, 1925-26, p. 394 fi g. 5 = AE 1927, 145.24 Appendice alla Guida del Museo Lateranense profano e cristiano, Roma 1927, p. 6 nr. 245.B.
<159>
7 - REGIONES, VICI E IUVENTUS 179
Racillanensium, bensì Racilianensium. Questa piccola correzione è della massima importanza perché permette di vedere chiaramente quale sia l’origine, altrimenti oscura25, del nome di questo collegium iuvenum. Nella regio XIV,regio XIV,regio XIV la Transtiberina, quella cioè da cui proviene l’iscrizione, noi conosciamo, tramite la base Capitolina26, l’esistenza di due vici, uno denominato Raciliani minor(is), l’altro Raciliani maioris. Il collegium iuvenum Racilianensium altro non è, dunque, che un’organizzazione giovanile, con propri dirigenti, facente capo ad uno di questi vici o ad entrambi27.
La seconda iscrizione, già compresa in CIL, VI (26 = WALTZING, op. cit. (nt. 9), III, 613 cfr. ILS 7303), è incisa su una tabella marmorea vista dal De Rossi, dal Brunn e dal Dressel, nel chiostro di S. Lorenzo al Verano, | ove però più non si trova. Essa dice: Fabius Demetrius et Caecilius / Philon aedem cum sigillo / Apollinis iuvenibus Oecianis d(ono) d(ederunt) d(e)d(icaverunt)28. Il De Rossi, come pare, e lo Henzen, che conobbe l’epigrafe da un apografo del Brunn, lessero alla riga 3 Oecia-ni. Il Dressel, che rivide il testo per conto del Dessau, lesse Oecianis. Che così si dovesse intendere avevano capito del resto anche lo Henzen e, soprattutto, il Mommsen che aggiunse, all’edizione del testo nel CIL, la seguente nota: “Quotquot praeterea iuvenum collegia innotuerunt, quae cognomina habeant eaque quae aliquatenus intellegantur denominantur a locis; cf. cf. cf inter alios titulus vol. III n.4779 genio iuventutis Manliensium dedicatus a gentilibus nescio quibus qui consistunt in Manlia.Quare sive retinemus Oeciani formam sive substituimus Oecianis, simile quid subesse hic quoque suspicor”. L’osservazione del Mommsen appare tanto più acuta e feconda ora che conosciamo l’iscri-zione del collegium iuvenum Racilianensium. Essa ci mostra infatti che, allo stesso modo in cui fuori Roma i collegia iuvenum prendevano abitualmente nome dalla città d’appartenenza, a Roma potevano desumerlo dal vicus in cui si trovavano a reclutare i loro aderenti. In altre parole c’invita, anche se non conosciamo altrimenti un vicus Oeci, a considerare iuvenes Oeciani un equivalente di iuvenes Racilianenses, membri anch’essi cioè di un collegium iuvenum facente capo ad un vicus. Che questo potesse denominarsi Oeci non appare d’altronde impossibile, posto che esiste un cognomen Oecius29 e non mancano vici che traggono la loro denominazione da un cognomen piuttosto che da un gentilizio o da altra fonte30.
25 Di fatto, non seppero darne un’interpretazione né l’edito-re né gli studiosi successivi che ebbero ad occuparsene (vedi, tra l’altro, DE RUGGIERO – LO BIANCO, in Diz. Epigr., IV, 10, 1942, p. 317; JACZYNOWSKA, Collegia iuvenum, cit. (nt. 9), p. 184 nr. 153). Solo lo Ashby, pur senza correggere l’errore di lettura, intravide la retta spiegazione (Topographical Dictio-nary of Ancient Rome, Oxford 1929, p. 577).26 CIL, VI 975 cfr. 31218, p. 3777 = ILS 6073 cfr. VALEN-TINI – ZUCCHETTI, Codice topografi co della città di Roma, I, Roma 1940, p. 46: fi anco destro, col. II, righe 41 sgg.27 Per la dedica ad Ercole Augusto e per le impronte della statua che la base sorreggeva (verosimilmente Ercole con la mano destra appoggiata alla clava), l’iscrizione potrebbe appartenere, come proposto dal Marucchi, all’età di Com-modo che amava, come ben si sa, farsi rappresentare sotto le sembianze di Ercole. I caratteri paleografi ci non contrastano con tale datazione. Sulla particolare connessione dei collegi giovanili con il culto di Ercole: JACZYNOWSKA, Les collegia, cit. (nt. 9), pp. 28-32.
28 Tecnicamente possibile, ma, per me, meno probabile la lettura d(onum) d(ederunt) d(ecreto) d(ecurionum) proposta dubitativamente dalla JACZYNOWSKA nella sua Appendix epi-graphica, p. 158 nr. 1, ove si ha però anche la retta lettura Oecianis e si svolge (p. 91), per quanto riguarda l’interpre-tazione, il suggerimento del Mommsen di cui subito dirò. Questa iscrizione e la tessera urbana ROSTOWZEW, Sylloge,cit. (nt. 9), p. 103 nr. 843, tav. VIII, 53 sono le sole testi-monianze di culto di Apollo da parte della iuventus: JACZY-NOWSKA, Les collegia, cit. (nt. 9), p. 36.29 CIL, X 106 = ILS 4039: Herae Laciniae sacrum / pro salute Mar/cianae sororis / Aug(usti), Oecius lib(ertus)proc(urator). Il nome deriva evidentemente dal greco oij-keivo" (domesticus).30 Tre sono ricordati nella base Capitolina, citati sopra: il vicus Fortunati, nella regio XIII, il vicus Pauli ed il vicus Victoris nella XIV. A questa stessa regione forse appartenne XIV. A questa stessa regione forse appartenne XIVanche un vicus Epicteti cfr. Epictetinses in CIL, VI 31893 = ILS 6072 = ILS 6072 = ILS LUGLI, Fontes, III, p. 189 nr. 408.
<160>
180 II – URBS ROMA
Dubbio mi sembra il riferimento alla iuventus romana di un’altra iscrizione inserita dalla Jaczy-nowska nella sua Appendix epigraphica31.
In sostanza abbiamo un gruppetto di testimonianze dalle quali sembra emergere che, se vi fu a Roma una iuventus aristocratica limitante le sue esibizioni probabilmente ad alcune cerimonie tradizionali32
o ad altre occasioni eccezionali (non interessano a questo riguardo le partecipazioni a titolo personale), vi furono anche dei collegi giovanili molto meno esclusivi, se non addirittura a carattere popolare. Per due di questi, vi è fondato motivo di ritenere che fossero strettamente collegati a vici da cui prendevano la denominazione. Nel caso della nuova iscrizione, se non si parla di vici, v’è un accenno alle regiones: l’ambiente sociale cui appartennero Sesto Vetuleno Lavicano ed i suoi coniuvenes non sembra sostan-zialmente diverso da quello cui appartennero iuvenes Racilianenses e iuvenes Oeciani33.
Nel contesto di questa iuventus popolare proporrei dunque di collocare l’attività di auriga del nostro personaggio. Anche nei municipi, l’attività sportiva, nelle sue varie forme, ivi compresa quella circense, costituiva uno degli aspetti preminenti della vita dei collegia iuvenum34. Essa trovava il suo sfogo prin-cipale in apposite feste denominate Iuvenalia35. Ludi dello stesso nome, ma spesso diversi nello spirito, a quanto pare, si ebbero anche a Roma per iniziativa di qualche imperatore36. Io vorrei supporre tuttavia che, oltre a queste saltuarie occasioni elargite dall’alto, altre ne fossero ricercate dalla gioventù popolare riunita, com’è certo almeno per qualche caso visto sopra, in collegi di quartiere.
La stessa vastità del complesso urbano ed il numero della popolazione poterono consigliare, a Roma, un frazionamento dell’attività giovanile che, nei piccoli centri, era unitaria. Regiones e vici, entità ben defi nite, con una propria struttura organizzativa, poterono fungere da elementi catalizzatori. Non solo, ma l’organizzazione vicana, con le sue festività d’antica origine, come i ludi Compitalici, sospesi solo per breve tempo tra il 64 e il 58 a.C., ma tollerati da Cesare e ridati a nuova vita da Augusto37,
31 P. 158 nr. 2. È iscrizione dell’anno 179 pubblicata da G. MARCHETTI LONGHI (su interpretazione di A. DEGRASSI), in Bull. Comm. Arch. Roma, 71, 1943-45, p. 79 nr. XIII fi g. 16 = AE 1948, 97 cfr. A. DEGRASSI, in Doxa, 2, 1949, p. 66 = Scritti vari, I, Roma 1962, p. 335: ···ÎÎòÎòÎ õê÷æ÷æ÷ ùô÷ê÷ê÷ Èôòòôéô) / Æúì(ì(ì usto)‚ II, P. Martio / Vero II co(n)s(ulibus), / V kal(endas) Martias, / T.T.T Fl(avius) Vitalio / q(uin)q(uennalis)electus / Genium trib(us) / Pal(atinae) corp(oris) iun(iorum)Iuven(alis) hon(oratorum) / ex arg(enti) libr(is) / [tri]bu[s]d(ono) d(edit). Qui Iuven(alis) mi sembrerebbe soltanto un appellativo del corpus iuniorum honoratorum della tribù.32 Come, oltre al lusus Troiae, che non aveva una ricorrenza fi ssa e si poteva tenere nelle più diverse occasioni (ROSTOW-ZEW, Bleitesserae, cit. (nt. 9), pp. 63-71: J. TOUTAIN, in Dict.Ant. Gr. Rom., V, 1, 1918, pp. 493-496; DELLA CORTE, op. cit.(nt. 9), passim; K. SCHNEIDER, in RE, XIII, I927, coll. 2059-2067), la transvectio equitum del 15 luglio, anch’essa ridata a nuova vita da Augusto (T. MOMMSEN, Römisches Staatsre-cht, III, 1, Leipzig 1887, pp. 493 sgg.; ST. WEINSTOCK, Rö-mische Reiterparade, in Stud. Mat. Stor. Rel., 13, 1937, pp. 10-24; ID., in RE, IV A, 2, 1937, coll. 2178 sgg.; Inscr. It.,XIII, 2, 1963, p. 483).33 Vedi sopra, nt. 5. Anche nomi come C. Istimennius Felix,Fabius Demetrius e Caecilius Philon, tutti senza indicazione
di patronimico e due con cognomi greci e senza prenome, rinviano ad ambiente libertino o comunque modesto.34 Vedi sopra, nt. 16.35 Documentazione epigrafi ca si ha per Tusculum (CIL,XIV 2592, 2640 = ILS 6213), Ostia (CIL, XIV 409 = ILS 6146), Pompei (CIL, IV 8521), Anagnia (CIL, X 5928 = ILS 6264), Velitrae (CIL, X 6555 = ILS 3697), Ameria (CIL, XI 4371 = ILS 6631; 4386; 4395 = ILS 6632), Carsulae (CIL,XI 4580 = ILS 6634), Amiternum (Not. Sc., 1936, p. 97 = AE 1937, 111). Vedi anche ROSTOWZEW, Sylloge, cit. (nt. 9),pp. 103-109 e DIO CASS. 66, 15. Importante anche il passo della SHA, Gord. tres, 4: Cordus dicit in omnibus civitatibus Campaniae Etruriae Umbriae Flaminiae Piceni de proprio illum per quadriduum ludos scaenicos et Iuvenalia dedit.36 SUET. Calig., 17, 2: et ut laetitiam publicam in perpetuum quoque augeret, adiecit diem Saturnalibus appellavitque Iuvenalem; TAC. Ann., 14, 15, 1: Nec tamen adhuc publico theatro dehonestaretur instituit ludos Iuvenalium vocabulo cfr. 15, 33, 1 e 16, 21, 1, SUET. Ner., 2, 1; DIO CASS. 61, 19-21; DIO CASS. 67, 14 cfr. 68, 34; SID. APOLL. Carm., 23, 307 sg. e 428.37 SUET. Aug., 31, 4: nonnulla etiam ex antiquis caerimonis paulatim abolita restituit ut… ludos Saeculares et Compi-talicios… Compitales Lares ornari bis anno instituit vernis
<161>
<162>
7 - REGIONES, VICI E IUVENTUS 181
poteva fornire alcune delle occasioni d’esibizione ricercate dalla iuventus dei singoli quartieri. Sembra che anche qualche imperatore si sia reso conto di questa necessità di frazionamento poiché risulta aver organizzato spettacoli nelle singole regioni, forse con la partecipazione della iuventus locale38. Altre gare poterono essere organizzate dagli stessi collegi, al loro interno od opponendo i propri atleti a quelli di altri vici o regiones39.
Se queste ipotesi colgono nel vero, Sesto Vetuleno Lavicano poté gareggiare come auriga per un collegio avente la sua sede nella sesta o settima regione cittadina. Il vessillo, che solleva con la sinistra, può essere appunto quello | collegiale40 piuttosto che segno di vittoria. Non meravigli la sua età (44 anni) poiché, senza contare i maggiorenti, non mancano altri casi di persone adulte, o anche anziane, apparte-nenti a collegia iuvenum: si tratta evidentemente, anche se non sempre è indicato, di istruttori o sosteni-tori41. Anche l’attività funeratizia rientra tra quelle note, anzi importanti, per questo tipo di collegi42.
fl oribus et aestivis, cfr. SERV. Ad Aen., 8, 717. Per le vicen-de anteriori di questi ludi si vedano i passi di controversa interpretazione di ASC. Ad Pis., 6 e DION. HAL., 4, 14 con le discussioni di S. ACCAME, La legislazione romana intorno ai collegi nel I secolo a.C. in Bull. Comm. Arch. Roma, 70, 1942. Appendice (Boll. Mus. Imp. Rom., 13), pp. 13-48 ed, ora, di A.W. LINTOTT, Violence in Republican Rome, Oxford 1968, pp. 77-83 (ivi bibliografa precedente). A p. 80 il Lin-tott mette giustamente in evidenza la scarsa attendibilità di Dionisio quando afferma che il culto anche ai tempi suoi era riservato ai soli schiavi. In generale su questi ludi, ancora ricordati nei Fasti Filocaliani e di Polemio Silvio: E. SAGLIO, in Dict. Ant. Gr. Rom., V, 2. 1887, pp. 1428-1429; WISSOWA, in RE, IV, 1, 1900, coll. 791 sg.; M.P. NILSSON, Studien zur Vorgeschichte des Weihnachtsfestes, in Arch. Rel. Wiss., 19, 1916-19, pp. 54 sg. (Opuscula selecta, I, 1951, pp. 219 sg.). Sul carattere di conceptivae di queste feriae, testi e discus-sione presso Inscr. It., XIII, 2, 1963, pp. 390-391.38 Un’iniziativa del genere ebbe già Cesare (SUET. Iul., 39, 1: Munus gladiatorium, ludos etiam regionatim urbe tota et quidem per omnium linguarum histriones, athletas, nauma-chiam) e così anche L. Domitius Ahenobarbus, cos. a. 16 a.C., durante la sua pretura (SUET. Ner., 4: venationes et in circo et in omnibus urbis regionibus dedit) ed Augusto (SUET. Aug., 43, 1: Spectaculorum et assiduitate et varietate et magnifi centia omnes antecessit… fecitque nonnumquam etiam vicatim, cfr. 45, 2: spectavit autem studiosissime pu-giles et maxime Latinos, non legitimos atque ordinarios modo… sed etiam catervarios oppidanos inter angustias vi-corum pugnantis temere ac sine arte). Vedi anche TAC. Hist.,2, 95, 1: Quin et natalem Vitellii diem Caecina et Valens
editis tota urbe vicatim gladiatoribus celebravere, ingenti paratu et ante illum diem insolito.39 Anche in questo contesto potrebbero risultare importanti i frammenti epigrafi ci dal Foro di Cesare che, secondo alcu-ni, documenterebbero l’obbligo per i vici magistri di offrire una venatio al momento del loro ingresso in carica, ma sul-le incertezze esistenti circa la loro interpretazione si veda quanto ho detto II, 6 nt. 58.40 L’uso dei vari collegi di avere un proprio vessillo con cui partecipavano ad ogni tipo di cerimonie pubbliche è testi-moniato dalla presenza, nel loro ambito, di vexillarii (WALT-ZING, op. cit. [nt. 9], I, p. 425), da fonti letterarie (raccolte da WALTZING, ibid., II, pp. 186-187) e da raffi gurazioni di vario genere tra cui mi limito a ricordare il noto rilievo di Virunum (II sec. d.C.) con parata di iuventus, a cavallo, vessillo in testa (R. EGGER, Eine Darstellung des Lusus Iuvenalis, in Jahresh. Oesterr. Arch. Inst., 18, 1915, pp. 115-119, tav. 65) e l’affresco ostiense con processione di bambini (D. NOGA-RA, Le Nozze Aldobrandine, i paesaggi con scene dell’Odis-sea e le altre pitture antiche conservate nella BibliotecaVaticana e nei Musei Pontifi ci, Milano 1907, tav. XLIX. In generale: M. ROSTOVTZEFF, Vexillum and Victoria, in Journ.Rom. Stud., 32, 1942, pp. 92-106; G. FORNI, in Enc. Art. Ant.,IV, 1961, pp. 163-166.41 Vedi ad es., CIL, III 1828 = ILS 7303a (Narona7303a (Narona7303a ( ); CIL, XII 122 = ILS 7307 (Vintium); Not. Sc., 1900, p. 141 = ILS 6635 (Spoletium); Not. Sc., 1911, p. 266 = ILS 9421 (Aricia9421 (Aricia9421 ( ).42 Come risulta dalla documentazione epigrafi ca, essa può riguardare tanto membri del collegio quanto estranei. Questo aspetto dei sodalizi giovanili è stato ben illustrato di recente da JACZYNOWSKA, Les collegia, cit. (nt. 9), pp. 24 e 26-27.
<163>
NOTA COMPLEMENTARE – AE 1971, 44. – Vd. anche E. COURTNEY, Musa lapidaria, Atlanta 1995, pp. 114 sg. nr. 114 (con erronea interpretazione del cognomen come indicazione di provenienza). – Su qui nostri memores quique fuere sui: G. SANDERS, in Cultura epigrafi ca dell’Appennino, Faenza 1985, pp. 22 sg. (ID., Lapides memores, Faenza 1991, p. 434). – Sul delicius Matris
182 II – URBS ROMA
Matutae ((sextae)) regionis vd. ora CHR. BRUUN, in Zeitschr. Pap. Ep., 112, 1996, pp. 219-223. – Sulla funzione di praeconese nuntii negli spettacoli teatrali e atletici: D. GILULA, in Athenaeum, 81, 1993, pp. 283-287; N.B. CROWTHER, in Nikephoros, 7, 1994, pp. 135-155. – Aurighi, loro status e raccolta generale (nella quale però il nostro manca): G. HORSMANN, Die Wagen-lenker der römischen Kaiserzeit, Stuttgart 1998; loro rappresentazione: R. THOMAS, in Köln. Jahrb., 34, 2001, pp. 489-522. – Sull’organizzazione della iuventus, aderendo per quanto riguarda Roma all’interpretazione qui proposta: M. JACZYNOWSKA, Les associations de la jeunesse romaine sous le Haut-Empire, Wrokław 1978, in part. pp. 66 sg.; J. LINDERSKY, in Ktèma, 17, 1992, p. 74; H. GALSTERER, in Athenaeum, 59, 1981, pp. 426-428. Più perplesso: P. GINESTET, Les organisations de la jeunesse dans l’Occident Romain, Bruxelles 1991, in part. p. 215. Non prende posizione: D. LAGAGE, in Chiron, 9, 1979, p. 346 nt. 215. – Tra i più recenti contributi sull’origine, le caratteristiche e la funzione dei collegia iuvenum: S. PEREA YEBENES, in Gerión, 10, 1992, pp. 295-305 (a proposito del libro di Ginestet e delle attestazioni spagnole); A. FRASCHETTI, in Storia dei giovani, 1. Dal-l’antichità all’età moderna, Roma - Bari 1994, pp. 89-94 (anteriorità dell’organizzazione giovanile in alcuni municipi rispetto a quella romana; introduzione dei giovani alla politica e loro controllo); M. KLEIJWEGT, in Epigraphica, 56, 1994, pp. 29-40; A. BANCALARI MOLINA, in Semanas de estudios romanos (Valparaiso), 7-8, 1996, pp. 197-217 (formazione dei quadri dirigenti); M.D. SAAVEDRA - GUERRERO, in At. Roma, 41, 1996, pp. 24-31 (non solo iuvenes ma anche iuvenae); A. BANCALARI MOLINA, in Flor. Ilib., 9, 1998, pp. 41-68, in part. 47-57 (fi nalità essenzialmente educativa per “la preparación de futuros hombres de estado, políticos y administratores para dirigir las ciudades imperiales”). − Sul signifi cato del vexillum: GINESTET, op. cit., pp.
1 - Iscrizione inedita con menzione di coniuvenes.
Nelle ricerche che ormai da anni vado conducendo con l’ausilio di un gruppetto di valenti colla-boratori nei musei e nelle località di scavo, nei magazzini archeologici e presso le chiese, gli antiquari, le collezioni private di Roma, per la preparazione di un nuovo supplemento al volume VI del Corpus Inscriptionum Latinarum1, sono ormai innumerevoli le iscrizioni inedite di rilevante interesse di cui sono venuto a conoscenza. Di alcune ho già dato notizia in varie occasioni2. Di altre sto preparando la pubblicazione e con me alcuni collaboratori all’impresa come le dottoresse Fiorella Martorelli e Patrizia Sabbatini Tumolesi ed i dottori Giulio Molisani, Ivan Di Stefano e Stefano Priuli3. Le sole iscrizioni inedite di militari (pretoriani, urbaniciani, vigiles, equites singulares ecc.) secondo un calcolo che ho fatto di recente sono oltre 150 e tra queste ve ne sono alcune, soprattutto di pretoriani ed urbaniciani, dal cui studio, appena agli inizi, è lecito attendersi fi n d’ora risultati piuttosto rilevanti. Molte sono anche le iscrizioni sacre, imperiali e, via via, di tutte le altre classi in cui il Corpus è abitualmente suddiviso. Alle inedite, che in totale si aggireranno intorno alle 5000, vanno poi aggiunte naturalmente le migliaia d’iscrizioni pubblicate dopo il 1915, cioè dopo il limite dell’ultimo fascicolo del CIL, | non poche delle quali risultano pur esse bisognose di emendamenti di lettura e di approfondimento nel commento.
In tanta abbondanza di materiale, ho pensato intanto di riservare a questa sede un gruppetto d’iscri-zioni riguardanti più o meno direttamente la topografi a romana, per alcune delle quali mi limiterò ad una sommaria presentazione, mentre in qualche altro caso, in considerazione dell’importanza e dei problemi connessi, dovrò soffermarmi un po’ più a lungo.
Comincio con un frammento di base marmorea che ho trovato nel giardino dell’Antiquario Comu-nale del Celio. È alto 60 cm, largo 43 e spesso 33. Sulla fronte, scorniciata, si legge (fi g. 1):
Numini domusAugustorum sacr(um)Bono Event«ui»
* Nuovi documenti epigrafi ci per la topografi a di Roma antica, I, in Rend. Pont. Ac. Arch., 43, 1970-71, pp. 109-117.1 L’impresa, promossa nel 1960 dalla Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Zentralinstitut für Alte Ge-schichte und Archäologie, dal 1968 ha ricevuto nuovo im-pulso grazie ad un fi nanziamento del C.N.R, col quale è stata raccolta anche la documentazione necessaria per la presente comunicazione.2 Due novità epigrafi che romane: 1) Cerimonie per il dies natalis di Augusto in un nuovo frammento degli Atti degli Arvali; 2) Una defi xio latina dal Palatino, in Rend. Ac.
Linc., ser. 8, 23, 1968, pp. 315-340. - Miscellanea epigrafi ca IV: 1) Iscrizioni onorarie dalla basilica Emilia; 2) Tiberius Iulius Zoili fi lius Fabia Pappus, in Epigraphica, 31, 1969, pp. 104-120. - Tra epigrafi a e topografi a. 1) Negotiantes de Sacra Via; 2) Una nuova edicola compitale e la cura regio-num urbis; 3) Regiones, vici e iuventus, in Arch. Class., 22, 1970, pp. 131-163.3 Il volume 26, 1-2, 1971 dei Rendiconti dei Lincei conter-rà intanto un contributo di F. Martorelli su alcuni carmina epigraphica romani ed una nota di G. Molisani relativa al-l’importante epigrafe sepolcrale inedita di un architetto che lavorò per Q. Lutazio Catulo, console nel 78 a.C.
II,8 - CELLA LUCCEIANA*
<109>
<110>
184 II – URBS ROMA
Tutelae cellae5 Lucceianae
M. M. M Iunius Agathopu(s)cum Agathopo fi l(io)aedem et signumBoni Event`u´i impens(a)
10 sua omni a solofacie[---][------ ?]
Sulla fi ne del testo resta qualche incertezza, peraltro non sostanziale, a causa della frattura che ci ha privato della parte inferiore del marmo. Considerato che in tutta l’iscrizione si tende ad evitare le abbreviazioni, e calcolato lo spazio disponibile per una buona impaginazione, riterrei che anche la formula conclusiva fosse scritta per esteso su due righe e suonasse, tenuto conto della parte conservata, facie[nda] o facie[ndum] in una riga e [curavit] nella successiva. La prima forma è ovviamente la sola corretta, ma faciendum risulta più corrispondente alle esigenze dell’impaginazione e non stupirebbe troppo in un’epigrafe che rivela non poche incertezze linguistiche nel suo redattore e ripensamenti in-teressanti.
Così alla fi ne della terza riga è chiaro dalla visione diretta che in origine era stato scritto Eventopoi corretto in Eventui. Alla quarta riga Tutele con desinenza monottongata, è stato corretto successiva-mente con l’inserimento di una A. Il ripensamento più interessante, e anche divertente si ha però nella terz’ultima riga ove l’originario genitivo errato Boni Eventi risulta diligentemente corretto mediante | l’inserimento di una piccola V in Boni Eventui che è sproposito peggiore del precedente.
Da questo punto di vista, l’iscrizione è una bella conferma della generale tendenza del latino co-mune a trasformare sostantivi della quarta declinazione in sostantivi della seconda, fi no alla scomparsa stessa della quarta declinazione.
Non ho scelto però questa iscrizione per motivi linguistici, bensì per il ricordo, ch’essa ci conserva, di una cella, cioè di un complesso di costruzioni adibite a deposito commerciale, in particolare di derra-te. Come tali, le cellae mi sembrano particolarmente interessanti in | quanto capaci di defi nire da sole il carattere del quartiere in cui venivano a trovarsi.
Importa, naturalmente, la datazione e la provenienza del documento.La prima risulta abbastanza complessa anche se siamo parzialmente aiutati dalla presenza, sul lato
sinistro, della data della dedicatio. Essa è disposta su due righe e si legge con un po’ di fatica per la consunzione del marmo e le incrostazioni, come segue (fi g. 2):
Ded(icata) VI k(alendas) Mai(as)Libone et Iuniore
Può essere incerto se alla fi ne della prima riga si leggesse Mai, o Maia, o Maias (ma la prima forma mi sembra più probabile) e se alla fi ne della seconda riga, dopo Iuniore, in caratteri minuti, data la ristret-tezza dello spazio, vi fosse o no l’abbreviazione cos., per consulibus, che non era del resto necessaria4. Queste incertezze non toccano comunque la sostanza: giorno, mese e nomi dei consoli appaiono certi.
4 D. VAGLIERI, in Diz. Epigr., II, 1, 1900, p. 705. 5 VAGLIERI, art. cit. (nt. 4), pp. 702 sg.
<111>
<112>
8 - CELLA LUCCEIANA 185
La coppia consolare risulta tuttavia nuova. Non è certamente di consoli ordinari il che induce su-bito, come suggerito anche dalla paleografi a, a non cercare oltre gli inizi del III sec. essendo noto che l’eponimia dei suffetti diffi cilmente si trova ancora dopo quegli anni5.
I cognomi non sono dei più comuni. Il cognomen Libo è portato da consoli ordinari dell’anno 16 (L.Scribonius Libo), dell’anno 128 (M.M.M Annius Libo) e del 204 (M.M.M Annius Flavius Libo). Vi sono inoltre un L. Scribonius Libo Frugi che dovrebbe essere stato console suffetto prima del 99 o del 1006 ed un M.M.MAnnius Libo, rispettivamente, come pare, fi glio e nonno dei consoli prima ricordati del 128 e del 2047,che, risultando probabile governatore della Siria nel 1638, dovrebbe aver ricoperto | prima un consolato suffetto. Come si vede, consolari, sicuri o probabili, con cognomen Libo, si hanno soltanto nelle gentes Scribonia ed Annia.
Ancor più raro tra i consolari, sicuri o probabili, il cognomen Iunior, che risulta portato soltanto da Cn. L. Terentius Homullus Iunior, console suffetto nel 146. Questo cognomen non doveva avere valore comparativo, ma era ereditario se, come sembra, anche suo nonno, un cavaliere amico di Plinio il Giovane, si chiamava C. Terentius Iunior9. In tal caso è più che verosimile che il cognomen sia pas-sato anche a qualche discendente, fi n qui non conosciuto, giunto al consolato dopo Terentius Homullus Iunior. Questo discendente potrebbe essere, a mio avviso, un fi glio di quest’ultimo personaggio per le ragioni che dirò.
Il giorno in cui avvenne la dedicatio è il 26 di aprile. Ora, proprio in questo giorno, come sappiamo da varie fonti10, cade il dies natalis di Marco Aurelio, che veniva festeggiato a Roma e fuori Roma con spettacoli circensi e con sacrifi ci. Se si osserva poi che la dedica è fatta in primo luogo Numini Domus Augustorum non si avrà diffi coltà a vedere in ciò una conferma che l’iscrizione dovette essere posta durante il regno di Marco Aurelio in cui, per la prima volta, si attuò il principio della correggenza, prima di Marco Aurelio con Lucio Vero e poi con Commodo11.
6 A. DEGRASSI, I Fasti Consolari dell’Impero Romano,Roma 1952, p. 29 (prima del 99), cfr. R. SYME presso E. MARY SMALLWOOD, Documents illustrating the Principates of Nerva, Trajan, and Hadrian. Cambridge 1966, p. 11 (pri-ma del 100).7 PIR2, A 668 (E. GROAG); P. LAMBRECHTS, La composition du sénat romain de l’accession au trône d’Hadrien à la mort de Commode (117-192), Antwerpen 1936, p. 72. nr. 335.8 SHA, Verus, 9, 2: verum illud praecipuum quod, cum Libo-nem quendam patruelem suum Marcus legatum in Syria<m> misisset, atque ille se insolentius quam verecundus senator efferret dicens ad fratres suos [fratrem suum se [fratrem suum se [ Pet.] scrip-turum esse, si qui<d> forte dubitaret, nec Verus praesens pati posset, subitoque morbo notis prope veneni exsistentibus interisset visum est nonnullis, non tamen Marco, quod eius fraude putaretur occisus. Nel 162 o all’inizio del 163 pone il governatorato G.A. HARRER, Studies in the History of the Roman Province of Syria, Princeton 1915, p. 31; circa nel-l’anno 163, il LAMBRECHTS ed il GROAG, loc. cit. (nt. 7); nel 163, E. HONIGMANN, in RE, IV A, 1932, col. 1630, dopo C. Iulius Commodus Orfi tianus (cfr. PIR2, I 271) e prima di Cn.Iulius Verus (cfr. PIR2, I 618), nel 163-164 H.-G. PFLAUM, Les sodales Antoniniani de l’époque de Marc Aurèle, in Mém. Ac.
Inscr., 15, 2 1967, p. 222. Sull’attendibilità della vita Veri e di questo episodio in particolare T.D. BARNES, Hadrian and Lucius Verus, in Journ. Rom. Stud., 57, 1967, pp. 65-79, in part. p. 73; R. SYME, Emperors and Biography. Studies in the Historia Augusta, Oxford 1971, p. 32.9 LAMBRECHTS, op. cit. (nt. 7), p. 94 nr. 493. In generale sulla famiglia e la sua condizione: A. STEIN, Der römische Ritter-stand, München 1927, p. 201; A. STEIN in RE, V A, 1934, col. 663 nr. 53 cfr. nr. 50 (E. GROAG).10 Raccolte da A. DEGRASSI, Inscr. It., XIII, 2, 1963, p. 449.11 Non mi sembra dubbio che in questo caso si voglia espri-mere con Numini Domus Augustorum un atto di omaggio al numen della domus di due imperatori contemporaneamente sul trono e non genericamente al numen della domus impe-riale, includendo nell’omaggio anche imperatori precedenti al regnante per cui vd. E. MEYER, Zur Geschichte des Wallis in römischer Zeit, in Bas. Zeitschr. Gesch. Altert. (Stähelin Festschrift), 42, 1943, pp. 59-78: ID., Augusti, in Mus. Helv.,16, 1959, pp. 273 sg.; ID., Augusti, ein Nachtrag, ibid., 17, 1960, p. 118; ID., Nochmals Augusti, in Klio, 52, 1970, pp. 283-285. Contra: G. BARBIERI, Nuove iscrizioni campane,in Akte 4. Int. Kongr. Griech. Lat. Epigr., Wien 1964, p.
<113>
<114>
186 II – URBS ROMA
Credo vi siano poi altri indizi che consentono di delimitare ulteriormente la datazione. Già si è visto come, tra i Liboni consolari, ve ne sia uno, M.M.M Annius Libo che, essendo governatore della Siria proba-bilmente nel 163, dovrebbe aver rivestito un consolato suffetto poco prima. Egli potrebbe ben essere, dunque, il primo componente della nuova coppia consolare. L’altro potrebbe essere invece un fi glio del Terentius Homullus Iunior, console nel 146. In tal modo la nuova coppia di consoli suffetti, in carica al 26 aprile (e quindi probabilmente nominata a partire dal primo marzo) dovrebbe essere inserita nei fasti consolari tra il 161 (salita al trono di Marco Aurelio e Lucio Vero) e 163 (governatorato della Siria di M.M.MAnnius Libo). Tra 161 e 162 avrei poi una leggera preferenza per la seconda data12.
Ma il problema della datazione ci ha portato un po’ lontano dalla | topografi a. Veniamo quindi alla provenienza del pezzo, importante perché è chiaro che la cella si trovava nel luogo in cui aedes e signum Boni Eventus furono eretti13.
Come ho potuto apprendere grazie ad una segnalazione del prof. Colini ed alla cortesia del prof. Giulio Cressedi, nel registro dei trovamenti della X Ripartizione del Comune, volume XI, p. 170, l’iscri-zione che ci interessa è riportata in data 19 maggio 1939 con l’indicazione di trovamento “piazza Bocca della Verità, presso la casa dei Pierleoni”.
Per la casa dei Pierleoni bisogna intendere qui, come mi ha spiegato quell’ottimo conoscitore della topografi a romana che è Carlo Buzzetti, la cosiddetta Casa dei Pierleoni che, esistente un tempo tra via del Ricovero e via di Porta Leone14, fu demolita con tutto il quartiere adiacente per la costruzione del
47 nt. 29; F. ZEVI, Nuovi documenti epigrafi ci sugli Egrili ostiensi, in Mél. Éc. Fr. Rome, 82, 1970, p. 317. Sulla que-stione vd. anche H. CHANTRAINE, Freigelassene und Sklaven im Dienst der römischen Kaiser, Wiesbaden 1967, pp. 225-263. Sul numen Augusti: D.M. PIPPIDI, Le “numen Augusti”,in Rev. Étud. Lat., 9, 1931, pp. 83-112, in part. pp. 102-103; R. ÉTIENNE, Le culte impérial dans la péninsule ibérique d’Auguste à Dioclétien, Paris 1958, pp. 309-317.12 Certamente negli anni 161 e 162 i suffetti non mancaro-no, anche se non possiamo precisare i mesi in cui rivestiro-no la carica (vd. A. DEGRASSI, I Fasti Consolari dell’Impero Romano, Roma 1952, pp. 45 sg.). Non basta ad escludere il 161 il fatto che un’iscrizione sacra urbana del 13 aprile di quell’anno (CIL, VI 596) sia datata con il consolato di Marco Aurelio e Lucio Vero poiché può trattarsi di un caso, frequente in quest’epoca di eponimia degli ordinari anche dopo l’uscita di carica (cfr. sempre a Roma, CIL, VI 1119: 15 dicembre). Noto tuttavia che, per la sua stretta parentela (patruelis(patruelis( ) (vd. SHA Verus, 9, 2, cit. (nt. 8) con Marco Au-relio, M.M.M Annius Libo poté ben essere tra i consoli designati nel primo anno di regno di questo imperatore e quindi in carica nel 162. Sempre la parentela con l’imperatore, ed un suo particolare favore, potrebbe spiegare poi l’incarico, immediatamente successivo, del governo della Siria. Una ragione di più per riferire la dedica al 162 si avrebbe infi ne se anche la dedica al Bonus Eventus potesse essere in qual-che modo riferita alla casa imperiale oltre che alla cella Lucceiana. È nel 162 infatti che Lucio Vero, non prima del
28 marzo, non si sa precisamente quanto dopo, parte da Roma, accompagnato da Marco Aurelio fi no a Capua, per la guerra contro i Parti, cadendo poco dopo malato a Canu-sio. Dediche al Bonus Eventus in età imperiale non di rado si trovano associate a spedizioni d’imperatori o ad imprese di carattere militare e per l’appunto il 26 aprile 162 la par-tenza di Lucio Vero poteva essere prossima o avvenuta da poco. Ma sono il primo a riconoscere il labile fondamento di quest’ipotesi. Sulla cronologia degli avvenimenti del 162: H. DODD, Chronology of the Eastern Campaigns of the Emperor Lucius Verus, in Num. Chron, ser. 4, 11, 1911, pp. 209-267, in part. pp. 209-215: J. SCHWENDEMANN, Der historische Wert der Vita Marci bei den Scriptores Histo-riae Augustae, Heidelberg 1923, p. 143 con nt. 4; P. LAM-BRECHTS, L’empereur Lucius Vérus. Essai de réhabilitation,in Ant. Class., 3, 1934, pp. 173-201, in part. p. 194. Sul carattere delle dediche al Bonus Eventus in età imperiale: E. DE RUGGIERO, in Diz. Epigr., I, 1895, p. 1018. A Roma sene conosce una sola: CIL, VI 144 = ILS 3750. Sull’esisten-za di un templum ed una porticus Boni Eventus: PLATNER – ASHBY, Dictionary, pp. 86 e 420.13 A protezione della cella s’invoca anche Tutela, che è ap-punto divinità protettrice soprattutto di luoghi, case, edifi ci, horrea: E. EHLERS, in RE, VII A, 1948, coll. 1599 sg.14 Se ne veda l’esatta ubicazione in Pianta di Roma (1 : 4000), A. MARINO – M. GIGLI ed., Roma 1934, foglio 14, m. 7, nr. 184. Un accenno in F. HERMANIN, Rome au Moyen Age, Paris 1927, p. 161. Casa dei Pierleoni era detta
<115>
8 - CELLA LUCCEIANA 187
Palazzo dell’Anagrafe e fu quindi ricostruita, con alcune alterazioni, appunto in piazza Bocca della Veri-tà, tra la moderna via del Teatro di Marcello e via San Giovanni | Decollato. Nel ‘39 lo spostamento era già avvenuto, il che concorda con la duplice indicazione “piazza Bocca della Verità” e “presso la Casa dei Pierleoni”, che in un primo momento mi era riuscita di diffi cile comprensione. Questa precisazione potrà essere, credo, di qualche utilità per chi voglia defi nire i caratteri del quartiere romano scoperto nella zona dell’Anagrafe e dell’antistante via del Teatro di Marcello. So che il prof. Colini ne darà tra poco, con altri, una completa edizione. Per intanto esso è già parzialmente noto per alcune anticipazioni del Lugli15, del Cressedi16 e dello stesso prof. Colini17. Come si può vedere dalla pianta del Gismondi pubblicata dal Lugli18, il quartiere, costituito da otto isolati, era compreso tra la grande strada dal foro Olitorio al Foro Boario e il Tevere ed era attraversato da una strada interna che corrisponde all’incirca all’asse del tempio rettangolare. Su entrambi i lati di questa strada interna sorgeva un complesso di costruzioni la cui destinazione è stata ritenuta commerciale dagli scavatori. In particolare, ad occidente della strada, si sono riconosciuti tre grandi magazzini di derrate fondati all’inizio del II sec. d.C., i quali, sulla via, avevano le botteghe al livello, mentre dalla parte opposta, che guardava il Tevere, si aprivano ad un livello più basso, direttamente sulla banchina del fi ume.
La nuova iscrizione, trovata in questo punto, forse spostata di poco dalla sua collocazione origina-ria, con il ricordo di una cella, che, si badi bene, non sembra indicare abitualmente un solo locale, ma un complesso di depositi a carattere commerciale, torna pienamente a conferma dell’interpretazione del quartiere da parte degli scavatori, consolida la datazione del complesso originario al II secolo, e, acqui-sizione non secondaria, fornisce nel contempo un nome plausibile per il complesso di magazzini, so-prattutto verso il fi ume, che trova ottimi confronti, per posizione e disposizione, con altre cellae note, ad esempio le cellae vinariae Nova et Arruntiana trovate a nord di Ponte Sisto, nell’ampliamento del letto del Tevere all’altezza dei giardini della Farnesina19, e la cella Civiciana, i cui resti sono stati scoperti in via del | Porto di Ripagrande: non se ne possiede una pianta, ma la posizione sul fi ume è perfettamente analoga20. Chissà che il prof. Colini non possa addirittura riconoscere l’ambiente, l’aedes, in cui il si-gnum del Bonus Eventus fu collocato.
in verità nel Medioevo il teatro di Marcello, trasformato in fortezza da quella famiglia che in quei pressi appunto, dietro S. Nicola in Carcere, aveva le sue abitazioni: L. PERNIER, A proposito di alcuni lavori eseguiti recentemente nell’inter-no del Teatro di Marcello, in Bull. Comm. Arch. Roma, 29, 1901, pp. 56-59. E. AMADEI, Le torri di Roma, Roma 1932, pp. 108-110; C. CECCHELLI, Roma medioevale, in CASTAGNO-LI – CECCHELLI – GIOVANNONI – ZOCCA, Topografi a e urbani-stica di Roma, Bologna 1958, p. 295.15 G. LUGLI, I monumenti antichi di Roma e suburbio. Sup-plemento, Roma 1940, p. 154; ID., Itinerario di Roma anti-ca, Milano 1970, p. 311.16 G. CRESSEDI, I porti fl uviali in Roma antica, in Rend.Pont. Ac. Arch., 25-26, 1949-51, pp. 53-65.17 A.M. COLINI, Riassunto di comunicazione in Rend. Pont.
Ac. Arch., 13, 1937, p. 12.18 G. LUGLI, Roma antica. Il centro monumentale, Roma 1946, tav. IX dopo p. 544.19 Bibliografi a e pianta in NASH, Dictionary2, I, 1968, p. 225.20 Sulla cella Civiciana: G. MANCINI, in Not. Sc., 1913, p. 117 e G. GATTI, in Bull. Comm. Arch. Roma, 62, 1934, pp. 117 sg. (AE 1937, 61). Altre cellae note a Roma sono: la Ni-griniana menzionata in un’iscrizione sacra trovata nell’area di Palazzo Antonelli, sul versante occidentale del Quirinale, in una zona ricca di simili depositi distrutti per la costruzio-ne delle Terme Costantiniane (CIL, VI 3739 cfr. 31065), e la cella Groesiana ricordata in una dedica al Sole, alla Luna, a Silvano e al Genio della cella stessa, d’ignota provenienza (CIL, VI 706 cfr. p. 3006 = ILS 3941).ILS 3941).ILS
<116>
<117>
NOTA COMPLEMENTARE – AE 1971, 29. – Sulle dediche al numen della domus imperiale: D. FISHWICK, Imperial Cult in the Latin West, II, 1, Leiden 1991, pp. 423 sgg. − La data della dedica, grazie anche ad un nuovo diploma militare (B. OVERBECK, in Chiron, 2, 1972, pp. 452 sg. = AE 1972, 657; AE 1972, 657; AE M. ROXAN, Roman Military Diplomas 1957-1977, London 1978, pp. 78 sg. nr. 55)
188 II – URBS ROMA
si può ora fi ssare con certezza al 26 aprile 161 (su M. Annius Libo: A. CABALLOS RUFINO, Los senadores hispanorromanos y la romanisación de Hispania, I, Ecija 1990, pp. 60 sg. nr. 26; su Camurius Numisius Iunior vd. PIR2, N 207). – Ambientazione del ritrovamento nel complesso portuale tiberino: F. CASTAGNOLI, in Mem. Am. Ac. Rome, 36, 1980, pp. 35-39, in part. p. 36 (ID., Topografi a antica. Un metodo di studio, I, Roma 1993, pp. 593-607; A.M. COLINI, ibid., pp. 43-51, in part. p. 47; A.M. COLINI - C. BUZZETTI, in Arch. Laz., 7, 2, Roma 1986, pp. 157-197, in part. p. 159 fi g. 2 e p. 161 fi g. 6. – Sulla cella Lucceiana e gli interessi dei Luccei nella zona della porta Flumentana: R.E.A. PALMER, in Bull. Comm. Arch. Roma, 85, 1976-77 [1980], pp. 135-161; L. CHIOFFI, in Lex. Top. Urb. Rom., I, 1993, p. 257.
1 - Dedica inedita con menzione della cella Lucceiana(fronte).
2 - Dedica inedita (lato sinistro).