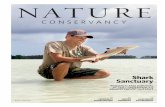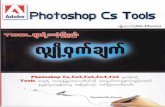THE ANCIENT LIMEKILN IN THE SANCTUARY OF ST. FRANCIS OF PAOLA (PAOLA, CS) STRATEGIES FOR ANALYSIS...
Transcript of THE ANCIENT LIMEKILN IN THE SANCTUARY OF ST. FRANCIS OF PAOLA (PAOLA, CS) STRATEGIES FOR ANALYSIS...
Vth Conference “Diagnosis, Conservation and Valorization of Cultural Heritage” 11/12 December 2014
THE ANCIENT LIMEKILN IN THE SANCTUARY OF ST. FRANCIS OF PAOLA (PAOLA, CS) STRATEGIES FOR ANALYSIS AND REPRESENTATION1
Antonio Agostino Zappani*, Giuseppe Fortunato**
* PhD, Università della Calabria, via Pietro Bucci, Cubo 39B, Rende (CS) 0984.496950, e-mail: [email protected]
**Ricercatore, via Pietro Bucci, Cubo 39B, Rende (CS) 0984.496936, e-mail: giuseppe.fortunato@unical.
Key words: survey, 3D model, architectural representation, graphical analysis Abstract
The architectural survey organizes the research path results within a structure, more or less complex, which aggregates different information types (drawings, historical notes, iconographic and photographic documents, diagnostic investigations, ...), with the aim of creating a system of knowledge to understand and analyze the investigated object. The interpretive method proceeds according to a triadic scheme, in which the surveyor, the architectural structure and its architectural representation interact in a cyclical “self-correcting” dialogue, with a constant refinement of informations deduced from the object and its representation. This system allows, on the one hand, to going deeper the knowledge of the historical building through consecutive modifications and clarifications, on the other hand to improve the examination and interpretation skills of the surveyor itself. Within this framework, the architectural representation is a “creative context”, which acts as an active “tool” in analysis of the historical building under investigation, stimulating the thought formation. Having said that, will be applied to the case study of the ancient limekiln changed into a chapel, built probably in 15th century, perhaps in the presence of St. Francis, who wanted in his native Paola the first evidence of the Order of Minims by himself founded. The survey was conducted with optical 3D measurement techniques (laser scanner and photogrammetry) whose results will be opportunity to test new strategies to “read” and analyze a monument until today ignored and that instead deserves an appropriate attention for recovery and for its valorization. Introduzione
Nel riportare i tanti miracoli compiuti da san Francesco di Paola durante la costruzione delle sue chiese, mons. G.M. Perrimezzi afferma “che di queste difficilmente mostrar si può pietra, la quale contrassegnata non sia coll’impronta gloriosa del suo miracolo” 2. Gli eventi miracolosi connessi alla fornace per la cottura della calce, materiale necessario all’edificazione del santuario di Paola, sono alcune tra le testimonianze prodigiose più fortemente legate alla memoria collettiva del Santo; in particolare, due sono i miracoli a cui ci riferiamo: nel primo, san Francesco entra nella fornace ardente per ripararla e ne esce illeso (figg. 1a,b,c); nel secondo, riporta in vita l’agnello Martinello, mangiato dagli operai
Vth Conference “Diagnosis, Conservation and Valorization of Cultural Heritage” 11/12 December 2014
e le cui ossa sono state gettate, dagli stessi, nel fuoco della fornace.
Fig. 1a,b,c – San Francesco ripara la fornace ardente, incisioni della seconda metà del sec. XVI. In questa memoria presentiamo un percorso di conoscenza focalizzato sullo studio dei caratteri e delle peculiarità della cappella – costruita “sulle” strutture murarie dell’antica calcara, a testimonianza dei prodigi operati dal Santo –, con l’obiettivo di creare una solida base documentaria del bene architettonico, che funga da indirizzo per ogni intervento di valorizzazione, conservazione, o restauro3. Nell’analisi del manufatto edilizio, convergono i risultati derivanti, da un lato, dalla ricerca d’archivio, dalla consultazione delle fonti bibliografiche e iconografiche, dallo studio della manualistica architettonica, dall’altro, i risultati dell’azione grafico-analitica di interpretazione promossa con il rilevamento architettonico. Descrizione e note storiche
Attualmente l’esterno della cappella presenta un’articolazione volumetrica piuttosto “confusa”, dovuta all’addizione di vari elementi alla struttura circolare primaria, che inficia la leggibilità e riflette solo in parte l’organizzazione dell’invaso interno. L’aspetto esterno è il risultato di circostanze costruttive particolari e di episodi contingenti: dall’aggiunta del muro a scarpa lungo il lato nord-ovest per contrastare la spinta della cupola; alla realizzazione dell’edicola con la statuina di san Francesco per “segnare” l’ingresso; all’acquedotto che poggia sullo spigolo ovest e continua lungo il lato nord-ovest, sovrapponendosi al muro a scarpa; fino all’edificazione della nuova chiesa, di ulteriori strutture per il contenimento della spinta della cupola e degli archi posti a presidio dell’antica basilica (fig. 2). Al contrario dell’esterno della cappella, l’interno ha una struttura compositiva “chiara” ed equilibrata. La pianta, di forma circolare con raggio all’incirca pari a 1,90 m, è scandita da sei paraste ed è caratterizzata da un sedile che corre lungo il perimetro, interrompendosi solo in corrispondenza dell’ingresso. Le paraste doriche poggiano su un piedistallo e al di sopra di esse si sviluppa ininterrotta la trabeazione. Non esiste più il pavimento, il cui livello si può approssimativamente desumere dall’altezza del sedile, dalla quota dell’ingresso e dal pilastrino posto in corrispondenza della seconda lesena a destra dell’ingresso (fig. 3a). La cupola si imposta su un tamburo circolare, anch’esso cadenzato dalla prosecuzione delle paraste, nonché da altrettante finestre strombate e ornate con una cornice. Un’ulteriore
Vth Conference “Diagnosis, Conservation and Valorization of Cultural Heritage” 11/12 December 2014
membratura orizzontale continua segna il passaggio tra il tamburo e la cupola emisferica, suddivisa in sei spicchi dalla presenza dei costoloni rastremati, prolungamento delle sottostanti lesene e culminanti nel cervello della volta. Similmente all’intradosso, l’estradosso è diviso in sei spicchi da altrettanti costoloni che convergono verso la base della lanterna cieca, posta alla sommità della cupola (fig. 3b).
Fig. 2 – Vista dell’esterno della fornace.
Figg. 3a,b – Interno della fornace; vista delle paraste e del pilastrino in corrispondenza della seconda lesena a destra dell’ingresso (a), vista dal basso del sistema tamburo-cupola (b).
Vth Conference “Diagnosis, Conservation and Valorization of Cultural Heritage” 11/12 December 2014
La trasformazione della fornace nell’attuale cappella, secondo Lucas de Montoya4, risale al 1614 e si deve all’opera di padre Dionigi Iulianelli da Paola, iniziativa favorita da Giovan Battista Costanzo5 – Arcivescovo di Cosenza dal 1591 al 1617 – e da Francesco Spinelli, marchese di Fuscaldo. Montoya riporta una descrizione dettagliata dell’interno della cappella, che ben corrisponde a quanto oggi è possibile vedere in situ. Coincidono il numero, il tipo e il materiale delle paraste, coincide la trabeazione (“[…] seis colunas de piedra, cò su vasa, y chapiteles, cerradas con friso, y coronacion.”)6 e il sistema tamburo-cupola con le relative membrature (“sobre el friso y cornisamento destas colunas estan otras seis menores, con sus luzes, en quadro, coronacion, y friso, que todo remata en bella cupula, ò medio naranja, […]”)7. Ma il cronista riferisce anche della presenza di pitture, di un altare collocato nel mezzo della cappella e di un quadro, oggi non più esistenti: “[…] y un Altar en el medio, con un lienço de valiente pinzel, en que està nuestro Padre San Francisco, elevado en las musicas celestiales, recibiendo el blason de la caridad” 8. Infine, dalla medesima cronaca si evince chiaramente che nella trasformazione in cappella sono stati preservati brani murari dell’antica calcara. Un’ulteriore testimonianza, anche se molto più scarna rispetto alla precedente, la ritroviamo nel resoconto redatto in seguito alla Visita Apostolica di mons. Andrea Pierbenedetto, Vescovo di Venosa dal 1611 al 1634, al convento paolano (16 dicembre 1928). Il presule, dopo aver descritto, in modo dettagliato, la chiesa con gli altari, le reliquie in essa conservate, gli ex voto, le suppellettili, i paramenti sacri e, in maniera sommaria, il resto del convento, ci lascia una breve descrizione della calcara ormai cappella: “[…] viditque in ea altare extructum communis formae, et decenter ornatum, in quo singulis quibusque hebdomadis, et prout eleemosinae elargiuntur celebrari dixerunt” 9. Un documento grafico fondamentale, che fissa la “situazione” costruttiva del santuario nel primo quarto del Seicento, è la veduta pubblicata da Pieter Mortier (fig. 4) nel terzo volume del “Novum Italiae theatrum, …” (1704), successivamente ripubblicata da Rutgert Christoffel Alberts (1724) e, infine, da Thomas Salmon ne “Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del mondo naturale, …” (1761)10. In realtà, tutte derivavano dalla veduta del santuario incisa da Valerien Regnard nel 1625.
Fig. 4 – S.P. Francisci de Paula Eremus et Solitudo (P. Mortier, 1704); Particolare della veduta con la rappresentazione della fornace già trasformata in cappella e contrassegnata con la lettera “D”.
Vth Conference “Diagnosis, Conservation and Valorization of Cultural Heritage” 11/12 December 2014
La veduta tratteggia con estrema precisione le fabbriche e accenna ai grandi lavori di ampliamento e riorganizzazione che interessano il complesso conventuale tra Sei e Settecento; un vademecum che illustra, con lettere corredate da brevi didascalie, gli edifici, gli eventi miracolosi operati dal Santo e i luoghi legati alla sua esistenza terrena. In particolare, la fornace – contrassegnata con la lettera “D” e con la scritta “Fornax Calcaria in quae B. vir ingressus illaesus ab igne permasit” – è raffigurata nei suoi tratti essenziali, come un volume cilindrico sormontato dalla cupola con lanternino, mentre lingue di fuoco si sprigionano da essa, a perenne ricordo del miracolo compiuto. Il rilievo architettonico
Per rilevare la fornace abbiamo usato tecniche range-based integrate con tecniche image-based. In particolare, abbiamo impiegato prevalentemente il laser scanner TOF ad impulsi Leica HDS 3000, per scandire l’interno e l’esterno del manufatto con una griglia teorica pari a 1x1 cm (fig. 5); mentre, tramite fotogrammetria digitale, basata su tecniche structure from motion, abbiamo integrato i dati provenienti dalla scansione laser, per ricostruire il cono d’ombra dello scanworld all’interno della fornace. Nell’allineamento dei singoli scanworld abbiamo utilizzato target piani ad elevata riflettenza, disposti efficacemente all’interno della scena, oltre a sfruttare le zone di sovrapposizione tra scanworld. L’errore di allineamento massimo sui target è pari ad 2 mm. Il risultato della campagna d’acquisizione e della successiva fase di allineamento è una nuvola di punti densa, cioè un modello numerico tridimensionale, che codifica in forma discreta la continuità delle superfici reali con un alto grado di oggettività. L’oggettività della nuvola di punti, risultato del connubio tra le caratteristiche strumentali e il metodo adoperato, è il requisito fondamentale per poterla considerare una replica digitale dell’opera, ovvero un contenitore di informazioni che affianca il manufatto nel rilevamento e, sulla quale, il rilevatore esercita la sua azione grafico-analitica di interpretazione. Oltretutto, la nuvola di punti è un prodotto per molti aspetti nuovo, dall’accresciuto contenuto informativo (quantità e qualità metrica dei dati, fotorealismo, …), in grado di concretizzare nuovi scenari operativi/conoscitivi; in sostanza la nuvola di punti può “stimolare” nuove opportunità per la documentazione, l’analisi e la rappresentazione del fenomeno architettonico indagato.
Fig. 5 – Vista prospettica a quadro inclinato della fornace, dedotta dalla nuvola di punti.
Vth Conference “Diagnosis, Conservation and Valorization of Cultural Heritage” 11/12 December 2014
La nuvola di punti scardina l’iter del rilevamento tradizionale, modificando il metodo, le procedure per l’acquisizione dei dati, trasformando i rapporti rilevatore-manufatto, incidendo sul processo di produzione delle immagini e dei disegni, “spingendo” il rilevatore verso situazioni grafico/analitiche e modalità di indagine proprie della tecnica stessa. Si ha, quindi, un’evoluzione del tradizionale processo interpretativo del rilevamento tradizionale, che procede secondo uno schema triadico, in cui il manufatto architettonico, il rilevatore e le restituzioni grafiche interagiscono in un continuo dialogo ciclico, con un costante raffinamento e revisione delle informazioni dedotte dall’oggetto e dalla sua rappresentazione11. Il funzionamento della calcara
La lettura della fabbrica non è di immediata comprensione, sia per l’esiguità delle fonti archivistiche, sia perché nasce da un adattamento ad una struttura preesistente il cui progetto originario, quello di una calcara, doveva rispondere a logiche compositive legate solo ad esigenze funzionali del ciclo di produzione, estranea quindi, a quelle estetiche. L’opera (figg. 6-7), nonostante le modeste dimensioni, merita una rinnovata attenzione perché custode di diversi valori, non solo architettonici, ma anche religiosi e non tanto perché la tradizione la lega ad un episodio prodigioso operato dal Santo, ma anche per il suo valore simbolico: se è facile vedere nel Santo paolano il “generatore spirituale” dei Minimi, la calcara possiamo vederla come “generatore materiale” dell’Ordine stesso, contribuendo alla costruzione della prima comunità di un Ordine che vanterà, già due secoli dopo, oltre 450 conventi, attivi anche in Belgio, Inghilterra, Portogallo e in Sudamerica. La tecnica di produzione della calce ricalca una tradizione già antica nel medioevo, le prime fonti sul tema compaiono già nel De Architettura di Vitruvio, in cui l’autore descrive le composizioni di malta con calce e sabbia. A questi si aggiungono autori come Plinio e Catone, ed insieme diventano riferimenti indiscussi per tutta la trattatistica del Seicento e del Settecento, che preferisce non apportare variazioni sul tema per il successo ottenuto dalla qualità delle malte di epoca romana. La calce è ottenuta da un processo di cottura di calcari, puri per le calci aeree magre (impurità fino al 5%) o grasse (impurità superiori al 5%), argillosi (impurità tra l’8 e il 20%) per le calci idrauliche. La pietra adottata nella cottura per la produzione di calce, veniva scelta in base alla tipologia di malta che si voleva ottenere: per Vitruvio, seguito anche da Francesco di Giorgio Martini, da Andrea Palladio e da Francesco Scamozzi bisognava preferire pietre dure e compatte (“bianche” o di selce) per le malte adottate come legante per le murature a quelle porose per la realizzazione di intonaci. Leon Battista Alberti che si discosta dalle indicazioni di Vitruvio seguendo invece quelle di Catone scrive nel suo trattato Dell’ Architettura: “Sarà inutile a far calce ogni pietra che sia consunta, arida o marcia, tale cioè nel farla cuocere il fuoco non vi trovi nulla da consumare: tale è il tufo, tali sono le rocce un poco rossicce e slavate”. Lo Scamozzi fornisce ulteriori indicazioni sulla scelta delle pietre da calce: “E buonissimo segno quando le pietre percosse l’una con l’altra s’amaccano, e fanno una certa farina, e che rendono l’odore del corno abbruciato, & al gusto non so che di falso. Si lodano più tosto grandi, e grevi, che picciole, e leggieri, perche all’hora hanno maggior virtù, e rendono fortezza alla calce; e finalmente al tutto siano gravi, e vive, e di molto nervo”. I tipi di fornace per la cottura delle pietre sono prevalentemente di due tipi: a fuoco intermittente, nel quale il calcare non era a diretto contatto con la legna, e a fuoco continuo, in cui le pietre inumidite ed il
Vth Conference “Diagnosis, Conservation and Valorization of Cultural Heritage” 11/12 December 2014
combustibile venivano accatastati a strati alterni. Necessitavano tre o sei giorni per il completamento del processo di calcinazione. A riguardo Scamozzi scrive:12 “Le pietre da calcina si cuoceno più presto e più tardi: secondo la forma della fornace, e la forza del foco e la quantità, e la qualità delle pietre, e l’ordine nel quale sono state poste la dentro: onde essendo le cose in mediocrità in 60 hore si cuoceno i cementi, o pietre di monte per esser più tenere, e dolci, e porose dell’altre; ma le pietre dure, e vive, e quelle di scaglia padoana, e quelle di torrenti non vogliono meno di 100 hore di foco continuo, & anco alle volte più”. La calce idrata, come detto, è un legante aereo ottenuto dalla cottura ad alte temperature (circa 900°C) delle pietre da calce ma, per essere impiegata come legante, deve subire ulteriori trasformazioni passando dalla fase di spegnimento. Nel sistema tradizionale, questa fase si raggiunge attraverso la preparazione di un grassello ottenuto dall’immersione in acqua delle zolle di calce viva che, sprigionando un’abbondante emissione di calore, si spengono. Durante questa fase, la calce viva viene ripetutamente impastata o lasciata macerare a lungo, fino a completa maturazione. I tipi di spegnimento sono diversi, ma quello più comune è quello detto con il metodo ordinario: descritto già da Vitruvio, consisteva nella realizzazione di due vasche a quote differenti. Quella a quota più alta accoglieva la pietra cotta e man mano si riversava dell’acqua al suo interno. L’amalgama così ottenuto, veniva ripetutamente mescolata tramite apposite zappe a manico lungo che lo spingevano, una volta ottenuta la consistenza ottimale, verso il canale di collegamento all’altra vasca posta più in basso. Al canale era inoltre applicata una griglia, giustapposta per setacciare gli eventuali materiali di scarto o i frammenti di pietra non completamente calcinati. Le restituzioni grafiche
Il rilievo effettuato ha cercato, come detto, di rimettere attenzione ad un monumento fino a poco tempo fa trascurato e che un attuale progetto di restauro cerca di recuperare e valorizzare. Trascurato non solo a causa del degrado che lo minaccia, ma anche dai vari rilevatori, più concentrati verso altri corpi di fabbrica del complesso. Non sono noti elaborati grafici che ne descrivono accuratamente la struttura. Si è cercato di colmare tali disattenzioni proponendo alcune elaborazioni grafiche di seguito riportate. I tipi di elaborati sono perlopiù incentrati sullo studio delle irregolarità (figg. 9a,b,c) della fabbrica (evidenziando le irregolarità delle calotte sferiche, intradossali ed estradossali, della cupoletta) e sulla sua rappresentazione con l’immediato intorno (figg. 10a,b), mentre il tentativo di lettura delle geometrie della cappella secentesca non ha portato a interessanti
Fig. 6 – Vista interna della calcara sul condotto che alimentava la combustione interna.
Fig. 7 – Schema planimetrico della calcara.
Vth Conference “Diagnosis, Conservation and Valorization of Cultural Heritage” 11/12 December 2014
risultati giacché il suo progetto non è stato frutto di quelle logiche compositive spesso suggeribili dal sito in cui si l’opera si colloca (posizionamento, allineamenti, dimensionamento, orientamento, …). Ciò perché la struttura e il suo intorno hanno subìto radicali cambiamenti (figg. 8a,b) in occasione della costruzione, della nuova aula liturgica.
Figg. 8 a,b – Riassetto dell’intorno della calcara a seguito dei lavori per la costruzione della nuova Aula liturgica conclusi nel 2000; vista della calcara prima dello sbancamento del versante in cui era inserita (a) e rilievo attuale del nuovo assetto (b).
Figg. 9 a,b,c – Fotopiani in falsi colori dedotti da nuvole di punti; sezione in cui si evidenzia lo spessore non uniforme della cupoletta (a); proiezione, in cui si evidenza in rapporto volumetrico tra interno ed esterno (b) e ipografia (c).
Vth Conference “Diagnosis, Conservation and Valorization of Cultural Heritage” 11/12 December 2014
Figg. 10 a,b –Ricostruzioni virtuali per la rappresentazione della fabbrica e del suo intorno.
Vth Conference “Diagnosis, Conservation and Valorization of Cultural Heritage” 11/12 December 2014
Note 1 I paragrafi “Introduzione”, “Descrizione e note storiche” e “Il rilievo architettonico” sono a cura di Antonio Agostino Zappani; mentre i paragrafi “Il funzionamento della calcara” e “Le restituzioni grafiche” sono a cura di Giuseppe Fortunato. 2 Giuseppe Maria Perrimezzi, La vita di san Francesco di Paola, fondatore dell’Ordine de’ Minimi scritta da Monsignor Giuseppe-Maria Perrimezzi dello stess’Ordine vescovo di Ravello, Scala e di Oppido in Calabria. Di nuovo ristampata, e ridotta a miglior uso di Lingua Italiana, Venezia, ed in Milano: nella stamperia di Giuseppe Mazzucchelli, successore Malatesta, 1764, p. 26. 3 Lo studio della fornace si inserisce in un più ampio quadro di indagini, analisi e ricerche condotte dal Laboratorio di Rilievo dell’Architettura (responsabile scientifico prof. Aldo De Sanctis). 4 Lucas de Montoya, Coronica general de la Orden de los Minimos de S. Francisco de Paula su fundador donde se trata de su vida y milagros, origen de la Religion, erection de Prouincias y varones insignes della, En Madrid por Bernardino de Guzman, 1619, libro tercero, p. 5. Padre Dionigi da Paola, descritto da Lucas de Montoya come “[…], varon insigne en Pulpito, y zelo de la religion, (oy Provincial de Calabria) […]” (Ibidem), ricopre la carica di Correttore Provinciale della Provincia di san Francesco dal 1616 al 1619 e dal 1623 al 1626; durante il suo provincialato, l’atrio esterno viene arricchito con l’aggiunta di colonne e affreschi (Cfr. G.M. Perrimezzi, Vita S. Francisci de Paula Minimorum ordinis Institutoris scripta ab Anonymo eiusdem sancti discipulo eique coaevo. Pars secunda: dissertationes, Romae Typis Bernabò, 1707, p. 151). 5 Montoya riporta “Juan Bautista Cataneo”. 6 Ivi, p. 6. 7 Ibidem. 8 Ibidem. 9 Vincenzo Antonio Tucci, La visita apostolica di mons. Andrea Pierbenedetto alla Città e Diocesi di Cosenza 1628, Cosenza Pubblicità Grafiche Perri, 2012, p. 449. 10 Alcuni autori sostengono che la veduta del santuario è stata pubblicata anche da Joan Blaeu, ma non è presente in nessuna copia consultata del “Theatrum civitatum et admirandorum Italiae …” e del “Theatrum Civitatum nec non Admirandorum Neapolis et Siciliae Regnorum”. 11 Questo “dialogo” consente, sia di approfondire la conoscenza dell’opera, attraverso successive modifiche e precisazioni, che di affinare e perfezionare le capacità di osservazione e interpretazione del rilevatore stesso. 12 Scamozzi, 1615, Vol. II, Libro VII, capo XVIII, pag. 228. References
1. Carla Arcolao, Le ricette del restauro. Malte, intonaci e stucchi dal XV al XIX secolo, Venezia Marsilio Editori, 1998, pp. 3-8.
2. Lucas de Montoya, Coronica general de la Orden de los Minimos de S. Francisco de Paula su fundador donde se trata de su vida y milagros, origen de la Religion, erection de Prouincias y varones insignes della, En Madrid por Bernardino de Guzman, 1619.
3. Giuseppe Maria Perrimezzi, Vita S. Francisci de Paula Minimorum ordinis institutoris scripta ab anonymo ejusdem sancti discipulo, eique coaevo. Ex Italico primum Gallice, ex Gallico deinde idiomate Latine reddita anno 1637. Pars secunda: dissertationes, Romae Typis Bernabò, 1707.
4. Francesco Russo, Il Santuario-basilica di Paola. Monografia storica e guida illustrata, Cava dei Tirreni Arti Grafiche Di Mauro, 1966.
5. Vincenzo Antonio Tucci, La visita apostolica di mons. Andrea Pierbenedetto alla Città e Diocesi di Cosenza 1628, Cosenza Pubblicità Grafiche Perri, 2012, pp. 446-450.