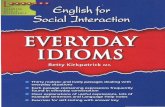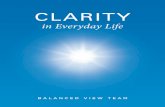The algebra of everyday life. La musica di Christian Wolff
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of The algebra of everyday life. La musica di Christian Wolff
The algebra of everyday life: la musica di Christian Wolff di Marco Lenzi Dei quattro compositori appartenenti alla cosiddetta ‘New York School’ – John Cage (1912-1992), Morton Feldman (1926-1987), Earle Brown (1926-2002) e Christian Wolff (1934) – Wolff è indubbiamente il meno conosciuto. Se i primi due sono ormai divenuti dei ‘classici’ della musica del secondo Novecento, e se Earle Brown è stato il primo, insieme a Cage, ad esercitare una certa influenza sullo scenario internazionale della musica contemporanea già dalla fine degli anni Cinquanta, grazie soprattutto alle nuove forme di notazione grafica di cui è stato uno dei pionieri – la partitura del suo December ’52, tratto dai Folio pieces (1952-54), è stata sin da allora riprodotta innumerevoli volte in antologie, enciclopedie, mostre e pubblicazioni varie, tanto da assurgere presto a modello del grafismo aleatorio – la figura e le opere di Christian Wolff attendono ancora di essere pienamente riconosciute nella loro originalità e individualità stilistica e di essere fatte oggetto di uno studio approfondito.1 Le ragioni di questo ritardo sono, credo, riconducibili principalmente a tre fattori: il primo è che le sue opere più note, quelle indeterminate degli anni Cinquanta e Sessanta (dal Duo for pianists I del 1957 a Edges del 1968), risultano a un primo ascolto difficilmente distinguibili da quelle coeve di Cage, delle quali sono state a lungo considerate una sorta di ‘corollario’; il secondo ha a che fare invece con la personalità schiva del compositore, che ha condotto fin dai primi anni Cinquanta una vita appartata, in buona parte dedita allo studio e all’insegnamento delle lingue classiche (Wolff ha insegnato latino e greco per quasi quarant’anni nelle università americane, prima ad Harvard quindi a Dartmouth) e dunque lontana dagli agoni festivalieri e dalle strategie autopromozionali.2 Il terzo, last but not least, è costituito dalle notevoli difficoltà di interpretazione che presentano molte delle composizioni indeterminate di Wolff; infatti, a dispetto di un’apparente facilità di lettura (la maggior parte di queste opere ha un aspetto piuttosto scarno e rarefatto), gli esecutori si trovano spesso di fronte a problemi interpretativi di non facile – e talvolta assai ardua – soluzione, legati sia alle complesse interrelazioni tra di essi che la partitura richiede (in molti momenti le scelte di un esecutore sono condizionate da quelle di un altro) che a questioni estetiche più generali (disegno complessivo del brano, intenti espressivi del compositore, senso musicale tout court). Eppure, a una lettura più attenta, molte delle quasi
1 La prima monografia sul compositore, curata da Stephen Chase e Philip Thomas, è stata pubblicata recentemente:
cfr. S. CHASE / PH. THOMAS (a cura di), Changing the system: the music of Christian Wolff, Farnham, Ashgate, 2010. Raccoglie contributi, oltre che dei curatori, di M. Parsons, M. Hicks, A. C. Beal, J. Saunders, Ch. Fox, D. Ryan e C. Gresser. 2 “Data la sua giovane età, e per il fatto che la sua vita sia stata così ‘monastica’, egli è meno conosciuto di Cage,
Brown o me stesso”, B. H. FRIEDMAN (a cura di), Give my regards to Eighth Street. Collected writings of Morton Feldman, Exact Change, Cambridge (Mass.), 2000, p. 16. (Ogni traduzione dall’inglese, ove non altrimenti specificato, si intende nostra).
duecento opere composte dal 1950 a oggi rivelano una personalità musicale ricca e straordinaria, dotata di grande fascino e originalità, e meritano dunque uno studio approfondito.
*** Nato a Nizza nel 1934, Christian Wolff crebbe in una famiglia tedesca dagli ampi orizzonti culturali. Il nonno era stato un musicista legato al circolo di Brahms e il padre, Kurt Wolff, era l’editore di Kafka e di diversi altri scrittori, molti dei quali ebrei, rappresentanti dell’Espressionismo mitteleuropeo. Alla presa del potere da parte di Hitler, per ovvie ragioni, la famiglia abbandonò la Germania per trasferirsi prima in Francia e quindi, per un breve periodo, in Italia, nei pressi di Firenze. Nel 1941 i Wolff riuscirono a emigrare definitivamente negli Stati Uniti e si stabilirono a New York, dove fondarono un’importante casa editrice, la Pantheon Books, e dove presto allacciarono strette relazioni con il ricco e vivace ambiente culturale della città. Tra gli amici che frequentavano la famiglia figuravano musicisti importanti, tra i quali Edgard Varèse, Adolf Busch, Rudolf Serkin, nonché i membri del celebre Juilliard String Quartet, grazie ai quali il giovanissimo Wolff ebbe modo di ascoltare per la prima volta opere di Bartók, Schönberg, Berg e Webern, che fecero su di lui una profonda impressione. Fu anzi proprio l’incontro con la musica moderna a consolidare in lui il desiderio di comporre: […] il Juilliard Quartet aveva appena iniziato a suonare Bartok e la Scuola di Vienna […] e io ne fui totalmente catturato. Pensai che fosse qualcosa di grande, di meraviglioso. Fu per me una sorpresa perché ero stato estremamente conservatore nei miei gusti musicali. […] Ascoltando tutta quella musica, mi venne voglia di far qualcosa. Non volevo semplicemente assorbirla passivamente. Così iniziai a comporre, da solo. […] Pensai: “Questo è ciò che voglio fare, qualcosa che suoni diversamente da qualsiasi altra cosa”. Non volevo imitare proprio quella musica.
3
La sua formazione musicale, se si escludono le consuete lezioni di pianoforte che egli intraprese sotto la guida di Grete Sultan, la futura dedicataria delle Études Australes (1974-75) di Cage, fu però quasi interamente da autodidatta, non incentrata sui tradizionali studi di contrappunto e armonia ma limitata allo studio di un manuale di teoria e dell’intera collana della New Music Edition curata da Henry Cowell, che gli rivelò le più avanzate tendenze della musica sperimentale americana. Fu la sua stessa insegnante di pianoforte, alla quale Wolff aveva sottoposto i suoi primi timidi ma audaci esperimenti compositivi, a indirizzarlo verso John Cage. All’epoca il compositore californiano viveva nella oggi mitica residenza di Monroe Street, quella ‘Bozza’s mansion’ nella quale viveva anche Morton Feldman e che di lì a poco avrebbe suggellato l’atto di nascita della New York School e di quella musica indeterminata e aleatoria ad essa indissolubilmente legata. Così, nella primavera del 1950 l’appena sedicenne Wolff si presentò a Cage e questi, meravigliato dalla radicalità di quelle sue prime, acerbe composizioni, lo accettò entusiasticamente come allievo. Le lezioni durarono poco più di due mesi, alla fine dei quali Cage si rese conto che Wolff era perfettamente in grado di proseguire da solo, possedendo quei requisiti disciplinari – linguaggio, senso della forma, scelta dei materiali e più in generale capacità di scrittura – che gli avrebbero consentito di andare avanti per la propria strada senza alcun bisogno di una guida che lo seguisse. Tuttavia quelle poche lezioni furono importanti per entrambi i compositori e vale la pena soffermarsi un poco sul loro contenuto. Esse consistevano di quattro progetti: l’analisi del primo movimento della Sinfonia op. 21 di Webern; l’esposizione dei principi che informano la rhythmic structure, un metodo per l’organizzazione temporale di una composizione che Cage aveva escogitato e applicato alle sue opere già da diversi anni; alcuni esercizi di contrappunto classico, simili a quelli che Schönberg aveva sottoposto a Cage durante i 3 Ch. Wolff, Cues. Writings and conversations, Köln, Edition MusikTexte, 1998, p. 236.
suoi anni di apprendistato nelle università di Los Angeles; la discussione critica delle composizioni che Wolff di volta in volta portava a lezione e che spesso scaturivano dagli esercizi che il maestro assegnava all’allievo. Sia l’analisi della Sinfonia che l’apprendimento dei principi che governano la rhythmic structure furono di particolare importanza per Wolff: dalla prima egli trasse spunti preziosi per l’elaborazione di una originalissima poetica minimalista, che anticipa di un quindicennio le scoperte e le innovazioni di compositori come Riley, Reich e Glass; la seconda gli consentì di superare l’impasse della forma aforistica, alla quale erano vincolate le sue prime esperienze compositive, attraverso una strutturazione più rigorosa del tempo musicale. Ma l’originale interpretazione di Webern proposta da Wolff è rilevante anche da un punto di vista storico, poiché sancisce la diversità della ricezione americana del compositore austriaco rispetto a quella, coeva, europea. Infatti, ciò che più colpì il giovane allievo nella disamina del primo dei due movimenti della Sinfonia, un canone doppio per moto contrario, non fu tanto il metodo dodecafonico o la disposizione ‘a specchio’ della serie, né il meccanismo canonico, quanto piuttosto il fatto che a ciascuna altezza della serie (fatta eccezione per un paio di casi, che presentano un raddoppio) venisse affidato un unico registro e, forse ancor di più, il senso di staticità temporale che ne consegue, rafforzato dall’uso di pochi e semplicissimi moduli ritmici, da un andamento lento e da un cauto dosaggio dinamico.4 Alla luce di simili considerazioni, la differenza tra le due immagini europee di Webern, entrambe radicate in una medesima filosofia della storia di stampo progressista – l’una, rappresentata da Boulez e Stockhausen, che pone al centro del proprio interesse l’analisi dell’evoluzione linguistica; l’altra, rappresentata da Nono e Maderna, che invece mette in evidenza la continuità di una tradizione espressiva – ci appare meno pronunciata rispetto alle peculiarità della ricezione americana. Fu insomma il suono di Webern, l’aspetto puramente percettivo e fenomenico della sua musica – e non dunque il suo linguaggio né il suo metodo compositivo – a lasciare una traccia indelebile nei compositori della New York School e in particolare in Feldman e nel primo Wolff. A differenza dei compositori europei, gli americani erano insomma interessati alla cosa più che al come, al fatto puro e semplice del “non aver mai sentito prima nulla di simile”, al quale va correlato il candido desiderio di Wolff di “fare qualcosa di totalmente altro e diverso”; perciò le questioni legate alla metodologia compositiva dodecafonica e al suo sviluppo nel senso di una serialità allargata furono da essi ignorate in favore di un’operazione di radicale riduzione fenomenologica, tendenzialmente astorica e aconcettuale, che li portasse a un suono indeterminato e libero da vincoli strutturali, non filtrato da alcun trattamento parametrico elaborato a priori. Ma se Feldman intraprese fin da subito, nelle serie delle Projections (1950-51) e delle Intersections (1951-53), l’esplorazione delle risorse espressive offerte dall’indeterminazione e dai processi intuitivi, Cage e specialmente Wolff vi arrivarono in un secondo momento, rimanendo per qualche anno ancora legati a metodi compositivi e a strategie costruttive che, utilizzando tabelle e quadrati magici, mostrano comunque un certo grado di affinità con il pensiero seriale europeo. Tra il 1950 e il 1952 Wolff compone una serie di pezzi basati su pochissime altezze: tre note nel Duo for violins e nella Serenade per flauto, clarinetto e violino, entrambe composte nel 1950, quattro nel Trio (1951) per flauto, tromba e violoncello, cinque nello String Trio (1950), nove in Nine (1951) per nove strumenti e in For piano I (1952). Tali altezze sono sottoposte a una continua permutazione e presentate in configurazioni ritmico-melodiche sempre diverse, ciascuna delle quali caratterizza un tipo di ‘suono’. Lo scopo di una tale drastica riduzione è infatti non tanto e non solo quello di, per usare le parole dello stesso compositore, “scoprire quanto si possa essere liberi entro confini così ristretti”, quanto piuttosto quello di riformulare la gerarchia dei parametri
4 Cfr. CH. WOLFF, Randomly fixed points. On the music of Anton Webern, in: ID., Cues, op. cit., pp 344-349. Una
interpretazione analoga della poetica di Webern è quella offerta dal ‘padre’ del minimalismo americano, LaMonte Young: cfr. L. YOUNG / M. ZAZEELA, Selected writings, Heiner Friedrich, München, 1969, s. p.
sonori relegando l’altezza allo stesso grado di importanza della durata, del timbro e dell’articolazione dinamica. Tre note articolate da due strumenti danno, infatti, sei distinti ‘suoni’: tre suoni singoli e tre possibili coppie. Se poi si considerano tutte le varie combinazioni di durate (precedenza del primo suono sul secondo o del secondo sul primo, simultaneità di attacco ma non di chiusura e viceversa, etc.), di dinamiche e di timbri, le possibilità aumentano fino a farsi indefinite. L’ascoltatore è così invitato non più a ‘seguire un discorso’ ma a concentrarsi sull’attimo, sul dettaglio, per coglierne tutte le sfumature espressive. Un altro metodo importante che Wolff mise a punto in questa prima fase della sua attività compositiva, mutuato da Cage5 e che in un certo senso si contrappone a quello appena descritto, consiste nell’utilizzo di gamuts of sounds, di collezioni cioè di suoni fissi che vengono dislocati in un quadrato magico secondo criteri sia intuitivi ed estemporanei che preordinati (ma senza alcun criterio seriale di organizzazione).6 In For prepared piano (1951), un pezzo al quale Cage attribuirà un’importanza cruciale nella storia della musica sperimentale americana in quanto prima opera che sancisce la rottura effettiva della continuità lineare,7 tali suoni vengono dapprima disposti verticalmente in un quadrato magico (una matrice di 5x5 caselle alle quali corrispondono altrettante battute in ciascuno dei quattro pezzi in cui è suddiviso il brano) per essere poi distribuiti secondo la canonica lettura orizzontale in partitura. Un procedimento compositivo che sembra mediare tra la flessibilità del primo metodo e la rigidità del secondo sta invece alla base del primo pezzo elettronico di Wolff, For magnetic tape (1952), scritto per una coreografia di Merce Cunningham e realizzato nell’ambito del Project for magnetic tape coordinato da Cage, al quale contribuirono anche Feldman e Brown. Com’è noto, in quegli anni John Cage intratteneva una fitta corrispondenza con Pierre Boulez. I due compositori si erano incontrati per la prima volta a Parigi nel 1949 e da allora andarono consolidando un’amicizia, basata sulla stima e sull’influenza reciproca, che si sarebbe però affievolita nel breve volgere di pochi anni in seguito al drastico rifiuto che Boulez espresse nei confronti dei metodi aleatori usati da Cage. In termini ancora più duri il compositore francese si espresse rispetto alle prime opere di Feldman e di Wolff, giudicandole, in sostanza, “troppo semplici e imprecise”.8 Se Feldman si risentì profondamente di tale giudizio e da allora fece dello strutturalismo europeo il bersaglio prediletto dei suoi strali polemici, la reazione di Wolff, che aveva tra l’altro passato un’intera settimana a stretto contatto con Boulez nell’estate del 1951, fu meno perentoria e più costruttiva. Alla domanda “Why so few notes?”, che Boulez gli rivolse dopo aver esaminato le sue prime opere minimaliste, egli rispose con For piano II (1953) un pezzo che, per quanto ancora basato sulle strutture ritmiche e sulle collezioni di suoni usate nelle opere precedenti, estese tali suoni a tutti gli ottantotto tasti del pianoforte, inaugurando così una fase ‘complessa’ che tenne occupato il compositore fino al 1957. Le due opere pianistiche successive, la Suite (I) (1954) per pianoforte preparato e For piano with preparations (1957), sono infatti caratterizzate da una scrittura molto spinta sia sotto il profilo delle relazioni spaziali, con la costante opposizione dei registri estremi, sia sotto quello delle durate, articolate in complesse sovrapposizioni di gruppi irregolari e basate su una sincopazione serrata. Tali opere, che per espressa ammissione dell’autore risentono sia dell’influenza di Boulez che di quella dei primi Klavierstücke di Stockhausen, risultano tuttavia all’ascolto improntate a una sorta di ascetica neutralità, a quella scarna e asciutta astrattezza tipica della musica sperimentale americana,
5 Tale metodo viene usato per la prima volta da Cage in maniera sistematica nello String quartet del 1949-50 e nelle
successive Six melodies for violin and Keyboard (1950). 6 Una descrizione approfondita di questo procedimento si trova nel saggio On form. Cfr. CH. WOLFF, Cues, op. cit., pp.
38-44. 7 Cfr. J. CAGE, Silenzio, Milano, Shake, 2010, p. 91.
8 Cfr, P. BOULEZ / J. CAGE, Corrispondenza e documenti, Milano, Archinto, 2006, p. 185.
lontana sia dall’ampia gestualità e dall’incessante e isterico flusso ritmico bouleziano che dalle improvvise e aggressive combustioni sonore dei primi lavori di Stockhausen. Verso la fine del 1957 Wolff iniziò ad elaborare una nuova forma di notazione musicale che segnò il suo ingresso nell’indeterminazione e che costituì il suo principale contributo al grafismo aleatorio. Fatta eccezione per Madrigals (1950), un pezzo per tre voci la cui notazione a campo aperto offre solo una vaga idea del profilo intervallare della melodia, tutte le opere composte fino a quel momento erano state infatti scritte convenzionalmente, avvalendosi della semiotica musicale tradizionale. A partire dal Duo for pianists I (1957) e nelle opere composte per tutto il corso degli anni Sessanta e oltre (il ritorno alla notazione convenzionale non sarà comunque mai, fino ad oggi, definitivo) Wolff si avvalse di segni e simboli nuovi per indicare agli interpreti le azioni da compiere e le varie modalità esecutive. Numeri, linee e lettere variamente distribuite nello spazio bianco della pagina e corredate di altri segni congegnati ad hoc per ogni singolo pezzo (e ovviamente di una articolata legenda che ne specifica il significato e la funzione) sostituirono così le note e i pentagrammi tradizionali. Le circostanze che favorirono una tale svolta stilistica furono di natura sia pratica che teorica. Come spesso accade, un primo stimolo venne da esigenze puramente contingenti, come ad esempio il dover assolvere a una commissione trovandosi ad avere poco tempo a disposizione per comporre. Per la prima esecuzione del già citato Duo for pianists I Wolff aveva infatti programmato un concerto per due pianoforti, che doveva tenere col pianista Frederic Rzewski, all’epoca suo compagno di studi ad Harvard, e si trovò di fronte alla necessità di elaborare una partitura in tempi brevi, cosa difficilmente conciliabile col metodo di lavoro paziente e rigoroso dal quale erano scaturite le opere composte fino ad allora, specialmente quelle ‘complesse’ del periodo appena precedente. Gli venne dunque l’idea di affidare le scelte compositive a decisioni prese dagli stessi interpreti nel momento esecutivo anziché dal compositore: invece cioè di comporre strutturando preordinatamente le varie collezioni di altezze e caratterizzandone in modo fisso i vari parametri, egli le dispose in diversi gruppi, ciascuno contrassegnato da una lettera dell’alfabeto, dai quali l’esecutore deve attingere ogni volta che gli viene richiesto. In altre parole: invece di riempire due o tre battute di note ognuna delle quali avente una propria durata specifica, si chiede all’esecutore di suonare, ad esempio, sei note appartenenti al gruppo ‘a’ nello spazio di due secondi. In questo modo il complesso disegno notazionale può essere ridotto a una semplice formula del tipo ‘2: 6a’ (che significa appunto “suona entro due secondi – e con qualsiasi articolazione temporale interna – sei note a scelta tra quelle appartenenti al gruppo ‘a’”). Ulteriori specificazioni, sempre indicate da lettere o da abbreviazioni di vario genere, riguardano poi le dinamiche, i timbri e gli attacchi del suono (suonare piano o forte, sulla tastiera o direttamente sulle corde, col polpastrello o con l’unghia, pizzicando o sfregando la corda, producendo armonici o rumori vari, etc.), nonché le eventuali preparazioni di alcune corde. Per quanto si possano avere, in questo modo, formule più lunghe e complesse (ad esempio: ’30: 13 key 1 touch 3 mute h’, che significa “entro uno spazio temporale di trenta secondi suona diciassette note del gruppo ‘h’, di cui tredici sulla tastiera, una smorzando la corda e tre appoggiandovi il dito in modo da produrre armonici”), la partitura si riduce ad un'unica pagina, diversa per ciascun esecutore, in cui sono segnati soltanto i frames temporali (nel caso specifico trentanove, che vanno da una durata minima di un sedicesimo di secondo a una massima di cinquantaquattro secondi e mezzo, per una durata complessiva di tre minuti, cinquantacinque secondi e un nono di secondo) lungo i quali vengono disposti i vari gamuts ogni volta che occorrono e le istruzioni per l’esecuzione sotto forma di formule, come nell’esempio:
Ma una evidente tendenza irresistibile a complicare le cose, già riscontrabile nelle composizioni del periodo minimalista (Nine e For piano I presentano una scrittura più complessa del Duo for violins o della Serenade) dovette manifestarsi presto anche in questa prima fase indeterminata, se già in For pianist (1959) Wolff perviene a un ‘virtuosismo notazionale’ tale da mettere a dura prova la pazienza di qualsiasi interprete, per quanto animato da buone intenzioni. Definito da David Tudor, che ne curò la prima esecuzione, un conundrum, un rompicapo, il pezzo si presenta come un intricato labirinto di percorsi possibili e alternativi la cui attivazione dipende talvolta dall’esito di un’istruzione: se, ad esempio, si prescrive di suonare una nota il più piano possibile in una brevissima frazione temporale, vi sono tre percorsi possibili da seguire successivamente, corrispondenti ai tre possibili esiti dell’istruzione (la nota può risultare effettivamente in pianissimo, inudibile o più forte del dovuto); sono previste inoltre situazioni in cui l’eccessiva sovrapposizione di eventi rende praticamente impossibile l’esecuzione, nel qual caso si consente all’esecutore di postulare un ‘tempo zero’ (concetto, questo, che avrà una grande importanza nelle opere immediatamente successive) che lo esime dal rispettare i limiti imposti dai frames temporali. Al di là delle questioni pragmatiche e di circostanza, un fattore decisivo nel cammino verso l’indeterminazione fu il sempre più marcato interesse mostrato da Wolff per la flessibilità sintattica e formale e per l’improvvisazione. Le nuove forme di notazione vennero concepite come mezzi per raggiungere risultati che nessun altro tipo di notazione avrebbe potuto perseguire (“L’indeterminazione fu un modo per produrre suoni che non avrei potuto ottenere altrimenti. In questo senso essa fu meramente un’idea pratica”). Ma la questione ancora più decisiva fu l’attenzione rivolta agli aspetti concretamente performativi dell’esperienza musicale e all’interazione fra gli esecutori. Nelle opere scritte nei primi anni Sessanta Wolff abbandona la griglia temporale generata dalle rhthmyc structures, residuo di una concezione preordinata della scrittura, per esplorare la dimensione più vitalistica della temporalità musicale, nella quale la scrittura stessa diventa una sorta di immagine del comportamento degli esecutori, invitati a porre la massima attenzione all’ascolto reciproco. Le azioni sonore del singolo interprete non sono più, qui, l’esito delle indicazioni e dei suggerimenti – delle intenzioni – del compositore, ma divengono ‘risposte’ alle azioni dell’altro, secondo un sistema di cues, di indizi per l’articolazione e lo sviluppo di processi coordinati. Ciò che un esecutore fa, in altre parole, è condizionato da ciò che fa l’altro (o gli altri): di qui la necessità di una massima concentrazione sia sull’ascolto reciproco che sulle scelte individuali. In opere come il Duet I (1960) per pianoforte a quattro mani, la Suite II (1960) per corno e pianoforte e il Duo for violinist and pianist (1961) – non a caso scritte per non più di due esecutori – non si chiede più di suonare un determinato numero di suoni con determinate caratteristiche entro un determinato frame temporale, ma di coordinarsi l’uno con l’altro. I due esecutori possono così sovrapporsi (attaccando e rilasciando il suono simultaneamente o in momenti diversi) o alternarsi (l’uno attacca immediatamente dopo che l’altro si ferma oppure dopo un certo numero di secondi di
silenzio, o ancora attacca immediatamente dopo non il primo ma il secondo, o il terzo suono prodotto dall’altro) secondo le varie combinazioni possibili; per questa idea nuova Wolff escogitò una forma di notazione come quella dell’esempio qui sotto, tratto dal Duet II (1961) per corno e pianoforte:
Ciò che si ascolta in questi pezzi è dunque l’immagine sonora di un comportamento, piuttosto che un brano musicale inteso in senso tradizionale. La funzione svolta dal compositore è ancora, in buona parte, quella di predisporre un materiale differenziato e dare delle indicazioni sulle modalità della sua articolazione, ma l’esecutore è chiamato a responsabilizzarsi rispetto alle decisioni che deve prendere sul momento, in tempo reale, e che richiedono disciplina e sensibilità oltre che, ovviamente, il rispetto del senso complessivo dell’opera. Non è un caso, infatti, se quasi nessuna delle composizioni aleatorie di Wolff possa essere letta a prima vista o dopo la semplice lettura della legenda dei simboli e delle istruzioni esecutive; né, d’altra parte, è in alcun modo raccomandabile prepararsi delle versioni scritte e fissate a priori per sconfessare l’eventualità di uno smarrimento durante l’esecuzione. Il rischio (l’alea appunto, secondo uno dei significati del termine latino) è sempre in agguato, fa sempre parte del gioco. Se nell’atto della scrittura, nel momento ideativo del pezzo, il compito del compositore è quello di ridurre al minimo la possibilità di un suo stravolgimento, sta all’esecutore, poi, comprendere e vedere i limiti oltre i quali esso può verificarsi. Da qui emerge l’importanza di un altro aspetto della poetica musicale di Wolff: la sua vocazione pedagogica ed euristica. Pedagogica perché le sue composizioni, specialmente quelle indeterminate, sono innanzitutto un invito a prendere confidenza con un mondo sonoro del tutto nuovo, a prepararsi all’avventura di un’esperienza profondamente diversa da quelle che di solito l’interprete, anche abituato ad eseguire musica contemporanea, deve accingersi a fare. Euristica perché l’interpretazione dei segni e dei simboli usati dal compositore impone un ampio ventaglio di scelte, in quanto chiara e univoca solo da un punto di vista puramente lessicale: essa deve poi calarsi in contesti spesso problematici che devono a loro volta essere interpretati alla luce di altri fattori contingenti e che non si esauriscono e non possono esaurirsi in chiarimenti concettuali. Se nelle opere scritte tra il 1957 e il 1965 l’attenzione di Wolff è rivolta prevalentemente alla costruzione di un nuovo mondo sonoro e alla definizione delle sue caratteristiche interne, in quelle della seconda metà degli anni Sessanta, segnatamente dalla serie delle Electric springs I-III (1966-70), cominciano ad emergere tracce del fermento culturale e dei rivolgimenti sociali e politici che caratterizzarono quell’epoca e che saranno decisivi per l’ulteriore svolta stilistica del decennio successivo. Gli organici utilizzati nei tre pezzi (corno, chitarra elettrica, basso elettrico e contrabbasso nel primo; flauto dolce contralto, flauto dolce tenore, trombone, chitarra elettrica e basso elettrico nel secondo; violino, corno, chitarra elettrica e basso elettrico nel terzo), per quanto piuttosto bizzarri, ricordano infatti più da vicino le formazioni dei gruppi rock che quelle di musica classica. Sotto il profilo della notazione, pur rimanendo nel contesto dei cues e delle azioni coordinate tra gli esecutori, fanno la loro apparizione frammenti melodici indipendenti tra loro ma segnati con precisione su dei piccoli frames pentagrammati. Da un punto di vista più
genericamente estetico, infine, il piglio astratto e crittografico delle composizioni aleatorie più spinte lascia il posto a una maggiore perspicuità ritmico-melodica. Nel biennio 1967-68, approfittando di un congedo sabbatico, Wolff si trasferì a Londra dove visse e lavorò a stretto contatto con la scena sperimentale che in quegli anni si stava raccogliendo intorno al pianista e compositore Cornelius Cardew, vero e proprio trait d’union tra le esperienze avanguardistiche europee (collaborò attivamente alla stesura di Carré di Stockhausen) e quelle americane (fu tra i primissimi a promuovere in Europa la musica di Cage e di Feldman, oltre che di Wolff). I due si erano conosciuti a Colonia nel 1960, ma fu soltanto dalla seconda metà di quel decennio che cominciarono a collaborare in maniera più stretta e continuativa. Cardew era una personalità multiforme e onnivora, instancabile organizzatore di eventi, promotore culturale e raffinato pianista, aperto alle influenze più disparate e autore di opere di grande spessore (il suo Treatise può essere considerato la summa dell’alea europea): oltre ad aver animato una vivace scena musicale (della quale facevano parte, tra gli altri, i compositori David Bedford, Howard Skempton, Michael Parsons e Christopher Hobbs e il pianista John Tilbury), all’epoca collaborava assiduamente con gli AMM, uno dei gruppi più importanti della musica free, dedito all’improvvisazione totale. Per questa formazione Wolff compose Edges (1968), il suo brano più ‘aperto’, consistente unicamente di simboli di varia natura, sparsi su un’unica pagina, che fungono da riferimenti attorno ai quali si realizza l’improvvisazione. Durante il soggiorno londinese egli tenne inoltre numerosi seminari per varie istituzioni, soprattutto nelle scuole d’arte; per gli studenti di quest’ultime (tra i quali figurava un giovanissimo Brian Eno, che lo ingaggiò per una serie di incontri alla Ipswich Art School) elaborò alcune partiture verbali che, incrementate negli anni seguenti, avrebbero poi costituito la Prose collection (1968-71). Si tratta di un’importante raccolta concepita nello spirito di un approccio alla musica democratico e antigerarchico – che segna tra l’altro un momento importante nell’ambito della didattica musicale non tradizionale – costituita da una serie di brani realizzabili anche con mezzi rudimentali e alla portata di chiunque, musicista o non. Con intenti analoghi Cardew nel 1969 fondò insieme a Parsons e Skempton la Scratch Orchestra, un gruppo formato sia da musicisti di varia estrazione, provenienti dalla musica classica e dal Jazz, che da dilettanti e inesperti. Se per questo gruppo Cardew compose quello che è considerato da molti il suo capolavoro, The Great Learning (1968-70) per voci e strumenti su testi di Confucio, Wolff scrisse tra il 1970 e 1971 Burdocks, una delle sue opere più significative e la prima concepita per un ampio organico. L’esperienza della Prose collection e la collaborazione con la Scratch Orchestra rappresentarono un momento cruciale nell’attività compositiva di Wolff. La frequentazione assidua di compositori come Cardew e Rzewski risvegliò in lui un interesse sempre più marcato per le questioni etiche e politiche, in linea con le trasformazioni sociali che in quel periodo alimentavano il dibattito culturale sia in Europa che in America, dal movimento studentesco alle battaglie per i diritti civili, alle manifestazioni contro la guerra nel Viet Nam. A partire da Accompaniments (1972), per un pianista che oltre a suonare il proprio strumento deve anche suonare alcuni strumenti a percussione e cantare un testo tratto dal libro di J. Myrdal e G. Kessle China: the revolution continued, le riflessioni politiche si intrecciano a quelle musicali dando luogo a una svolta stilistica che feconderà gran parte della produzione del ventennio successivo e oltre. In un primo momento tale sintesi è veicolata dall’integrazione di testi di esplicito contenuto politico nel tessuto musicale. Sull’esempio di Accompaniments, Wolff inserisce infatti altri testi in alcune composizioni successive: in Changing the system (1972-73) per otto o più esecutori, che si avvale di un’intervista a uno studente militante apparsa sul mensile Rolling Stone; in Wobbly music (1975-76) per coro misto, una o più chitarre e due o più strumenti melodici, ispirata agli Industrial Workers of the World, il più importante movimento operaio americano, detto appunto dei wobblies, attivo nei primi decenni del secolo scorso. Infine in I like to think of Harriet Tubman
(1985) un pezzo per voce ed ensemble su testo della scrittrice femminista Susan Griffin. Dalla metà degli anni Settanta, con gli String quartet exercises out of songs (1974-76) Wolff inaugura una lunga serie di pezzi strumentali che traggono il materiale compositivo dal repertorio delle canzoni di protesta, trasformandone radicalmente gli elementi motivici, sia ritmici che melodici, attraverso processi di variazione continua che tendono in genere a nascondere o a rendere irriconoscibile la fonte originale – trasposizioni, diminuzioni, proliferazioni, scambi di voce, etc. – in un nuovo stile che richiama alcuni aspetti della musica di Satie (nell’uso non funzionale dell’armonia e nella rarefazione della texture) e di Ives (nel carattere eterofonico e politonale del contrappunto). Sul senso etico e politico di un certo modo di intendere la musica Wolff si sofferma in una sintetica dichiarazione scritta in calce al catalogo Peters delle sue opere. Per il compositore americano fare musica significa essenzialmente Trasformare la pratica musicale in un’attività collaborativa e trasversale (dall’esecutore al compositore all’ascoltatore al compositore all’esecutore, etc.), essendo il carattere cooperativo di tale attività la fonte stessa da cui scaturisce la musica. Sollecitare, attraverso la produzione di musica, la consapevolezza delle condizioni politiche nelle quali viviamo e delle modalità per mezzo delle quali esse potrebbero essere cambiate nella direzione di un socialismo democratico.
9
Ma la svolta stilistica degli anni Settanta non riguardò soltanto l’integrazione di testi o l’uso di materiali estrapolati da canzoni: anche gli aspetti più interni, legati alla scrittura, alla notazione e più in generale al linguaggio musicale subirono radicali trasformazioni rispetto al periodo aleatorio. L’introduzione di piccoli frammenti melodici ‘vaganti’ e autonomi, già attestata in alcune opere scritte nella seconda metà degli anni Sessanta, condurrà Wolff verso l’abbandono del grafismo e il recupero delle forme convenzionali di notazione, almeno per ciò che concerne le altezze e le durate (altri aspetti ‘secondari’ come la dinamica, l’agogica e il fraseggio sono ancora lasciati alla libera scelta dell’interprete). Tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta Wolff aveva attraversato una fase di transizione nella quale è riscontrabile una certa influenza del minimalismo di Young, Riley, Reich e Glass: in opere come Snowdrop (1970) per clavicembalo (e/o altri strumenti a tastiera), ad esempio, si trovano frammenti di scale continuamente ripetuti e variati, anche se svincolati dalla pulsazione regolare e dal diatonismo che sono le caratteristiche più evidenti del minimalismo americano; altre, come la serie dei Tilbury pieces 1-4 (1969-70) per organico imprecisato, presentano un materiale esiguo lasciato decantare lentamente in uno spazio statico e uniforme. Ma è con la prima serie degli Exercises 1-14 (1973-74) per tre o più strumenti, che Wolff mette definitivamente a punto un nuovo linguaggio compositivo. Nella loro originalità e freschezza, nell’atmosfera ludica e incantatoria che li pervade, essi costituiscono un esempio perfetto di quella che una volta John Cage definì come la “musica classica di una civiltà sconosciuta”.10 La maggior parte di essi consiste in semplici linee melodiche – o forse sarebbe meglio dire successioni di singoli suoni, dato il loro carattere antilirico e decisamente poco cantabile – lette contemporaneamente da tutti gli esecutori senza preoccuparsi troppo dell’omoritmia, anzi suggerendo a ciascuno di essi di mantenere un proprio tempo, per quanto non troppo diverso da quello degli altri; vengono così a crearsi dei leggeri e continui ritardi e anticipazioni che offuscano la nettezza del profilo lineare. Inoltre, la possibilità di leggere tali frasi in chiavi diverse o trasponendole di un tono, conferisce alla musica un aspetto estraniante: una sorta di organum triplo per seconde e seste parallele, articolato da un ritmo sbilenco, zoppicante. L’effetto di apparente imprecisione che ne risulta richiama l’interesse dichiarato da Wolff per generi e stili musicali che fanno un largo uso dell’eterofonia, dal Jazz dei primordi (il Dixieland) alla musica del pigmei Ba-Benzele.
9 Cfr. il catalogo Peters degli anni Ottanta, ad nomen.
10 L’osservazione di Cage è riportata in CH. WOLFF, Cues, op. cit., p. 10.
Come è stato per molti altri compositori della sua generazione, passati attraverso le esperienze più radicali delle cosiddette seconde avanguardie, anche il linguaggio musicale di Wolff non ha subito, fino ad oggi, nuove e significative svolte stilistiche dopo quella degli anni Settanta. Le quattro fasi principali che ha attraversato la sua opera (minimalista, complessa, aleatoria ed ‘eterofonica’ – chiamiamola così, non riuscendo a trovare migliore definizione) sono comprese nei primi vent’anni dei suoi sessanta di attività. Si può semmai registrare, dalla metà circa degli anni Ottanta, un diradamento delle composizioni ispirate a più o meno espliciti contenuti politici e l’uso promiscuo di tutte le forme di notazione escogitate fino ad allora, in una dimensione eclettica che sintetizza le esperienze delle opere precedenti.
*** Nella prefazione alla prima edizione degli scritti di Wolff, Rzewski parla della musica del suo collega come di una “algebra della vita quotidiana”, rimarcandone il carattere insieme ambiguo e intrigante: Il primo incontro con la musica di Christian Wolff ci lascia con l’impressione di avere appena ascoltato (o eseguito, o letto) qualcosa di incredibilmente strano e diverso da tutto il resto. Eppure, se ci si riflette, si comprende che essa è allo stesso tempo qualcosa di assolutamente normale e ordinario, che ci è familiare come le azioni che compiamo nella vita di tutti i giorni.
11
Non dotata del fascino e della presa immediata che caratterizzano molta musica di Feldman, né dell’indubbia teatralità di quella di Cage, la musica di Christian Wolff si è conquistata lentamente, nell’ombra, il favore di un pubblico sempre più ampio di ascoltatori e di esecutori, come dimostrano le sempre più numerose esecuzioni di sue opere in tutto il mondo e l’ormai ampio catalogo di pubblicazioni discografiche che è venuto componendosi soprattutto negli ultimi dieci anni. La sua influenza sotterranea su generazioni di compositori di varia estrazione e provenienza, da Cardew a Rzewski, da John Zorn ai Sonic Youth, e il riconoscimento del suo valore e della sua originalità fanno di essa un punto di riferimento nel panorama internazionale della musica sperimentale e di ricerca, sotto molti aspetti ancora vivo e vegeto nonostante le apparenze contrarie.
11
Ibid.