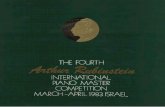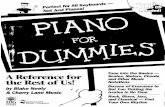Piano Intercomunale della Mobilità Sostenibile
-
Upload
uni-dortmund -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Piano Intercomunale della Mobilità Sostenibile
1
AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
Corso di Porta Vittoria, 27 – 20122 Milano
DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – 20126 Milano
PIANO INTERCOMUNALE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
– RAPPORTO FINALE –
Luglio 2011
2
Il Progetto è stato realizzato nel periodo aprile 2009-luglio 2011. Progetto cofinanziato dalla FONDAZIONE CARIPLO Area Ambiente Bando 2008 Azione: Promuovere forme di mobilità sostenibile alternative all'auto privata
Ente Capofila: Provincia di Milano - Area Infrastrutture e Mobilità In partenariato con:
- Comune di Arese - Comune di Bollate - Comune di Garbagnate Milanese - Comune di Lainate - Comune di Pero
Con la consulenza scientifica dell’Università degli Studi di Milano Bicocca Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale1 Con il supporto gestionale del Centro di Iniziativa Europea di Milano
1 In dettaglio per l’Università di Milano Bicocca hanno eseguito i lavori la prof.ssa Francesca Zajczyk (coordinamento
scientifico), i prof. Mario Boffi e Matteo Colleoni, l’architetto Andrea Airoldi, l’ingegnere Stefano Bardo e i dott. Giulio Mattioli e Clara Melzi.
3
INDICE
1. Finalità, obiettivi e azioni del Progetto (pag. 6) 1.1 - Finalità 1.2 - Obiettivi 1.3 - Azioni 1.4 - Risultati attesi 2. Introduzione alla mobilità sostenibile (pag. 8) 2.1 - Mobilità sostenibile e qualità ambientale 2.2 - Mobilità sostenibile e ricadute economiche 2.3 - Il mobility management
2.4 - Quadro normativo di riferimento per la mobilità sostenibile in Italia 3. Relazione tra Piano Intercomunale della Mobilità Sostenibile e strumenti di settore (pag.11)
3.1 - Inquadramento: necessità di un Piano Intercomunale della Mobilità Sostenibile 3.2 - Le caratteristiche del Piano: principali contenuti e metodologia 3.3 - Gli strumenti di settore 3.4 - Collocazione del Piano tra gli strumenti di settore vigenti
4. Contesto territoriale (pag. 18) 4.1 - Inquadramento infrastrutturale, servizi di trasporto offerti e accessibilità 4.2 - Expo 2015: scheda degli interventi infrastrutturali previsti sul territorio 4.3 - Area ex Alfa Romeo: scheda del progetto di trasformazione dell’area 5. Pianificazione di settore vigente (pag. 23)
5.1 - Indicazioni sulla pianificazione di settore vigente 5.2 - Comune di Arese
5.3 - Comune di Bollate 5.4 - Comune di Garbagnate Milanese 5.5 - Comune di Lainate 5.6 - Comune di Pero
5.7 - Prime considerazioni sui Piani esaminati 6. Best practice di mobilità sostenibile nel territorio (pag. 32)
6.1 - Introduzione 6.2- Comune di Arese Arese in movimento
6.3- Comune di Bollate Servizio di bike sharing e rete delle piste ciclabili Pedibus
6.4 - Comune di Garbagnate Milanese Rete di percorsi ciclabili 6.5 - Comune di Lainate Piedibus Rinnovo del parco veicolare dell’ente con criteri ecosostenibili 6.6 - Comune di Pero Servizio di trasporto pubblico Servizio di trasporto aziendale
4
6.7 - Provincia di Milano Coordinamento Intercomunale d’Area sulla Mobilità Sostenibile Bollettini periodici MMNews Gasati (incentivi per la trasformazione a Gpl/metano)
Eco_spes@ (spesa on line)
7. Metodologia per la stima delle emissioni prodotte dai veicoli durante gli spostamenti casa lavoro (pag. 38)2 - Premessa - Inquadramento - Descrizione delle sorgenti di inquinamento - Metodo di stima - Funzioni per il calcolo dei fattori di emissione - Metodologia per la stima del PM non esausto - Procedura per la stima delle emissioni - Qualità dei dati - Riferimenti bibliografici e siti Internet 8. Risultati dell’applicazione della stima delle emissioni (pag. 84) - Introduzione
- L’indagine - Stima della velocità media - Stima dei consumi di carburante - Stima dei dati ambientali - Stima dei giorni di lavoro in un anno - Suddivisione in classi del parco veicolare - Stima delle emissioni - Conclusioni ‐ Riferimenti bibliografici e siti Internet
9. Profili e caratteristiche della mobilità dei dipendenti (pag. 96) 9.1 - Finalità e obiettivi di indagine 9.2 - Metodo di indagine
9.3 - Caratteristiche socio demografiche 9.4 - Profili e caratteristiche della mobilità dello spostamento casa lavoro 9.5 - Percezioni ed atteggiamenti in tema di mobilità 9.6 - Orari e spostamenti in orario di lavoro 9.7 - Mezzi e consumi per la mobilità 9.8 - Morfologia della mobilità: ipotesi di approfondimento 9.9 - Sintesi dei principali risultati 9.10 - Conclusioni
10. Analisi territoriale (pag. 173) 11. Linee di azione (pag. 175) 11.1 - Buone pratiche nei comuni 11.2 - Aree problematiche e proposte operative 2 I capitoli 7 e 8 non riportano nell’indice la numerazione dei paragrafi e dei sotto-paragrafi avendo l’autore adottato
una numerazione specifica, alla quale si rinvia nel testo.
6
1. Finalità, obiettivi, azioni e risultati attesi del Progetto 1.1 - Finalità
Il progetto è finalizzato a coinvolgere enti pubblici in buone pratiche di mobilità, attraverso la realizzazione di uno studio, la redazione di un Piano intercomunale della mobilità sostenibile e la sua applicazione su un’area campione del territorio milanese. Esso consiste in primo luogo nella predisposizione di uno strumento di indagine finalizzato a raccogliere i dati necessari a stimare le emissioni prodotte dai flussi di traffico casa-lavoro, a reperire le informazioni utili a tracciare il profilo di mobilità di chi si sposta per motivi di lavoro e a conoscere le motivazioni alla base della scelta dei mezzi di trasporto. Sulla base dei risultati dello studio verrà redatto un Piano intercomunale della mobilità sostenibile finalizzato a proporre interventi idonei a modificare le pratiche di mobilità per lavoro del personale. Il Piano raccoglie e mette a sistema le istanze locali, interagisce con gli strumenti pianificatori e di settore vigenti, adotta una metodologia di riferimento per la valutazione delle attività di mobility management e propone azioni concrete modellate sui profili di mobilità individuati. 1.2 - Obiettivi In dettaglio il Progetto si pone i seguenti obiettivi:
• integrare nell’ambito degli studi sulla mobilità sostenibile i campi di ricerca ambientale e sociologico;
• elaborare un Piano intercomunale della mobilità sostenibile che integri e sviluppi le azioni di mobility management previste, in accordo con le politiche delle Amministrazioni coinvolte, con l’intento di ridurre la frammentazione degli operatori che agiscono sul tema e di sviluppare sul territorio la presenza di una rete di tecnici ed esperti di mobilità;
• definire un metodo efficace per la stima delle emissioni (CO2, PM10, COV ed altri agenti inquinanti) prodotte dai trasporti su gomma negli spostamenti casa-lavoro;
• conoscere le motivazioni alla base delle scelte di mobilità sistematica dei dipendenti e costruire il loro profilo spazio-temporale degli spostamenti;
• promuovere interventi concreti per una mobilità più sostenibile, valutarne l’efficacia e l’efficienza attraverso la realizzazione di un appropriato monitoraggio;
• incrementare la consapevolezza nei dipendenti e in tutti i cittadini che la lotta ai cambiamenti climatici e all’inquinamento si esercita attraverso il contributo individuale, che si manifesta anche attraverso cambiamenti di comportamento.
Per la definizione di metodologia e obiettivi la Provincia di Milano si è avvalsa delle competenze dell’Università Bicocca, così come previsto nell’ambito delle attività del Coordinamento Intercomunale d’Area della Mobilità Sostenibile promosso dall’ente provinciale, cui aderisce l’Università. 1.3 - Fasi di lavoro Le fasi di lavoro sono due:
7
1) Nella prima fase si prepara e si realizza l’indagine sulle motivazioni, sui profili e le caratteristiche di mobilità dei dipendenti e sulle emissioni prodotte dai veicoli privati negli spostamenti casa-lavoro; 2) Nella seconda fase viene predisposto il Piano intercomunale della mobilità sostenibile, il cui processo di redazione vedrà il coordinamento di tavoli di lavoro sul tema che favoriranno una partecipazione collegiale alla stesura del Piano, la selezione di interventi di mobilità sostenibile con riguardo al contesto e alle informazioni raccolte e la realizzazione della valutazione del Progetto, con attenzione alle sue diverse fasi e con l’ausilio di indicatori ex-ante, di processo, ex-post. 1.4 - Risultati attesi I principali risultati attesi sono:
1. l’elaborazione di un metodo e di tecniche validi per la stima e il controllo del livello di emissione prodotta dal traffico (con riferimento all’allegato 2 del D.M. 01/10/2002 n. 261), con un numero massimo di elaborazioni previste pari a 1.100 stime;
2. la rilevazione on line delle motivazioni e dei profili di mobilità dei lavoratori finalizzati all’adozione di stili di mobilità sostenibili;
3. la redazione del Piano intercomunale della mobilità sostenibile condiviso dagli enti partner del Progetto ma anche da un gruppo rappresentativo di associazioni di categoria che opera sul territorio. Il Piano è finalizzato a proporre (e applicare) azioni, procedure, interventi e servizi di mobilità sostenibile coerenti con i bisogni e i profili degli spostamenti rilevati;
4. la creazione di un sistema di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del Progetto; 5. la diffusione della cultura della mobilità sostenibile attraverso il coinvolgimento diretto
dei dipendenti e dei cittadini dei comuni dell’area territoriale di sperimentazione.
8
2. Introduzione alla mobilità sostenibile 2.1 - Mobilità sostenibile e qualità ambientale La crescente attenzione al tema dei cambiamenti climatici e all’inquinamento atmosferico delle aree urbane suggerisce di introdurre quanto prima nel settore dei trasporti iniziative adeguate per la soluzione delle criticità ambientali. Documenti europei (Linee guida europee per la redazione degli inventari delle emissioni, 2006) affermano che “nel 2005 i trasporti (escluso quelli aerei e marittimi) hanno contribuito per circa il 21% del totale delle emissioni di gas serra nell’Europa a 15 Stati. Il confronto tra i dati del 2005 e quelli del 1990 ha evidenziato, inoltre, un aumento del 23% delle emissioni di CO2.” L’Unione Europea ha posto da tempo il tema delle aree urbane sotto la luce dei riflettori per la necessità di trovare nuove risposte alle criticità riscontrate. Il binomio sostenibilità-città si è venuto progressivamente rafforzando nella politica dell’Unione Europea, sempre più interessata a promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. La dispersione localizzativa, fenomeno definito in termini tecnici come sprawl urbano, genera un aumento delle distanze da percorrere per svolgere le attività quotidiane e soddisfare i propri bisogni. La necessità di connettere luoghi distanti, o difficilmente accessibili con il trasporto pubblico, provoca un incremento degli spostamenti con il mezzo privato. La proliferazione di funzioni e di servizi genera una moltiplicazione degli spostamenti con il risultato che il traffico veicolare è sempre più invasivo e determina una pressione molto forte sull’ambiente urbano, sia per la molteplicità degli impatti, sia per la loro intensità. Secondo quanto rilevato dall’indagine Origine/Destinazione 2002 della Regione Lombardia, circa tre spostamenti su quattro riguardano il mezzo privato (il 72,2% degli spostamenti totali è effettuato in auto o in moto; questa quota cresce al 76,4% se si considerano unicamente gli spostamenti verso la sede di lavoro) e che quotidianamente i movimenti in auto che hanno origine e destinazione in provincia di Milano sono oltre tre milioni. Le ricadute ambientali sono significative: si stima che circa il 15% della CO2 prodotta in Italia sia immessa in atmosfera in Lombardia e, di questa, circa 1/3 nella sola provincia di Milano (fonti: ministero dell’Ambiente, ARPA). 2.2 - Mobilità sostenibile e ricadute economiche La Commissione Europea, nell’adottare il Piano di azione per l’efficienza energetica (2007-2012) ha stabilito come obiettivo di ridurre la domanda di energia (nonché agire in maniera mirata sul consumo e sull’approvvigionamento) per diminuire del 20% il consumo annuo di energia primaria entro il 2020 (rispetto alle proiezioni sul consumo energetico per il 2020), oltre a ricavare il 20% del fabbisogno energetico complessivo da fonti rinnovabili. La necessità di occuparsi dei trasporti con un approccio sostenibile e innovativo non deriva solo da motivi etici o ambientali: In Europa il 30% dei consumi energetici è dovuto ai trasporti, di cui il 73% al trasporto su gomma. I trasporti stradali dipendono per il 98% dal petrolio, e il 70% del petrolio utilizzato in Europa è importato da altre parti del mondo (Unione Europea, Libro Bianco sui trasporti). In Italia oltre il 30% dell’energia utilizzata, pari a circa 45 Mtep (Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), è assorbita dal settore dei trasporti, e ricerche autorevoli sottolineano che in Italia una quota vicina al 2% del PIL (dato OCSE) è persa a causa dei problemi connessi ai trasporti stradali,
9
ovvero traffico, incidentalità e dispersione di tempo, inquinamento, consumi energetici, costi sanitari e sociali. 2.3 - Il mobility management Il mobility management è primariamente un approccio orientato alla gestione della domanda di mobilità, che sviluppa e implementa concetti e strategie volti ad assicurare la mobilità delle persone e il trasporto delle merci in modo efficiente, con riguardo particolare a scopi sociali e ambientali (tale definizione è contenuta nei rapporti finali dei progetti Mosaic e Momentum, promossi dall’Unione Europea). Costituiscono componenti fondamentali del mobility management l’implementazione di politiche, di azioni e di progetti mirati a promuovere uno sviluppo urbano sostenibile anche attraverso importanti opere di comunicazione e sensibilizzazione; il coordinamento tra enti pubblici e imprese private e tutte le forme di partenariato tra soggetti diversi di supporto al cambiamento della percezione (e del comportamento) rispetto alle modalità di trasporto eco-compatibili. Le misure proprie del mobility management sono definite “soft”, in quanto non prevedono la realizzazione di nuove infrastrutture, ma piuttosto la creazione di nuove partnership e la realizzazione di una serie di strumenti di supporto e sensibilizzazione. Il mobility management, per dare risposte efficaci alle problematiche precedentemente ricordate, si avvale in prevalenza di misure classificabili in due principali categorie:
a. interventi migliorativi della situazione; b. azioni finalizzate alla comunicazione.
Gli interventi (a.) sono a loro volta riconducibili a tre distinte tipologie, a seconda del modello di regolazione e del grado di coercizione espresso dall’intervento medesimo; tali modalità di azione prendono il nome di:
a.a. interventi di persuasione (per esempio, azioni che hanno l’obiettivo di creare la consapevolezza del problema e di modificare le abitudini quotidiane dei cittadini);
a.b. interventi di concessione (per esempio, azioni che hanno l’intento di rafforzare l’offerta di trasporto collettivo e di fornire nuovi servizi e agevolazioni ai cittadini; azioni di promozione dell’intermodalità);
a.c. interventi di restrizione (per esempio, azioni di disincentivazione dell’uso individuale dell’auto privata; azioni di limitazione alla circolazione; azioni che prevedono l’introduzione di tariffazioni).
La comunicazione (b.), presupposto indispensabile per il conseguimento degli obiettivi del mobility management, si divide in:
b.a. attività di informazione agli utenti (preceduta dall’individuazione del target), con la distribuzione di informazioni esaustive e mirate facenti leva sulla necessità di sostenibilità e su motivazioni a carattere prevalentemente culturale;
b.b.attività di coordinamento dei diversi soggetti pubblici e privati, per sottoscrivere intenti comuni e sviluppare sinergie su progetti specifici.
Nato come un insieme di tecniche per ottimizzare l’uso delle infrastrutture e razionalizzare gli spostamenti, il mobility management, è stato negli ultimi anni investito di attenzione crescente a seguito dell’interesse maturato intorno alle problematiche ambientali: nella politica del mobility è stata individuata una possibile soluzione per limitare il problema dell’inquinamento e del consumo energetico in chiave locale. Infatti le politiche di mobility management sviluppano, consolidano e diffondono la cultura della mobilità sostenibile, esprimono una visione ecologica e sono orientate ad uno sviluppo sostenibile.
10
2.4 - Quadro normativo di riferimento per la mobilità sostenibile in Italia Con la firma del Protocollo di Kyoto il Governo Italiano ha assunto in sede internazionale l’impegno di ridurre del 6,5% le emissioni di gas serra entro il 2010 (rispetto ai valori del 1990). Il Ministero dell’Ambiente, recependo tale impegno nel contesto nazionale, tra le varie iniziative intraprese ha posto l’attenzione sul mobility management con il Decreto “Mobilità Sostenibile nelle Aree Urbane” del 27 marzo 1998 (più noto come Decreto Ronchi, dal nome dell’allora Ministro in carica), approccio alla gestione della mobilità (in particolare sistematica) che, come visto poco sopra, consiste nell’implementare progetti e politiche con l’obiettivo di governare la domanda di mobilità ottimizzando e razionalizzando gli spostamenti di persone e merci. Il D.M. 27/03/1998, oltre ad indicare una serie di misure per limitare l’emissione di agenti inquinanti nell’atmosfera, istituisce la figura del responsabile della mobilità aziendale (mobility manager), con l’obiettivo di coinvolgere le imprese nella progettazione e nella gestione di soluzioni a basso impatto ambientale, e dispone che tutte le aziende di medie e grosse dimensione (con oltre 300 dipendenti per unità locale o con complessivamente oltre 800 addetti distribuiti su più unità locali) debbano identificare il proprio mobility manager e debbano dotarsi di uno strumento per l’ottimizzazione degli spostamenti sistematici del personale (il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro – PSCL), puntando soprattutto sulla riduzione dell’uso individuale dell’auto privata. Il successivo Decreto ministeriale del 20 dicembre 2000 ha istituito presso gli enti locali la figura del mobility manager d’area, che si occupa di mettere a sistema le singole esperienze e di implementare interventi di carattere spiccatamente pubblico. Con il Decreto del 21 dicembre 2000 il Ministero ha esteso l’ambito territoriale di riferimento del mobility manager d’area a tutte le zone in cui esiste una elevata concentrazione di spostamenti di persone o merci ed a tutte le aziende, o ad altri attrattori, che fanno parte della stessa area. Sono stati inseriti fra i soggetti interessati anche luoghi di divertimento, scuole, ospedali, stadi sportivi, manifestazioni periodiche.
11
3. Relazione tra Piano intercomunale della mobilità sostenibile e strumenti di settore 3.1- Inquadramento: necessità di un Piano Intercomunale della Mobilità Sostenibile L’analisi dello stato della mobilità nelle aree urbane mostra che gli spostamenti sono sempre più articolati e frammentati, e che tale complessità è dovuta ad una molteplicità di profili di mobilità (elemento evidenziato dalla scomposizione del volume complessivo dei movimenti): la gestione della domanda di mobilità impone quindi il ricorso ad azioni mirate, integrate fra di loro a scala sovracomunale, per intercettare flussi diversificati che si intersecano sul territorio. Le politiche di mobility management risultano particolarmente idonee nella gestione del traffico veicolare, soprattutto qualora applicate in modo sistemico per affrontare le criticità diffuse in territori densamente conurbati. Definito quindi la strategia operativa e i riferimenti teorici, bisogna comprendere quale sia lo strumento più idoneo per governare la questione mobilità. Tale strumento dovrebbe ricostruire la situazione della mobilità a scala intercomunale e chiarire come l’approccio del mobility management può, allo stato attuale del traffico e sulla base delle analisi degli spostamenti sistematici, limitare le esternalità negative prodotte dai principali attrattori di traffico su una porzione di territorio vasta; per la sua portata, dovrebbe essere un documento che interessa sia i Comuni che le imprese, sia i residenti che le popolazioni pendolari, in un’ottica partecipativa (ad esempio, anche con riferimento a quanto contenuto nel Testo Unico sull’Ambiente D.Lgs. 152/2006 successivamente integrato dal D.Lgs. 4/2008, e in ambito regionale a quanto indicato dalla L.R. Lombardia 12/2005). Occorre riconosce come il tradizionale approccio al tema della pianificazione dei trasporti, sia sempre più inadeguato e incapace di far fronte all’evoluzione quantitativa e qualitativa della domanda di mobilità. Lo stato di crisi della mobilità va probabilmente affrontato con nuove politiche e nuovi strumenti, che devono scaturire dal confronto tra tutti gli attori interessati. È possibile, nonché auspicabile, che dal confronto tra punti di vista non scontati scaturiscano modelli che si avvalgono di modalità di intervento inedite ed esportabili in altri contesti, per trattare problemi al momento irrisolti. Poiché la mobilità negli ultimi anni ha assunto connotati nuovi, e innovativo è l’approccio del mobility management, forse può essere una strada fertile concepire anche strumenti originali per la gestione della mobilità (piano d’area), ma sarebbe un errore pensare che la soluzione stia nel creare strumenti a getto continuo, che invece devono essere pochi e appropriati. Con la consapevolezza, quindi, che non serve ampliare all’infinito il numero degli strumenti, rivolti alla risoluzione di problemi specifici, si sottolinea l’importanza di individuare soluzioni con una visione organica e non convenzionale, possibilmente in grado di risolvere in modo integrato ed efficace un problema complesso. Le buone pratiche, avviate all’inizio del decennio scorso dai progetti pilota del Ministero dell’Ambiente, e le esperienze innovative più significative, promosse dagli enti locali e sperimentate con discreto successo in diverse aree urbane, si sono sufficientemente sedimentate. Si sono ormai compresi contenuti, metodi e processi delle attività di mobility management: è giunto probabilmente il momento di espandere queste pratiche in contesti estesi, e di ricomprendere i progetti avviati in uno strumento di pianificazione, con un ampliamento verso confini più ampi di interventi fino ad ora puntuali, in una logica di innovazione e integrazione. Inoltre, la crescente attenzione posta ai cambiamenti climatici, prodotti in larga misura dall’immissione antropica di CO2 in atmosfera (sotto questo aspetto il peso dei trasporti su gomma
12
è rilevante), e l’allarme continuo sulla bassa qualità dell’aria nelle aree metropolitane, dovuta alle emissioni di agenti inquinanti quali il PM10, ecc, impongono alla classe politica di provvedere con interventi strutturali, anche per non incorrere nelle infrazioni previste dall’Unione Europea in materia. Di conseguenza, appare appropriato interrogarsi su come il mobility management possa costituire il perno di un documento di pianificazione che instauri un dialogo fertile con gli strumenti urbanistici e di settore vigenti, recependone le indicazioni e proponendo a sua volta temi, suggestioni e proposte concrete. In un quadro così delineato, la via più promettente pare la realizzazione dei “piani della mobilità sostenibile a scala vasta” per creare un quadro sinottico, per sviluppare sinergie, per riconoscere un “potere” al mobility manager d’area. Questa soluzione è una via suggestiva, forse rischiosa da intraprendere in quanto non trova conferme in esperienze pregresse, ma anche logica in quanto l’innovativo campo della mobilità sostenibile, che si pone in rottura con il paradigma odierno, ha bisogno di strumenti propri. È dunque in questo quadro complesso che si colloca l’esperienza del Piano Intercomunale della Mobilità Sostenibile, documento sviluppato con l’intento di individuare azioni specifiche che contrastino le criticità riscontrate, come uno strumento integrato, a più scale, che nasce in ambito locale ma in grado di agire in un contesto allargato e capace di ricucire i singoli progetti dispersi sul territorio costruendo scenari per l’azione. Una raccomandazione sull’atteggiamento da assumere in fase di redazione del Piano pare d’obbligo: più che seguire la strada di fornire indicazioni numerose ma eccessivamente vaghe, oppure praticare la via più percorsa, di definire elementi prescrittivi che si rivelano troppo spesso sterili, serve ricomprendere in un unico documento, volto a costruire scenari strategici in base ai quali orientarsi, tutte le azioni di mobilità sostenibile già in essere e che saranno individuate sulla base dei risultati emersi dagli studi analitici. 3.2 - Le caratteristiche del Piano: principali contenuti e metodologia Il Piano Intercomunale della Mobilità Sostenibile è un Piano incentrato sui temi della sostenibilità sul lungo periodo, ovvero un Piano che fa propri i principi del mobility management: ciò dà modo di sviluppare una strategia ideale per un uso ottimale delle infrastrutture esistenti, per un’armonizzazione degli investimenti (per la programmazione di quegli interventi, anche “hard”, come gli interscambi, volti comunque ad una riduzione dell’uso dell’auto) e per una razionalizzazione degli spostamenti. È possibile stabilire alcune delle caratteristiche che ha avere il nuovo piano, non con l’intento di costruire una lista esaustiva, ma piuttosto di richiamare alcuni principi irrinunciabili per salvaguardare l’efficacia dello strumento. I tratti ineludibili del piano sono l’orizzonte temporale di medio periodo, la permeabilità all’introduzione di progetti innovativi, la possibilità di contenere alcuni margini adattativi nell’implementazione degli interventi dovuta all’apprendimento sul campo (learning by doing) e a un’inclusione progressiva nel piano stesso di nuovi progetti, un’adeguata flessibilità nella combinazione dei progetti contenuti improntata a una ricomposizione degli assetti territoriali. Il Piano si deve definire come strumento di partecipazione e concertazione tra Provincia, amministrazioni locali e tessuto imprenditoriale. I documenti di pianificazione di scala comunale dovrebbero relazionarsi con le indicazioni contenute in questo Piano: ciò significa produrre un lavoro complesso, che coniuga strategie a larga scala e decisioni a livello micro, con una preziosa
13
opera di raccordo tra soggetti che devono interfacciarsi e scelte che devono essere tutti orientate verso una maggiore sostenibilità. La metodologia utilizzata ha carattere sperimentale, vista la limitatezza di esperienze paragonabili nel panorama nazionale. Occorre pertanto procedere, per passi successivi, alle seguenti operazioni:
- individuazione di una metodologia di raccolta e trattamento dei dati; - costituzione di un elenco di elementi da tenere in considerazione per definire e precisare le
zonizzazioni e individuare comparti omogenei in cui intervenire; - stesura di un indice tipo (con alcuni margini di flessibilità); - individuazione dei contenuti e formalizzazione della struttura di Piano (in parte come
mosaico di esperienze preesistenti e buone pratiche, in parte costituito da elementi propri). Se per l’elaborazione aggregata dei dati raccolti dalle indagini è possibile richiamare altre esperienze già mature nel settore dei trasporti, si incontrano problematiche maggiori nella definizione di un modello per l’organizzazione, l’armonizzazione e il coordinamento delle azioni previste nei PSCL aziendali, e ancora inesplorata appare l’individuazione di indicatori appropriati per la valutazione e la revisione di un piano della mobilità sostenibile a scala vasta. Infine, si richiama all’attenzione la necessità di predisporre metodologie applicabili in territori circoscritti per la stima delle emissioni di CO2, affinché questo parametro diventi elemento di valutazione tecnica-politica in fase decisionale rispetto agli interventi di mobilità proposti. 3.3 - Gli strumenti di settore È opportuno ricostruire il quadro in cui si opera per chiarire come si inserisce il Piano Intercomunale della Mobilità Sostenibile e comprendere le aspettative di cui investire il Piano, a partire dalle relazioni con gli strumenti vigenti. Lo schema proposto ricostruisce lo stato attuale della strumentazione in materia di trasporti, sia come programmi di indirizzo che come piani operativi. Riportiamo lo specchietto degli strumenti di settore (e di riferimento) vigenti, seguiti da un breve commento:
• PGTL, Piano Generale dei Trasporti e della Logistica • PRMT, Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti • PTCP, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale • PPBMT, Piano Provinciale di Bacino della Mobilità e dei Trasporti • PTVE, Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana • PUM, Piano Urbano della Mobilità • PUT, Piano Urbano del Traffico • PTOOPP, Piano Triennale delle Opere Pubbliche • PTS, Piano Triennale dei Servizi • Piani annuali • PUP, Piano Urbano dei Parcheggi • Piani mobilità ciclabile • Piani d’Area (es: per temi o per la gestione di grandi eventi)
14
Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) a livello nazionale e il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) a livello regionale definiscono gli assetti delle reti e fissano gli scenari di sviluppo del territorio in materia di infrastrutture, logistica e mobilità. A livello provinciale vi è il Piano Provinciale di Bacino della Mobilità e dei Trasporti (PPBMT), un piano strategico di medio-lungo termine che definisce la programmazione degli interventi infrastrutturali e dei servizi, con la finalità di conseguire un riequilibrio modale dei trasporti e migliorare l’accessibilità al sistema economico e insediativo provinciale. Questo Piano viene redatto dalle Province e approvato dalle stesse, dopo consultazioni con gli enti locali interessati e nel rispetto degli indirizzi trasmessi dalla Regione attraverso il PRMT. Il PPBMT definisce dunque gli interventi prioritari per il sistema infrastrutturale e della mobilità a scala provinciale, in accordo con le prescrizioni di sviluppo e tutela del territorio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e con le indicazioni sugli impegni di spesa previsti per le infrastrutture, contenute nel Piano Triennale della Opere Pubbliche (PTOOPP). Le variazioni previste alla rete di trasporto pubblico, secondo le indicazioni contenute nel PPBMT, vengono inserite nel Programma Triennale dei Servizi (PTS) e recepite dal Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana (PTVE), strumento che si compone di varie schede attuative. Il PTS è uno strumento di programmazione di breve termine adottato dalle Province e successivamente dalla Regione competente, finalizzato alla riorganizzazione della rete del trasporto pubblico e alla seguente suddivisione in sottoreti. Il PTVE è uno strumento di breve termine, adottato dalle Province, finalizzato a perseguire il miglioramento della circolazione stradale, la riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico e il risparmio energetico sulle infrastrutture di trasporto esistenti. Per quanto riguarda la gestione della mobilità in area urbana, lo strumento di riferimento è il Piano Urbano della Mobilità (PUM), strumento programmatico di durata decennale al quale si devono raccordare i Piani Urbani del Traffico (PUT), introdotti nel 1992 dal nuovo Codice della Strada come strumenti di regolamentazione di breve periodo della mobilità su scala urbana. Il PUT è un piano tattico di durata biennale, mentre il PUM è un piano strategico che racchiude le opere necessarie per trattare le criticità irrisolvibili con il PUT. Si approfondiscono ora i due strumenti principali di riferimento nell’organizzazione e gestione della mobilità, il PUM e il PUT. In Italia un primo tentativo di integrazione tra ottica dei trasporti e struttura insediativa è stato compiuto nel 1992, con il nuovo Codice della Strada, che introduce il Piano Urbano del Traffico (PUT) come strumento di regolamentazione e gestione di breve periodo della mobilità su scala urbana per tutti i Comuni con più di 30.000 abitanti (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, art. 36). (“All’obbligo (…) sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell’anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale” (art. 36, comma 2). In assenza di altre indicazioni, si lascia intendere che vi è facoltà di redazione per i Comuni al di sotto dei 30.000 abitanti non compresi tra quelli di cui all’art. 36 comma 2.) Con l’istituzione dei PUT si è espressa la volontà di coordinare le opere stradali e governare il traffico al fine di raggiungere sei classi di obiettivi: - il miglioramento delle condizioni di circolazione; - il miglioramento della sicurezza stradale; - la riduzione degli inquinamenti atmosferico e acustico; - il risparmio energetico; - l’accordo con gli strumenti urbanistici e con i piani dei trasporti vigenti; - il rispetto dei valori ambientali.
15
I PUT hanno tuttavia visto interpretazioni distanti dai principi originari per i quali sono stati creati: se qualche successo è stato conseguito in termini di miglioramento delle condizioni di circolazione e di miglioramento della sicurezza stradale, si rileva comunque una connotazione programmatoria scevra di una “visione” del futuro e una certa inefficacia soprattutto in merito alle capacità di tutela ambientale, di previsione e mitigazione dei fenomeni di inquinamento acustico ed atmosferico, di sviluppo di politiche e progetti integrati tra pianificazione urbanistica e pianificazione dei trasporti. Nel 2001 il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica introduce il Piano Urbano della Mobilità (PUM), che deve essere predisposto dai Comuni con più di 100.000 abitanti e può anche avere natura intercomunale, ovvero essere un piano sviluppato e condiviso da Comuni con un numero inferiore di abitanti, aggregatisi per sviluppare scenari condivisi. Il Piano Urbano della Mobilità è predisposto con la collaborazione di tutti i settori tecnici comunali e approvato dal Consiglio Comunale: è un progetto strategico, con un forte volume di investimenti e che si muove nell’orizzonte delle scelte attuabili e dei progetti avviabili entro dieci anni. È dunque uno strumento di pianificazione ben diverso per struttura e concezione dal Piano Urbano del Traffico che, per sua natura, non dà obiettivi di riassetto infrastrutturale ma punta solo a razionalizzare le strutture esistenti. I PUM, tuttavia, riportano troppo spesso un elenco omnicomprensivo di interventi senza definire priorità e sono talvolta interpretati come semplici studi del traffico, incapaci di legare pianificazione e mobilità. Il PUT non ha dunque raggiunto gli esiti auspicati nell’organizzare le politiche per la mobilità; il PUM è potenzialmente più interessante ma non si dedica sufficiente spazio al suo interno per contemplare discorsi di mobilità sostenibile, dando in prevalenza indicazioni sullo sviluppo delle infrastrutture (azioni hard di incremento dell’offerta di trasporto). Se si considera che gli strumenti previsti dalla normativa non dedicano sufficiente spazio ai temi della mobilità sostenibile e, nelle pratiche, hanno scarse possibilità di mettere a sistema le singole esperienze in favore della mobilità sostenibile, allora il percorso di definizione di uno strumento per la gestione della mobilità (e la sua collocazione nella scacchiera degli strumenti vigenti) appare rilevante per sviluppare scenari per l’azione, controllare il traffico, governare gli spostamenti e proporre politiche orientate ad una gestione della mobilità basata sull’approccio del mobility management. 3.4 - Collocazione del Piano tra gli strumenti di settore vigenti Uno sguardo attento va riservato alle relazioni di questo documento con gli altri strumenti di settore: va sviluppato un ragionamento sulla collocazione appropriata del “Piano intercomunale della mobilità sostenibile” nel quadro degli strumenti in essere. In assenza di una normativa specifica che istituisca il nuovo strumento, la legittimazione del Piano può essere ricondotta al Decreto Ronchi e nei successivi emendamenti del Ministero dell’Ambiente (Decreto Silvestrini, dicembre 2000), che affidano al mobility manager d’area il compito di coordinare ed armonizzare le singole iniziative implementate dai mobility manager aziendali e alla Provincia (art. 14, 15, L. 142/90) le funzioni di viabilità e trasporti. Questo piano può rappresentare un tassello importante, un primo momento di riflessione di un percorso che in alcuni casi è stato intrapreso, singolarmente, da diversi anni.
16
Basti ricordare che in un’ampia maggioranza di casi i Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) aziendali sono stati redatti dai mobility manager delle imprese con l’ausilio di esperienza e competenza tecnica offerta dagli enti pubblici, in un rapporto di collaborazione che ha portato ad una fertile condivisione di alcuni servizi e alla realizzazione di progetti congiunti. Oltre ad un lavoro di raccolta e rielaborazione dei singoli PSCL, sia in termini di dati emersi dalle indagini svolte nelle aziende e dirette ai dipendenti, sia in termini di prescrizioni ed azioni previste, si possono elaborare elementi originali e peculiari di un piano a scala territoriale: ad esempio, proposte di variazione di percorsi, fermate ed orari delle linee di TPL. Gli apporti conoscitivi provenienti dall’attività di mobility management (sia a livello di indagini, con gli studi sui bacini di utenza potenziale per il mezzo pubblico, sia a livello di monitoraggio, con la revisione dei PSCL) contribuiscono a fotografare lo stato di fatto, indicando elementi utili alla strutturazione e/o alla modifica delle linee di TPL e fornendo una serie di dati che possono essere inseriti nel PTS (Programma Triennale dei Servizi), senza sovrapposizione con questo strumento, ma anzi costruendo una fertile sinergia. Se l’obiettivo di un piano d’area della mobilità è indicare alcune linee di intervento fertili per indirizzare lo sviluppo territoriale su prospettive di sostenibilità sotto il profilo ambientale e trasportistico, allora questo tipo di Piano è in forte accordo con le indicazioni contenute nel PTCP: individuato un punto di contatto tra Piano e PTCP, che è un piano con valenza paesistico-ambientale volto alla tutela del territorio, può essere opportuno inserire i ragionamenti in merito alla mobilità sostenibile come parte di un disegno più ampio volto alla salvaguardia dell’ambiente (riduzione delle emissioni inquinanti) e alla preservazione del territorio (difesa del consumo di suolo di un modello di sviluppo basato sull’uso dell’auto). Il Piano, che si inserirebbe nel PTCP sia a livello di studi che di proposte, presenterebbe quindi una serie di politiche e di progetti basati sull’approccio del mobility management. Pertanto, si porrebbe accanto ad altri strumenti che prevedono l’aumento della dotazione infrastrutturale integrandone le azioni hard con una visione improntata alla gestione della domanda (azioni soft). Un Piano così formulato intende mostrare i benefici apportati dalle attività di mobility management e l’impatto dei progetti in termini di diminuzione del traffico, riduzione dell’inquinamento, risparmio energetico: serve dunque un documento che abbia capacità di rappresentare e di rappresentarsi, in grado di dialogare con gli altri strumenti settoriali di pari livello e i cui contenuti possano essere recepiti dagli strumenti a cui è sovraordinato, senza forzarli. Un ostacolo all'inserimento del piano della mobilità in un PTCP viene dalle suddivisioni amministrative del territorio, che potrebbero limitare l’efficacia dello strumento: ad esempio, le aree omogenee per i blocchi del traffico non corrispondono a delimitazioni territoriali cui fanno riferimento soggetti istituzionali, quindi sotto questo aspetto è meglio avvalersi di uno strumento d’area. In alternativa, il Piano potrebbe essere un piano esecutivo di uno strumento già vigente, il Piano Provinciale di Bacino della Mobilità e dei Trasporti (PPBMT): non quindi un piano che si andrebbe a sommare a quelli già esistenti, complicando e confondendo ulteriormente una situazione che ha visto negli ultimi anni una proliferazione di piani settoriali, ma uno strumento che si inserisce agilmente nel quadro normativo attuale, senza dannose sovrapposizioni. Il Piano di Bacino individua lo scenario infrastrutturale e dei servizi che permette di migliorare l’accessibilità del territorio provinciale. All’interno di questo documento si inserisce il Piano del Traffico per la Viabilità Extraurbana (PTVE), uno strumento di programmazione ed attuazione di breve periodo che recepisce le scelte di assetto territoriale provinciale (PTCP ed altri documenti strategici) ed individua soluzioni per diminuire il livello di congestione del traffico con i problemi ad esso connessi (sicurezza della circolazione, dispersione della ricchezza, danni per la salute, etc.)
17
e per avere una mobilità più sostenibile e più rispettosa dell’ambiente. Un’altra ipotesi vede dunque una possibile collocazione per il piano d’area della mobilità all’interno del PTVE, strumento composto da diversi piani attuativi specialistici. Gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria, dell’accessibilità del territorio su cui insistono, la gestione (complessiva?) del fenomeno mobilità, suggeriscono di interpretare il PIMS come un piano esecutivo. Riteniamo che il Piano potrebbe produrre risultati consistenti se dialogasse in via diretta e concretamente con altri strumenti quali il PTVE, il PUM e/o il PUT, anche recependone alcune indicazioni, mentre esiste il rischio che l’unico rapporto che si instauri è di tipo formale, con i controlli di congruenza del primo rispetto ai secondi durante l’istruttoria tecnica per l’approvazione del PIMS da parte dell’attore pubblico: il prevedibile approccio, infatti, è che in fase di istruttoria tecnica ci si limiti a verificare la non contraddittorietà dei contenuti del PIMS con le prescrizioni e le previsioni dei documenti di pianificazione vigenti. Alle amministrazioni comunali coinvolte in questa esperienza spetta dunque non solo la traduzione operativa di quanto suggerito in questo Piano, ma anche il compito di assimilare l’approccio del mobility in modo da contaminare gli altri Piani (ad esempio, in fase di rielaborazione secondo le tempistiche previste dalla normativa), in un processo cumulativo ed evolutivo dei saperi.
18
4. Contesto territoriale 4.1 - Inquadramento infrastrutturale, servizi di trasporto offerti e accessibilità La porzione di territorio a Nord-Ovest di Milano costituita dai Comuni di Arese, Bollate, Garbagnate Milanese, Lainate e Pero, è un’area densamente conurbata e interessata da fenomeni di pesante congestione stradale, sia sulla rete infrastrutturale primaria che sulle maglia locale. Il territorio così individuato accoglie al suo interno o nelle immediate vicinanze due punti critici di attrazione/generazione di traffico: la Nuova Fiera (polo esterno) di Rho-Pero ormai entrata pienamente in funzione e l’ex comprensorio Alfa Romeo-Fiat ad Arese, la cui trasformazione è oggetto di un accordo di programma che a diversi anni dalla sottoscrizione fatica a trovare applicazione, creando una situazione di indeterminazione sul futuro dell’area. Questo territorio, già sensibile e fragile sotto il profilo ambientale, si troverà inoltre a subire la pressione di un grande evento come EXPO2015, rispetto al quale manca ancora uno scenario organico di riferimento per l’azione territoriale. La realizzazione dell’edizione 2015 dell’Expo avrà, infatti, ripercussioni sostanziali sull’area incrementandone i flussi di mobilità. Tali interventi di grande valore strategico-economico producono effetti importanti e di complessa gestione anche sul sistema locale della mobilità. In prospettiva, il contributo del mobility management è di sicura utilità poiché in grado di orientare le scelte di mobilità delle persone a vantaggio di modalità alternative, innovative ed integrate. Non essendo questa la sede opportuna per trattarne, ci si limita a citare il fenomeno di delocalizzazione delle funzioni logistiche con il trasferimento di tali attività dalla città di Milano verso aree più esterne e la loro rilocalizzazione, in buona misura, sull’asta del Sempione. Al fine di fornire un quadro d’insieme delle infrastrutture presenti sul territorio, si delineano di seguito i tratti essenziali della situazione viabilistica dell’area. Essa è attraversata da importanti assi stradali:
- il sistema autostradale intorno a Milano, formato dalla A8 Milano-Laghi, A4 Torino-Venezia, Tangenziale Ovest e Tangenziale Nord);
- le grandi strade statali che attraversano il territorio secondo la direttrice storica verso la città di Milano: la Statale del Sempione (SS 33), la Padana Superiore (SS 11), la Varesina (SP ex SS 233), la Comasina (SP ex SS 35), la Milano-Meda (SP ex SS35 dei Giovi, tratto Nord).
- il recente prolungamento e riqualificazione della Rho-Monza (SP 46), unico grande asse per i movimenti trasversali Est-Ovest.
Tale rete necessita di alcuni interventi per il raggiungimento e il mantenimento degli standard prestazionali e di sicurezza adeguati alla gerarchia funzionale qui riportata, anche in relazione alla creazione di un robusto sistema di connessione del polo fieristico di Rho-Pero con la maglia stradale primaria, tramite la realizzazione della variante SS33 Sempione a Pero, il collegamento in galleria del Sempione con la Rho-Monza e il sistema degli svincoli con la Autostrada A4. Il sistema del ferro vede la presenza sui territori di Garbagnate Milanese e di Bollate delle stazioni delle ferrovie Nord – ramo Milano-Saronno: Garbagnate Milanese, Garbagnate Parco delle Groane, Garbagnate Serenella, Bollate Traversagna/Nord, Bollate Centro. Presso le stazioni ferroviarie di Garbagnate Milanese e Bollate Traversagna/Nord è previsto potenziamento delle strutture di interscambio, con l’individuazione di interventi volti alla realizzazione di parcheggi di interscambio, sosta bus e miglioramento accessibilità ciclo-pedonale.
19
Il territorio non è direttamente servito dalle Ferrovie dello Stato. La presenza delle linee del Servizio Ferroviario Regionale sulla linea Milano – Saronno potrebbe favorire il disegno un nuovo sistema di trasporto pubblico di superficie che, nel fornire i servizi di adduzione alle stazioni, diviene capace di servire con efficienza la mobilità interna all’area. Ciò in considerazione che il cadenzamento è garantito ogni mezz’ora durante tutta la giornata sia per quanto concerne le linee che si attestano alla stazione nord di Cadorna, sia per quanto concerne i treni del servizio Passante che fermano in Bovisa e proseguono fino a P.ta Vittoria. In totale vi sono 42 corse/giorno in andata e altrettante in ritorno (dunque ca. 84 passaggi/giorno): il servizio garantito dalle attuali frequenze è dunque piuttosto buono, anche se non altrettanto può dirsi per gli altri parametri di qualità quali la puntualità, la pulizia, l’affollamento, ecc. Id. Linea Tragitto Fermate nei Comuni interessati S1 SARONNO – BOVISA – MILANO
ROGOREDO GARBAGNATE MILANESE– SERENELLA – BOLLATE Traversagna/Nord – BOLLATE Centro
S3 SARONNO – BOVISA – CADORNA FN
GARBAGNATE MILANESE– SERENELLA – BOLLATE Traversagna/Nord – BOLLATE Centro
In Comune di Pero insiste una fermata della linea MM1 Molino Dorino – Sesto S.G. Il problema della mancata integrazione tariffaria tra area urbana ed extraurbana, la vicinanza alla fermata di Molino Dorino (ex capolinea) e le distanze relativamente contenute dall’attuale capolinea Rho Fieramilano e dalla fermata Lotto non paiono favorire la costituzione di un nodo di interscambio ferro-gomma (intesa sia come trasporto pubblico che come mobilità privata) presso la fermata Pero della metropolitana MM1. Per quanto riguarda le infrastrutture, nel Nord Milano è prevista una nuova linea di trasporto pubblico in sede propria con andamento trasversale ed il potenziamento delle strutture di interscambio presso le stazioni ferroviarie di Garbagnate Milanese e Bollate Traversagna/Nord, luoghi di rilevanza sovracomunale, con l’individuazione di interventi volti alla realizzazione di parcheggi di interscambio, sosta bus e miglioramento accessibilità ciclo-pedonale. Per quanto concerne il trasporto pubblico su gomma, il territorio è suddiviso tra Lotto 6 – Area Ovest, già aggiudicato tramite gara (ex L.R. Lombardia 11/2009) e dato in concessione a Movibus e Lotto 1 – Area Nord-Ovest, ancora in fase di aggiudicazione e dove operano tuttora le aziende titolari di concessione (in particolare dal consorzio GTM – Groane Trasporti e Mobilità). Movibus è un’azienda costituita da STIE, ATM e ATINOM che gestisce il lotto 6 operando su 28 linee extraurbane e un servizio a chiamata, per una percorrenza annua che ammonta a circa 6.780.000 bus-km, con un aumento di circa il 5% rispetto alla situazione preesistente la gara. Sono 8 le linee, riportate nello specchietto seguente, che interessano due dei Comuni (Lainate e Pero). I servizi attuali offrono una concentrazione di corse nelle ore di punta per i movimenti pendolari, a Lainate servendo specialmente gli istituti scolastici e a Pero giovandosi della prossimità con i nodi delle fermate metropolitane di connessione con Milano. Visti i livelli di servizio (e di domanda) relativamente deboli nella fascia di morbida, si ritiene di interesse l’impiego di mezzi di piccole/medie dimensioni, sia per diminuire l’impatto in zone particolarmente delicate a livello urbanistico come il centro abitato, sia per avere mezzi circolanti con emissioni minori. Rispetto al tradizionale schema centripeto – Milano-centrico è stato compiuto un primo passo in avanti dando più forza alle linee di attraversamento “trasversale” del territorio, ma occorre forse rinnovare il servizio con maggior coraggio verso questa direzione di lavoro. Se infatti permangono i
20
movimenti radiali incentrati su Milano, sono affiancati da un numero crescente di spostamenti tangenziali al capoluogo, mentre sul lato dell’offerta del TPL si rileva una certa carenza proprio dei collegamenti trasversali.
Id. Linea
Tragitto Comuni interessati
N. corse giorno
feriale a/r
Primo passaggio in
centro a/r
Ultimo passaggio in
centro a/r Z601 LEGNANO – MILANO MM
DORINO via Sempione PERO 48/52 5.37/5.24 23.57/00.34
Z605 S. GIORGIO S.L. / CANEGRATE / PARABIAGO / MILANO
PERO 1/1 7.11 12.58
Z606 CERRO MAGGIORE – RHO – MILANO
PERO 9/9 6.52/8.13 19.12/19.33
Z607 VILLANOVA / GARBATOLA / BARBAIANA – RHO FIERA / MM DORINO
LAINATE, PERO
3/5 6.37/15.53 , 6.53/13.34
14.07/19.38 , 14.23/19.19
Z608 STAB. NERVIANO – MM DORINO PERO 6/5 16.34/7.35 18.01/8.25 Z612 LEGNANO – CERRO M. – LAINATE LAINATE 17/17 6.15/6.20 20.08/19.05 Z617 ORIGGIO/LAINATE – MILANO LAINATE 33/33 5.50/6.19 19.14/20.29 Z619 S. VITTORE O. / LAINATE / CERRO
M. / NERVIANO – PARABIAGO LAINATE 2/2 7.28/13.30 7.45/14.20
La ciclabilità ha trovato nel Piano MiBici il proprio riferimento fondamentale, quale momento di approfondimento tecnico-progettuale per la costruzione di una rete organica della mobilità ciclabile a scala sovracomunale. Il Piano inquadra in uno schema generale le principali direttrici di connessione ciclabile tra comuni limitrofi. Questa rete rappresenta l'ossatura portante della ciclabilità, sulla quale vanno opportunamente innestati i percorsi complementari di collegamento con le polarità urbane (attrattori/generatori, in particolare le funzioni pubbliche) ed i diversi quartieri. 4.2 - EXPO2015: scheda degli interventi infrastrutturali previsti sul territorio Nel 2008 Il BIE – Bureau International des Expositions ha assegnato alla città di Milano l’Expo per l’anno 2015. Tra i documenti consegnati alla commissione aggiudicatrice la città di Milano, in accordo con gli altri livelli di governo, ha presentato un programma contenente diverse decine di progetti, suddivisi in opere essenziali, connesse o necessarie (ovvero stabilendo delle priorità, seppure parziali) per l’ottimale riuscita dell’evento. Tra tutti i progetti previsti, sono stati selezionati e riportati nello schema seguente gli interventi di carattere infrastrutturale che insistono direttamente sui territori dei Comuni o in aree strettamente limitrofe al confine amministrativo degli stessi. La dotazione infrastrutturale dovrebbe essere irrobustita soprattutto per quanto riguarda le opere di connessione (raccordi e svincoli) del sito alle grandi arterie stradali di scorrimento veloce (sistema delle autostrade e delle tangenziali) e la predisposizione di aree adibite a parcheggio e attrezzate con un sistema di collegamenti veloci al sedime dell’esposizione. Se appare incauto ipotizzare le ricadute in termini di distribuzione puntuale di flussi (molto della governante dell’evento rimane da stabilire), appare di certo ragionevole ipotizzare che le grandi masse di popolazione richiamate dall’evento (21 milioni di visitatori attesi, per un totale di 29 milioni di ingressi all’Expo nei sei mesi di apertura, con picchi fino a 200-250.000 presenze in giornate di particolare afflusso, anche se oggi pare esserci una stima delle presenze tendente al
21
ribasso rispetto a quanto indicato dal Dossier di candidatura) produrranno delle ricadute importanti sul territori più prossimi al sito che ospiterà l’Esposizione universale. L’Expo2015, oltre a portare indubbi benefici, contribuirà ad aumentare il livello di congestione stradale nell’area, già oggi particolarmente elevato. Un ulteriore motivo a sostegno dell’urgenza di implementare azioni di mobilità sostenibile, a salvaguarda del territorio e della qualità della vita dei residenti e di tutte le popolazioni che vivono in questa porzione della regione urbana milanese.
Intervento Classificazione dell’opera
Costo (in Mil. Euro)
Data prevista fine lavori
Collegamento SS11 da Molino Dorino a Autostrada dei Laghi, lotto 1 (Molino Dorino – Cascina Merlata) essenziale 54,2 09 / 2014
Adeguamento A8 tra nuovo svincolo EXPO e svincolo Fiera (corsie bus) essenziale 6,9 09 / 2014
Parcheggio P2 – Arese: 3.000 posti auto essenziale 12,7 04 / 2014 Parcheggio P3 – Rho: 7.000 posti auto + 1.000 posti bus essenziale 21,3 04 / 2014 Riqualificazione SP 46 Rho-Monza connessa 273,0 09 / 2014 Interconnessione nord-sud tra SS 11 e A4 (Viabilità Cascina Merlata – stralcio gamma) connessa 28,0 12 / 2013
Collegamento tra SS 33 e SS 11 (Via Gallarate – PII Cascina Merlata) connessa 20,0 12 / 2013
Lavori su SS 233 Varesina – tratto nord connessa 9,0 05 / 2014 Adeguamento rampa Tangenziale Ovest – A8 connessa 5,0 09 / 2014 5° corsia A8, revisione degli svincoli necessaria 70,0 12 / 2012 4.3 - Area ex Alfa-Romeo: scheda del progetto di trasformazione dell’area Il sedime che ospita gli ex stabilimenti di produzione dell’Alfa Romeo insiste su quattro differenti Comuni: Arese, Garbagnate Milanese, Lainate, Rho. L’area ha una superficie complessiva di oltre 2 milioni di metri quadrati, di cui il 42,6% (pari a ca 882.000 mq) sul territorio del Comune di Arese, il 34,9% (pari a ca 725.000 mq) in Comune di Lainate, il 14,5% (pari a ca 302.000 mq) in Comune di Garbagnate Milanese e l’8,0% (pari a ca 165.000 mq) in Comune di Rho. L’area è già in parte in fase di trasformazione e al suo interno sussistono attività ancora in essere: la frammentazione della proprietà immobiliare e la divergenza di interessi verso il destino dell’area, unitamente alla mancanza di una chiara e univoca vocazione territoriale e alla presenza di più Amministrazioni (oltre a ai quattro Comuni sono coinvolte la Provincia di Milano e la Regione Lombardia) non agevola il processo di riconversione. Nella seduta del 25/03/2009 in seduta del tavolo tecnico dell’Accordo di Programma, i Sindaci dei quattro Comuni hanno presentato un documento indicante le linea guida cui attenersi per la riqualificazione dell’intera area:
- Utilizzare una parte preponderante dell’area per attività industriali, terziarie e ricettive in grado di creare nuovi posti di lavoro.
- Valorizzare il sito museale e, supportato da un progetto sostenibile, prevedere il riutilizzo della ex pista di collaudo a fini ricreativi, sportivi e culturali.
- Destinare una quota della superficie a residenza di qualità. - Valorizzare l’area dal punto di vista ambientale, quale cerniera di collegamento tra il Parco
delle Groane e il sistema del verde dell’area Nord-Ovest. - Completare l’assetto delle infrastrutture viarie del rhodense, per sopperire alla carenza
infrastrutturale che contraddistingue questo quadrante. - Valorizzare gli impianti tecnologici esistenti, la centrale termoelettrica e il depuratore delle
acque, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale dell’area.
22
A distanza di alcuni mesi, i Sindaci hanno poi sottoscritto un Protocollo di Intesa per una gestione organica della pianificazione dell’area, individuando gli ambiti delle destinazioni d’uso e le superfici di riferimento, come riportato nello schema seguente.
Ambito e sub-ambito
Destinazione Superficie territoriale (mq)
S.L.P. (mq) Superficie standard (mq)
Superficie aree compensaz. (mq)
a Produttivo 155.300 63.400 274.200* - b Produttivo 619.700 320.000 274.200* 37.800
c1/a Residenza 171.400 68.600 54.900 91.600* c1/b Commercio 153.000 77.000 154.000 57.500 c1/c Terziario 21.400 17.600 28.600 91.600* c1/d Ludico-
ricreativo 95.000 2.500 2.500 -
c2 Museale-ricettivo 143.000 63.000 47.300 8.500
d1 Direzionale 19.400 28.000 28.000 9.500 d2,d3 Impianti
tecnologici 90.300 2.000 - 24.700
strade 71.600 - - - TOTALE 1.540.100 642.100 589.500 229.600
23
5. La pianificazione di settore vigente 5.1 - Indicazioni sulla pianificazione di settore vigente (nel territorio oggetto di Piano) I Comuni di Arese, Bollate, Garbagnate Milanese, Lainate e Pero, tutti facenti parte della Provincia di Milano, hanno deciso di associarsi per redigere un documento di piano atto a promuovere e realizzare interventi di mobilità sostenibile ed applicare sistemi di monitoraggio ai flussi di traffico casa-lavoro. È sembrato pertanto opportuno condurre un’attività di verifica dello stato della pianificazione di settore vigente nel territorio di riferimento, per tratteggiare il quadro in essere e identificare gli strumenti con cui si troverà a dialogare il Piano intercomunale della mobilità sostenibile. Pertanto, si propone di seguito uno schema di sintesi che raccoglie gli strumenti nell’ambito dei trasporti attualmente vigenti presso le cinque Amministrazioni. Si richiama anche che tutti i Comuni stanno condividendo esperienze di pianificazione congiunta sul tema dei trasporti essendo stati coinvolti nell’elaborazione del Piano d’Area del Rhodense, piano che identifica, fra i molti temi infrastrutturali presenti in quest’area, quelli ritenuti di maggiore importanza per la qualità dell’ambiente e della vita dei cittadini.
Comune Strumento Data approvazione Arese P.G.T.U. 03/05/1999 Bollate P.U.T. 04/02/2002 Garbagnate Milanese P.G.T.U. 17/09/2004 Lainate PUT 12/02/2001 (ultimo aggiornamento nel 2007) Pero P.G.T.U. 07/06/1999 (in corso di aggiornamento)
Criteri di analisi per la rilevazione Si riportano alcune note di carattere metodologico applicate per la consultazione dei documenti:
- anzitutto, con l’ausilio dei tecnici sono stati raccolti i documenti vigenti (a scala comunale) inerenti infrastrutture, viabilità, trasporti e mobilità, della quale è stata effettuata una lettura complessiva;
- è stata inoltre condotta un’analisi di ulteriori materiali riportanti lo stato di fatto del sistema infrastrutturale e del sistema della mobilità del Nord Milano, con approfondimenti mirati in caso di previsione di progetti particolarmente rilevanti (VAS, piani attuativi).
- a ciò è seguita un’analisi mirata di tutto quanto attiene alla mobilità sostenibile, ovvero particolare attenzione è stata posta a rintracciare e selezionare i seguenti aspetti:
o mobilità ciclabile, intesa come disponibilità di infrastrutture, qualità della rete, possibilità di fruizione;
o mobilità pedonale; o servizi di TPL (riportati nel capitolo su contesto territoriale e accessibilità); o nodi di interscambio; o promozione dei mezzi eco-compatibili; o regolazione della sosta (per le auto); o disponibilità di spazi per la sosta (per le auto e per le bici).
Le informazioni più significative riscontrate su infrastrutture, nodi di interscambio, trasporto pubblico locale, sono state riportate nel capitolo “Contesto territoriale”, che legge quanto rilevato in un’ottica d’area.
24
- infine, è stata avviata una valutazione dei contenuti (sia stato di fatto che previsionali) degli strumenti per rilevarne la congruenza con le politiche di mobilità sostenibile e poter effettuare una comparazione tra gli strumenti stessi.
5.2 – Comune di Arese
Strumento e data di approvazione P.G.T.U. vigente approvato con delibera C.C. n. 15 del 15/02/1999 e successive integrazioni con delibera C.C. n. 45 del 03/05/1999. Alcuni dati di analisi dei flussi di traffico Le stazioni FS a Garbagnate, Bollate, Rho, sono collocate a una distanza, in linea d’aria, di circa 3-4 km dal centro abitato di Arese, ciò porta alla considerazione che è possibile predisporre misure atte a migliorare l’offerta di trasporto e orientare la domanda di mobilità. La infrastrutture principali sono la SS Varesina, la SP153, via Alfa Romeo e via per Passirana. Particolarmente intenso è il traffico nell’incrocio della SS Varesina con via Passirana, nel quale si registra un TGM complessivo di circa 35.000 veicoli. La fase di punta è riscontrata tra le 7.45 e le 8.30, con una frequenza più marcata tra le 8.00 e le 8.15. I veicoli per il trasporto delle merci rappresentano l’8% del totale, ma su alcune strade di rilevanza sovracomunale possono arrivare sino al 40% o addirittura superare tale quota. Il traffico in entrata arriva soprattutto da Bollate e Garbagnate e in misura minore da Lainate e Rho, mentre in uscita si dirige verso Milano e in misura minore verso Bollate, Garbagnate, Lainate, Rho. Il traffico avente origine e destinazione in Arese ha una quota non residuale. L’84,3% delle autovetture è occupata da una persona sola, il 13,9% da due perone, l’1,8% da tre o quattro persone, nessuna delle autovetture era pienamente utilizzata; il motivo principale dello spostamento è per lavoro. Coloro che si recano al lavoro con il mezzo pubblico rappresentano poco più del 4% del totale. Si rileva che una quota elevata di studenti si reca in altri Comuni per frequentare istituti scolastici ed università, che per i propri spostamenti utilizzano prevalentemente i mezzi pubblici. Mobilità ciclopedonale L’analisi della mobilità ciclopedonale ha evidenziato alcuni problemi di sicurezza stradale, per quanto attiene le utenze deboli, risolvibili attraverso interventi di moderazione del traffico e di riqualificazione urbana di archi e nodi del grafo stradale. Politiche di regolamentazione per la sosta Il Piano dei Parcheggi ad Arese è predisposto fin dal 1989. Con il Piano si individua la localizzazione delle principali aree di sosta. Le aree di sosta centrali arrivano in alcuni casi a saturazione completa o pressoché completa nella seconda fascia mattutina e nel pomeriggio, ciò per la vocazione commerciale dell’area centrale della città.
25
5.3 – Comune di Bollate Strumento e data di approvazione Aggiornamento P.U.T. approvato con delibera C.C. n. 41 del 03/07/2009 (vigente approvato con delibera C.C. n. 18 del 04/02/2002). Alcuni dati di analisi dei flussi di traffico Il traffico risulta essere molto intenso, sia di attraversamento diretto verso Milano (notevoli sono anche le zone di Garbagnate/Senago, Arese/Rho e Novate, verso cui si dirige un terzo di tale traffico), sia interno al comune, con la presenza di una quota significativa di veicoli commerciali. Per quanto riguarda il traffico in ingresso destinato in Bollate, questo proviene per metà da Milano, per un terzo da Novate e Baranzate ed in misura ancora minore da Cormano/Paderno (8%) e da Rho/Arese (7%). Si evidenziano sia livelli elevati di congestione sulla rete viaria principale (dovuti in gran parte al traffico di attraversamento) che problemi legati alla viabilità locale (inopportuna gerarchizzazione della rete viaria locale, spesso usata dal traffico di attraversamento e interrotta nelle sua continuità dalla linea ferroviaria; incroci pericolosi; spazi di sosta inadeguati e scarsa regolamentazione; rete ciclabile discontinua, poco sicura e mancante di segnaletica). Per quanto concerne le grandi direttrici il comparto a nord di Bollate risulta più attrattivo rispetto alle zona poste a sud, per le quali prevale nettamente il traffico generato nel comune di Bollate. Per quanto riguarda la composizione degli spostamenti per motivo, sia per i viaggi attratti sia per i viaggi generati la quota di chi si sposta per lavoro è molto simile (57-58%), mentre per i viaggi interni tale quota cala al 36%. Per motivi di studio l’attrattività di Bollate cala sensibilmente (è inferiore al 10%). Gli spostamenti per tutti gli altri motivi mostrano sia in attrazione sia in generazione da Bollate valori compresi tra il 32 e il 36%, contrariamente agli spostamenti interni a Bollate che paiono molto più legati a motivi diversi dallo studio e dal lavoro (con una ripartizione percentuale pari al 66%). Si nota la grande prevalenza dell’uso dell’auto, e la presenza di quote significative di intermodalità solo per i viaggi diretti verso Milano. L’uso del mezzo pubblico per gli spostamenti diretti a Milano si attesta attorno al 25%, con una netta prevalenza nell’uso del treno. Mobilità ciclopedonale L’uso dei modi di spostamento non motorizzati per gli spostamenti interni al comune è significativa a Bollate, poiché risulta pari al 20% degli spostamenti per la pedonalità ed al 10% per la ciclabilità (dati matrice O/D 2002 Regione Lombardia). I problemi principali sono legati a conflitti puntuali con il traffico, essenzialmente localizzati nei punti di attraversamento degli assi stradali primari, e nei sistemi di passaggio della ferrovia. Per quanto in particolare riguarda la bicicletta, la rete ad essa dedicata, pur relativamente estesa, soffre dei problemi comuni a molte altre realtà urbane, e cioè della mancanza di continuità del
26
sistema, dell’insufficiente trattamento delle intersezioni, della totale assenza di segnaletica di indirizzamento. Gli assi principali della rete sono attualmente costituiti da:
- il percorso ciclopedonale di via Friuli Venezia Giulia che connette Cascina del Sole e Cassina Nuova a Bollate (ad eccezione dell’ultimo tratto di via Martiri di Marzabotto fino alla linea ferroviaria);
- la pista ciclabile di via Attimo, dalla quale si diparte un primo segmento di marciapiede ciclabile in via Verdi (appena ultimato) e proseguendo la pista ciclabile di via M. di Marzabotto; e un secondo tratto a sud, all’altezza del cimitero da cui prende origine il percorso ciclopedonale di via Repubblica (il più generoso in termini di dimensioni complessive);
- la pista ciclabile di via Ghisalba, che collega la zona industriale di Ospiate alla via Ferraris e alla Varesina;
- la pista ciclabile di via Kennedy che assicura l’accessibilità a Cassina Nuova. A questi elementi si aggiungono altri segmenti di ciclabilità, in parte non connessi alla rete portante sopra elencata. L’idea che si sta perseguendo è quella di estendere e ricucire la rete delle piste ciclabili esistenti, con l’obiettivo principale di collegare tra loro le frazioni Cascina del sole, Cassina Nuova e Castellazzo e di riqualificare i sottopassi ciclopedonali della linea ferroviaria FNM (per rompere l’isolamento urbano tra il centro e le frazioni a est di Cassina Nuova e Cascina del Sole). Politiche di regolamentazione per la sosta Il sistema della sosta nell’area centrale conta circa 3.000 posti auto (che risultano ridotti di 500 posti auto durante i giorni in cui si svolge il mercato comunale) di cui una quota significativa concentrati nella piazza della Resistenza. Rispetto al totale un numero limitato, circa 350 posti, è regolato a tempo; nelle aree regolate (in genere dalle ore 9.00 alle 19.00) la sosta è, in genere, regolata a tempo con durata di 30’ o di 60’ o al massimo bioraria. Occorre rivedere il sistema dei parcheggi di corrispondenza nelle stazioni delle FNM. Si deve tener presente come entro un raggio di 300-400 metri dalla stazione sono raggiungibili almeno due grandi aree di sosta concentrata, che presentano ancora discreti margini di capacità, e che sarebbero pertanto in grado di fornire una ragionevole alternativa per la sosta dei pendolari. 5.4 - Comune di Garbagnate Milanese Strumento e data di approvazione Aggiornamento P.G.T.U. approvato con delibera C.C. n. 54 del 17/09/2004 (vigente approvato con delibera C.C. n. 28 del 10/04/2001). Alcuni dati di analisi dei flussi veicolari Si confermano le criticità riscontrate e assunte nel precedente PUT. La situazione della SS233 Varesina è caratterizzata da traffico misto consistente, anche se non eccezionale. Si rimarca che
27
l’andamento “costante” del traffico persiste nell’arco dell’intera giornata. La stessa situazione si presenta sull’asse Lainate-Garbagnate, via Montenero, con carichi tali da rendere critica l’intersezione via Peloritana, via Montenero e via Varese, con flussi sia in direzione nord-sud che est-ovest: su di essa gravita interamente il traffico di attraversamento SP109-SP133 (itinerario est-ovest). L’intersezione tra le vie Kennedy, Garibaldi e I° Maggio è altrettanto problematica, avendo anch’essa flussi complessivamente molto rilevanti (oltre 3.700 v/h rilevati nell’intersezione in ora di punta), l’intersezione resta senza dubbio la più problematica della rete comunale. L’impianto urbanistico dell’area centrale non è adatto a sopportare il carico del traffico di attraversamento, particolarmente gravoso negli orari di prima mattina e prima sera. Si verifica in questa area un conflitto tra gli spostamenti pedonali e i transiti veicolari (anche tra veicoli in movimento e in sosta) che si verificano nelle aree centrali della città per minimizzare i tempi di attraversamento della città. Mobilità ciclopedonale Obiettivo primario è la costituzione di una rete continua di percorsi ciclabili intesa come pre-condizione per la promozione di forme di mobilità alternativa all’uso dei mezzi privati. Le strade interquartiere saranno dotate di corsia ciclabile in sede propria o su banchina mista ciclo-pedonale, comunque mai nella carreggiata veicolare, definendo la rete ciclabile principale della città. Le strade interzonali e locali possono essere intese, viste le limitazioni di velocità imposte (Zone con velocità limitata a 30 km/h), come aree di convivenza tra cicli e auto, indicando come norma generale la priorità a cicli e pedoni. All’interno di queste aree non è necessaria l’individuazione di sedi proprie per la mobilità ciclabile. Va invece definita normativamente la presenza di parcheggi per cicli in corrispondenza delle sedi di servizio pubblico e privato, e dei punti di interscambio con il mezzo pubblico, sia nella consueta forma di rastrelliere portabici, che nella forma di aree di deposito coperte e chiuse, con eventuale sorveglianza, in corrispondenza dei luoghi di sosta di lunga durata (scuole, nodi di interscambio, ecc.). Oltre a questi, sono ovviamente previsti interventi di potenziamento e decongestionamento della rete viaria, che riguardano anche la rete di percorsi ciclabili. In particolare, si ravvisano quattro punti sensibili che interessano la mobilità ciclo-pedonale:
- individuazione di punti prioritari di intervento di moderazione del traffico; - individuazione della localizzazione dei principali attraversamenti ciclo-pedonali della SS233
per una maggiore integrazione delle frazioni (anche eventuali sovra-sottopassi); - definizione della rete ciclopedonale, realizzata in sede propria lungo gli assi viari principali e
fatta convivere con il traffico veicolare nelle aree ambientali; - Individuazione di possibili soluzioni per la realizzazione di percorsi pedonali protetti al
servizio delle sedi scolastiche. Politiche di regolamentazione per la sosta Il piano propone una verifica per l’eventuale estensione di regolamentazione della sosta a tutta l’area centrale (eventualmente con sosta a pagamento), il cui perimetro esatto deve essere definito con accuratezza. Il numero di posti auto rilevati in territorio comunale è di circa 7.100.
28
5.5 – Comune di Lainate Strumento e data di approvazione P.U.T. vigente approvato con deliberazione G.C. n. 53 del 12/02/2001. Il P.U.T. di Lainate più recente è stato redatto nel 2006, cui è seguito un aggiornamento nel 2007; questo Piano non è mai stato ufficialmente approvato dal Consiglio Comunale. Tuttavia, poiché di fatto è questo il Piano che guida le scelte dell’Amministrazione, si è scelto di condurre l’analisi su tale documento. Alcuni dati di analisi dei flussi veicolari I flussi di traffico più consistenti si verificano su due assi stradali: l’asse est-ovest (via Filzi, via XXV Aprile, via Garbagnate) con valori che variano tra i 600 e i 900 veicoli/ora e raggiungono picchi di 2100 veicoli/ora all’ingresso da ovest; l’asse nord-sud (via Rho, viale Rimembranze, via Re Umberto I) con valori che variano tra i 500 e i 900 veicoli/ora e picchi in ingresso da sud di 1700 veicoli/ora. I flussi bidirezionali più consistenti si registrano su via Milano, con picchi che raggiungono i 1877 veicoli/ora tra le 8.00 e le 9.00 in entrambe le direzioni, e superano i 1900 tra le 17.30 e le 18.30. Gli spostamenti interni al comune costituiscono il 15%, i movimenti in ingresso nel comune il 7%, i movimenti in uscita dal comune il 46% (in prevalenza verso Milano) e il traffico di attraversamento il 32%. I movimenti da Lainate assumono dunque nel complesso un peso predominate, costituendo quote significative sugli assi principali di scorrimento. Dai dati rilevati si nota che le autovetture rappresentano la componente decisamente prevalente, con un’incidenza che varia tra il 73 e l’85%, mentre risibile è la quota degli spostamenti che avvengono in bicicletta. Il coefficiente medio di occupazione dei mezzi motorizzati a quattro ruote è 1,2 persone/veicolo. Nell’ora di punta del mattino, si evince che circa il 78% degli spostamenti vengono effettuati per gli spostamenti casa-lavoro, con un’ulteriore quota di circa il 5% relativa a viaggi per motivi di lavoro non abituali, che porta ad un totale di circa 83% di movimenti per lavoro; circa il 5% di spostamenti sono relativi all’istruzione. I maggiori poli attrattori di traffico sono le zone industriali ad est e ad ovest, le zone del centro storico e quelle residenziali a nord dell’autostrada dove sono localizzati gli istituti scolastici. Mobilità ciclopedonale Le piste ciclabili esistenti sono poche e piuttosto frammentate, per questo il PUT propone di completare la rete per incentivare la mobilità ciclabile, dando la priorità alla realizzazione di percorsi protetti sulle direttrici a massima domanda e dove è presente maggiore conflittualità con il traffico automobilistico, mentre in altre arre è possibile agire con interventi di moderazione della velocità, anche tramite l’introduzione di Zone 30, consente la coesistenza di veicoli e biciclette. Esiste già un tracciato in sede propria che attraversa il Comune da Est a Ovest (lungo il canale Villoresi) e nell’area a Nord ma mancano le connessioni con i poli sensibili, in particolar modo gli istituti scolastici: alcuni tracciati possono essere realizzati laddove si crea un senso unico, altri possono prevedere l’eliminazione di alcuni stalli di sosta per le auto.
29
Un obiettivo del PUT è la messa in sicurezza di tutti i percorsi pedonali, sia come marciapiedi che come attraversamenti stradali, oltre a informare e sensibilizzare per diffondere una nuova cultura della strada basata sulla coesistenza pacifica tra auto, bici e pedoni. Politiche di regolamentazione per la sosta Per quanto riguarda la sosta, emerge la necessità di ridurre l’attuale disponibilità di parcheggi per favorire la mobilità pedonale e ciclabile. La politica della sosta deve essere innanzitutto finalizzata a garantire da una parte condizioni di sicurezza alla mobilità pedonale e ciclabile e dall’altra una disponibilità adeguata alla domanda, sia dei residenti sia dei non residenti. L’occupazione complessiva dei parcheggi risulta attualmente essere di poco superiore al 40% nella fascia notturna, e di valori che oscillano attorno al 60% nelle ore diurne, con un picco di circa il 67% nell’ora di punta tra le 11.00 e le 12.00. Su circa 1.800 posti ad uso pubblico rilevati nelle aree centrali, si registra un alto tasso di occupazione che non arriva però a limiti eccessivi di saturazione. 5.6 - Comune di Pero Strumento e data di approvazione P.G.T.U. vigente approvato con deliberazione GC n. 70 del 07/06/99, cui è seguito un aggiornamento nel 2005. Un nuovo P.G.T.U. è in avanzata fase di redazione: la bozza definitiva è stata presentata alla Giunta nel Giugno 2010. Alcuni dati di analisi dei flussi veicolari Il comune è interessato dall’elevato livello del traffico sul tratto urbano della SS33 Statale del Sempione (18.000 Veq al giorno, con punte massime vicine agli 800 v/h per direzione), in larga misura costituito da movimenti di attraversamento. Si ravvisa una scarsa disponibilità di sosta per la rotazione breve, dovuta sia alla regolazione non completa, sia al mancato rispetto delle regolazioni esistenti. Inoltre, si è riscontrata la presenza di elevata incidentalità, legata ai flussi di traffico ragguardevoli ed al loro conflitto con le altre funzioni urbane; tale fenomeno potrebbe essere contrastato con l’introduzione di interventi di moderazione del traffico, quali le Zone 30. Altra possibilità per proteggere la rete viaria interna di Pero è rappresentato dai cosiddetti ‘semafori filtro’, ai quali è affidato il compito di limitare il flusso entrante sino a livelli che si ritengono compatibili con un regolare funzionamento della viabilità. Mobilità ciclopedonale Si evidenziano gli itinerari più significativi rilevati anche dal piano provinciale MiBici: il primo è il sistema, esistente e di progetto, che si sviluppa lungo l’intero tracciato del Sempione, e che sarà affiancato da un itinerario parallelo lungo l’Olona; il secondo è quello dell’itinerario Pisacane-Figino, il cui inserimento ha comportato una profonda revisione dell’assetto dell’intero asse. Tali interventi sono funzionali a servire i principali poli attrattori presenti sul territorio e a collegare tutti i comparti residenziali.
30
Un elemento fondamentale del sistema ciclabile è infine rappresentato dal nodo della stazione della metropolitana, che deve essere completato con una adeguata e ben attrezzata struttura per il ricovero delle biciclette al fine di agevolare le funzioni di interscambio metro-bici. La rilevazione degli spazi pedonali ha fatto emergere una modesta qualità e funzionalità, anche a causa della mediamente bassa qualità degli arredi urbani. Politiche di regolamentazione per la sosta Pero ha già sviluppato una politica organica di controllo della sosta, che richiede di essere applicata per rispondere alle criticità emerse nel corso delle analisi. In particolare, si propone di attivare i seguenti interventi: - l’estensione della zona a tempo con rotazione breve (30’-60’) all’intera asta urbana del Sempione e al primo tratto di alcune delle principali traverse. Una possibile ulteriore evoluzione di tale regolazione è l’introduzione della regolamentazione a pagamento; - la regolazione a tempo con rotazione lunga (120’) di tutta la sosta libera ancora presente nel quadrilatero Oratorio, Figino, Orti, Alessandrini, XXV Aprile e Pisacane. Anche in questo caso può essere ipotizzato il rilascio di permessi a pagamento per ridurre l’impatto e le relative difficoltà di gestione del dispositivo. Una riflessione particolare va dedicata al nuovo parcheggio ricavato all’inizio della via Pisacane, oggi utilizzato in prevalenza dagli utenti della linea metropolitana, con tassi di riempimento molto elevati e lunghe permanenze. La sua localizzazione lo rende altresì utilizzabile sia dagli utenti dei servizi presenti lungo l’asta del Sempione, sia dei residenti del comparto residenziale a Nord della via Pisacane, nonché dei residenti nei quartieri di Pero più distanti dalle stazioni della metropolitana e, di conseguenza, più dipendenti dall’uso del mezzo privato per l’accesso a queste ultime. A tal fine potrebbe essere estesa anche ad esso una regolazione a ‘tempo lungo’, con eventuale esclusione per i residenti nel comparto sopra menzionato . Infine, si riporta che nel Regolamento Viario è prescritto di riservare spazi adeguati per il ricovero delle biciclette nei cortili o in altre idonee parti comuni dei fabbricati esistenti o di nuova costruzione. In particolare, le aree destinate a parcheggio pubblico devono essere dotate di attrezzature per la sosta delle biciclette in un rapporto minimo di 1 posto bici ogni 10 posti auto; si raccomanda anche che tali attrezzature debbano essere collocate nell’immediata prossimità con i luoghi di destinazione prevalenti. 5.7 - Prime considerazioni sui Piani esaminati La legislazione di settore prevede, da parte delle amministrazioni comunali, la redazione di specifici strumenti di settore; tra i principali si annoverano i Piani Urbani della Mobilità (PUM) e i Piani Urbani del Traffico (PUT). Questi strumenti si occupano in prevalenza di gestire la mobilità tramite l’organizzazione dei flussi di traffico intervenendo sulla viabilità locale e tramite il potenziamento dell’offerta di trasporto con lo sviluppo della dotazione infrastrutturale, senza investigare le motivazioni che stanno alla base della esigenze di mobilità né indagando le caratteristiche degli spostamenti. Inoltre, raramente riescono ad integrare nei contenuti previsionali l’attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale.
31
Ampio spazio nei documenti è riservato alla classificazione tipologica e funzionale della rete stradale, come definita dal Codice della Strada e come previsto nello strumento, dunque alla gerarchizzazione della maglia stradale per governare i flussi veicolari e razionalizzare i percorsi che avvengono all’interno del territorio comunale. Tale spazio ricopre una parte significativa dei documenti soprattutto per quanto riguarda i documenti di Bollate, Lainate e Pero, nel cui caso la redazione del PGTU ha costituito l’occasione per la stesura del regolamento viario. Alla gerarchizzazione tipologica e funzionale della rete è dunque dedicato un peso notevole nei piani: tuttavia, lo sforzo compiuto sembra avere dei limiti nella capacità di individuare i reali utilizzi della rete (si pensi ad esempio al riconoscimento del sistema delle strade friendly per la mobilità ciclabile) e nel suggerire soluzioni progettuali (ad esempio, interventi di ZTL che vadano oltre la semplice enunciazione dello strumento, descrivendo le limitazioni verso determinati flussi e in specifiche fasce orarie, sulla base della tipologia e dell’utilizzo delle strade da parte degli utenti). Sebbene si riconoscano delle attenzioni al tema della mobilità sostenibile, non fermandosi all’enunciazione di buoni principi ma riscontrando tale attenzione anche nell’impianto di piano (PUT di Bollate), nella cura del tema della sosta in relazioni ai nodi di interscambio (PUT di Pero), nell’indicazione di soluzioni progettuali (PGTU di Garbagnate Milanese), che tengono conto delle esigenze di mobilità familiare attraverso specifiche indagini (PGTU di Arese) e in particolare orientate alla salvaguardia delle utenze deboli (PUT di Lainate), dall’analisi dei Piani emerge che finora le amministrazioni locali sono state impegnate nello studio e nell’implementazione di strumenti che interessano in via marginale la mobilità sostenibile (valga come esempio che in nessun piano esiste un titolo di capitolo o di paragrafo che contenga tale espressione), pertanto il Piano Intercomunale della Mobilità Sostenibile si pone come occasione di verifica sul tema, sia interna ad ogni singola Amministrazione che di confronto tra le stesse. In conclusione, si evidenzia uno spazio d’azione per le politiche di mobilità sostenibile, solo parzialmente contemplato ed esplorato nei piani esaminati.
32
6. Best practice di mobilità sostenibile 6.1 - Introduzione In questa parte del Piano Intercomunale della Mobilità Sostenibile si intende ricostruire il quadro delle buone pratiche attuate dagli Enti coinvolti nel campo della mobilità sostenibile. I materiali collezionati sono suddivisi per soggetto attuatore e presentati tramite una descrizione puntuale dell’intervento. Oltre alle buone pratiche che hanno riguardato direttamente i territori dei Comuni coinvolti nel processo di redazione del Piano, è stato ritenuto di interesse riportare anche alcune azioni promosse dalla Provincia di Milano, in quanto potrebbero essere estese a quei Comuni che ancora non hanno aderito alle iniziative qui riportate. 6.2 – Comune di Arese Arese in movimento Il progetto “Arese in movimento – Progettiamo una mobilità sostenibile” è stato cofinanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando 2009 “Promuovere forme di mobilità sostenibile alternative all’auto privata” ed è in fase di attuazione (insieme a Fondazione Rete Civica Milano e Fondazione Legambiente, partner di progetto). Con questo progetto il Comune di Arese vuole raggiungere i seguenti obiettivi:
- diffusione di forme di mobilità sostenibili alternative all’utilizzo dell’auto privata, nell’ottica sia di ridurre il traffico veicolare sul territorio, sia di contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico;
- coinvolgimento attivo dei cittadini nella definizione di un sistema di servizi di mobilità sostenibile che tenga in elevata considerazione le esigenze di mobilità e le proposte degli utenti, in funzione dei diversi interessi rappresentati. Lo schema cui si punta è volto ad integrare e valorizzare il sistema di Trasporto Pubblico Locale connettendo i poli attrattori del territorio (uffici, scuole, servizi pubblici, aziende) con i principali nodi di interscambio situati nell’area.
- studio di fattibilità per quanto attiene la realizzazione di un sistema di bike-sharing comunale, cui seguirà la definizione e l’attivazione di un progetto pilota
La durata del progetto è fissata in 18 mesi, durante i quali saranno attivate varie iniziative quali una campagna mediatica di informazione e sensibilizzazione, attività per il coinvolgimento dei cittadini e la partecipazione sul territorio, indagini per ascoltare i cittadini e i loro bisogni di mobilità, la realizzazione di eventi a tema, la partecipazione in rete tramite l’utilizzo di una piattaforma informatica appositamente sviluppata, lo studio di fattibilità per il servizio di bike sharing e la sperimentazione del servizio stesso, la pubblicazione “Muoversi ad Arese” Il progetto si propone di innescare comportamenti maggiormente sostenibili e incidere nelle scelte modali della popolazione, con la finalità di migliorare la qualità della vita della comunità locale, integrandosi in modo ottimale con le politiche condotte finora dal Comune in materia di promozione della mobilità ciclabile, tant’è che Arese è dotata di un esteso sistema di piste ciclabili, pari al 40% della rete viaria comunale.
33
6.3 – Comune di Bollate Servizio di bike sharing e rete delle piste ciclabili Nell’ambito della mobilità, "debole" è chi, pur non possedendo un'auto, deve comunque potersi muovere nella città, anche per andare a lavorare o solo per vivere la propria città, in autobus, o – perché no – in bicicletta. L’Amministrazione comunale ha deciso di adottare una serie di interventi per favorire l’utenza debole (ciclisti e pedoni) e per promuovere e facilitare l’uso di mezzi alternativi all’auto, in particolare la bicicletta. È in fase di avanzata progettazione il servizio di bike sharing, che verrà sperimentato a breve sul territorio comunale grazie ad uno specifico finanziamento ottenuto. Al momento si attende solo il regolamento di gestione per poter attivare il servizio, permettendo così ai cittadini di spostarsi per Bollate con la bici presa a noleggio. La prima “velo-stazione” per il noleggio (una rastrelliera dotata di cinque mezzi) sarà allestita vicino alla sede del Comune, per poi estendere la rete nel prossimo futuro. Inoltre, entro la fine del 2010, saranno completate alcune opere molto attese, inerenti la realizzazione del sistema inserito nel piano della mobilità provinciale MiBici e finalizzati a ricucire i tratti rimasti scollegati. Con l’acquisizione delle aree, è stata avviata la realizzazione della pista ciclabile lungo tutta via Ferraris (nella frazione di Ospiate) che, proseguendo il percorso esistente lungo via Ghisalba, collegherà in sicurezza il centro della frazione fino al confine con il Comune di Arese. Si è deciso di dare prosecuzione alla pista ciclabile lungo via Verdi sino alla via Novara; gli uffici tecnici stanno rivedendo il progetto, che comprende anche una nuova rotatoria all’incrocio con Via Novara, per rendere l’opera più sicura per i cittadini: rispetto all’idea precedentemente sviluppata di una “semirotonda”, si è scelto di optare per una rotatoria completa, che consentirà di mettere in sicurezza uno degli incroci più pericolosi di Bollate. Verrà sistemata definitivamente piazza Solferino: anche in questo caso sono state apportate alcune modifiche migliorative al progetto, per aumentare il livello di sicurezza negli attraversamenti pedonali: il nuovo progetto prevede una rotatoria di più ampie dimensioni, per non offrire alle auto il cono visivo rettilineo, e le intersezioni pedonali connotate da strisce colorate per fare risaltare la zona di attraversamenti e “protette” tramite dossi caratterizzati da pendenza adeguata per rallentare i veicoli in transito. Pedibus Il progetto Pedibus rientra nell’ambito del Piano Territoriale degli Orari, finanziato dalla Regione Lombardia (con L.R. n. 28 del 28 ottobre 2004) ed attuato dal Comune di Bollate, che ha così inaugurato il percorso che condurrà all’adozione del Piano comunale dei Tempi e degli Orari. Obiettivo del progetto è fare diminuire il traffico automobilistico nei pressi delle scuole, nelle vie cittadine durante l’orario di punta mattutino, migliorando la sicurezza e la salute di tutti i cittadini e promuovendo la diffusione della cultura della mobilità sostenibile. Nel progetto sono stati coinvolti i cinque plessi scolastici presenti sul territorio comunale, ovvero le scuole primarie Don Milani, Galimberti, Masih, Montessori e Rosmini. È stato realizzato un simpatico volantino (pieghevole a tre ante), personalizzato per ogni scuola, che spiega in cosa consiste l’iniziativa, riporta su una mappa i percorsi con le fermate e gli orari di raccolta dei bambini e il modulo per l’iscrizione all’iniziativa. Sono attualmente in procinto di essere attivate dieci diverse linee, tutte aventi nomi di piccoli animali e indentificate con loghi di facile riconoscimento.
34
Per aumentare la visibilità e la sicurezza dei bambini facenti parte della linea di Pedibus, è consegnata loro una fascia distintiva da indossare lungo il percorso, mentre gli accompagnatori indossano una pettorina. 6.4 – Comune di Garbagnate milanese Rete di percorsi ciclabili Il Comune di Garbagnate Milanese negli anni recenti ha programmato e realizzato diversi interventi per incrementare l’estensione della propria rete ciclabile e migliorare la sicurezza dei tratti esistenti. Il sistema di percorsi ciclo-pedonali assume una duplice valenza, sia di favorire la mobilità quotidiana, sia di permettere la fruizione del Parco delle Groane per i momenti ludici e ricreativi. Anzitutto, la rete ciclabile è stata ampliata con la costruzione della pista lungo il canale Villoresi (ove possibile su entrambi i lati), mettendo in collegamento alcune funzioni pubbliche rilevanti quali il centro sportivo, un istituto secondario e una scuola materna, mentre sono in corso di realizzazione il collegamento con l’ospedale lungo l’asse che attraversa il Parco verso Cesate (collegandosi ad altri percorsi già esistenti), quest’ultimo tratto da progetto avente una sezione media omogenea di 2,50 m e raggi di curvatura non inferiori a 3,50 m. La rete potrà essere ulteriormente estesa per favorire la fruizione delle ville presenti sul territorio (Lainate, Arese); l’utilizzo delle bici potrà essere inoltre incentivato qualora venisse realizzato un servizio di noleggio biciclette in corrispondenza della fermata delle ferrovie Nord sita nel comune di Garbagnate presso l’entrata del Parco delle Groane. Per quanto riguarda la messa in sicurezza dei percorsi, si segnala la realizzazione del sovrappasso della ex SS Varesina dove in precedenza esisteva solo un attraversamento a raso. 6.5 – Comune di Lainate Piedibus Il Piedibus è un progetto attraverso il quale si cerca di educare bambini (e genitori) a lasciare l'auto in garage ed andare a scuola a piedi seguendo un percorso a tappe utilizzando, quando possibile, le piste ciclabili o ciclo-pedonali esistenti, accompagnati da genitori volontari dei Comitati Genitori delle scuole aderenti, sotto la vigilanza nei tratti più critici e pericolosi di agenti di Polizia locale o volontari delle Associazioni di Protezione Civile lainatesi (in particolare, Carabinieri e Polizia di Stato). Dopo le prime esperienze del 2008 e del 2009 l’esperienza del piedibus si è oramai consolidata e viene gestita direttamente dai genitori. Nei precedenti anni, il progetto ha ottenuto grande successo e molti insegnanti e genitori hanno espresso il desiderio di ripetere l’esperienza, anche in modo autonomo rispetto al coinvolgimento delle forze di Polizia, individuando una serie di percorsi protetti. Per rendere più stabile e più sicuro il Piedibus, nel maggio 2009 la Polizia locale ha indetto un concorso a premi tra i bambini delle classi prime, terze e quinte (le classi coinvolte nel progetto di educazione stradale della PL) di tutte le scuole primarie lainatesi, con lo scopo di realizzare un disegno/logo per la posa dei cartelli stradali necessari alla creazione di un percorso casa-scuola permanente del progetto Piedibus. Sul territorio sono stati posizionati circa 30 cartelli stradali, nei quali vengono riportati il percorso e le varie fermate con gli orari, come se fosse un vero e proprio percorso di un servizio pubblico.
35
Rinnovo del parco veicolare dell’ente con criteri ecosostenibili Nel 2007 il Comune di Lainate, per concorrere a un finanziamento della Regione Lombardia, ha dato corso ad un analisi del parco auto comunale, la cui rilevazione ha prodotto i seguenti risultati: l’Amministrazione era in possesso di 15 mezzi (di cui 6 alimentati a gasolio, 5 a benzina, 3 a doppia alimentazione, 1 elettrico), con un’età media dei veicoli di 5,7 anni. L’analisi ha evidenziato una bassa percorrenza media dei mezzi, che è risultata essere di soli 4.770 km annui per veicolo, e l’elevato livello di CO2 emesso dal settore di Polizia locale rispetto al totale delle emissioni del parco veicolare comunale, imputabile all’elevato chilometraggio e al numero di mezzi in dotazione. Pertanto, nel corso degli anni successivi alcuni di questi veicoli sono stati rottamati e sostituiti con mezzi meno inquinanti: in particolare, per la Polizia locale si è acquistato un veicolo alimentato a gas, oltre ad un ciclomotore elettrico e a due biciclette a pedalata assistita (bici elettriche). 6.6 – Comune di Pero Servizio di trasporto pubblico L’amministrazione comunale di Pero si è distinta in particolare negli ultimi anni per la razionalizzazione del servizio di trasporto pubblico comunale. Gli obiettivi principali che hanno guidato l’operazione di modifica del servizio esistente sono stati: - la fruibilità dei luoghi di interesse del territorio comunale; - la riduzione dei tempi di percorrenza del servizio; - la diminuzione dei tempi di attesa alle fermate; - il miglioramento del livello di comfort e di sicurezza, sia in vettura che a terra; - l’incremento della domanda di trasporto pubblico; - la diminuzione delle emissioni inquinanti; - l’integrazione modale tra autobus e metropolitana. Le migliorie più evidenti, a fronte di una seria razionalizzazione dei percorsi, sono il raddoppio delle corse e il maggiore numero di fermate giornaliere, che dimostrano l’attenzione con la quale il servizio di trasporto pubblico urbano è diffuso capillarmente sul territorio. Altra novità introdotta non meno rilevante è l’estensione del servizio pubblico, che viene così a coprire la fascia oraria 7:15-19:40, per favorire la mobilità di lavoratori e studenti pendolari (residenti a Cerchiate e Cerchiarello) per recarsi alle fermate della metropolita sfruttando il trasporto pubblico. Il percorso di andata risulta pari a circa 6,7 km, mentre quello di ritorno a circa 5,5 km, per un servizio di percorrenza annuo pari a complessivi 23.790 km. Inoltre, l’impiego di un pulmino a 19 posti (a sedere) Euro 4 per il trasporto comunale consente una diminuzione degli elementi atmosferici inquinanti e la realizzazione della “carta dei servizi della mobilità” definisce lo standard di puntualità, regolarità e pulizia dei mezzi e assicura un livello elevato di servizio costituiscono ulteriori elementi di qualità del servizio. La politica tariffaria adottata è particolarmente favorevole (al costo di 0,50 € la corsa, gratuito per i minori di anni 14 e i maggiori di anni 65), al fine di incentivare ulteriormente l’utilizzo del trasporto urbano. Servizio di trasporto aziendale
36
Unitamente al trasporto pubblico urbano, va ricordato il servizio di trasporto dedicato attivo per alcune aziende di Pero, che finanziando economicamente il servizio sostengono le azioni di miglioramento delle politiche ambientali dell’Amministrazione comunale limitando l’uso delle automobili private. Il servizio di trasporto aziendale è rivolto ai lavoratori delle Aziende di Pero che hanno sottoscritto una convenzione con l’Amministrazione comunale: è attiva una linea che collega la fermata della metropolitana MM1 Molino Dorino alle aziende site in via Morandi a Cerchiarello, con una fermata intermedia nei pressi di via Figino/Boschi. L’orario delle corse, due al mattino e due alla sera, è stato strutturato in modo tale da essere compatibile con l’entrata e l’uscita dei lavoratori dalle aziende. Il percorso (Molino Dorino-Figino-Morandi) è pari in andata a circa 4,5 km e in ritorno a circa 4,1 km, per un servizio di percorrenza annuo pari a complessivi 3.288 km. 6.7 – Provincia di Milano La Provincia di Milano ha implementato nel corso dell’ultimo decennio vari progetti atti a favorire una mobilità più sostenibile. Le buone pratiche condotte dall’Amministrazione provinciale ed attuate nel territorio di riferimento, sono riportate di seguito. Coordinamento Intercomunale d’Area sulla Mobilità Sostenibile A seguito dell’esperienza del progetto pilota sulla mobilità sostenibile nel Vimercatese, cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente con 1,8 milioni di Euro, che ha visto la Provincia di Milano quale capofila e il coinvolgimento quali partner di progetto di 6 Amministrazioni comunali (Agrate Brianza, Arcore, Concorezzo, Monza, Villasanta, Vimercate) e 7 aziende private (Alcatel, Celestica, IBM, Peg Perego, Soges, Star, Stmicroelectronics), la Provincia di Milano ha disposto la creazione di un “Coordinamento Intercomunale d’Area sulla Mobilità Sostenibile”. Tale Coordinamento si occupa principalmente di creare sinergie tra la Provincia, le Amministrazioni Pubbliche e le aziende allo scopo di razionalizzare gli spostamenti sistematici sul territorio. La condivisione del know-how, il supporto alla redazione dei Piani degli Spostamento Casa-Lavoro (PSCL) aziendali, l’integrazione di progetti sviluppati singolarmente sono i tratti peculiari del Coordinamento. Bollettini periodici MMNews Un aspetto di fondamentale importanza nella gestione delle politiche di mobilità è saper orientare i comportamenti creando consenso e non in modo coercitivo. Una buona comunicazione si rivela efficace quando induce la modifica di abitudini consolidate, e quindi può portare in modo graduale al cambiamento del proprio sistema di valori. La Provincia privilegia gli strumenti di comunicazione funzionali alla gestione delle politiche di mobilità in quanto capaci di fornire informazioni e al contempo richiamare ad una scelta consapevole, focalizzare l’attenzione sulle ricadute ambientali, economiche e sociali della mobilità. La pubblicazione MMNews (Mobility Management News) è lo strumento più diffuso, trattasi di un bollettino informativo distribuito in seimila copie con cadenza bimestrale alle aziende e ai comuni aderenti al Coordinamento. Il bollettino viene altresì divulgato ad enti, aziende e direttamente ai dipendenti mediante l’invio in formato elettronico e la sua collocazione sul sito Internet del Settore.
37
Oltre alle informazioni sulle campagne abbonamenti o sugli incentivi del Trasporto Pubblico Locale, il bollettino promuove la mobilità sostenibile divulgando iniziative, seminari o convegni tanto nelle cadenze previste quanto nei numeri monografici dedicati a particolari iniziative e nei numeri speciali. Gasati (incentivi per la trasformazione a Gpl/metano) Fin dal 2000 in Italia i livelli più alti di governo hanno incentivato l’utilizzo delle auto alimentate a metano e Gpl. La Provincia di Milano ha seguito questo stesso orientamento con la promozione della campagna Gasati, che consiste in un incentivo alla trasformazione delle auto da benzina a Gpl/metano. Oggigiorno emerge con forza la necessità di monitorare i risultati conseguiti dal progetto. Si intende pertanto, viste le crescenti richieste di trasformazione a Gpl o metano finanziate da Provincia, sviluppare un sistema di controllo che renda conto di quanto questa trasformazione sia efficace in termini di riduzione della produzione di anidride carbonica. Tale sistema consiste sostanzialmente nel confronto delle emissioni del veicolo con alimentazione a benzina con il certificato di emissioni del veicolo trasformato ed alimentato a gas. Per l’erogazione dell’incentivo alla trasformazione si richiede l’ultimo certificato delle emissioni obbligatorio prodotto per il veicolo. Inoltre, una volta effettuata la trasformazione a gas, si richiede il nuovo livello di emissioni prodotte dall’auto appena trasformata, cui seguirà l’erogazione dell’incentivo a rimborso della spesa. Eco_spes@ (spesa on line) La Provincia di Milano da diversi anni ha avviato un sistema di incentivi per favorire la spesa on-line (ora Eco_spes@), che consente di non recarsi nel luogo di distribuzione con il proprio mezzo privato per effettuare gli acquisti. Infatti, attraverso ordinazioni via Internet, si possono evitare gli spostamenti da/per il punto vendita. L’esigenza di finanziare questa attività è nata dalla lettura di diverse indagini spostamenti casa-lavoro effettuate presso aziende/enti che facevano rilevare una importante problematica. Infatti diversi lavoratori scelgono di usare l’automobile perché effettuano soste durante tale spostamento per recarsi a fare la spesa: l’introduzione della spesa on line è volta a diminuire questa esigenza. Si intende, quindi, proporre la continuazione di questa incentivazione, accompagnandola con un monitoraggio che consenta di capire se chi si avvale della spesa on line varia le sue abitudini legate all’utilizzo del mezzo privato per recarsi al lavoro.
38
7. Metodologia per la stima delle emissioni prodotte dai veicoli durante gli spostamenti casa lavoro3
Indice
0 Premessa 1 Inquadramento
1.1 Descrizione generale 2 Descrizione delle sorgenti di inquinamento
2.1 Descrizione del processo 2.1.1 Inquadramento 2.1.2 attività coperte 2.1.3 tecnologie e relative regolamentazioni
3 Metodo di stima 3.1 Algoritmo 3.2 dati di partenza: assunzioni ed ipotesi di lavoro
3.2.1 dati ricavati da un'indagine diretta 3.2.2 dati ricavati da fonti esterne o da rielaborazione dei risultati di indagine
3.2.2.1 dati di temperatura e numero di giorni di pioggia 3.2.2.2 lunghezza di percorso 3.2.2.3 metodo di stima delle velocità medie 3.2.2.4 consumi 3.2.2.5 consumi di metano
3.2.3 dati richiesti al responsabile della gestione del personale a cui si rivolge la ricerca 3.3 fattori di emissione
3.3.1 fattori di emissione a caldo 3.3.2 fattori di emissione a freddo 3.3.3 emissioni dipendenti dal consumo di carburante 3.3.4 emissioni di anidride carbonica 3.3.5 fattori correttivi delle emissioni 3.3.6 degrado delle emissioni dovuto all’età dei veicoli 3.3.7 effetti del carburante
3.4 dati statistici di attività 4 funzioni per il calcolo dei fattori di emissione
4.1 auto passeggeri a benzina 4.1.1 Pre-Euro
4.1.1.1 Emissioni a caldo 4.1.1.2 Emissioni a freddo
4.1.2 Euro 1 e successivi 4.1.2.1 Emissioni a caldo 4.1.2.2 Emissioni a freddo
4.2 auto passeggeri a Diesel 4.2.1 Pre-Euro
4.2.1.1 Emissioni a caldo 4.2.1.2 Emissioni a freddo
3 La ricerca descritta nei capitoli 7 e 8 è stata realizzata dall’ingegnere Stefano Baldo.
39
4.2.2 Euro 1 e successivi 4.2.2.1 Emissioni a caldo 4.2.2.2 Emissioni a freddo
4.3 auto passeggeri a GPL 4.3.1 emissioni a caldo 4.3.2 emissioni a freddo
4.4 auto passeggeri a motore ibrido 4.5 ciclomotori a 2 cilindri <50 cc 4.6 motocicli >50 cc 4.6 funzioni che esprimono il degrado delle emissioni in funzione dei chilometri percorsi 4.7 effetti del carburante
5 metodologia per la stima del PM non esausto 5.1 algoritmo di calcolo per le emissioni da usura di freni e pneumatici
5.1.1 fattori di emissione da usura di freni e pneumatici 5.1.1 fattori di emissione da usura di freni e pneumatici
5.1.1.1 fattori di emissione da usura di pneumatici 5.1.1.2 fattori di emissione da usura di freni
5.2 algoritmo e fattori di emissione da usura del manto stradale 6 Procedura per la stima delle emissioni
6.1 dati derivati dall’indagine 6.1.1 tempi di percorrenza 6.1.2 scomposizione del tragitto casa-lavoro 6.1.3 determinazione delle velocità medie relative ai diversi tipi di percorso 6.1.4 tragitto percorso a freddo 6.2.1 stima dati ambientali 6.2.2 numero di spostamenti effettivi in un anno
6.3 applicazione delle funzioni dei fattori di emissione 6.3.1 suddivisione del campione 6.3.2 correzioni
6.4 verifica del bilancio del carburante 7 Qualità dei dati
7.1 verifiche 7.1.1 verifica attraverso il bilancio del consumo di carburante 7.1.2 campi di applicazione dei fattori di emissione a caldo 7.1.3 Accuratezza e precisione 7.1.4 scala di lavoro
8 Riferimenti bibliografici e siti Internet
40
0 - Premessa Nel presente documento viene descritta la metodologia per la stima delle emissione prodotta da veicoli durante gli spostamenti casa lavoro. Essa consiste nell’applicazione e adattamento4 delle linee guida contenute nel testo: “ EMEP/EEA emission inventory guidebook ” predisposta dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, di cui si allega una parziale traduzione ed a cui si rimanda per approfondimenti. La presente metodologia (di seguito “metodologia”) risulta infatti modificata rispetto all'originale (di seguito “metodologia originaria”), poichè mira alla descrizione di un metodo per la stima delle emissioni prodotte su scala molto piccola e non serve, come nel caso della metodologia originaria, a realizzare un inventario delle emissioni a livello nazionale. Tuttavia, nel corso della trattazione, saranno riportate tabelle estratte direttamente dalla metodologia originaria. La maggior parte degli spostamenti casa lavoro avvengono in ambito urbano, e dato che la produzione di CO2 e il PM costituisce il maggiore problema ambientale prodotto dal traffico, qui vengono trattate solo le emissioni di anidride carbonica (CO2) e particolato fine (PM), prodotte da veicoli adibiti al trasporto passeggeri. L'obiettivo della metodologia è quello di definire un metodo per la stima delle emissioni, che possa essere adottato da parte di aziende o enti, per ottenere una stima delle emissioni prodotte annualmente dai propri dipendenti durante gli spostamenti casa lavoro. 1 - Inquadramento 1.1 - Descrizione generale La metodologia, attraverso l’elaborazione dei risultati di un’indagine spostamenti casa-lavoro, permette di calcolare le emissioni contenute nei gas di scarico delle seguenti categorie di veicoli:
• automobili destinate al trasporto passeggeri • ciclomotori e motocicli
Gli inquinanti presi in esame sono i seguenti: • monossido di carbonio (CO); • anidride carbonica (CO2); • particolato fine (PM2,5) sia come prodotti di combustione, sia di altra origine; • composti organici volatili (COV, o con acronimo inglese VOC); La scala spaziale di riferimento corrisponde all’ambito territoriale entro il quale abitano i dipendenti dell’organizzazione che intende effettuare l’indagine spostamenti casa-lavoro. Il periodo di riferimento per la stima è l’anno, mentre con l’indagine si raccolgono dati per caratterizzare uno spostamento tipo giornaliero, da cui si simuleranno gli spostamenti in un anno. Si fa notare che la stima delle emissioni di CO e COV consentiranno, come spiegato nel paragrafo 3.3.4, la stima delle emissioni nette di CO2. Al fine di rendere la metodologia più completa, nel capitolo 5 viene trattata anche la procedura di stima delle emissioni prodotte dall’usura di pneumatici, dei freni e dall’usura del manto stradale. Le stime di emissione del PM si riferiscono al PM 2,5, poiché la frazione grossolana (PM >2,5)è trascurabile nelle emissioni allo scarico, allo
4 Alcune parti del testo e le tabelle sono state riprese in modo identico dalle linee guida “ EMEP/EEA emission
inventory guidebook ”
41
stesso modo, per poter effettuare un confronto, si stimeranno le emissioni di PM 2,5 non esausto. La presente metodologia consente di calcolare anche il consumo di carburante. 2 - Descrizione delle sorgenti di inquinamento 2.1 - Descrizione del processo 2.1.1 - Inquadramento Le emissioni di gas esausti prodotte dai veicoli su strada nascono dalla combustione di carburanti come, la benzina, il gasolio, il gas da petrolio liquefatto (GPL), ed il gas naturale nei motori a combustione interna. La combustione della miscela aria/carburante può essere avviata attraverso una scintilla oppure spontaneamente dalla compressione. 2.1.2 - Attività coperte Le emissioni di CO2 e PM prodotte da veicoli adibiti al trasporto passeggeri sono associate alle due categorie di veicoli elencate nel paragrafo 1.1. Per avere una stima più dettagliata delle emissioni, queste categorie devono essere suddivise secondo il tipo di alimentazione, la cilindrata, e rispetto alla normativa così detta Euro. I fattori di emissione associati a queste categorie di veicoli possono essere ulteriormente suddivise in tre diversi “stili di guida”, individuati secondo tre tipologie di strada percorsa: “autostrada”, “strada extraurbana” e “urbana”. 2.1.3 - Tecnologie e relative regolamentazioni Nelle pagine seguenti si riportano le tabelle riepilogative delle tecnologie e delle regolamentazioni associate trattate da questo testo. Lo schema identifica i veicoli trattati, auto passeggeri e motoveicoli, distinti per: alimentazione, cilindrata e normativa antinquinamento europea di riferimento. Tabella 2.1 categorie di veicoli adibiti al trasporto passeggeri trattati dalla presente metodologia
43
3 - Metodo di stima Il livello di dettaglio della presente metodologia si può considerare medio-alto, poiché attraverso un'indagine diretta, si ricavano le stime delle lunghezze dei percorsi su diversi tipi di strada (urbano, extraurbano, autostradale), e si raggiunge una stima dettagliata del consumo di carburante. Pertanto si procede con l'adattamento che nella metodologia originaria è indicata con il livello 3. Tutte le elaborazioni vengono effettuate, in una prima fase, avendo come riferimento, in termini di percorrenze, il tragitto giornaliero casa-lavoro. Successivamente verranno effettuate le opportune estensioni a periodi diversi (settimana, mese, anno). 3.1 - Algoritmo Il totale delle emissioni dei gas esausti prodotte dai veicoli adibiti al trasporto passeggeri vengono calcolati come somma delle emissioni a caldo dipendenti dalla velocità media (quando il motore è nelle sue normali condizioni operative di temperatura), e le emissioni prodotte durante la fase di transizione per raggiungere le normali condizioni operative, ( chiamate “emissioni a freddo”). Si deve notare che, in questo contesto, per “motore” si intende “motore e tutti i dispositivi di post-trattamento dei gas esausti”. La distinzione tra emissioni durante la fase “a regime” del motore e quella di “transizione”, di riscaldamento, è necessaria a causa della sostanziale differenza di prestazione in termini di riduzione di emissione nei veicoli. Le concentrazioni di alcuni inquinanti durante la fase di riscaldamento sono spesso più alte che durante la condizione a caldo. Pertanto, si richiede un differente metodo per la stima delle emissioni durante la fase a freddo, queste ultime sono dipendenti dalla temperatura ambiente e dalla lunghezza media del percorso. Riassumendo, il totale delle emissioni può essere calcolato attraverso la seguente equazione: ETOT = EHOT + ECOLD (1) dove, ETOT= emissioni totali (g) per ciascun inquinante alla scala di applicazione temporale e spaziale, EHOT = emissioni (g) durante la fase operativa di regime del motore a caldo (hot), ECOLD = emissioni (g) durante la fase di transizione di riscaldamento del motore a freddo (cold-start). Le emissioni prodotte dai veicoli sono fortemente dipendenti dalle condizioni operative del motore e dallo “stile di guida”. Differenti situazioni di guida determinano differenti condizioni del motore, e quindi una differente prestazione in termini di emissioni. A questo proposito, si opera una ulteriore distinzione tra “stile di guida” in urbano, extraurbano e autostradale, identificando quindi lo “stile di guida” con il tipo di strada percorsa. Pertanto, vengono attribuiti diversi fattori di emissione per ogni stile di guida. Le emissioni a freddo vengono attribuite principalmente allo stile di guida urbano (e solo in seconda istanza allo stile extraurbano), poiché ci si aspetta che solo un limitato numero di viaggi comincia a partire da un’autostrada. Quindi per quanto riguarda gli stili di guida, il totale delle emissioni si calcola attraverso la seguente equazione:
44
ETOT = EU + EEU + EA (2) dove: EU, EEU e EA sono il totale delle emissioni (g) di ciascun inquinante per il rispettivo stile di guida. 3.2 - Dati di partenza: assunzioni ed ipotesi di lavoro Prima di avviare la procedura per la stima delle emissioni è necessario procedere con la raccolta di tutti i dati necessari. Questi ultimi si possono distinguere in tre categorie:
1. dati ricavati da un'indagine diretta ai dipendenti della propria organizzazione (azienda o ente) di cui si vuole stimare le emissioni,
2. dati ricavati da fonti esterne o da rielaborazione dei risultati della precedente indagine, 3. dati richiesti al responsabile della gestione del personale a cui si rivolge la ricerca.
Inoltre, al fine di semplificare le elaborazioni, è necessario definire adeguate assunzioni e ipotesi di lavoro descritte nei prossimi paragrafi. 3.2.1 - Dati ricavati da un'indagine diretta Come si è detto la metodologia potrà essere impiegata da medio piccole realtà aziendali o enti pubblici che siano intenzionati, attraverso un'indagine conoscitiva, a determinare una stima delle emissioni prodotte dai veicoli dei propri dipendenti durante gli spostamenti casa-lavoro. Di seguito si propone un elenco di domande che dovranno comparire nel questionario dell'indagine spostamenti casa lavoro, necessarie al reperimento di informazioni utili alla stima delle emissioni:
1. indirizzo del luogo di lavoro 2. indirizzo dell'abitazione da cui si parte per recarsi a lavoro 3. se lo spostamento è diretto o si fanno soste intermedie 4. quanti minuti durano le soste nel tragitto casa-lavoro 5. quanti minuti durano le soste nel tragitto lavoro-casa 6. orario di partenza da casa per recarsi al lavoro 7. orario di arrivo a lavoro 8. orario di uscita dal lavoro 9. orario di arrivo a casa 10. tipo e sequenza del o dei mezzi (se si usa più di un mezzo) che si usano per gli spostamenti
casa lavoro 11. se si sceglie il tragitto da effettuare secondo criteri di rapidità o lunghezza del percorso 12. tipo e caratteristiche del mezzo usato nel periodo estivo 13. tipo di motore del veicolo usato per recarsi normalmente a lavoro 14. anno di prima immatricolazione del veicolo 15. chilometri percorsi fino al momento dell'indagine 16. cilindrata del veicolo 17. categoria Euro 18. spesa media mensile per il carburante
Quasi tutte le domande prevedono risposte predeterminate fra cui il dipendente potrà scegliere.
45
Di seguito se ne fornisce una descrizione: Quesiti 1-2 Si richiedono gli indirizzi del luogo di lavoro e di casa perché costituiscono rispettivamente il punto di arrivo e di partenza del percorso da studiare. Queste informazioni dovranno essere il più possibile dettagliate. Si dovrà fornire il nome del Comune e l'indirizzo comprensivo di numero civico e codice di avviamento postale. Quesito 3 Interessa conoscere se ci siano soste durante il tragitto al fine di prevedere se vi siano grandi divergenze rispetto al tragitto diretto casa-lavoro. Quesiti 4-5 Queste informazioni unite a quelle del quesito precedente consentono di calcolare quale tempo non sia impiegato per il solo tragitto casa lavoro Quesiti 6-7-8-9 Conoscere gli orari di arrivo e partenza sia per il tragitto casa-lavoro, sia per quello lavoro-casa consente di determinare i tempi di percorrenza impiegati da ogni singolo veicolo. A tali tempi devono essere sottratti i tempi in cui si effettuano le soste. Questa operazione consente di confrontare i tempi netti impiegati per l'andata e quelli per il viaggio di ritorno. Quest'ultimo calcolo porta a verificare quanto siano diversi (in termini di tempo impiegato) i percorsi di andata e ritorno. Se la differenza risulta di bassa entità, si assume che il viaggio di andata e di ritorno siano uguali anche per lunghezza e quindi si procede a stimare le emissioni come se i due percorsi fossero uguali. Quesito 10 Si deve conoscere se il mezzo utilizzato sia un'automobile oppure un motociclo/ciclomotore Quesito 11 Questa informazione insieme a quelle ottenute con i quesiti da 1 a 9 concorre a definire le caratteristiche del percorso. Infatti, conoscendo la lunghezza ed il tempo impiegato per ogni singolo percorso se ne determina la velocità media. Conoscere se il percorso è stato scelto con criteri di rapidità o lunghezza consente di definire meglio le caratteristiche del singolo viaggio. Con queste informazioni (luoghi e tempi di arrivo e partenza, tragitto rapido, o breve), attraverso uno strumento di tipo GPS o analoghi strumenti a disposizione su internet si può simulare ogni singolo percorso, ed anche dividerlo in diverse tipologie di strada percorse (urbana, extraurbana, e autostradale). In questo modo, si potranno conoscere il numero di chilometri percorsi nelle diverse tipologie e quindi determinare la velocità media per ogni diverso tipo di strada. Quesito 12
46
Gli effetti del clima ambientale, ed in particolare la temperatura, si riflettono sull'entità delle emissioni prodotte dai veicoli, quindi, assumendo che in estate alcuni individui decidano di recarsi a lavoro con un mezzo diverso, ne consegue che il periodo estivo debba essere valutato in maniera separata. Quesito 13 Si possono indirizzare le risposte a questa domanda proponendo le diverse tipologie di motore previste dalla metodologia originaria:
• a benzina, • a benzina ad iniezione diretta, • Diesel senza filtro anti-particolato, • Diesel con anti-particolato, • a gpl, • a metano • ibrido (benzina più elettrico).
Per i veicoli a due ruote si distinguono tre tipi, è necessario sapere se si tratta di un ciclomotore o di un motociclo a due o quattro cilindri. Quesito 14 conoscere l'anno di immatricolazione permette, oltre a fornire l'indicazione dell'età del parco veicolare considerato, consente di valutare i consumi. Quesito 15 Il numero di chilometri percorsi dal veicolo consente di apportare correzioni alla stima delle emissioni dovute all'usura del veicolo stesso. La metodologia originaria prevede il calcolo di appositi coefficienti correttivi. Quesito 16-17 Queste informazioni risultano indispensabili alla caratterizzazione dei veicoli. Si dividono i tipi di cilindrata in tre classi
• cilindrata fino a 1400 cc • cilindrata da 1400 cc a 2000 cc • cilindrata oltre 2000 cc
Le categorie Euro sono le 6 conosciute, inoltre si aggiunge una categoria denominata Euro 0 per individuare tutti i veicoli precedenti all’entrata in vigore delle normative Euro. Quesito 18 La richiesta della spesa mensile consente di determinare il consumo medio dei veicoli presi in considerazione
47
3.2.2 - Dati ricavati da fonti esterne o da rielaborazione dei risultati di indagine Di seguito si presenta il metodo per il calcolo delle emissioni a freddo. Poiché esso dipenderà dalla temperatura e dalla lunghezza media del percorso sarà necessario reperire queste informazioni. 3.2.2.1 - Dati di temperatura e numero di giorni di pioggia Le emissioni prodotte con il motore a freddo dipendono dalla temperatura, risulta quindi necessario individuare un valore di temperatura ambiente adeguato rispetto al periodo di riferimento su cui si vuole effettuare la stima. Poiché si intende stimare le emissioni prendendo come periodo di riferimento l'anno, si possono reperire le serie storiche delle temperature giornaliere o mensili presso gli organi competenti (p.e. ARPA) e ricavare una media mensile o annuale su una base di dati di almeno 4 anni precedenti. Su questa base di dati è possibile definire un valore medio di temperatura per ogni stagione, avendo così 4 valori distinti di riferimento, e conseguenti differenti emissioni a freddo. Si possono determinare quattro valori stagionali come segue:
1. media delle temperature mensili nel periodo estivo (giugno, luglio, agosto) dei 4 anni precedenti
2. media delle temperature mensili nel periodo primaverile (marzo, aprile, maggio) dei 4 anni precedenti
3. media delle temperature mensili nel periodo autunnale (settembre, ottobre, novembre) dei 4 anni precedenti
4. media delle temperature mensili nel periodo estivo (dicembre, gennaio, febbraio) dei 4 anni precedenti
Ovviamente ci si aspetta, a queste latitudini, che il valore di temperatura in primavera e autunno siano simili, il valore estivo sia il più alto e quello invernale il più basso. Contemporaneamente si possono raccogliere le serie storiche dei giorni di pioggia che serviranno alla stima delle emissioni prodotte dall'usura di pneumatici, freni e manto stradale. Infatti si assume che nei giorni di pioggia non abbiano luogo emissioni di PM non esausto. 3.2.2.2 - Lunghezza di percorso I risultati dell'indagine forniranno i valori dei singoli tragitti, pertanto si può determinarne la lunghezza del percorso medio, utile per il calcolo delle emissioni a freddo. 3.2.2.3 - Metodo di stima delle velocità medie Poiché i fattori di emissione a caldo dipendono dalla velocità media di percorrenza, l’individuazione di questa informazione e della distinzione del valore di velocità associato ad ogni tipo di strada risulta di fondamentale importanza. La metodologia originaria propone di assegnare una velocità rappresentativa della velocità media per ogni tipo di strada ‘urbana’, ‘extraurbana’ e ‘autostrada’ (p.e. 20 km/h, 60 km/h e 100 km/h, rispettivamente). Di seguito si descrive brevemente un metodo per stimare i valori di tali velocità. I risultati dell'indagine forniranno i tempi e i punti di partenza e arrivo di ogni singolo percorso, successivamente, attraverso uno strumento di calcolo del percorso di tipo GPS, si suddividono i percorsi nei diversi tipi di strada, ottenendo le frazioni di percorso di tipo urbano, extraurbano ed autostradale. In seguito, con un'operazione di regressione lineare si possono stimare le velocità medie per ogni tipo di strada.
48
Il tempo T e lo spazio S sono legati dalla relazione T=S/V dove S è lo spazio percorso e V e la velocità di percorrenza. Il tempo impiegato per percorrere ogni singola porzione del tragitto casa-lavoro può essere descritto come la somma dei tempi impiegati per percorrere i diversi tratti come segue: Ť= tu+te+ta (3) dove Ť rappresenta il tempo impiegato per percorrere l'intero tragitto casa-lavoro, tu la frazione di tempo impiegato per percorrere la parte urbana dello stesso percorso, te la frazione di tempo impiegato per percorrere la parte extraurbana dello stesso percorso e ta la parte relativa alla frazione autostradale. Abbiamo detto che T si esprime come rapporto S/V e quindi sostituendo nella (3) si ha: Ť= su/vu+se/ve+ sa/va (4) Dove, su,se,sa rappresentano lo spazio percorso per i diversi tipi di strada (rispettivamente urbano, extraurbano, autostradale) vu,ve,va rappresentano la velocità media per i diversi tipi di strada (rispettivamente urbano, extraurbano autostradale). Nel nostro caso le nostre incognite nell'equazione (4) risultano essere le velocità. I risultati dell'indagine porteranno a conoscere i valori del vettore T (colonna dei tempi di ogni singolo viaggio) e la matrice Suea (matrice S degli spazi percorsi in urbano, extraurbano e autostradale) delle diverse porzioni di spazio percorso, le colonne di detta matrice saranno costituite rispettivamente dai valori delle porzioni di tragitto urbano, extraurbano e autostradale. Le righe della matrice individuano i singoli percorsi. Di seguito si riporta l’esempio del vettore T e della matrice Suea
T1 Su11 Se12 Sa13 T2 Su21 Se22 Sa23 … … … … Ti Sujk Sejk Sjk Tn Sun1 Sen2 San3
Dove n rappresenta la numerosità del campione dell’indagine e Sun1, Sen2, San3 e Tn rispettivamente i valori urbano extraurbano e autostradale, e il tempo di percorrenza dell’n-esimo tragitto. Dall'applicazione di una regressione lineare, simbolicamente rappresentata dalla seguente equazione matriciale T=C *Suea (5) si otterranno i tre coefficienti Cu, Ce, Ca che rappresentano gli inversi della stima delle velocità medie relative alle diverse porzioni di percorso, come indicato di seguito Cu=1/vu; Ce=1/ve; Ca= 1/va
49
Si sottolinea che i valori dei coefficienti ricavati non costituiscono la reale media delle velocità di ogni singolo tratto, ma si assume di poter prendere questi risultati come buona approssimazione delle velocità medie. Tale valore, infatti, risulta strettamente dipendente dalla numerosità del campione analizzato. In seguito è possibile confrontare i risultati attraverso la consultazione presso enti preposti o di studi e strumenti di pianificazione al fine di verificarne l'attendibilità. 3.2.2.4 - Consumi Ai fini della stima delle emissioni, la valutazione del consumo di carburante risulta fondamentale per una verifica dell'attendibilità dei risultati raggiunti. La metodologia prevede di calcolare il fattore di consumo, quindi di determinare il consumo per ogni classe di veicoli. Al fine di effettuare il confronto tra consumi calcolati e i consumi rilevati attraverso l’indagine si propone una procedura che si può adottare:
1. Il questionario richiede la spesa media mensile per il carburante. Si può procedere all’individuazione del prezzo medio per ogni carburante.
2. Tale dato è messo a disposizione presso il sito web del Ministero dello sviluppo economico,
esso va valutato su un numero di anni, se possibile, pari all’età media del parco veicoli in considerazione, (media delle differenze dell'anno in corso e l'anno di prima immatricolazione) e, poi, lo stesso va attualizzato all'anno di riferimento attraverso i coefficienti di rivalutazione monetaria predisposti dall’ISTAT.
3. Si può procedere, poi, a dividere il valore della spesa mensile ottenuta dai risultati
dell'indagine, per il prezzo del carburante al litro e si ottiene il consumo in litri.
4. Si propone di calcolare la media dei valori in litri ottenuti.
5. Successivamente si possono dividere i chilometri percorsi dai veicoli (chilometraggio), ricavati dai risultati di indagine, per l'età del veicolo e diviso i dodici mesi dell'anno. Si assume che questa ultima sia una buona stima della percorrenza mensile del veicolo.
6. Si può calcolare la media dei valori di percorrenze mensili ottenuti.
7. Per ottenere il consumo medio per chilometro si effettua il rapporto della media dei valori in
litri, calcolato al punto 4, e la media delle percorrenze calcolato al punto 6, ottenendo il consumo mensile.
8. Il valore ottenuto di consumo medio in litri per chilometro che, attraverso il peso specifico
del carburante, si trasforma in chilogrammi, si moltiplica per i chilometri percorsi per il tragitto casa-lavoro per ogni classe di veicolo. La somma di questi ultimi valori determina il consumo totale dei veicoli nel tragitto casa-lavoro. Si considera il valore ottenuto come un valore statistico di riferimento, in quanto ottenuto da informazioni ricavate da indagine diretta.
50
9. In fine, Il rapporto tra il valore statistico ed il valore calcolato con la metodologia fornisce il livello di attendibilità della stima delle emissioni di inquinanti dipendenti dal consumo di carburante. Il risultato del rapporto tra valore statistico e calcolato deve essere vicino ad uno.
3.2.2.5 - Consumi di metano Si noti che attualmente la stima del consumo dei veicoli a metano, adibiti al trasporto passeggeri, risulta difficoltosa a causa della carenza di dati. Pertanto è utile valutare il metodo di stima in funzione della qualità e quantità di dati disponibili. In particolare, è possibile procedere, analogamente agli altri carburanti, dividendo le spese mensili per il costo del metano al chilogrammo. Successivamente si calcola la media dei valori ottenuti e si determina il consumo mensile in kg. Si calcola poi la media delle percorrenze mensili dei veicoli, così come spiegato al paragrafo precedente. E si definisce così il consumo medio mensile per chilometro (kg/km), dividendo la media dei consumi in kg per la media delle percorrenze mensili. Infine, moltiplicando il valore ottenuto per i chilometri percorsi si ottiene il consumo totale. 3.2.3 - Dati richiesti al responsabile della gestione del personale a cui si rivolge la ricerca Poiché si intende valutare la stima delle emissioni annuale prodotta dai veicoli solo per gli spostamenti casa-lavoro, risulta utile richiedere al responsabile della gestione del personale quale sia il numero medio annuale dei giorni in cui un dipendente si reca a lavoro, al netto di ferie e giorni di malattia. Si assume, inoltre, che durante l'anno vi sia una diversa concentrazione di giorni lavorati nei quattro periodi stagionali individuati. Pertanto, si fornisce un peso per ogni stagione (0,3 primavera e autunno, 0,25 inverno, 0,15 estate) e si moltiplica per i giorni lavorati in una anno e si ottiene la stima dei giorni lavorati per ogni stagione. Poiché dal questionario si ottengono informazioni sulla giornata tipo, i valori di emissione da esse ottenuti si devono moltiplicare per il numero di giorni di lavoro in un anno. 3.3 - Fattori di emissione Le emissioni di gas esausto dipendono da vari fattori come: la distanza che ogni veicolo percorre, la sua velocità (o il tipo di strada che percorre), la sua età, il suo peso e la dimensione del motore. 3.3.1 - Fattori di emissione a caldo La formula base per la stima delle emissioni a caldo per un dato periodo è la seguente: emissioni [g] = fattore di emissione [g/km] × numero di veicoli [vei]× km percorsi per veicolo [km/vei] (6) È necessario usare specifici fattori di emissione, numeri di veicoli e percorrenze per veicolo per ogni categoria e classe di veicolo. Il periodo di riferimento (mese, anno, ecc.) si sceglie a seconda dell’applicazione. Quindi, la formula da applicare per il calcolo delle emissioni a caldo, nel caso di stima delle emissioni in un anno è data dalla seguente:
51
EHOT; i, k, r = Nk × Mk,r × eHOT; i, k, r 5 (7) dove, EHOT; i, k, r = emissioni a caldo dell’inquinante i [g], prodotte nel periodo di riferimento dai veicoli di tecnologia k, viaggiando su strade di tipo r, Nk = numero di veicoli [vei] di tecnologia k nel periodo di riferimento, Mk,r = percorrenze per veicolo [km/vei] effettuate su strade di tipo r da veicoli di tecnologia k, eHOT; i, k, r = fattore di emissione a caldo [g/km] per l’inquinante i, relative ai veicoli di tecnologia k, che hanno percorso strade di tipo r. Gli inquinanti, le classi di veicoli e le tipologie di strade percorse sono individuate come segue: i = inquinanti coperti dalla presente metodologia CO, COV, CO2 e PM, k = tecnologie di veicoli riportata nella tabella 2.1, r = tipo di strada (‘urbana ’, ‘extraurbana ’, e ‘autostrada ’). NOTA: la stessa formula è anche applicata per il calcolo del totale del carburante consumato dai veicoli della specifica classe. 3.3.2 - Fattori di emissione a freddo Le emissioni a freddo si verificano in tutte le categorie di veicoli, però i fattori di emissione sono disponibili, o possono essere ragionevolmente stimati, solo per le auto a benzina, diesel o gpl. Tali fattori, inoltre, non si considerano funzione dell’età del veicolo. Le emissioni a freddo sono calcolate come una extra emissione aggiunta alle emissioni che ci si aspetterebbe se tutti i veicoli operassero con i motori e i dispositivi catalizzatori a caldo. Si applica un fattore corrispondente al rapporto tra emissioni a freddo su emissioni a caldo alla frazione di km percorsi a motore freddo (valore sempre maggiore o uguale a 0). Le emissioni a freddo sono inserite nei calcoli come emissioni addizionali per km, usando la seguente formula: ECOLD; i, k = βi, k × Nk × Mk × eHOT; i, k × (eCOLD / eHOT|i,k - 1)6 (8) dove, ECOLD; i, k = emissioni a freddo dell’inquinante i (per il periodo di riferimento), prodotte dal veicolo di tecnologia k, 5 Attraverso l’utilizzo dei risultati dell’indagine, i valori Nk e Mk,r si possono sostituire direttamente con i chilometri
percorsi da tutti i veicoli di una specifica tecnologia e classe in un determinato tipo di strada. 6 Anche qui, attraverso l’utilizzo dei risultati dell’indagine, i valori Nk e Mk,r si possono sostituire direttamente con i
chilometri percorsi da tutti i veicoli di una specifica tecnologia e classe.
52
βi, k = frazione del chilometraggio percorso con motore a freddo per l’inquinante i e il veicolo di tecnologia k, Nk = numero di veicoli [vei] di tecnologia k in circolazione nel periodo di riferimento, Mk = totale delle percorrenze per veicolo [km/vei] nei veicoli di tecnologia k, eCOLD / eHOT|i,k = rapporto fra emissioni fredde/calde per l’inquinante i per veicoli di tecnologia k. Il parametro β dipende dalla temperatura ambiente ta, e in particolare dalla lunghezza media dello spostamento ltrip. In riferimento ai dati statistici disponibili, è stato individuato in 12.4 km il valore Europeo rappresentativo per ltrip. In ogni caso il valore di ltrip dovrebbe ricadere tra 8 km e 15 km. Quindi, si è proposto che il valore di 12.4 km può essere utilizzato in assenza di altri dati. L’introduzione di standard di emissione più restrittivi per i veicoli a benzina con dispositivi catalizzatori ha imposto tempi per raggiungere la temperatura di regime più brevi. Ciò si riflette in un più basso valore di km percorsi con motore a freddo. Quindi, il parametro β è anche funzione della classe di controlli normativi per le auto a benzina (normativa Euro). Il rapporto tra emissioni fredde ed emissioni calde eCOLD/eHOT dipende anche dalla temperatura ambiente e dall'inquinante considerato. L'approccio proposto non descrive ancora pienamente il comportamento nella fase di riscaldamento dei veicoli di nuova generazione. Come già discusso, le emissioni a freddo vengono normalmente attribuite solo alla parte degli spostamenti svolta in contesto urbano. Tuttavia un'altra porzione può essere attribuita anche ai contesti extraurbani, nei casi in cui lo spostamento svolto in condizioni di riscaldamento (parametro β) superi la frazione di percorso attribuita al contesto urbano (SURBAN). Ciò comporta una modifica dell'equazione (8), che diventa come segue: Se βi,k > SURBAN ECOLD URBAN; i,k = SURBAN; k × Nk × Mk × eHOT URBAN; i,k × (eCOLD / eHOT|i,k – 1) ECOLD RURAL; i,k = (βi,k - SURBAN; k) × Nk × Mk × eHOT URBAN; i, k × (eCOLD / eHOT|i,k – 1) (8-bis) In questo caso si considera che lo spostamento totale percorso in contesto urbano corrisponde alla fase di riscaldamento, mentre la parte di percorso che eccede quello svolto in contesto urbano sono attribuite al contesto extraurbano. Il caso mostrato nell'equazione (8-bis) è piuttosto eccezionale e può capitare solo quando si posseggono veramente pochi dati per definire il ltrip.. Il valore di eHOT che si deve usare nella (8) è quello relativo al contesto urbano. Prima di effettuare la stima delle emissioni a freddo, si deve moltiplicare β per ltrip e verificare che il chilometraggio percorso a freddo non superi il valore del tragitto medio percorso in contesto urbano (dato ricavato dall’indagine). Nel caso tale valore fosse superiore, allora si deve utilizzare l’equazione (8-bis). 3.3.3 - Emissioni dipendenti dal consumo di carburante
53
Le emissioni totali degli inquinanti, che dipendono dal consumo di carburante, si dovrebbero ricavare sulla base di dati statistici (reali) di consumo di carburante, che generalmente sono noti da fonti statistiche. Le emissioni degli inquinanti dipendenti dal consumo di carburante dovrebbero essere prima di tutto determinate sulla base del consumo di carburante calcolato (per ogni classe di veicolo), successivamente si opera una correzione con i dati statistici reali. In termini matematici tale correzione si esprime come segue:
(9) dove,
= l'emissione corretta dell'inquinante i (CO2) emesso dai veicoli di tecnologia k alimentato da carburante m
= l'emissione dell'inquinante dipendente dal consumo di carburante i (CO2) stimato sulla base del consumo di carburante calcolato del veicolo di tecnologia k alimentato da carburante m
= il valore statistico del consumo totale del carburante m (m= benzina, Diesel, GPL, metano)
= il consumo totale di carburante calcolato di tutti i veicoli di tecnologia k alimentati da carburante m
In questo modo il totale delle emissioni degli inquinanti dipendenti dal consumo di carburante è equivalente a quello derivato dalle statistiche di consumo del carburante. 3.3.4 - Emissioni di anidride carbonica Le emissioni di CO2 possono essere stimate in base al solo consumo di carburante, assumendo che il contenuto di carbonio del carburante sia totalmente ossidato in CO2. La massa di CO2 emessa dai veicoli nella tecnologia k che bruciano carburante m può essere calcolata con la seguente formula:
(10) Dove FCCALC è il consumo di carburante m dei veicoli j per il periodo considerato. rH:C,m è il rapporto idrogeno su carbonio descritto nella tabella 3.1 per ogni carburante.
54
Se si vogliono, invece, calcolare le emissioni di CO2 allo scarico, allora si devono prendere in considerazione anche le altre emissioni degli atomi di C in forma di CO,VOC e particolato. Per cui si applica la seguente formula (11):
(11) Nella tabella seguente si riportano i rapporti idrogeno su carbonio di diversi tipi di carburante: Tabella 3.1 rapporti idrogeno su carbonio di diversi tipi di carburante
3.3.5 - Fattori correttivi delle emissioni Le equazioni 7-8 sopra presentate vengono usate per calcolare le emissioni base. È necessario applicare ad esse delle correzioni al fine di considerare le variazioni introdotte dalle seguenti condizioni:
• Età del veicoli (chilometraggio): i fattori di emissione base ricavati con l’equazione 7 corrispondono ad un parco auto con chilometraggio medio di 30.000-60.000 km e già comprendono un fattore di degrado. Si dovrebbe applicare una rimodulazione usando un fattore correttivo di degrado dovuto all’aumento del chilometraggio solo per le auto passeggeri a benzina.
• Miglioramenti del carburante: dal 2000 è diventato obbligatorio in Europa un nuovo
carburante. Gli effetti del carburante migliorato sulle emissioni dei veicoli vecchi e attuali possono essere introdotti attraverso altri fattori di correzione appropriati. Tali fattori possono essere applicati solo per le stime relative agli anni successivi all’introduzione del nuovo carburante.
3.3.6 - Degrado delle emissioni dovuto all’età dei veicoli Bisogna applicare fattori di correzione ai fattori di emissione base per le auto passeggeri a benzina. Tali fattori di correzione sono dati dalla seguente equazione:
55
MCC,i = AM × MMEAN + BM (12) Dove, MCC,i = fattore di correzione del chilometraggio per un dato chilometraggio per l’inquinante i MMEAN = chilometraggio medio dei veicoli per cui si applica la correzione AM = degrado delle emissioni per chilometro BM = livello di emissioni delle auto nuove BM è minore di 1 perché i fattori di correzione sono determinati usando flotte di veicoli con chilometraggi da 16.000 a 50.000 km. Pertanto, ci si aspetta che le auto nuove emettano meno delle auto del campione su cui il fattore di emissione è basato. Si assume che le emissioni non degradino ulteriormente oltre i 120.000 km per le auto euro 1-2, e oltre i 160.000 per le euro 3-4. L’effetto della velocità media sul degrado delle emissioni è preso in considerazione combinando il degrado osservato con i due stili di guida urbano e extraurbano. Si assume che per le velocità al di fuori degli intervalli definiti per le condizioni urbane (19 km/h) e extraurbane (63 km/h) il degrado sia indipendente dalla velocità. Un’interpolazione lineare tra i due valori definisce il degrado delle emissioni negli intervalli intermedi. 3.3.7 - Effetti del carburante I carburanti con caratteristiche migliorate sono diventati obbligatori in due fasi, rispettivamente gennaio 2000 e gennaio 2005. Le tabelle seguenti mostrano le caratteristiche per auto a benzina e Diesel. Tabella 3.2 specifiche della benzina
Tabella 3.3 rapporti specifiche del carburante per motori Diesel
56
I veicoli hanno prodotto emissioni più basse grazie al miglioramento delle proprietà dei carburanti. Di conseguenza con il carburante 2000 si sono raggiunti gli standard restrittivi delle emissioni Euro3 e quelli ancora più restrittivi Euro 4-5 con il 2005. La tabella seguente mostra i fattori di emissione base per ogni classe di veicolo. Tabella 3.4 rapporti carburante base per ogni classe di veicolo
L’uso di tali carburanti porta ad una riduzione di emissioni anche per i veicoli pre-Euro, per i quali, il carburante del 1996 viene considerato come base. Queste riduzioni sono applicabili sia per le emissioni a caldo, sia per quelle a freddo. Si applicano le equazioni derivate dal programma quadro (ACEA e Europa, 1996) del The EuEuropean Programme on Emissions, Fuels and Engine Technologies (EPEFE). I fattori di emissione a caldo sono corretti secondo la seguente equazione: FCeHOT; i, k, r = FCorri, k, Fuel / FCorri, k, Base × eHOT; i, k, r (13) Dove, FCeHOT; i, k, r: = fattore di emissione a caldo corretto per l’uso del carburante migliorato, per l’inquinante i del veicolo di tecnologia k che percorre una strada di tipo r, FCorri, k, Fuel: = carburante corretto per l’inquinante i del veicolo di tecnologia k calcolato con equazioni riportate più avanti FCorri, k, Base: = carburante corretto per l’inquinante i calcolato con le equazioni riportate in seguito. L’equazione (13) non deve essere usata per determinare il deterioramento delle emissioni quando viene usato un vecchio carburante in una nuova tecnologia (p.e. l’uso di un carburante 2000 in veicoli Euro4). Il fattore di emissione calcolato in questo modo deve essere introdotto nelle equazioni per la stima delle emissioni a caldo e a freddo. 3.4 - Dati statistici di attività
57
La metodologia originaria ha come obiettivo la redazione dell’inventario nazionale delle emissioni. Pertanto essa ricorre a diverse banche dati nazionali per reperire informazioni utili alla stima delle emissioni. Il presente documento ha un obiettivo estremamente diverso. L’intento è quello di descrivere un metodo per la stima delle emissioni prodotte da veicoli durante gli spostamenti casa-lavoro. Tale metodo potrà essere messo a disposizione di qualsiasi organizzazione che abbia intenzione di effettuare la stima delle emissioni prodotte dai propri dipendenti durante tali spostamenti. Ne consegue che, per la metodologia descritta nel presente testo, si farà ricorso alle informazioni di partenza descritte sopra, e in particolare, alle informazioni ricavate dai risultati dell’indagine spostamenti casa-lavoro proposta ai dipendenti dell’organizzazione. 4 - Funzioni per il calcolo dei fattori di emissione I fattori di emissione possono essere separati in due classi in relazione al tipo di inquinante:
1. quelli per cui è necessaria e possibile una dettagliata valutazione, CO, VOC, e PM e consumo del carburante;
2. quelli per cui possono essere predisposti fattori di emissione ed equazioni più grossolani,
come l’anidride carbonica (CO2). NOTA: Si nota che la metodologia originaria non fornisce un fattore di emissione specifico per il consumo di metano per i veicoli adibiti al trasporto passeggeri, tuttavia mette a disposizione un fattore di emissione per le emissioni di CO2 pari a 2,75 fornito in kg/(kg di carburante). Sarà necessario, quindi, reperire il dato di consumo di metano in altro modo, come proposto nel paragrafo 3.2.2.5. 4.1 - Auto passeggeri a benzina 4.1.1 - Pre-Euro 4.1.1.1 - Emissioni a caldo Le emissioni a caldo per i veicoli convenzionali (per convenzionali si intendono i veicoli precedenti alle normative dette Euro, pre-euro) sono riportati nelle tabelle 4.1, 4.2 e 4.3 per i differenti inquinanti e il consumo di carburante. Ogni equazione è valida all’interno dell’intervallo di velocità e dimensioni del motore definiti. Tabella 4.1 funzioni dipendenti dalla velocità per i fattori di emissione del CO per auto passeggeri a benzina (pre-euro)
58
Tabella 4.2 funzioni dipendenti dalla velocità per i fattori di emissione del VOC per auto passeggeri a benzina (pre-euro)
Tabella 4.3 funzioni dipendenti dalla velocità per i fattori di emissione del consumo di carburante (FC) per auto passeggeri a benzina (pre-euro)
59
4.1.1.2 - Emissioni a freddo Nelle tabelle 4.4 e 4.5 sono riportati i rapporti eCOLD/eHOT per gli inquinanti CO e COV, e l'equazione attraverso la quale è stato calcolato il parametro β. L’introduzione dei valori nell’equazione (8), insieme ai fattori di emissione calcolati in precedenza, fornisce le stime delle emissioni a freddo. Tabella 4.4 rapporti eCOLD/eHOT per i veicoli a benzina pre-euro
Tabella 4.5 frazione di percorrenza a freddo (parametro β)
60
4.1.2 - Euro 1 e successivi 4.1.2.1 - Emissioni a caldo Le emissioni a caldo per le auto passeggeri a benzina Euro 1 e successive sono calcolate con funzioni che dipendono dalla velocità. In questo caso si usa la seguente generica funzione, di cui i coefficienti sono riportati in tabella 4.6 EF = (a + c × V + e × V²)/(1 + b × V + d × V²) (14) Tabella 4.6 valori da introdurre nell’equazione (14) per il calcolo delle emissioni delle auto passeggeri a benzina euro 1 e successive
61
Nella tabella 4.7 sono riportati i fattori di emissione semplificati che devono essere utilizzati per il calcolo delle emissioni di PM prodotte delle auto passeggeri a benzina Euro 1 e successive. Si propone un distinto valore di fattore di emissione per le auto GDI, dovuto al differente processo di combustione di questo motore. Tabella 4.7 fattori di emissione per il PM per auto passeggeri a benzina euro 1 e successive
4.1.2.2 - Emissioni a freddo Le emissioni dei veicoli equipaggiati con dispositivo catalizzatore sono significativamente più alte nella fase di riscaldamento, rispetto alle condizioni di regime di temperature stabili del motore. Questo accade a causa della ridotta efficienza del convertitore al di sotto della temperatura alla quale entra in funzione il catalizzatore (light-off). Pertanto, si deve determinare un modello di dettaglio degli effetti sulle emissioni in fase di riscaldamento adatto per gli Euro 1 e successivi. La seguente tabella riporta i rapporti eCOLD/eHOT per i principali inquinanti e per il consumo del carburante. Tali valori sono espressi in funzione della temperatura ambiente e della velocità media. Tabella 4.8 rapporti di sovra-emissione eCOLD/eHOT per auto a benzina euro1 e successive
62
Si noti che se il valore calcolato di eCOLD/eHOT è minore di 1, si deve usare 1 come valore di questo rapporto. Si introducono due intervalli di valori di velocità (5-25 km/h e 25-45 km/h). Come nel caso dei fattori di emissione a caldo, il valore di velocità inserito nelle equazioni dovrebbe corrispondere alla velocità media dello spostamento, e non alla velocità istantanea. Gli intervalli di velocità proposti sono sufficienti a coprire la maggior parte delle applicazioni, poiché le emissioni a freddo sono collocate solo in riferimento allo stile di guida urbano. Per il CO e VOC, le emissioni a freddo sono prodotte, oltre che a causa dell'inefficienza del dispositivo catalizzatore, anche per l'arricchimento del carburante durante la fase del riscaldamento che consente una migliore condizione di guida del motore freddo. Tale arricchimento dipende dalla temperatura del motore durante la fase di riscaldamento. Pertanto, le emissioni a freddo di questi inquinanti, non solo sono più alte di quelle degli NOx ( che in generale non sono influenzate dall'arricchimento del carburante), ma hanno anche una forte dipendenza dalla temperatura. E questo è il motivo per cui si devono definire due intervalli di temperatura per i CO e VOC. Generalmente, gli effetti della fase di riscaldamento del motore diventano trascurabili sopra i 25 °C nel caso del CO, e sopra i 30 °C per i VOC. Ciò non solo perché la parte in eccesso dell'emissione in queste condizioni ambientali è piccola, ma anche perché i motori si raffreddano più lentamente e le temperature all'avvio del motore possono essere ancora alte dopo diverse ore di parcheggio. La frazione di chilometraggio percorso nella fase di riscaldamento è calcolata attraverso la funzione nella tabella 4.5. Dopo aver calcolato il parametro βe i rapporti eCOLD/eHOT , l'applicazione della formula (8) è diretta. La riduzione di emissioni durante la fase di riscaldamento dei veicoli post-Euro 1 rispetto ai precedenti è principalmente dovuta alla riduzione del tempo richiesto per i moderni dispositivi catalitici per raggiungere la temperatura di light-off. Tale riduzione si riflette ulteriormente nella diminuzione della distanza percorsa con il motore o dispositivi di post-trattamento parzialmente in temperatura. La tabella seguente riporta i fattori di riduzione (bci,k) da applicare al parametro β a seconda dell'inquinante e della classe del veicolo.
Tabella 4.8 fattori di riduzione (bci,k) del parametro βper i veicoli a benzina post-euro 1 Non c'è alcuna evidenza a supporto dell'uso di valori differenti di eCOLD/eHOT per le differenti classi di veicoli7. Ciò significa che i valori del rapporto eCOLD/eHOT calcolati per i veicoli Euro 1 possono essere anche applicati ai veicoli più recenti senza ulteriori riduzioni. Allo stesso modo il fattore di emissione a caldo utilizzato nella stima delle emissioni a freddo dovrebbe essere il valore dell'Euro 1. Quindi per i veicoli post-Euro 1 l'equazione (8) diventa:
7 Comunque tale affermazione probabilmente fallisce nella previsione della riduzione delle emissioni aggiuntive che
potrebbe essere ricavata dal test a freddo (-7 °C) per Euro III e veicoli successivi. Molto probabilmente la strategia della miscela di arricchimento deve cambiare per consentire a questi veicoli di aderire a questi test. Questo in conseguenza porterà ad una riduzione del rapporto eCOLD/eHOT . Tuttavia la significatività degli effetti di tale modifica ad alte temperature è discutibile. Per questa ragione ed in assenza di analisi più dettagliate per il momento si è deciso di tralasciare le correzioni del rapporto eCOLD/eHOT.
63
ECOLD;i,k = bci,k × βi,Euro 1 × Nk × Mk × ehot, i, Euro 1 × (eCOLD / eHOT - 1)|i, Euro 1 (15) 4.2 - Auto passeggeri a Diesel 4.2.1 - Pre-Euro 4.2.1.1 - Emissioni a caldo Dati sperimentali da misure rilevate su auto passeggeri Diesel <2,5 ton (Hassel et al., 1987; Pattas et al., 1985; Rijkeboer et al., 1989; 1990) hanno portato a realizzare una distinzione tra le cilindrate per gli NOx, e i fattori di emissione dipendenti dalla velocità per veicoli pre-Euro. Nella tabella seguente si riportano le equazioni dei fattori di emissione da introdurre nell'equazione (8) per il calcolo delle emissioni a caldo dei veicoli passeggeri diesel. Tabella 4.9 funzioni dipendenti dalla velocità dei fattori di emissione e del consumo di carburante dei veicoli passeggeri pre-euro diesel
4.2.1.2 - Emissioni a freddo La frazione addizionale di emissioni a freddo prodotta dai veicoli diesel non è particolarmente significativa rispetto ai veicoli a benzina. Pertanto non c'è distinzione tra veicoli convenzionali ed Euro 1. Nella tabella seguente si riportano i valori dei rapporti eCOLD/eHOT per le auto diesel. Tabella 4.10 valori dei rapporti eCOLD/eHOT per i veicoli passeggeri diesel pre-euro
4.2.2 - Euro 1 e successivi 4.2.2.1 - Emissioni a caldo Le emissioni a caldo per i veicoli Euro 1 e successivi sono calcolati come funzione della velocità. La funzione generale usata in questo caso è la seguente: EF = (a + c × V + e × V²)/(1 + b × V + d × V²) + f/V (16)
64
la tabella 4.11 riporta i valori dei coefficienti usati per calcolare i fattori di emissione. Per i veicoli euro 3, alcune case costruttrici produssero veicoli dotati di dispositivo FAP. Essi non erano significativamente diversi dai veicoli convenzionali in termini di emissione di NOx, CO o HC, ma producevano basse emissioni di PM. Tabella 4.11 valori da introdurre nell’equazione (16) per il calcolo delle emissioni delle auto passeggeri diesel euro 1 e successive
La seguente tabella presenta i fattori di emissione specifici per il PM dei veicoli con filtro anti particolato (FAP o, in inglese, DPF), si assume che per tali fattori i veicoli utilizzino il carburante di standard EN590:2005. NOTA: il fattore di consumo per i veicoli euro 4 si pone pari a 55 g/km per le auto passeggeri diesel fino a 2000 cc e 73 g/km oltre i 2000 cc. Questi ultimi valori sono stati presi dal livello 2 della metodologia originaria. Tabella 4.12 fattori di emissione del PM per veicoli passeggeri diesel equipaggiati con dispositivo FAP
65
4.2.2.2 - Emissioni a freddo Per calcolare le emissioni a freddo dei veicoli passeggeri diesel Euro 1 e successivi, il parametro β è calcolato per ogni classe usando la formula della tabella 4.5 e i valori di eCOLD/eHOT sono gli stessi usati per i veicoli pre-euro. Tuttavia è necessari applicare una ulteriore riduzione per i veicoli post-Euro 4 (Rfi,k) , fornita dalla tabella 4.13. E basandosi su queste riduzioni la funzione (8) può essere applicata ai veicoli passeggeri diesel fino alla tecnologia Euro 4, ma per i veicoli post- Euro 4 si deve esprimere così: ECOLD;i,k = βi,k × Nk × Mk × (100-RFi,k) / 100 × eHOT; i, Euro 4 × (eCOLD / eHOT|i,Euro 1 - 1) (17) Tabella 4.13 fattori di riduzione delle emissione per veicoli passeggeri diesel euro 5 e euro 6
4.3 - Auto passeggeri a GPL La metodologia per i veicoli a benzina è valida anche per i veicoli a GPL. Tuttavia va sottolineato che i dati su veicoli a GPL sono veramente limitati e quindi si è dovuto ricorrere a numerose assunzioni ed estrapolazioni sulla base delle informazioni esistenti per disporre di un consistente set di fattori di emissione per le emissioni a caldo e a freddo. 4.3.1 - Emissioni a caldo Per i veicoli GPL convenzionali ed euro 1 si usa l'equazione (7). Le seguenti tabelle 4.13 e 4.15 riportano i fattori di emissione a caldo per i veicoli convenzionali ed Euro 1. Tabella 4.14 funzioni dipendenti della velocità dei fattori di emissione per i veicoli passeggeri pre-euro GPL
Tabella 4.15 funzioni dipendenti della velocità dei fattori di emissione per i veicoli passeggeri euro 1 GPL
66
Si forniscono fattori di riduzione rispetto ai valori delle auto Euro 1 per i veicoli post-Euro 1 GPL. Essi si posso introdurre nell'equazione (18), e i valori di riduzione dei fattori di emissione sono riportati nella tabella 4.16: eHOT; i, k, r = (100-RFi,k) / 100 × eHOT; i, Euro 1, r (18) Tabella 4.16 percentuali di riduzione dei veicoli post-euro 1 da applicare ai veicoli passeggeri GPL euro 1
NOTA: Il fattore di consumo di carburante si pone pari a 57 g/km per i veicoli passeggeri a gpl di tutte le cilindrate. Questo ultimo valore è stato preso dal livello 2 della metodologia originaria. 4.3.2 - Emissioni a freddo I dati sulle emissioni a freddo relativi ai veicoli a GPL sono molto pochi (AQA, 1990; Hauger et al.; 1991). Per consistenza, tuttavia, e poiché la tecnologia dei veicoli GPL è simile a quella dei veicoli a benzina, qui si applica la stessa metodologia usata per i veicoli a benzina. La tabella seguente fornisce i valori dei rapporti eCOLD/eHOT che sono valide per tutte le classi dei veicoli a GPL. Tabella 4.17 rapporti eCOLD/eHOT per i veicoli passeggeri GPL
67
L’equazione (8) viene applicata per i veicoli fino alla classe Euro 1, mentre l’equazione (17) si applica ai veicoli successivi. Il fattore di riduzione del parametro β sono uguali a quelli per i veicoli a benzina. 4.4 - Auto passeggeri a motore ibrido Per derivare i fattori di emissione dei veicoli ibridi a benzina, è stato usato un limitato database di misure di emissione. Sono stati inclusi solo i veicoli ibridi “full” Euro 4 e con cilindrata < 1600 cc. Con il termine “full” si intendono i veicoli ibridi che possono effettuare la partenza solo con il motore elettrico. Pertanto si assume che non si eseguano stime per le emissioni a freddo. La tecnologia è simile a quella delle auto a benzina, e si usa l’equazione (19) per calcolare i fattori di emissione ed il consumo di carburante: EF = a + c × V + e × V² (19) La seguente tabella mostra i parametri da utilizzare nell’equazione (19) Tabella 4.18 coefficienti da introdurre nell’equazione 19 per veicoli a motore ibrido
4.5 - Ciclomotori a 2 cilindri <50 cc I ciclomotori sono utilizzati principalmente in area urbana, quindi nelle tabelle 4.19 e 4.20 si propongono fattori di emissione solo di tipo urbano. Questi fattori di emissione sono da considerare come valori comprensivi anche delle emissioni a freddo, poiché non si fanno distinzioni tra emissioni a freddo e a caldo. Tabella 4.19 fattori di emissione e consumo di carburante per ciclomotori
Tabella 4.20 fattori di emissione del PM per ciclomotori
68
4.6 - Motocicli >50 cc I fattori di emissione per i motocicli pre-euro e Euro 1 con cilindrata superiore a 50 cc vengono calcolati con l’equazione (19). Le tabelle 4.21 e 4.23 riportano i valori dei coefficienti per il calcolo dei fattori di emissione dei motocicli pre-euro ed Euro 1, rispettivamente a 2 e 4 cilindri: Tabella 4.21 funzioni dei fattori di emissione e consumo di carburante dipendenti dalla velocità per motocicli a 2 cilindri pre-euro ed euro 1 >50 cc
La tabella 4.22 mostra i fattori di riduzione rispetto a Euro 1 per i veicoli più recenti a 2 cilindri. Tabella 4.22 coefficienti di correzione rispetto a euro 1 dei fattori di emissione e consumo di carburante per motocicli a 2 cilindri euro 2 e successivi >50 cc
69
Tabella 4.23 funzioni dei fattori di emissione e consumo di carburante dipendenti dalla velocità per motocicli a 4 cilindri pre-euro ed euro 1 >50 cc
Tabella 4.23bis funzioni dei fattori di emissione e consumo di carburante dipendenti dalla velocità per motocicli a 4 cilindri pre-euro ed euro 1 >50 cc
70
La tabella 4.24 riporta i fattori di emissione in urbano, extraurbano e autostrada per i motocicli a 4 cilindri di ultima generazione. Tabella 4.24 fattori di emissione e consumo di carburante per motocicli a 4 cilindri euro 2 ed euro 3 >50 cc
71
La tabella 4.25 infine mostra i fattori di emissioni del PM per i veicoli a 2 ruote. Le emissioni di PM sono particolarmente importanti per i veicoli a 2 cilindri. Questi fattori di emissione corrispondono alla miscela di minerale e lubrificante usato per i veicoli a 2 cilindri. Tabella 4.25 fattori di emissione del PM per motocicli a 2 e a 4 cilindri per veicoli pre e post euro >50 cc
4.6 - Funzioni che esprimono il degrado delle emissioni in funzione dei chilometri percorsi Le seguenti tabelle riportano le funzioni di degrado che si devono usare per simulare il deterioramento delle performance di emissione dei veicoli adibiti al trasporto passeggeri a benzina dotati di dispositivo catalizzatore. Tabella 4.26 coefficienti da introdurre nell’equazione che esprime il degrado delle emissioni dovuto all’età per veicoli adibiti al trasporto passeggeri a benzina euro 1 e 2
72
Tabella 4.27 coefficienti da introdurre nell’equazione che esprime il degrado delle emissioni dovuto all’età per veicoli adibiti al trasporto passeggeri a benzina euro 3 e 4
Tabella 4.28 espressione del degrado delle emissioni dovuto all’età espressa come funzione della velocità
73
4.7 - Effetti del carburante Le tabelle seguenti riportano le funzioni di correzione richieste per la stima degli effetti delle proprietà dei carburanti sulle emissioni dei veicoli passeggeri rispettivamente a benzina e diesel come descritto nel paragrafo 3.3.7. Tabella 4.29 equazioni che simulano gli effetti delle proprietà del carburante sui veicoli a benzina
Tabella 4.30 equazioni che simulano gli effetti delle proprietà del carburante sui veicoli diesel
5 - Metodologia per la stima del PM non esausto
74
L’agenzia europea per l’ambiente mette a disposizione una particolare metodologia per la stima delle emissioni di PM derivato dall’usura di pneumatici, di freni e del manto stradale, quindi non derivato dalla combustione del carburante (non esausto). Si vuole inserire questa parte nel presente adattamento per maggior completezza. Per un confronto con i valori di PM ottenuti dall’applicazione dei fattori di emissione a caldo, è necessario effettuare il calcolo per la porzione di particolato individuata come PM2.5 5.1 - Algoritmo di calcolo per le emissioni da usura di freni e pneumatici La seguente equazione generale si usa per stimare separatamente le emissioni prodotte dall’usura di pneumatici e freni: TE = ΣjNj × Mj × EFTSP,s, j × fs, i × Ss(V) (20) dove: TE = emissioni totali nel periodo e nell’area di riferimento [g], Nj = numero di veicoli della categoria j nell’area di riferimento, Mj = chilometraggio [km] percorso da ciascun veicolo nella categoria j durante il periodo di riferimento EFTSP, s, j = fattore di emissione delle polveri sospese totali (PST) per i veicoli di categoria j [g/km], Fs, i = frazione in massa di PST che può essere attribuita alla dimensione di particolato di classe i, Ss(V) = fattore di correzione secondo la velocità media dei veicoli V. L’indice j si riferisce alle due categorie di veicoli (veicoli a due ruote e auto passeggeri) L’indice s si riferisce alla sorgente di emissione del PM, cioè usura di pneumatici (T) o freni (B) Le classi di particolato invece sono: TSP, PM10, PM2.5, PM1 e PM0.1. 5.1.1 - Fattori di emissione da usura di freni e pneumatici 5.1.1.1 - Fattori di emissione da usura di pneumatici La tabella seguente mostra i fattori di emissione delle polveri totali sospese (PST) per le differenti classi di veicolo. Tabella 5.1 fattori di emissione delle polveri totali sospese (PST) per le differenti classi di veicolo
75
l’indicatore B (cfr paragrafo 7.1.3) rappresenta fattori di emissione non statisticamente significativi basati su un piccolo set di misure e rielaborazioni. I fattori di emissione sono basati su dati sperimentali. Si noti che i fattori di emissione di PST non prevedono che l’intero materiale proveniente dall’usura di pneumatici si trasformi in particolato sospeso. Un profilo tipico della dimensione di PST provenienti dall’usura di pneumatici è stato ottenuto dalla combinazione con informazioni di letteratura. La seguente tabella mostra la frazione in massa delle differenti classi di particolato. Tabella 5.2 frazione in massa delle differenti classi di particolato
Al fine di derivare i valori di PST dove i fattori di emissione di PM10 sono disponibili solo in letteratura, è stato attribuito il valore 0,6 al rapporto PM10/TSP. Bisogna tener conto di un fattore di correzione di velocità per i fattori di emissione provenienti da usura di pneumatici. Si noti che, come nel caso dei fattori di emissione a caldo, la velocità corrisponde alla velocità media di viaggio. L’usura di pneumatici diminuisce all’aumentare della velocità, probabilmente perché le svolte e le frenate sono più frequenti in ambito urbano più che autostradale. Tale fattore di correzione di velocità ST(V) è dato dalle seguenti formule: V < 40 km/h: ST(V) = 1.39 40 km/h ≤ V ≤ 90 km/h: ST(V) = -0.00974·V + 1.78 (21) V > 90 km/h: ST(V) = 0.902 Si noti che si ha ST(V)=1, quando la velocità è 80 km/h, e ST(V) diventa stabile sotto i 40 e sopra i 90. Inoltre anche se l’equazione proposta è stata ricavata da misure solo su auto passeggeri, deve essere usata per tutte le categorie di veicoli. 5.1.1.2 - Fattori di emissione da usura di freni
76
I fattori di emissione del particolato proveniente dall’usura dei freni sono mostrati nella seguente tabella: Tabella 5.3 fattori di emissione del particolato proveniente dall’usura dei freni
L’indicatore di qualità D (cfr paragrafo 7.1.3) si riferisce a fattori di emissione stimanti applicando considerazioni di similitudine ed estrapolazioni. Il fattore di correzione di velocità SB(V) è dato dalla seguenti espressioni: V < 40 km/h: SB(V) = 1.67 40 km/h ≤ V ≤ 95 km/h: SB(V) = -0.0270·V + 2.75 (22) V > 95 km/h: SB(V) = 0.185. In questo caso il fattore di correzione è normalizzato per una velocità di 65 km/h L’usura dei freni è trascurabile alle alte velocità quando le frenate sono limitate. Ed ancora, anche se l’equazione proposta è derivata da misure solo su auto passeggeri, si deve utilizzare per tutte le categorie di veicoli. La seguente tabella mostra la frazione in massa delle differenti classi di particolato. Tabella 5.4 frazione in massa delle differenti classi di particolato
5.2 - Algoritmo e fattori di emissione da usura del manto stradale I dati sulle particelle sospese provenienti dal manto stradale sono veramente pochi. Tali emissioni sono calcolate con la seguente equazione: TER; i = ΣjNj × Mj × EFR; j × fR; i (23) dove
77
TER; i = emissioni totali dell’inquinante i derivati dal manto stradale nel periodo e nell’area di riferimento [g] Nj = numero di veicoli nella categoria j nell’area di riferimento Mj = chilometraggio percorso dai veicoli nella categoria j nel periodo di riferimento [km] EFR; j = fattore di emissione della massa di PST derivato dal manto stradale nella categoria j [g/km] fR; i = frazione di particolato che si può attribuire al particolato di dimensione i La metodologia fornisce solo una classificazione delle dimensioni basata sul peso della massa basata sul lavoro di Klimont e altri del 2002. I valori di PST corrispondono alle particelle primarie del manto stradale, ma essi sono basati su informazioni limitate e sono molto incerti. La tabella seguente mostra i fattori di emissione di PST primaria Tabella 5.5 fattori di emissione di PST primaria
L’indicatore di qualità C (cfr paragrafo 7.1.3) si riferisce a fattori di emissione stimati sulla base di dati di letteratura. La seguente tabella mostra la distribuzione di PST per le diverse classi di dimensione: Tabella 5.6 frazione in massa delle differenti classi di particolato
6 - Procedura per la stima delle emissioni 6.1 - Dati derivati dall’indagine La raccolta e la definizione dei dati di partenza per l’applicazione della metodologia risulta di estrema importanza. Si è già descritto come dovrà essere impostato il questionario spostamenti casa-lavoro da proporre alla popolazione oggetto dell’indagine (cfr paragrafo 3.2.1). Dopo lo svolgimento dell’indagine si devono trattare i risultati per costruire il set di dati per l’applicazione delle funzioni dei fattori di emissione.
78
I risultati devono essere puliti da dati incoerenti o incompleti, che non possono essere utilizzati ai fini dell’elaborazione. 6.1.1 - Tempi di percorrenza Si devono calcolare i tempi di percorrenza del tragitto di andata utilizzando le informazioni sugli orari di partenza da casa ed arrivo a lavoro. Analogamente si procede con il tragitto di ritorno. Ai valori ottenuti si sottraggono i tempi impiegati nelle soste sia per l’andata sia per il ritorno, e si calcola il valore medio dei tempi di andata e dei tempi di ritorno. Poiché l’obiettivo è quello di stimare le emissioni prodotte durante gli spostamenti casa-lavoro, si presume che in termini di distanza, il tragitto di andata sia uguale a quello di ritorno. Inoltre, si assume che se i valori medi dei tempi di percorrenza dei tragitti di andata e quelli di ritorno non si discostano di molto, allora i tragitti di andata si considerano uguali sia in termini di spazio percorso sia in termini di tempo impiegato, e quindi si assegna la stessa velocità media. 6.1.2 - Scomposizione del tragitto casa-lavoro Poiché dall’indagine si conoscono i punti di partenza e di arrivo dei tragitti di andata degli spostamenti casa-lavoro si possono stimare le frazioni percorse rispettivamente in contesto urbano, extraurbano e autostradale. Infatti, con strumenti di tipo GPS per il calcolo del percorso, o strumenti analoghi reperibili su siti internet, è possibile calcolare il percorso di ogni singolo tratto, come già spiegato nella descrizione del quesito 11 del questionario (cfr paragrafo 3.2.1). 6.1.3 - Determinazione delle velocità medie relative ai diversi tipi di percorso Attraverso l’applicazione del metodo descritto nel paragrafo 3.2.2.3, si individuano le velocità medie da attribuire ai diversi tipi di strada. Per tale applicazione si utilizzano i risultati ottenuti con i calcoli eseguiti con le modalità descritte nei precedenti paragrafi, Come descritto nella metodologia, è necessario scegliere in modo accurato il valore di velocità media distinta per ogni tipo di strada. I diversi tipi di strada, come si è detto, individuano diverse modalità o “stili di guida”, che influiscono in modo determinante sulle emissioni prodotte, poiché le funzioni di emissione a caldo dipendono dalla velocità media. 6.1.4 - Tragitto percorso a freddo Come descritto nel paragrafo 3.2.2.2, si deve determinare il tragitto medio di percorrenza al fine di stimare le emissioni a freddo. Il valore ottenuto rappresenta il tragitto medio e si identifica con il valore di ltrip definito nel paragrafo 3.3.2. Successivamente verrà calcolato il valore il valore del parametro β, e si dovrà verificare che il prodotto di ‘ltrip’ con il parametro β non superi il valore medio del tragitto percorso in contesto urbano. Tale prodotto, infatti, rappresenta il numero di chilometri percorsi a freddo. Qualora dovesse superare il percorso in contesto urbano, nel calcolo delle emissioni a freddo, si deve utilizzare l’equazione (8-bis) (cfr paragrafo 3.3.2) 6.2 - Dati esterni 6.2.1 - Stima dati ambientali
79
Abbiamo visto come le emissioni a freddo dipendano dalla temperatura. Se si vuole simulare il quantitativo di emissioni durante l’anno, bisogna tenere conto del cambiamento della temperatura. Per semplicità si può stimare un valore di temperatura per ogni stagione, ottenendo così quattro valori stagionali caratteristici. Per stimare la temperatura media sul periodo si può ricorrere alla base di dati predisposta da organi preposti (p.e. l’agenzia regionale per l’ambiente), raccogliendo serie storiche di almeno 5 anni prima. Allo stesso modo se si vogliono simulare le emissioni di PM non esausto, bisogna tenere conto dei giorni di pioggia e valutare le emissioni solo nei giorni secchi. 6.2.2 - Numero di spostamenti effettivi in un anno Dopo aver verificato l’entità in termini di percorrenze della somma del tragitto casa-lavoro e lavoro-casa, si assume questa percorrenza come tragitto giornaliero, spostamento casa-lavoro-casa. A questo punto, non resta che determinare il numero di giorni in cui i dipendenti dell’organizzazione cui si sta rivolgendo la ricerca, si recano a lavoro. Tale valore dovrebbe essere determinato al netto di ferie e malattie. Successivamente si assume che i giorni di lavoro siano concentrati in modo differente durante un anno, pertanto si moltiplica il numero totale dei giorni di lavoro annuali per dei pesi che rendono conto di tale concentrazione. Se si suppone che il periodo estivo sia il meno intenso, quelli primaverili ed autunnali più intensi e quello invernale mediamente intenso, si possono assegnare i seguenti pesi: 0,3 ai periodi autunnali e primaverili, 0,25 a quelli invernali e 0,15 a quelli estivi. In questo modo per esempio, se in un anno ci sono 200 giorni lavorativi, allora si avranno 60 giorni di lavoro in primavera ed in autunno, 50 in inverno e 30 in estate. Questa suddivisione è utile al fine di allocare in modo adeguato le emissioni a freddo che dipendono fortemente dalla temperatura. Analogamente si può calcolare il numero di giorni secchi in un anno e poi, attraverso una proporzione, determinare il numero di giorni di lavoro in cui non è piovuto. Su questi ultimi si può simulare il valore delle emissioni di PM non esausto. 6.3 - Applicazione delle funzioni dei fattori di emissione 6.3.1 - Suddivisione del campione Il campione oggetto dell'indagine spostamenti casa-lavoro è quello di cui si possono stimare le emissioni. Tale campione deve essere suddiviso per classi di veicoli come indicato nello schema delle tabelle 2.1 e 2.2. Per ognuna di queste classi si possono ottenere le stime di emissione applicando le funzioni riportate nei capitoli 4 e 5. 6.3.2 - Correzioni Questa metodologia prevede l’applicazione di alcune correzioni come descritto nei paragrafi 3.3.6 e 3.3.7, rispettivamente la correzione dovuta alle percorrenze dei veicoli, e la correzione dovuta all’utilizzo del nuovo carburante su veicoli precedenti. Un’altra modifica è relativa al parco auto di riferimento nel periodo estivo. Nel quesito 12 del questionario si richiede se si usa un altro mezzo nel periodo estivo. Pertanto, si può valutare qual è il nuovo mezzo, e se si tratta di un veicolo a motore, stimarne le emissioni. La stima delle emissioni di questo nuovo mezzo, se non se ne conoscono le caratteristiche precise si può stimare con un fattore di emissione calcolato sulla base dei valori ricavati per il periodo non invernale o prendendo come riferimento i valori presenti nel livello 2 della metodologia originaria.
80
6.4 - Verifica del bilancio del carburante Come spiegato nel paragrafo 3.2.2.4, una volta effettuate tutte le stime si può effettuare la verifica sul carburante, operando il rapporto tra il valore ottenuto dai dati statistici e quello ottenuto con le funzioni dei fattori di emissione. Poiché qui si stimano le emissioni di CO2, che dipende dal consumo di carburante, il valore finale delle emissioni può essere corretto con il rapporto sopra indicato secondo l’equazione (9). Per questa verifica si propone di procedere come spiegato nel paragrafo 3.2.2.4. Si propone, pertanto, di assumere che il valore del rapporto si possa determinare dividendo il valore statistico ricavato per il solo tragitto casa- lavoro e quello calcolato con le funzioni dei fattori di emissione per lo stesso tragitto. 7 - Qualità dei dati 7.1 - Verifiche Di seguito si presentano alcune considerazioni sulle stime delle emissioni da veicoli da trasporto su strada contenute nelle linee guida per la redazione degli inventari delle emissioni che si adattano al caso oggetto del presente documento. Una disaggregazione temporale o spaziale si accompagna ad una riduzione di accuratezza nella stima delle emissioni. Questo è particolarmente vero nel caso delle emissioni da trasporto su strada perché:
6. Ad alta risoluzione il carattere casuale delle attività dei trasporti domina sulla stima delle emissioni.
7. I fattori di emissione proposti sono aggregati e mediati su un ampio numero di cicli di guida. Pertanto essi non sono necessariamente rappresentativi delle emissioni istantanee dei veicoli circolanti nelle condizioni attuali.
7.1.1 - Verifica attraverso il bilancio del consumo di carburante Un controllo efficace nella valutazione della accuratezza globale dei calcoli per la stima delle emissioni è che il consumo totale di carburante calcolato (per tipo di carburante) deve eguagliare il consumo di carburante statistico relativo al campione di popolazione considerata. Se comunque il valore calcolato non eguaglia quello statistico., si devono modificare le variabili input “soft”. Qui per variabili “soft” si intendono le variabili a cui è associata una grande incertezza. Tuttavia gli autori delle linee guida per la compilazione degli inventari per le emissioni credono che la distribuzione delle percorrenze nelle diverse modalità di guida (urbano, extraurbano e autostradale) e le rispettive velocità medie siano le variabili da quantificare con la maggior accuratezza.. 7.1.2 - Campi di applicazione dei fattori di emissione a caldo I fattori di emissione forniti dalla metodologia sono stati derivati da una serie di programmi scientifici. I fattori di emissione per i veicoli passeggeri di vecchia tecnologia sono stati ricavati dalle prime attività di Corinair/copert (Eggleston et al., 1989), mentre i fattori di emissione per i veicoli più recenti sono stati calcolati sulla base dei dati del progetto Artemis (Boulter e Barlow, 2005; Boulter e McCrae, 2007).attori di emissione per i ciclomotori e i motocicli sono stati ricavati da uno studio sugli impatti delle emissioni dei veicoli a 2 ruote (Ntziachristos et al., 2004). Se ne deduce che dalla vasta quantità di dati utilizzati e dalle elaborazioni intercorse, i fattori di emissione ricavati hanno diversi limiti e restrizioni per le differenti classi di veicoli.
81
Tuttavia si riportano di seguito una serie di regole da seguire nell’applicazione della metodologia. I fattori di emissione devono essere applicati solo all’interno degli intervalli di velocità medie riportati nelle diverse tabelle. Tali intervalli sono stati definiti secondo la disponibilità dei dati sperimentali, per valori di velocità al di fuori degli intervalli. pertanto, non è consigliabile un’estrapolazione delle formule proposte. Le formule proposte devono essere utilizzate solo con velocità medie, e sono ben lungi da essere considerate accurate quando sono disponibili solo velocità istantanee o costanti. I fattori di emissione possono essere considerati rappresentativi con alte velocità costanti (> 100 km/h), quando in generale la variazione di velocità è limitata. I fattori di emissione non possono essere utilizzato in condizioni di traffico particolari (p.e. zone 30). Le tre tipologie di strada (autostrada, extraurbana e urbana) sono ovviamente sinonimi di specifici modelli di guida.. Per esempio ci sono situazioni per cui lo stile di guida associato all’autostrada in Germania è associato a velocità medie più alte che in Belgio, oppure lo stile urbano ad Atene è associato a velocità medie più basse che a Berlino, e così via. È possibile anche che gli stili di guida dipendano da altri parametri come l’età del veicolo o la cilindrata. Tali influenze devono essere prese in considerazione solo in presenza di dati disponibili. 7.1.3 - Accuratezza e precisione In tutti i casi di applicazione delle metodologie di stima, tutti i risultati ottenuti sono soggetti ad incertezza. Poiché le emissioni reali, in questo contesto, sono sconosciute, comunque si può ottenere una stima della loro precisione. Di seguito si propone un elenco degli indicatori di precisione, come previsti dalla metodologia originaria: A: fattori di emissione statisticamente significativi basati su un set di misure e stime di dati sufficientemente grande. B: fattori di emissione statisticamente non significativi basati su un piccolo set di misure e rielaborazioni di dati. C: fattori di emissione disponibili in letteratura D:fattori di emissione stimati applicando estrapolazioni La seguente tabella riporta gli indicatori di precisione della metodologia distinti per classi di veicolo ed inquinante. Tabella 7.1 indicatori di precisione della metodologia per auto passeggeri e per inquinante
Tabella 7.2 indicatori di precisione della metodologia per veicoli a due ruote e per inquinante
82
7.1.4 - Scala di lavoro La metodologia originaria può essere utilizzata con un sufficiente grado di certezza anche a piccola scala (cioè per la compilazione di inventari di emissione urbani con una risoluzione spaziale di 1x1 km2 e una risoluzione temporale di 1 h). Pertanto si assume che il presente adattamento della metodologia originaria porti a risultati attendibili. 8 - Riferimenti bibliografici e siti internet Di seguito si elencano alcuni riferimenti di documentazione estratti dalle linee guida “EMEP/EEA emission inventory guidebook 2009”, ed altri riferimenti utili a siti web.
EMEP/EEA emission inventory guidebook 2009 EMEP/EEA emission inventory guidebook 2006 Copert/Corinair Eggleston et al., 1989 Eggleston S., Gorißen N., Joumard, R., Rijkeboer R.C., Samaras Z., and Zierock K.-H.
(1989). Corinair Working Group on Emissions Factors for Calculating 1985 Emissions from Road Traffic. Volume 1: Methodology and Emission Factors. Final report contract No 88/6611/0067, EUR 12260EN.
Ntziachristos L., Mamakos A., Xanthopoulos A., Iakovou E., and Samaras Z. (2004), Impact assessment/Package of new requirements relating to the emissions from two and three-wheel motor vehicles. Aristotle University, Thessaloniki, Greece.
Boulter P. G. and T. J. Barlow (2005). Artemis: Average speed emission functions for heavy-duty road vehicles. TRL Unpublished project report UPR/IEA/12/05. TRL Limited, Wokingham.
Hassel D., Jost P., Dursbeck F., Brosthaus J. and Sonnborn K.S. (1987), Das Abgas-Emissionsverhalten von Personenkraftwagen in der Bundesrepublik Deutschland im Bezugsjahr 1985. UBA Bericht 7/87. Erich Schmidt Verlag, Berlin.
Boulter P and McCrae I (eds.) (2007). Artemis: Assessment and reliability of transport emission models and inventory systems. Final report. Deliverable No 15. TRL unpublished report UPR/IE/044/07. TRL Limited, Wokingham.
83
Pattas K., Kyriakis N., and Z. Samaras (1985). Exhaust Gas Emission Study of Current Vehicle Fleet in Athens (PHASE II). Volumes I, II, III. Final report to PERPA/EEC, Thessaloniki, Greece.
Hauger A. and R. Joumard (1991), LPG pollutant emissions. Use of Compressed Natural Gas (CNG), Liquefied Natural Gas (LNG) and Liquefied Petroleum Gas (LPG) as fuel for internal combustion engines, UN-ECE Symposium, Kiev, Ukraine.
http://ita.arpalombardia.it/ http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/ http://www.istat.it/prezzi/precon/rivalutazioni/ http://www.eea.europa.eu/publications/EMEPCORINAIR5/ http://lat.eng.auth.gr/copert/
84
8. Risultati dell’applicazione della stima delle emissioni8
0- Introduzione Nell'ambito del progetto promosso dalla Provincia di Milano: “Piano intercomunale della Mobilità Sostenibile” è stata svolta un'indagine spostamenti casa-lavoro presso i dipendenti di 5 comuni: Arese, Bollate, Garbagnate Milanese, Lainate e Pero. Ai risultati di questa indagine si è applicato un metodo per la stima delle emissioni che costituisce un riadattamento al caso specifico delle linee guida “ EMEP/EEA emission inventory guidebook ”. Pertanto, per una migliore comprensione dei dati esposti si consiglia la lettura di detta metodologia, poiché nel corso di questa presentazione vi saranno diversi riferimenti ad essa. Di seguito verranno mostrati e descritti i risultati dell'applicazione della metodologia per la stima delle emissioni prodotte durante gli spostamenti casa lavoro. Verranno anche riportate alcune informazioni di base utilizzate per lo svolgimento delle elaborazioni. 1 - L'indagine 1.1 - Il campione L'indagine spostamenti casa lavoro è stata rivolta a tutti i dipendenti comunali dei 5 comuni coinvolti. L'indagine è stata rivolta anche a due aziende che hanno voluto aderire: tuttavia, come previsto dal progetto finanziato da fondazione Cariplo, la stima delle emissioni ha interessato solo il personale degli enti pubblici. I risultati derivati dai questionari compilati dal personale delle aziende private sono stati utilizzati al fine di migliorare la stima di alcuni dati di partenza necessari per le elaborazioni successive. L'insieme dei questionari compilati in maniera completa costituiscono il campione oggetto delle elaborazioni. Le risposte all'indagine sono state 377. Si è dovuto, comunque operare qualche modifica alla numerosità del campione a causa di alcune incoerenze riscontrate sui dati. Le variazioni hanno interessato principalmente i questionari incompleti delle informazioni relative ai punti di partenza o arrivo del tragitto casa lavoro. Per la stima delle emissioni si sono selezionati soltanto i questionari che prevedevano l'utilizzo di veicoli a motore. Inoltre, si sono scelti solo quelli che utilizzavano l'auto come primo mezzo, come conducente. Inoltre, si sottolinea che un solo individuo, fra gli intervistati degli enti pubblici, ha risposto inserendo di utilizzare come secondo mezzo un mezzo pubblico. Il filtro e la pulizia di tutti i dati ha portato ad avere un campione da elaborare pari a 101 veicoli di cui 3 erano costituiti da veicoli a due ruote. 2 - Stima della velocità media Le elaborazioni sulle percorrenze e sui tempi descritte nei prossimi paragrafi sono state realizzate sul campione proveniente sia da aziende private sia da enti pubblici. Ciò è stato fatto perché questa è un'operazione preliminare alla stima della velocità media di percorrenza degli spostamenti casa-
8 La ricerca descritta nei capitoli 7 e 8 è stata realizzata dall’ingegnere Stefano Bardo.
85
lavoro e al fine di migliorare tale stima, si è pensato di utilizzare un campione più ampio. Il campione elaborato è pari a 189 veicoli di cui 5 a due ruote. 2.1 - Suddivisione dei tragitti casa-lavoro Attraverso lo strumento di calcolo del percorso messo a disposizione dal sito web di viamichelin è stato possibile stimare la lunghezza dei percorsi. Con le informazioni relative ai punti di partenza e ai punti di arrivo, con la scelta tra percorso rapido o percorso breve, è stato possibile calcolare ciascun percorso e suddividerlo secondo le tre tipologie previste dalla metodologia: strada urbana, strada extraurbana (statali, provinciali o superstrade) ed autostrada. Sono stati annotate tutte le distanze percorse per ogni tragitto secondo i diversi tipi di strada. I risultati sono stati suddivisi in tre gruppi: tragitti svolti interamente in contesto urbano, tragitti svolti in contesto urbano ed extraurbano e tragitti eseguiti in tutte e tre le tipologie previste Va detto che, per la specificità del contesto, i tratti relativi all'autostrada A4 e alle tangenziali milanesi sono stati considerati come tratti percorsi in contesto extraurbano e non autostradale. 2.2 - Calcolo dei tempi di percorrenza Sono stati calcolati i tempi di percorrenza di ciascun tragitto come differenza tra ora di arrivo e partenza, sia per il percorso di andata, sia per quello di ritorno. Sono stati sottratti ad ogni tragitto i minuti trascorsi per le soste. Dal confronto dei tempi di percorrenza in andata con quelli di ritorno, mediamente si è notato che non c'è molta divergenza, pertanto si è assunto che i tragitti di andata e ritorno siano uguali sia in termini di lunghezze sia in termini di tempi. 2.3 – Stima delle velocità 2.3.1 - Metodo di stima Attraverso l'applicazione del metodo descritto nella metodologia si sono ottenuti i valori di stima delle velocità medie di percorrenza sui diversi tipi di strada. Affinché i valori della regressione lineare fossero omogenei si è applicata la regressione a quattro gruppi distinti. Come descritto sopra, il campione è stato diviso in quattro gruppi:
• gruppo 1: distribuzione delle percorrenze e tempi dei tragitti percorsi solo in contesto urbano • gruppo 2:distribuzione delle percorrenze e tempi dei tragitti percorsi in contesto urbano ed
extraurbano • gruppo 3:distribuzione delle percorrenze e tempi dei tragitti percorsi in contesto urbano,
extraurbano e in autostrada. • gruppo 4:distribuzione delle percorrenze e tempi dei tragitti percorsi da veicoli a due ruote
successivamente si è applicata la media sui valori ottenuti dai diversi gruppi per le rispettive tipologie di strada e si sono assunti quei valori come rappresentativi delle velocità medie sulle diverse tipologie di strada. La seguente tabella riassuntiva mostra i valori ottenuti attraverso la regressione lineare applicata ai diversi gruppi, per i tragitti in solo contesto urbano si è applicata la media.
86
2.3.2 - Ipotesi di verifica dei risultati Dalla analisi dei Piani Urbani del Traffico e di altre informazioni in possesso agli Enti, si evincono alcune informazioni che potrebbero essere utili ad una ulteriore stima della velocità in contesto urbano. I Piani analizzati si presentano con diverso grado di completezza di dati, tuttavia si sono potuti ricavare alcuni spunti utili ad effettuare alcune verifiche. Si è scelto di valutare due tipologie di strade urbane denominate di scorrimento (classe D) e di distribuzione (classe F1), a cui è stata assegnata una capacità minima rispettivamente di 1000 e 300 veicoli. Sono state reperite inoltre, due curve di deflusso che, poiché si avvicinano alle caratteristiche delle strade prescelte, potevano essere applicate a questo contesto territoriale e poi associate ai due diversi tipi di strada. Le curve di deflusso consentono di simulare i tempi, e quindi le velocità di percorrenza di una strada, in funzione delle sue caratteristiche di capacità, e dei flussi di traffico che la percorrono. Dette curve hanno la seguente espressione, (per le curve scelte la distanza di riferimento è pari ad 1 km):
dove, t = tempo di percorrenza t0 = tempo di percorrenza a flusso libero f = flusso veicolare C = capacità della strada percorsa � �� parametri che esprimono le caratteristiche geometriche e le condizioni d'uso della strada.
risultati della regressione per il primo gruppovelocità (km/h)
urbano18
risultati della regressione per il secondo gruppovelocità (km/h)urbano extraurbano
22 50risultati della regressione per il terzo gruppo
velocità (km/h)urbano extraurbano autostrada
17 62 101risultati della regressione per il quarto gruppo
velocità (km/h)urbano extraurbano
26 67valori assunti come rappresentativi delle tipologie
velocità (km/h)urbano extraurbano autostrada
auto 19 56 101moto 26 67
87
valori differenti dei parametri individuano diverse condizioni di traffico e stradali. La seguente tabella mostra i parametri delle curve di deflusso applicate.
t0 (minuti) C � �
curva per strade di scorrimento 1,1 1000 4 3,5
curva per strade di distribuzione 1,7 450 4 3
Dalla lettura dei Piani urbani del Traffico si stima che per le strade di scorrimento il valore di flusso medio sia pari a 759 veicoli, mentre per le strade di distribuzione pari a 395. L'applicazione delle curve di deflusso porta a determinare delle velocità medie di deflusso rispettivamente per le strade di scorrimento pari a 22 km/h, per le strade locali pari a 10 km/h. Facendo la media dei valori ottenuti si stima una velocità pari a 16 km/h rappresentativa delle velocità medie in contesto urbano. La seguente tabella riassuntiva mostra i valori ottenuti attraverso la regressione lineare applicata ai diversi gruppi, (per i tragitti in solo contesto urbano si è applicata la media). 3 - Stima dei consumi di carburante Attraverso l'applicazione della metodologia descritta si è effettuata la stima dei consumi di carburante. I prezzi dei carburanti sono stati calcolati come media dei prezzi dal 2004 al 2010, periodo corrispondente all'età media del parco veicolare in esame. I prezzi medi sono stati attualizzati ai valori del 2010. Le variazioni mensili dei prezzi negli anni sono stati reperiti dal sito del Ministero dello sviluppo economico http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/ . Invece gli indici di rivalutazione monetaria sono stati ricavati dal sito ISTAT http://www.istat.it/prezzi/precon/rivalutazioni/ I prezzi adottati sono i seguenti:
• benzina 1,34 €/l • gasolio 1,21€/l • gpl 0,65 €/l
Per quanto riguarda il metano è stato preso come riferimento il prezzo del metano riportato sul numero 91 dell'agosto del 2009 della rivista “The GVR, Gas Vehicles Report” che ha pubblicato un quadro di insieme dei prezzi di metano nei diversi paesi europei. Per l'Italia è indicato il prezzo di 0,68 €/Nm3 che è stato convertito e attualizzato al 2010 in 0,97 €/kg 4 - Stima dei dati ambientali Dal sito meteo di ARPA Lombardia sono stati raccolti i dati settimanali negli anni dal 2005 al 2010 dei seguenti parametri:
19. Media sul periodo delle temperature massime giornaliere
88
20. Media sul periodo delle temperature minime giornaliere
21. Numero giorni piovosi (giorni con precipitazioni totali >0.5 mm)
si sono raccolti i rilievi delle stazioni più vicine all'ambito territoriale di riferimento del progetto: stazioni di Milano Brera, Milano Lambrate e Milano Parco Nord. Su questi dati si sono determinate le medie mensili e queste sono state aggregate per arrivare ad ottenere quattro valori rappresentativi delle temperature stagionali 5 - Stima dei giorni di lavoro in un anno Poiché si vuole effettuare una simulazione delle emissioni prodotte dai veicoli durante l'anno, è necessario conoscere il numero medio di giorni di lavoro a meno delle ferie e malattie. Pertanto è stato richiesto ai referenti comunali di indicare quale fosse il numero medio di giorni lavorati in un anno dai rispettivi dipendenti, ne è risultato che il numero medio di giorni in cui vengono fatti gli spostamenti casa lavoro in un anno è pari a 213. Come spiegato nella metodologia si assume che il numero di giorni in cui si effettuano gli spostamenti sia distribuito in modo diverso secondo le diverse stagioni. Sono stati assegnati 64 giorni all'autunno ed alla primavera, 53 all'inverno e 32 all'estate. Attraverso le informazioni raccolte sul numero di giorni di pioggia si è giunti, con una proporzione a stimare i giorni secchi nel periodo estivo e i giorni secchi nel periodo non estivo. Quest'ultima valutazione è necessaria per stimare per quanti giorni si devono simulare le emissioni di particolato non esausto (non proveniente dalla combustione nel motore). Si è assunto che in un anno mediamente ci sono 136 giorni secchi in periodo non estivo e 26 giorni secchi in periodo estivo. La distinzione tra periodo estivo e non estivo si attua perché il parco veicolare cambia con l'arrivo dell'estate 6 - Suddivisione in classi del parco veicolare Secondo la metodologia (cfr paragrafo 2.1.3) la stima delle emissioni prevede di raggruppare in classi il parco veicolare di riferimento. Dall'analisi dei risultati dell'indagine è emersa la distribuzione mostrata nella seguente tabella si mostrano anche i km totali percorsi per ogni categoria.
89
7 - Stima delle emissioni Di seguito vengono presentati i risultati delle stime delle emissioni per CO2 e PM ricavati dai risultati dell'indagine condotta. Si noti che la stima si effettuata sul percorso casa-lavoro tipo, tenendo conto dei chilometri percorsi durante i tragitti per le diverse tipologie di strada. Successivamente si è arrivati a simulare le emissioni totali durante l'anno. I seguenti paragrafi presentano rispettivamente i risultati delle emissioni a caldo, di quelle a freddo, le emissioni di PM prodotte dall'usura dei freni di pneumatici e dal manto stradale, ed infine, la somma delle emissioni nell'intero anno. 7.1 - Stima delle emissioni a caldo Nella tabella seguente vengono riportati i risultati prodotti dall'applicazione delle equazioni descritte nella metodologia per determinare le emissioni a caldo. Inoltre, a partire dai valori di emissione ottenuti, successivamente si sono applicate le correzioni dovute all'età dei veicoli e poi all'uso di carburanti rinnovati (cfr paragrafo 3.3.7 della metodologia). Tali successive correzioni hanno influenza solo sulle emissioni di CO2. I valori riportati nelle prossime tabelle esprimono le emissioni a caldo prodotte nello spostamento casa-lavoro per le percorrenze indicate, che costituiscono la somma dei chilometri totali percorsi da tutti i veicoli di una particolare categoria.
cilindrata euro
3 9,1 2,6 0 11,7a benzina Fino a 1400 cc 114 36 20 0 56a benzina Fino a 1400 cc 213 43,9 17,8 0 61,7a benzina Fino a 1400 cc 319 82,5 60,1 3 145,6a benzina Fino a 1400 cc 41 9,5 0 9,5a benzina Fino a 1400 cc 54 9,4 5,3 0 14,7a benzina Da 1401 cc a 2000 cc 35 19,6 18,9 0 38,5a benzina Da 1401 cc a 2000 cc 42 12,5 0 0 12,5A benzina GDI Fino a 1400 cc 41 2,8 6,2 0 9A benzina GDI Da 1401 cc a 2000 cc 31 3,3 2,9 0 6,2A benzina GDI oltre 2000 cc 41 6,5 0 0 6,5 ibrido Fino a 1400 cc 42 6,8 12,6 0 19,4a gpl Fino a 1400 cc 23 6,9 7,8 0 14,7a gpl Fino a 1400 cc 41 4 0 0 4a gpl Da 1401 cc a 2000 cc 22 8,4 14,7 0,8 23,9a gpl Da 1401 cc a 2000 cc 41 4,1 6,9 3 14a gpl oltre 2000 cc 42 10,6 0 6,6 17,2a metano Da 1401 cc a 2000 cc 44 12,5 6,8 12 31,3Diesel Fino a 1400 cc 32 8,4 6,1 24 38,5Diesel Fino a 1400 cc 41 10 27 0 37Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 11 0,9 2,1 0 3Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 24 19,3 10,2 18,5 48Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 36 27,3 21,3 31 79,6Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 42 2,3 3,5 0 5,8Diesel FAP Fino a 1400 cc 41 1,2 0 0 1,2Diesel FAP Da 1401 cc a 2000 cc 35 27,7 25 0 52,7Diesel FAP Da 1401 cc a 2000 cc 42 3,8 0 0 3,8motoveicolo Da 51 cc a 250 cc 31 2 0 0 2motoveicolo Da 251 cc a 750 cc 1
numero veicoli
km in urbano
km in extraurbano
km in autostrada
km totali
alimentazione/ tipo veicolo
90
In tabella sono rappresentati con “E CO2 hot” le emissioni di CO2 risultanti dall'applicazione delle equazioni descritte nella metodologia. Con “emissioni di CO2 corr. per età” si intendono le emissioni corrette con i fattori relativi all'influenza dell'età del veicolo. Tali correzioni sono applicabili solo ad alcune categorie di veicoli. La penultima colonna riporta i risultati ottenuti applicando le correzioni dovute agli effetti di nuovi carburanti su veicoli vecchi. Si noti che, in generale, l'effetto dell'età porta ad una diminuzione delle emissioni di CO2. Considerato che sono state stimate le emissioni di CO2 a meno delle emissioni di CO e composti organici volatili (COV), la diminuzione rilevata è probabilmente dovuta a maggiori emissioni di CO e COV che devono essere sottratte a quelle di CO2 producendo una diminuzione di queste ultime. Risulta, invece, positivo, anche se lievemente, l'effetto dell'utilizzo di nuovi carburanti su veicoli precedenti. Infatti, in questi casi, si ha un aumento di produzione di CO2 dovuto alla riduzione delle emissioni di CO e COV, (cfr per esempio veicoli Diesel Euro 1 da 1400 cc a 2000 cc) Le emissioni di CO2 dei veicoli a metano sono state stimate a partire dai valori di consumo di carburante dedotti dai risultati dell'indagine e dall'applicazione del fattore di emissione del livello 1 della metodologia originaria. Tali emissioni si considerano comprensive anche delle emissioni a freddo.
km tot cilindrata euro
3 11,7benzina Fino a 1400 cc 1 2232,87 2155,65 2169,21 0,0314 56benzina Fino a 1400 cc 2 10631,25 10578,04 10592,86 0,1513 61,7benzina Fino a 1400 cc 3 11519,96 11517,7 11521,28 0,0719 145,6benzina Fino a 1400 cc 4 27794,61 27792,37 27792,37 0,161 9,5benzina Fino a 1400 cc 5 2221,06 2221,06 0,014 14,7benzina Da 1401 cc a 2000 cc 3 3382,21 3380,56 3381,5 0,025 38,5benzina Da 1401 cc a 2000 cc 4 8463,42 8462,33 8462,33 0,042 12,5A benzina GDI Fino a 1400 cc 4 2923,76 2923,76 0,081 9A benzina GDI Da 1401 cc a 2000 cc 3 1763,58 1764,11 0,041 6,2A benzina GDI oltre 2000 cc 4 2086,89 2086,89 0,031 6,5 ibrido Fino a 1400 cc 4 691,52 691,52 02 19,4A gpl Fino a 1400 cc 2 3305,57 3305,57 03 14,7A gpl Fino a 1400 cc 4 2679,75 2679,75 01 4A gpl Da 1401 cc a 2000 cc 2 674,69 674,69 02 23,9A gpl Da 1401 cc a 2000 cc 4 4082,39 4082,39 01 14A gpl oltre 2000 cc 4 2388,71 2388,71 02 17,2A metano Da 1401 cc a 2000 cc 4 2612,36 2612,36 04 31,3Diesel Fino a 1400 cc 3 5214,77 5215,15 1,212 38,5Diesel Fino a 1400 cc 4 6636,08 6636,08 0,911 37Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 1 5746,94 5749,85 2,361 3Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 2 495,85 496,04 0,194 48Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 3 8005,67 8006,27 1,856 79,6Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 4 13716,43 13716,43 1,982 5,8Diesel FAP Fino a 1400 cc 4 999,75 999,75 0,011 1,2Diesel FAP Da 1401 cc a 2000 cc 3 244,4 244,41 05 52,7Diesel FAP Da 1401 cc a 2000 cc 4 9082,23 9082,23 0,112 3,8 Moto / Scooter Da 51 cc a 250 cc 3 277,16 277,16 0,021 2 Moto / Scooter Da 251 cc a 750 cc 1 191,25 191,25 0,04
num. veicoli
alimentazione/ tipo di veicolo
E CO2 (g) hot
emissioni CO2 (g) corr. per età
emissioni CO2 (g) corr. per carburante
emissioni PM (g) a caldo
91
7.2 - Stima delle emissioni a freddo La stima delle emissioni a freddo prevede il calcolo del percorso medio e il calcolo della frazione di chilometri percorsi con il motore non a regime. Il percorso medio,(chiamato ltrip) dai risultati dell'indagine, risulta essere pari a 15 km. Per il calcolo della frazione di tragitto percorsa non a regime, (c.d. �), si sono ottenuti quattro valori distinti per stagioni diverse
si noti come il valore invernale sia il più alto, mentre quello estivo il più basso. Nelle prossime due tabelle si mostrano i risultati delle stime delle emissioni a freddo rispettivamente di CO2 e PM, sempre riferite alle percorrenze del tragitto casa-lavoro indicate in precedenza. Si riportano, inoltre, le correzioni applicate per gli effetti dell'uso di carburante rinnovato.
Si è assunto che i veicoli ibridi non producano emissioni aggiuntive nella fase di riscaldamento. Non sono stati riportati i valori di emissione a freddo per i veicoli a due ruote perché si considera che i valori già mostrati siano comprensivi sia delle emissioni a caldo sia delle emissioni a freddo. Si ricorda che le influenze sull'uso del carburante rinnovato si evidenziano soltanto per i veicoli fino alla classe euro 3. Inoltre, tale influenza si ha solo per i veicoli Diesel e alimentati a benzina. Di seguito si presentano i valori di emissione a freddo del PM
0,25 0,21 0,17 0,21
β inverno
β primavera
β estate
β autunno
cilindrata euro
benzina Fino a 1400 cc 1 178,27 186,36 125,07 129,8 106,48 106,69 125,73 130,5benzina Fino a 1400 cc 2 978,35 1005,21 673,27 688,89 515,55 516,12 677,02 692,77benzina Fino a 1400 cc 3 1134,9 1150,04 776,29 785,04 571,58 571,81 780,69 789,51benzina Fino a 1400 cc 4 3004,5 3004,5 2013,98 2013,98 1325,81 1325,81 2026,08 2026,08benzina Fino a 1400 cc 5 200,16 200,16 134,17 134,17 88,33 88,33 134,98 134,98benzina Da 1401 cc a 2000 cc 3 347,92 351,37 236,8 238,77 167,27 167,35 238,16 240,15benzina Da 1401 cc a 2000 cc 4 1009,07 1009,07 675,89 675,89 439,93 439,93 679,97 679,97A benzina GDI Fino a 1400 cc 4 263,37 263,37 176,54 176,54 116,22 116,22 177,6 177,6A benzina GDI Da 1401 cc a 2000 cc 3 213,01 215,12 144,98 146,18 101,4 101,5 145,81 147,03A benzina GDI oltre 2000 cc 4 214,23 214,23 142,7 142,7 90,19 90,19 143,57 143,57ibrido Fino a 1400 cc 4 0 0 0 0 0 0 0 0A gpl Fino a 1400 cc 2 329,01 329,01 222,43 222,43 142,92 142,92 223,73 223,73A gpl Fino a 1400 cc 4 262,65 262,65 175,2 175,2 110,36 110,36 176,27 176,27A gpl Da 1401 cc a 2000 cc 2 67,88 67,88 45,88 45,88 29,46 29,46 46,15 46,15A gpl Da 1401 cc a 2000 cc 4 427,25 427,25 284,95 284,95 179,43 179,43 286,68 286,68A gpl oltre 2000 cc 4 196,67 196,67 131,15 131,15 82,57 82,57 131,95 131,95A metano Da 1401 cc a 2000 cc 4 0 0 0 0 0 0 0 0Diesel Fino a 1400 cc 3 290,86 290,96 181,03 181,07 101,65 101,64 182,36 182,4Diesel Fino a 1400 cc 4 183,95 183,95 114,45 114,45 64,22 64,22 115,29 115,29Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 1 560,83 561,99 350,89 351,41 198,89 198,89 353,43 353,95Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 2 48,75 48,83 30,44 30,47 17,18 17,18 30,66 30,69Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 3 457,37 457,52 284,66 284,72 159,82 159,82 286,74 286,8Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 4 616,57 616,57 383,62 383,62 215,25 215,25 386,43 386,43Diesel FAP Fino a 1400 cc 4 73,83 73,83 45,86 45,86 25,66 25,66 46,2 46,2Diesel FAP Da 1401 cc a 2000 cc 3 18,05 18,06 11,22 11,22 6,28 6,28 11,3 11,3Diesel FAP Da 1401 cc a 2000 cc 4 670,85 670,85 416,72 416,72 233,14 233,14 419,79 419,79
alimentazione/ tipo veicolo
emissioni CO2 (g) a freddo inverno
emissioni CO2 (g) a freddo inverno corr carburante
emissioni CO2 (g) a freddo primavera
emissioni CO2 (g) a freddo primavera corr carburante
emissioni CO2 (g) a freddo estate
emissioni CO2 (g) a freddo estate corr carburante
emissioni CO2 (g) a autunno inverno
emissioni CO2 (g) a freddo autunno corr carburante
92
Si noti che in estate la produzione di PM è nulla per tutti i veicoli e che, in generale, le emissioni di questo inquinante interessano soprattutto i veicoli Diesel. 7.3 - Stima delle emissioni di PM non esausto I valori di emissione riportati nelle prossima tabella rappresentano i valori di PM 2,5. Si è scelto di trattare solo questa dimensione della frazione di polveri sospese per avere dei valori confrontabili con quelli ottenuti per le stime di PM esausto. Per PM non esausto si intende il particolato derivato dall'usura dei freni, di pneumatici e dall'usura del manto stradale. Queste tre tipologie sono state aggregate e si forniscono come unico valore distinto per categoria. Inoltre, si ricorda che è stato valutata l'emissione prodotta nel solo tragitto casa-lavoro relativamente alle percorrenze indicate in precedenza.
cilindrata euro
benzina Fino a 1400 cc 1 0 0 0 0benzina Fino a 1400 cc 2 0 0 0 0benzina Fino a 1400 cc 3 0 0 0 0benzina Fino a 1400 cc 4 0 0 0 0benzina Fino a 1400 cc 5 0 0 0 0benzina Da 1401 cc a 2000 cc 3 0 0 0 0benzina Da 1401 cc a 2000 cc 4 0 0 0 0A benzina GDI Fino a 1400 cc 4 0 0 0 0A benzina GDI Da 1401 cc a 2000 cc 3 0 0 0 0A benzina GDI oltre 2000 cc 4 0 0 0 0ibrido Fino a 1400 cc 4 0 0 0 0A gpl Fino a 1400 cc 2 0 0 0 0A gpl Fino a 1400 cc 4 0 0 0 0A gpl Da 1401 cc a 2000 cc 2 0 0 0 0A gpl Da 1401 cc a 2000 cc 4 0 0 0 0A gpl oltre 2000 cc 4 0 0 0 0A metano Da 1401 cc a 2000 cc 4 0 0 0 0Diesel Fino a 1400 cc 3 0,29 0,09 0 0,1Diesel Fino a 1400 cc 4 0,18 0,06 0 0,06Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 1 1,15 0,37 0 0,38Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 2 0,08 0,02 0 0,03Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 3 0,45 0,15 0 0,15Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 4 0,61 0,2 0 0,2Diesel FAP Fino a 1400 cc 4 0 0 0 0Diesel FAP Da 1401 cc a 2000 cc 3 0 0 0 0Diesel FAP Da 1401 cc a 2000 cc 4 0,04 0,01 0 0,01
alimentazione/ tipo veicolo
emissioni PM (g) inverno
emissioni PM (g) primavera
emissioni PM (g) estate
emissioni PM (g) autunno
93
7.4 - Stima delle emissioni di PM e CO2 durante l'anno Nella seguente tabella si mostrano i risultati della simulazione della stima delle emissioni durante l'anno. Tali risultati costituiscono la somma totale delle emissioni di CO2 e PM e il valore dell'emissione per chilometro distinto per categoria di veicolo. I valori di PM, come più volte ricordato, si riferiscono tutti al PM 2,5 sia per quelli prodotti allo scarico (PM esausto), sia per quelli provenienti da altre fonti (PM non esausto), risultando pertanto confrontabili. La tabella finale è ordinata secondo i valori crescenti del PM esausto per chilometro. Si è scelto questo riferimento perché il PM esausto è un indicatore di inquinamento che esprime anche le caratteristiche del veicolo che lo produce. Il PM non esausto viene prodotto in modo indipendente dalla tipologia di automobile. In secondo ordine i valori si dispongono in ordine crescente dei valori di CO2 per chilometro. L'ultima colonna mostra i valori di PM totali per chilometro.
cilindrata euro
benzina Fino a 1400 cc 1 0,17benzina Fino a 1400 cc 2 0,81benzina Fino a 1400 cc 3 0,9benzina Fino a 1400 cc 4 2,07benzina Fino a 1400 cc 5 0,14benzina Da 1401 cc a 2000 cc 3 0,21benzina Da 1401 cc a 2000 cc 4 0,55A benzina GDI Fino a 1400 cc 4 0,19A benzina GDI Da 1401 cc a 2000 cc 3 0,12A benzina GDI oltre 2000 cc 4 0,09ibrido Fino a 1400 cc 4 0,1A gpl Fino a 1400 cc 2 0,27A gpl Fino a 1400 cc 4 0,21A gpl Da 1401 cc a 2000 cc 2 0,06A gpl Da 1401 cc a 2000 cc 4 0,33A gpl oltre 2000 cc 4 0,18A metano Da 1401 cc a 2000 cc 4 0,22Diesel Fino a 1400 cc 3 0,38Diesel Fino a 1400 cc 4 0,42Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 1 0,51Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 2 0,04Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 3 0,59Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 4 0,84Diesel FAP Fino a 1400 cc 4 0,08Diesel FAP Da 1401 cc a 2000 cc 3 0,02Diesel FAP Da 1401 cc a 2000 cc 4 0,75 Moto / Scooter Da 51 cc a 250 cc 3 0,03 Moto / Scooter Da 251 cc a 750 cc 1 0,01
alimentazione/ tipo veicolo
PM (g) non esausto
94
8 - Conclusioni Si è eseguita una verifica rispetto al consumo di carburante (cfr paragrafo 7.1.1 della metodologia). Infatti, tramite i risultati dell'indagine, come previsto dalla metodologia, si è calcolato il rapporto tra il consumo di carburante statistico rilevato dal questionario e il consumo calcolato con i fattori di emissione della metodologia. Si è giunti a tre valori di rapporti distinti per tipo di carburante. Si è detto che, per quel che riguarda il metano, tale verifica non è stata condotta poiché la metodologia non prevede i fattori di consumo per i veicoli a metano. Anzi, I dati statistici rilevati dall'indagine per determinare il consumo di metano sono serviti per determinare il consumo dei veicoli oggetto di ricerca, per poi calcolarne le emissioni di CO2. I valori dei rapporti tra consumo statistico e calcolato sono tutti vicini a 1, ma si rileva che per quel che riguarda il Diesel, c'è un scostamento maggiore degli altri carburanti rispetto l'unità. Di seguito si riportano i valori di tali rapporti.
La tabella finale consente di avere un quadro complessivo degli effetti prodotti dalle diverse categorie di veicoli rispetto alle emissioni di CO2 e PM2,5. Si sottolinea che, come indicato nel paragrafo 7.1 della metodologia, la stima delle emissioni condotta porta a risultati significativi in relazione alle categorie di veicoli, ma non risulta altrettanto efficace per la stima delle emissioni dei singoli percorsi. Infatti, una disaggregazione temporale o
cilindrata euro
1 6,5 0 0 6,5 ibrido Fino a 1400 cc 4 0,27 96,40 0,00 0 31,97 15,18 15,182 10,6 0 6,6 17,2 A metano Da 1401 cc a 2000 cc 4 1,11 151,88 0,00 0 70,62 12,67 12,672 8,4 14,7 0,8 23,9 A gpl Da 1401 cc a 2000 cc 4 1,55 151,97 0,00 0 94,07 15,58 15,581 4,1 6,9 3 14 A gpl oltre 2000 cc 4 1,00 167,33 0,00 0 58,12 12,81 12,811 4 0 0 4 A gpl Da 1401 cc a 2000 cc 2 0,29 167,57 0,00 0 19,68 15,18 15,182 6,8 12,6 0 19,4 A gpl Fino a 1400 cc 2 1,40 169,16 0,00 0 87,41 13,91 13,913 6,9 7,8 0 14,7 A gpl Fino a 1400 cc 4 1,13 180,67 0,00 0 67,35 14,14 14,145 19,6 18,9 0 38,5 benzina Da 1401 cc a 2000 cc 4 3,55 216,23 14,84 0,9 177,36 14,22 15,121 9,5 9,5 benzina Fino a 1400 cc 5 0,91 225,58 4,34 1,07 46,73 15,18 16,254 9,4 5,3 0 14,7 benzina Da 1401 cc a 2000 cc 3 1,39 224,29 6,77 1,09 68,41 14,47 15,56
19 82,5 60,1 3 145,6 benzina Fino a 1400 cc 4 11,55 186,42 67,65 1,09 670,72 14,24 15,3313 43,9 17,8 0 61,7 benzina Fino a 1400 cc 3 4,67 181,71 29,58 1,15 285,26 14,62 15,771 1,2 0 0 1,2 Diesel FAP Da 1401 cc a 2000 cc 3 0,13 289,72 0,88 2,02 4,96 15,18 17,25 27,7 25 0 52,7 Diesel FAP Da 1401 cc a 2000 cc 4 4,68 208,31 45,97 2,05 243,33 14,25 16,32 2,3 3,5 0 5,8 Diesel FAP Fino a 1400 cc 4 0,51 208,35 5,25 2,13 26,30 14 16,123 9,1 2,6 0 11,7 benzina Fino a 1400 cc 1 0,89 178,89 12,31 2,47 55,90 14,75 17,21
14 36 20 0 56 benzina Fino a 1400 cc 2 4,36 183,44 63,73 2,68 262,60 14,51 17,191 2,8 6,2 0 9 A benzina GDI Da 1401 cc a 2000 cc 3 0,68 176,19 13,39 3,49 33,86 16,47 19,971 3,3 2,9 6,2 A benzina GDI oltre 2000 cc 4 0,86 327,35 10,86 4,11 28,65 14,26 18,382 12,5 0 0 12,5 A benzina GDI Fino a 1400 cc 4 1,20 225,68 30,05 5,64 61,48 15,18 20,822 3,8 0 3,8 Moto / Scooter Da 51 cc a 250 cc 3 0,21 70,00 20,04 6,06 16,61 6,38 12,441 2 0 2 Moto / Scooter Da 251 cc a 750 cc 1 0,07 86,65 17,04 20 4,57 5,64 25,642 8,4 6,1 24 38,5 Diesel Fino a 1400 cc 4 3,32 202,16 364,78 22,24 134,67 10,8 33,046 27,3 21,3 31 79,6 Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 4 6,93 204,42 833,24 24,57 270,93 10,51 35,084 12,5 6,8 12 31,3 Diesel Fino a 1400 cc 3 2,65 199,07 491,39 36,85 124,22 12,25 49,14 19,3 10,2 18,5 48 Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 3 4,04 199,49 866,85 42,79 188,53 12,25 55,041 0,9 2,1 0 3 Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 2 0,26 203,07 83,91 65,65 13,42 13,81 79,461 10 27 0 37 Diesel Da 1401 cc a 2000 cc 1 3,01 190,79 1071,68 67,99 164,83 13,75 81,74
num veicoli
km urbano
km extra urbano
km autostrada
km totali
alimentazione/ tipo veicolo
emissioni CO2 (ton) anno
emissioni CO2 (g/km)
emissioni PM (g) anno
emissioni PM (mg/km)
emissioni PM non esausto (g) anno
emissioni PM non esausto (mg/km)
emissioni PM tot (mg/km)
rapporti stat/calcbenzina 0,91diesel 1,15gpl 0,93
95
spaziale si accompagna ad una riduzione di accuratezza nella stima delle emissioni. Questo è particolarmente vero nel caso delle emissioni da trasporto su strada, perché i fattori di emissione proposti sono aggregati e mediati su un ampio numero di cicli di guida. Pertanto essi non sono necessariamente rappresentativi delle emissioni istantanee dei veicoli circolanti nelle condizioni attuali. L'applicazione della metodologia può essere comunque utilizzata come strumento di analisi degli effetti inquinanti prodotti dagli spostamenti casa-lavoro. 9 - Riferimenti bibliografici e siti internet Di seguito si elencano alcuni riferimenti di documentazione estratti dalle linee guida “EMEP/EEA emission inventory guidebook 2009”, ed altri riferimenti utili relativi a siti web.
• EMEP/EEA emission inventory guidebook 2009 • EMEP/EEA emission inventory guidebook 2006 • Copert/Corinair Eggleston et al., 1989 • Eggleston S., Gorißen N., Joumard, R., Rijkeboer R.C., Samaras Z., e ZiZierock K.-H.
(1989). Corinair Working Group on Emissions Factors for Calculating 1985 Emissions from Road Traffic. Volume 1: Methodology and Emission Factors. Final report contract No 88/6611/0067, EUR 12260EN.
• Ntziachristos L., Mamakos A., Xanthopoulos A., Iakovou E., and Samaras Z. (2004), Impact assessment/Package of new requirements relating to the emissions from two and three-wheel motor vehicles.
• Aristotle University, Thessaloniki, Greece. • Boulter P. G. and T. J. Barlow (2005). Artemis: Average speed emission functions for
heavy-duty road vehicles. TRL Unpublished project report UPR/IEA/12/05. TRL Limited, Wokingham.
• Hassel D., Jost P., Dursbeck F., Brosthaus J. and Sonnborn K.S. (1987), Das Abgas-Emissionsverhalten von Personenkraftwagen in der Bundesrepublik Deutschland im Bezugsjahr 1985. UBA Bericht 7/87. Erich Schmidt Verlag, Berlin.
• Boulter P and McCrae I (eds.) (2007). Artemis: Assessment and reliability of transport emission models and inventory systems. Final report. Deliverable No 15. TRL unpublished report UPR/IE/044/07. TRL Limited, Wokingham.
• Pattas K., Kyriakis N., and Z. Samaras (1985). Exhaust Gas Emission Study of Current Vehicle
• Fleet in Athens (PHASE II). Volumes I, II, III. Final report to PERPA/EEC, Thessaloniki, Greece.
• Hauger A. and R. Joumard (1991), LPG pollutant emissions. Use of Compressed Natural Gas (CNG), Liquefied Natural Gas (LNG) and Liquefied Petroleum Gas (LPG) as fuel for internal combustion engines, UN-ECE Symposium, Kiev, Ukraine.
• http://ita.arpalombardia.it/ • http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/ • http://www.istat.it/prezzi/precon/rivalutazioni/ • http://www.eea.europa.eu/publications/EMEPCORINAIR5/ • http://lat.eng.auth.gr/copert/
96
9. Profili e caratteristiche della mobilità dei dipendenti9 9.1 - Finalità e obiettivi di indagine
L’indagine è finalizzata a rilevare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente delle cinque Amministrazioni comunali e di quello di due aziende private, la CSI e la Solvay Solexis con sede nel comune di Bollate. La decisione di includere nella ricerca il personale delle aziende private è motivata dall’interesse a rilevare la mobilità per motivi di lavoro del personale dipendente complessivo dell’area territoriale considerata. Poiché, rispetto alle Amministrazioni comunali, l’adesione all’indagine da parte delle aziende private era facoltativa, quelle considerate sono le sole aziende che hanno dichiarato la disponibilità ad aderire all’indagine proposta., L’obiettivo della ricerca è rilevare le informazioni necessarie per conoscere le caratteristiche e i profili di mobilità per motivi di lavoro del personale dipendente delle Amministrazioni comunali coinvolte nel Progetto. Sebbene parziale, rispetto alla mobilità complessiva (per finalità non solo limitate al lavoro) e rispetto a quella espressa anche dalle altre popolazioni residenti e non residenti che gravitano sul territorio indagato, la ricerca fornisce informazioni molto utili rispetto alla finalità operativa di proporre e avviare politiche mirate per la mobilità sostenibile. 9.2 - Metodo di indagine L’indagine si rivolge al personale dipendente a tempo determinato e indeterminato e a regime orario di tempo pieno o parziale delle Amministrazioni comunali di Arese, Bollate, Garbagnate Milanese, Lainate e Pero e delle aziende CSI e Solvay Solexis di Bollate. E’ quindi escluso dalla ricerca il personale con contratto di lavoro non dipendente che, avendo orari di lavoro atipici, presenta stili di mobilità non comparabili con quelli degli altri lavoratori. L’indagine è stata realizzata tramite la somministrazione di un questionario on-line10, ai dipendenti delle Amministrazioni comunali coinvolte nel Progetto. Il questionario è stato aperto alla compilazione il giorno 19 maggio 2010 e chiuso il 27 giugno successivo. L’invito a rispondere all’indagine (con l’indicazione dell’indirizzo web del questionario) è stato inoltrato per e-mail ai dipendenti da parte dei responsabili di ogni Comune o ente coinvolto, così come i successivi solleciti. Il questionario si articola in cinque sezioni: • informazioni generali (socio-anagrafiche e relative alle sede e al tipo di lavoro); • mobilità spostamento casa-lavoro (orario, durata, mezzo,); • soddisfazione e difficoltà dello spostamento casa-lavoro (per tipo di mezzo), • proposte per la mobilità sostenibile; 9 La ricerca è stata realizzata dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca. Il gruppo di lavoro è composto da Francesca Zajczyk (coordinamento scientifico) Mario Boffi e Matteo Colleoni (che hanno coordinato l’indagine), Giulio Mattioli (che ha curato, in particolare, la costruzione del questionario e l’analisi dei dati) e Clara Melzi. La predisposizione del questionario è stata supportata dalla consulenza di Andrea Airoldi e di Stefano Bardo (in particolare per la sezione “Mezzi, caratteristiche dei veicoli ed emissioni”). Tutte le fasi di ricerca e di predisposizione e applicazione dello strumento di rilevazione sono state condivise con i referenti del Settore per la mobilità della Provincia di Milano e delle Amministrazioni comunali che aderiscono al Progetto. 10 Il questionario on line è stato costruito con il software open- source Limesurvey installato sui server dei Servizi
informatici dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
97
• mezzi, caratteristiche del veicolo e emissioni. Al momento della chiusura dell’indagine il numero di risposte registrate è stato pari a 420; l’eliminazione dei record vuoti, non sufficientemente informativi e ridondanti ha portato alla cancellazione di 30 casi. Ai fini dell’analisi dei profili e delle caratteristiche di mobilità dei dipendenti il campione utilizzato consta dunque di 390 casi. Il numero dei rispondenti (Grafico 1) e il valore del tasso di risposta (Grafico 2) sono risultati essere significativamente eterogenei tra gli enti e le aziende coinvolti. Grafico 1 Distribuzione di frequenza assoluta delle risposte al questionario per ente partecipante (n=390)
Grafico 2 Tasso di risposta per ente partecipante, valori percentuali (n=390)
Si può notare in particolare l’entità molto esigua delle risposte – sia in termini assoluti che relativi – ottenute dai dipendenti di alcuni comuni, in particolare Lainate. Per questo motivo i risultati relativi a questo comune vengono riportati nel seguito del rapporto laddove si presentano distribuzioni per ente coinvolto, ma senza commento in quanto la numerosità troppo ridotta dei rispondenti non consente di esprimere una qualsiasi valutazione significativa. Va notato infine che il tasso di risposta ottenuto tra i dipendenti del comune di Arese non è noto, in quanto non è stato comunicato
98
dal referente al Progetto del Comune di Arese il numero di dipendenti della Amministrazione comunale”. Più in generale, va tenuto presente che, data l’entità del campione e la sua disomogeneità all’interno dei diversi enti partecipanti, l’indagine è da considerarsi esplorativa, e i dati non sono utilizzabili come rappresentazione del comportamento dei dipendenti pubblici e delle aziende private nel loro insieme. A maggior ragione, non essendo gli enti coinvolti rappresentativi delle occupazioni nei relativi comuni, non si possono considerare i risultati di questa indagine come indicativi della mobilità casa-lavoro dei lavoratori nell’area intercomunale considerata 9.3 – Caratteristiche socio-demografiche L’analisi delle caratteristiche socio-demografiche dei rispondenti mette in evidenza una serie di differenze marcate tra i dipendenti delle amministrazioni comunali e quelli delle aziende private coinvolte, che sembrano influire fortemente sui loro profili e caratteristiche di mobilità, come verrà illustrato nel seguito. Tra i dipendenti degli Enti comunali si riscontra infatti una tendenziale sovra rappresentazione delle donne ( Tabella 1), dei dipendenti nelle fasce di età più anziane (Tabella 2) dei soggetti con titolo di studio inferiore alla laurea (Tabella 3) e con figli (Tabella 4). Coerentemente, la distribuzione dei tipi di famiglie per ente (non riportata nel rapporto) mostra come la proporzione di rispondenti che vivono “con coniuge/partner e con figli” sia superiore alla media tra i dipendenti pubblici. Per converso, il gruppo dei dipendenti delle due aziende private coinvolte risulta essere mediamente più giovane, più istruito e composto in proporzione maggiore rispetto ai dipendenti pubblici da uomini e da single. Tabella 1 Distribuzione di frequenza percentuale per genere ed ente partecipante (n= 383)
Sesso Maschio Femmina Totale
Arese 23% 77% 100% Bollate comune 32% 68% 100% Garbagnate Milanese
32% 68% 100%
Lainate 57% 43% 100% Pero 40% 60% 100% CSI 55% 45% 100%
Azienda
Solvay Solexis 63% 37% 100% Totale 42% 58% 100%
Tabella 2 Distribuzione di frequenza percentuale per classe di età ed ente partecipante (n=378)
Fascia d'età 18-24 25-34 35-49 50-64 Totale
Arese 0% 15% 60% 25% 100%Bollate comune 1% 11% 61% 27% 100%
Azienda
Garbagnate Milanese
2% 10% 35% 53% 100%
99
Lainate 0% 0% 71% 29% 100%Pero 0% 20% 60% 20% 100%CSI 3% 45% 45% 7% 100%
Solvay Solexis 0% 26% 58% 16% 100%Totale 1% 18% 53% 28% 100%
Tabella 3 Distribuzione di frequenza percentuale per titolo di studio ed ente partecipante (n=380)
Qual è il suo titolo di studio? Scuola
dell'obbligo Diploma di scuola media
superiore/maturità Laurea Totale Arese 11% 50% 39% 100%Bollate comune 16% 58% 26% 100%Garbagnate Milanese
22% 60% 18% 100%
Lainate 0% 86% 14% 100%Pero 5% 37% 58% 100%CSI 0% 41% 59% 100%
Azienda
Solvay Solexis 1% 29% 70% 100%Totale 11% 47% 42% 100% Tabella 4 Distribuzione di frequenza percentuale per presenza di figli ed ente partecipante (n=379)
Ha figli? Sì NO Totale
Arese 60% 40% 100% Bollate comune 70% 30% 100% Garbagnate Milanese
77% 23% 100%
Lainate 71% 29% 100% Pero 74% 26% 100% CSI 41% 59% 100%
Azienda
Solvay Solexis 44% 56% 100% Totale 61% 39% 100%
9.4 - Profili e caratteristiche della mobilità nello spostamento casa-lavoro Alle differenze socio-demografiche riscontrate nella sezione precedente tra dipendenti pubblici e privati se ne aggiungono altre, che più ne influenzano gli stili di mobilità. La percentuale di dipendenti che risiedono nel comune in cui lavorano, che sfiora il 50% in alcuni Enti comunali, è invece molto ridotta tra i dipendenti di CSI e Solvay Solexis (Tabella 5). In maniera corrispondente, dunque, la proporzione di lavoratori provenienti da un comune diverso dai cinque coinvolti è invece molto elevata nelle due aziende private (dove supera l’80%). All’estremo opposto, il comune di Garbagnate Milanese, nel quale più del 50% dei dipendenti comunali che
100
hanno risposto al questionario risulta domiciliato nel territorio comunale, e quello di Bollate, attestato su valori analoghi, anche se leggermente meno elevati. Tabella 5 Distribuzione di frequenza percentuale per comune di domicilio ed ente partecipante (n=363)
Comune di domicilio
Arese BollateGarbagnate
Milanese Lainate Pero Altro Totale Arese
30% 6% 11% 4% 0% 49% 100%
Bollate comune
5% 47% 7% 1% 0% 40% 100%
Garbagnate Milanese
2% 1% 54% 0% 0% 43% 100%
Lainate
0% 0% 14% 43% 0% 43% 100%
Pero
10% 5% 0% 15% 20% 50% 100%
CSI
7% 14% 0% 0% 0% 80% 100%
Azienda
Solvay Solexis
2% 4% 2% 0% 0% 92% 100%
Totale 7% 14% 16% 2% 1% 60% 100%
Grafico 3 Distribuzione di frequenza percentuale per tipo di comune di domicilio (n=368)
Coerentemente, la durata mediana dello spostamento casa-lavoro (e lavoro-casa) risulta più elevata tra i dipendenti delle aziende private (in particolare di Solvay Solexis), così come la distanza
101
mediana percorsa nel tragitto di andata11 (Grafico 4 e Grafico 5). Tra i comuni, si rilevano tempi di percorrenza e distanze più elevate tra i dipendenti di Pero, mentre entrambi i valori hanno il loro minimo nei comuni di Garbagnate Milanese e Bollate. Per tutte le aziende (con la rilevante eccezione della Solvey Solexis) il tempo mediano di percorrenza è inferiore nel tragitto di ritorno. Grafico 4 Durata mediana degli spostamenti casa-lavoro e lavoro-casa (in minuti) per ente partecipante (n=338, casa lavoro; 329, lavoro casa)
Grafico 5 Distanza mediana complessiva percorsa (in chilometri) per lo spostamento casa-lavoro per ente partecipante (n=304)
11 Per valore mediano di una distribuzione si intende il valore del caso che si trova a metà della distribuzione di
frequenza. Esso può essere interpretato in questo modo: metà dei casi nella categoria di riferimento ha un valore minore o uguale a quello mediano, e un’altra metà ha valori maggiori o uguali..
102
Il Grafico 6 rappresenta graficamente il dato della variabile più importante dell’intera indagine, ovvero il mezzo abitualmente utilizzato nello spostamento casa-lavoro da parte dei dipendenti intervistati. Come si può notare, il predominio dell’automobile è incontrastato: quasi il 70% dei rispondenti la utilizza come mezzo principale (e in genere esclusivo) di trasporto. A questa cifra va aggiunto il circa 3% di dipendenti che viene accompagnato da altri al lavoro in auto. I mezzi pubblici si attestano su una percentuale molto ridotta (9%), che supera di poco il 10% se ad essa si sommano le combinazioni multimodali (bicicletta/trasporto pubblico e auto/trasporto pubblico) che coinvolgono i mezzi pubblici. Da questo punto di vista, si deve constatare che la multimodalità è un fenomeno praticamente inesistente tra i dipendenti degli enti coinvolti. I modi di spostamento della cosiddetta mobilità lenta (piedi e bicicletta) corrispondono ciascuno all’8% del campione: essi presentano dunque, se presi congiuntamente, una significativa maggiore consistenza dei mezzi di trasporto pubblici. Solo in quattro casi sui 334 validi, infine, il mezzo utilizzato abitualmente per lo spostamento casa-lavoro è una motocicletta o uno scooter. Grafico 6 Distribuzione di frequenza percentuale per mezzo principale / combinazione di mezzi utilizzati (n=334)
La ripartizione modale è ovviamente diversa nei vari enti coinvolti, come può essere osservato in Tabella 6. Se è vero che la percentuale di automobilisti (conducenti e passeggeri) non scende mai sotto il 50%, essa tocca valori notevolmente più elevati nel Comune di Arese (86%) e nelle aziende private, in particolar modo tra i dipendenti di CSI tra i quali supera il 90%. Per contro i comuni in cui l’auto risulta relativamente meno utilizzata sono Garbagnate Milanese e Bollate. L’utilizzo dei mezzi pubblici ha valori sopra la media solo tra i dipendenti dei comuni di Bollate, Pero e della Solvay Solexis (anch’essa situata nel comune di Bollate) mentre risulta inferiore alla media presso la CSI, a Garbagnate e (soprattutto) ad Arese. Gli spostamenti casa-lavoro a piedi o in bicicletta costituiscono una realtà consistente soltanto tra i dipendenti dei comuni di Garbagnate Milanese (dove congiuntamente costituiscono quasi il 40% degli spostamenti), Bollate e Pero, mentre sono di entità sostanzialmente irrilevante nelle due aziende private coinvolte. Tabella 6 Distribuzione di frequenza percentuale per mezzo principale utilizzato e per ente partecipante (n=331)
Mezzo principale
Piedi BiciclettaMoto / Scooter Auto
Mezzi pubblici Totale
Azienda Arese 7% 2% 2% 86% 2% 100%
103
Bollate comune 15% 15% 2% 54% 15% 100%Garbagnate Milanese
19% 19% 0% 59% 5% 100%
Lainate 0% 29% 0% 71% 0% 100%Pero 13% 0% 0% 69% 19% 100%CSI 0% 0% 0% 93% 7% 100%
Solvay Solexis 0% 1% 2% 81% 16% 100%Totale 8% 8% 1% 72% 11% 100% Come può essere osservato in Tabella 6, i dipendenti che lavorano ed abitano nello stesso comune utilizzano in maniera molto più consistente i modi della mobilità lenta per recarsi al lavoro, in una proporzione che sfiora il 50% ed è sostanzialmente pari a quella degli automobilisti (48%). I mezzi pubblici vengono invece utilizzati soltanto nel 2% dei casi nei tragitti intercomunali. Nel caso dei dipendenti che risiedono in uno dei comuni partecipanti e lavorano in un altro, lo share modale dell’auto sfiora invece il 95%, con il resto suddiviso più o meno equamente tra bicicletta e mezzi pubblici. Il trasporto pubblico sembra invece riacquistare competitività (14% degli spostamenti) per i tragitti (presumibilmente) più lunghi di quanti risiedono in un comune non aderente al progetto PIMS; in questo caso, l’auto continua a rappresentare all’incirca l’80% degli spostamenti, mentre l’uso della bicicletta è estremamente raro (3%). Va notato che è in questa categoria che si ritrovano i pochi casi di combinazioni multimodali (bici o auto più mezzi pubblici) dell’intero campione.
104
Tabella 7 Distribuzione di frequenza percentuale per mezzo principale/ combinazione di mezzi utilizzati e per tipo di comune di domicilio (n=319)
Mezzo o combinazione di mezzi
Piedi (per
più di 300m) Bicicletta
Moto / Scooter
Auto come conducente
Auto come
passeggeroMezzi
pubblici
Auto + mezzi
pubblici
Bici + mezzi
pubblici
Totale
Comune domicilio = comune lavoro
27% 20% 2% 40% 8% 2% 0% 0% 100%
Comune domicilio = Altro comune partecipante
0% 3% 0% 94% 0% 3% 0% 0% 100%
Comune domicilio = Altro comune non partecipante
0% 3% 1% 77% 2% 14% 2% 2% 100%
Totale 8% 8% 1% 69% 3% 9% 1% 1% 100% Il confronto per genere (Tabella 8) evidenzia che l’utilizzo dell’auto è leggermente più accentuato tra le donne (74%) che tra gli uomini (68%). Analogamente, essere accompagnati in auto sul lavoro da terzi è una pratica che coinvolge più frequentemente la parte femminile del campione. Interessante anche il fatto che, tra i modi della mobilità lenta, la bicicletta venga più spesso utilizzata dagli uomini, mentre le donne sembrano recarsi più spesso a piedi al lavoro. Per quanto riguarda il mezzo pubblico, l’utilizzo più marcato da parte degli uomini delle combinazioni multimodali (che sono invece del tutto assenti nella parte femminile del campione) fa sì che l’utilizzo del trasporto pubblico sia leggermente più accentuato tra gli uomini (13%) che tra le donne (9%). Il dato merita attenzione poiché in controtendenza rispetto a quello rilevato nelle indagini sulla mobilità che, normalmente, vede le donne più associate all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici. Tabella 8 Distribuzione di frequenza percentuale per mezzo principale / combinazione di mezzi utilizzati e per genere (n=333)
Mezzo o combinazione di mezzi
Piedi (per
più di 300m) Bicicletta
Moto / Scooter
Auto come
conduc.
Auto come
passeg.Mezzi
pubblici
Auto + mezzi
pubblici
Bici + mezzi
pubblici TotaleMaschio 4% 11% 3% 67% 1% 8% 2% 3% 100%Sesso Femmina 11% 5% 0% 70% 4% 9% 0% 0% 100%
Totale 8% 8% 1% 69% 3% 9% 1% 1% 100%
105
L’esame dei tipi di famiglie (Grafico 7) sembra evidenziare un utilizzo leggermente più marcato dell’auto da parte di coloro che hanno figli sotto i 14 anni, mentre chi non li ha (o ha figli più grandi) tende a scegliere più frequentemente i mezzi pubblici, la bicicletta o gli spostamenti a piedi – che comunque, se considerati congiuntamente, non superano in questa categoria la soglia del 30%. Grafico 7 Distribuzione di frequenza percentuale per mezzo principale utilizzato e per presenza-assenza di figli con meno di 14 anni (n=329)
Il titolo di studio (Tabella 9) sembra essere correlato positivamente in maniera piuttosto forte con l’utilizzo dell’auto: la percentuale di tragitti effettuati alla guida di un auto scende infatti addirittura sotto il 50% tra gli intervistati il cui titolo di studio non supera la scuola dell’obbligo. Per contro, la modalità “auto come passeggero” risulta fortemente sovra-rappresentata proprio nella categoria di titolo di studio più bassa. L’utilizzo dei mezzi pubblici presenta invece una distribuzione bi-modale: ha infatti valori alti e sopra la media sia tra i più istruiti sia tra i meno istruiti, mentre tocca il suo minimo tra chi si ferma al diploma di scuola superiore. L’utilizzo dei modi della mobilità lenta sembra invece essere correlato negativamente con l’istruzione: quasi il 20% dei meno istruiti si reca al lavoro in bicicletta (un valore doppio rispetto alla media del campione), mentre gli spostamenti a piedi hanno il loro massimo tra i diplomati. In entrambi i casi, la mobilità lenta rappresenta tra il 20% e il 30% del riparto modale, una percentuale che scende invece sotto il 10 tra i più istruiti. Tabella 9 Distribuzione di frequenza percentuale per mezzo principale / combinazione di mezzi utilizzati e per titolo di studio (n=331)
Mezzo o combinazione di mezzi
Piedi (per
più di 300m) Bicicletta
Moto / Scooter
Auto come
conduc.
Auto come
passeg.Mezzi
pubblici
Auto + mezzi
pubblici
Bici + mezzi
pubblici
Totale
Scuola dell'obbligo 9% 18% 0% 44% 15% 15% 0% 0% 100%
106
Diploma di scuola media superiore/maturità
13% 9% 1% 68% 3% 5% 1% 2% 100%
Laurea 3% 5% 1% 75% 1% 12% 1% 1% 100%Totale 8% 8% 1% 69% 3% 9% 1% 1% 100%
Questi dati risultano più facilmente interpretabili alla luce delle differenze nel livello di istruzione tra i dipendenti dei diversi enti partecipanti (Tabella 3): in particolare, sembra probabile che i dipendenti delle due aziende private, in cui i laureati rappresentano più della metà del campione (mentre “scuola dell’obbligo” risulta una categoria praticamente inesistente) tendano a risiedere più lontano e quindi ad avere scelte modali fortemente sbilanciate verso l’auto e (in secondo luogo) i mezzi pubblici. Per contro, i lavoratori con titoli di studio più bassi (concentrati prevalentemente tra i dipendenti dei comuni di Bollate e Garbagnate Milanese) tendono probabilmente ad abitare più vicino alla sede di lavoro e, allo stesso tempo, ad avere redditi inferiori che rendono difficile l’acquisto e l’utilizzo di più auto per nucleo familiare. Per questo motivo, in tali comuni risultano sovra-rappresentati tutti i modi diversi dall’”auto come conducente”. Il Grafico 8 illustra la variazione tra i dipendenti dei diversi enti e aziende della percentuale di rispondenti che nel periodo estivo utilizzano un mezzo diverso da quello abituale per percorrere il tragitto casa-lavoro, che sul totale del campione corrisponde al 13%. Come si può notare, non ci sono variazioni degne di nota tra i diversi enti, se si fa eccezione per CSI (dove il 22% dichiara di cambiare mezzo) e il Comune di Bollate (dove la percentuale scende al 7%). Grafico 8 Distribuzione di frequenza percentuale dei dipendenti che nel periodo estivo utilizzano un mezzo diverso da quello abituale per lo spostamento casa-lavoro, per ente partecipante (n=331)
Il riparto modale estivo è quindi riportato in Grafico 9, a confronto con quello abituale; esso evidenzia come l’utilizzo dell’auto, pur rimanendo di gran lunga dominante, scenda sotto il 70%, mentre aumentano bicicletta e (soprattutto) motocicli. A fare le spese di questo trasferimento verso le due ruote non è però solo l’auto: cala infatti anche lo share modale del trasporto pubblico, su valori (9%) addirittura inferiori a quelli della bicicletta. L’incrocio tra il mezzo utilizzato abitualmente e quello estivo, che permette di quantificare i flussi da una modalità all’altra, è riportato sinteticamente in Tabella 10 .
107
Grafico 9 Distribuzione di frequenza percentuale per mezzo principale utilizzato e per tipo di periodo (durante l’anno e nel periodo estivo) (n=334)
Tabella 10 Distribuzione di frequenza percentuale per mezzo principale utilizzato nel periodo estivo e per mezzo principale utilizzato normalmente (n=334)
Mezzo principale utilizzato nel periodo estivo
Piedi BiciclettaMoto / Scooter Auto
Mezzi pubblici Totale
Piedi
93% 7% 0% 0% 0% 100%
Bicicletta
0% 100% 0% 0% 0% 100%
Moto / Scooter
0% 0% 100% 0% 0% 100%
Auto
1% 5% 6% 88% 0% 100%
Mezzo principale utilizzato normalmente
Mezzi pubblici
0% 8% 5% 5% 81% 100%
Totale 8% 13% 6% 64% 9% 100% Come si può osservare dalla Grafico 10, il cambio del mezzo nel periodo estivo è una pratica relativamente più diffusa tra chi abita più vicino alla sede di lavoro (nello stesso comune). Essa tocca tuttavia il minimo non tra i dipendenti che abitano presumibilmente più lontano (in un comune non coinvolto nell’indagine) ma tra coloro che risultano domiciliati in uno dei cinque comuni censiti e lavorano in un altro. Le differenze sono particolarmente evidenti nella tabella successiva (Tabella 11): nel periodo estivo, tra i dipendenti che risiedono e lavorano nello stesso comune, la mobilità lenta assorbe più della metà degli spostamenti casa-lavoro (59%), una percentuale di gran lunga più elevata di quella dell’auto, che viene utilizzata per solo circa un terzo degli spostamenti. Del tutto residuale invece il valore relativo ai mezzi pubblici. Per contro, tra coloro che abitano nel comune coinvolto e lavorano
108
in un altro, è l’auto a dominare (94%), con poco o nessuno spazio per i modi alternativi. Questo dato va tuttavia interpretato con cautela, data l’entità esigua (in termini sia relativi sia assoluti) del gruppo di pendolari da un comune partecipante all’altro (si veda Grafico 3). Più significativo invece il dato riguardante coloro che abitano in un comune non censito: in questo caso l’auto domina sì, ma con percentuali più basse (73%) e il trasporto pubblico supera il 10% di spostamenti, anche se si situa su valori più bassi (14%) rispetto a quelli del periodo non estivo (vedi Tabella 7). Grafico 10 Distribuzione di frequenza percentuale dei dipendenti che nel periodo estivo utilizzano un mezzo diverso da quello abituale per lo spostamento casa-lavoro (n=331)
Tabella 11 Distribuzione di frequenza percentuale per mezzo principale utilizzato per lo spostamento casa-lavoro nel periodo estivo e per tipo di comune di domicilio (n=319)
Mezzo principale utilizzato durante il periodo estivo
Piedi BiciclettaMoto / Scooter Auto
Mezzi pubblici Totale
Comune domicilio = comune lavoro
28% 31% 7% 32% 2% 100%
Comune domicilio = altro comune partecipante
0% 3% 0% 94% 3% 100%
Comune lavoro
Comune di domicilio = altro comune non partecipante
0% 6% 7% 73% 14% 100%
Totale 8% 12% 6% 64% 10% 100%
Il Grafico 11 riporta il valore mediano della durata dello spostamento casa-lavoro in relazione al mezzo utilizzato. Si può notare come gli spostamenti più brevi siano quelli effettuati con i modi della “mobilità lenta”: circa metà di coloro che si spostano in bicicletta impiega un numero di minuti inferiore o uguale a 10 per raggiungere la sede di lavoro. Molto brevi anche gli spostamenti
109
di coloro che vengono accompagnati al lavoro in auto da terzi (mediana 13 minuti), segno che probabilmente questa pratica è diffusa tra chi abita vicino alla sede di lavoro. La mediana è invece considerevolmente più alta per “auto come conducente” (30 minuti) e ancor più per i mezzi pubblici (51,5 minuti) e per le combinazioni multimodali che li coinvolgono (anche se il dato per queste categorie va interpretato con cautela, a causa dell’esiguo numero di casi che vi fanno riferimento). Grafico 11 Distribuzione del valore mediano della durata dello spostamento casa-lavoro (in minuti) per mezzo principale / combinazione di mezzi utilizzati nello spostamento casa-lavoro (n=330)
I dati relativi alle distanze mediane percorse per mezzo di trasporto utilizzato (Grafico 12) sono interpretabili in maniera analoga12: metà degli spostamenti effettuati a piedi corrispondono a distanze molto ridotte (inferiori o uguali a 800 metri), così come sono generalmente brevi (mediana 2 km) i tragitti casa-lavoro percorsi in bicicletta o in “automobile come passeggero”. Per l’automobile come conducente invece la durata mediana dello spostamento si aggira attorno alla mezz’ora. Ai mezzi pubblici e alle combinazioni multimodali corrispondono distanze in genere più lunghe, anche se non in misura così elevata da giustificare la differenza con l’automobile riscontrata in termini di durata dello spostamento.
12 I dati relativi alla distanza presentati in questa parte del rapporto corrispondono alle distanze dichiarate dai
rispondenti nel questionario, e sono quindi ovviamente soggetti a distorsioni percettive che possono essere anche abbastanza ampie.. In particolare, il confronto tra le distanze percepite e una stima di quelle effettivamente percorse, effettuata per un sottocampione di 100 automobilisti ai fini della stima delle emissioni, tende mettere in evidenza una particolare tendenza alla sottostima della distanza percorsa tra coloro che effettuano i tragitti più brevi. Per questo motivo si fa riferimento al rapporto tra la distanza e la durata dello spostamento dichiarate con l’espressione “ Velocità percepita dello spostamento casa-lavoro”.
110
Grafico 12 Distribuzione del valore mediano della distanza percorsa nello spostamento casa-lavoro (in chilometri) per mezzo principale / combinazione di mezzi utilizzati nello spostamento casa-lavoro (n=330)
Dividendo il valore della distanza per quello della durata, è possibile ottenere una stima della velocità percepita per tipo di mezzo di trasporto (Grafico 13). E’ in questo modo possibile constatare che le velocità mediane sono tutte piuttosto ridotte: sempre inferiori ai 35 km/h tranne per la combinazione multimodale bicicletta/mezzi pubblici, che corrisponde però a un numero di casi troppo ridotto per generare un dato affidabile. Il 50% degli spostamenti effettuati in auto (come conducente) corrisponde a velocità percepite inferiori o uguali a 24 km/h (da porta a porta): un valore ridotto ma che comunque le concede un vantaggio competitivo rispetto ai mezzi pubblici, per i quali il valore mediano corrisponde a 17km/h. In questo contesto, le velocità più elevate risultano essere quelle corrispondenti ai veicoli motorizzati a due ruote (32 km/h), anche se anche in questo caso il dato va considerato con cautela, considerato il ridotto numero di rispondenti che si recano al lavoro con la motocicletta o con lo scooter. Grafico 13 Distribuzione del valore mediano della velocità percepita dello spostamento casa-lavoro (in km/h) per mezzo principale / combinazione di mezzi utilizzati nello spostamento casa-lavoro (n=296)
111
La Tabella 12 mette in evidenza come coloro che cambiano mezzo durante il periodo estivo debbano in genere percorrere tragitti più brevi, sia in termini di distanza sia di tempo, rispetto a coloro che utilizzano lo stesso mezzo sia nel periodo estivo che nel resto dell’anno: il 50% degli spostamenti di chi cambia mezzo dura infatti 17,5 minuti o meno, corrispondenti a grossomodo 4 km come valore mediano della distanza percorsa. Il cambiamento estivo del mezzo sembra dunque essere una prerogativa di chi abita vicino alla sede di lavoro. Tabella 12 Valori mediani della durata e della distanza percorsa nello spostamento casa-lavoro per le risposte alla domanda “Nel periodo estivo, per recarsi al lavoro, utilizza gli stessi mezzi?” (n=330, durata; 300, distanza)
Durata spostamento casa-lavoro (in minuti)
Distanza complessiva percorsa (in km)
nello spostamento casa-lavoro
nNel periodo estivo, per recarsi al lavoro, utilizza gli stessi mezzi?
Sì 25 8
NO 17,5 4 Totale 25 8
Per quanto riguarda i soli spostamenti automobilistici, in tre quarti dei casi la vettura è occupata da una sola persona (Grafico 14); nel restante 25% dei casi, sono invece presenti una (18%) o, più raramente, altre persone in almeno un tratto dello spostamento casa-lavoro. Grafico 14 Distribuzione di frequenza percentuale per numero di altre persone presenti nella vettura in almeno un tratto dello spostamento casa-lavoro (n=243)
Il Grafico 15 riporta la frequenza degli spostamenti indiretti (ovvero con soste o fermate intermedie per svolgere attività varie) sul totale degli spostamenti sul tragitto casa-lavoro-casa, per ognuno degli enti partecipanti all’indagine. Fatto salvo il caso particolare di Pero, in cui il 38% degli spostamenti casa-lavoro risulta essere indiretto (dato che però va interpretato con cautela, dato il numero ridotto di rispondenti tra i dipendenti del Comune di Pero), in tutti gli spostamenti con soste sono più frequenti nel tragitto di ritorno, con una percentuale che si aggira attorno al 25%. Fa eccezione il caso di Garbagnate Milanese, in cui la quota di spostamenti indiretti risulta essere particolarmente ridotta rispetto agli altri casi. Particolarmente elevati invece i valori corrispondenti al comune di Bollate (29%).
112
Grafico 15 Distribuzione di frequenza percentuale degli spostamenti indiretti (con soste o fermate intermedie per svolgere attività varie) durante lo spostamento casa-lavoro e lo spostamento lavoro-casa per ente partecipante (n=342, spostamento casa-lavoro; 312, spostamento lavoro-casa)
Gli spostamenti indiretti risultano essere relativamente meno frequenti tra chi utilizza i modi della mobilità lenta (Grafico 16), e in particolare tra chi raggiunge la sede di lavoro a piedi. Tuttavia, fatta eccezione per il dato relativo a “Moto/Scooter” (da considerare con cautela per lo scarso numero di motociclisti nel campione), le percentuali risultano piuttosto simili tra i diversi mezzi. In particolare, la somiglianza dei valori degli automobilisti e di chi utilizza i mezzi pubblici risulta interessante, in quanto in contraddizione con l’ipotesi (diffusa in letteratura) che una delle principali motivazioni dell’uso dell’automobile sia legata alla maggiore flessibilità del mezzo e dunque alla possibilità di concatenare diversi spostamenti e attività in un unico tragitto.
113
Grafico 16 Distribuzione di frequenza percentuale degli spostamenti indiretti (con soste o fermate intermedie per svolgere attività varie) durante lo spostamento casa-lavoro e lo spostamento lavoro-casa per mezzo principale utilizzato nello spostamento casa-lavoro-casa (n=332, spostamento casa-lavoro; 301, spostamento lavoro-casa)
Conformemente alle attese, per contro, la quota di spostamenti indiretti risulta notevolmente più elevata tra le donne che tra gli uomini, anche se questo gap si evidenzia quasi esclusivamente nel tragitto di ritorno (Grafico 17). Quasi una donna su tre, infatti, effettua uno spostamento indiretto nel tragitto lavoro-casa, presumibilmente legato allo svolgimento di compiti familiari. Per quanto riguarda il parcheggio, in circa metà dei casi l’auto viene lasciata in un parcheggio libero all’interno dell’azienda ( Grafico 18), mentre la percentuale di dipendenti che fruiscono dei parcheggi di interscambio con i mezzi pubblici è del tutto residuale (1%), confermando l’impressione che la multimodalità sia estremamente poco diffusa nel campione. Il dato relativo all’intero campione, tuttavia, risulta poco significativo in sé in quanto le modalità di parcheggio prevalenti sono fortemente variabili a seconda dell’ente partecipante (Tabella 13), riflettendo con ogni probabilità la dotazione di infrastrutture esistenti presso le diverse sedi. In questo senso, mentre sembrano esistere parcheggi liberi all’interno dell’azienda per entrambe le aziende private, il parcheggio libero nei pressi dell’azienda è la forma di sosta prevalente nei comuni, fatta eccezione per Bollate, dove sembra esistere un parcheggio riservato all’interno dell’azienda.
114
Grafico 17 Distribuzione di frequenza percentuale degli spostamenti indiretti (con soste o fermate intermedie per svolgere attività varie) ) durante lo spostamento casa-lavoro e lo spostamento lavoro-casa per genere (n=344, spostamento casa-lavoro; 315, spostamento lavoro-casa)
Grafico 18 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte alla domanda “Normalmente dove parcheggia l’auto?” (n=232)
115
Tabella 13 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte alla domanda “Normalmente dove parcheggia l’auto?” per ente partecipante (n=232)
Normalmente dove parcheggia l'auto?
In un parcheggio
libero all'interno
dell'azienda
In un parcheggio riservato
all'interno dell'azienda
In un parcheggio libero nei
pressi dell'azienda
In un parcheggio
di interscambio
Totale
Arese 0% 0% 97% 3% 100% Bollate comune
28% 69% 3% 0% 100%
Garbagnate Milanese
17% 11% 71% 0% 100%
Lainate 80% 20% 0% 0% 100% Pero 9% 0% 91% 0% 100% CSI 80% 20% 0% 0% 100%
Azienda
Solvay Solexis
82% 15% 0% 2% 100%
Totale 48% 21% 30% 1% 100%
9.5 - Percezioni ed atteggiamenti in tema di mobilità Il Grafico 19 rappresenta la sintesi di due domande simili, poste con formulazione parzialmente diversa a due diversi sotto-campioni. A chi ha utilizzato l’auto o il motociclo in almeno un tratto dello spostamento casa-lavoro è stato chiesto di indicare le difficoltà normalmente incontrate nel tragitto con quel mezzo, scegliendo una o più risposte (domanda a risposta multipla) tra quelle proposte. A coloro che invece non hanno utilizzato l’auto né il motociclo in nessuno dei tratti dello spostamento casa-lavoro è stato chiesto di indicare quali difficoltà ritenevano che avrebbero incontrato se avessero dovuto recarsi al lavoro con l’auto. Il raffronto delle due serie di risposte può essere interpretato nel modo seguente: da un lato le difficoltà effettivamente esperite dagli utenti dell’auto (e del motociclo), dall’altro quelle percepite dai non utenti, che possono essere pertanto considerate come i fattori scoraggianti dall’uso dell’automobile. E’ interessante innanzitutto notare che per quasi un terzo di automobilisti e motociclisti, lo spostamento casa-lavoro con il mezzo di riferimento non presenta alcuna difficoltà di rilievo; una percentuale di poco inferiore di non utenti (circa un quarto del sottocampione) ritiene analogamente che non incontrerebbe nessuna difficoltà se dovesse recarsi al lavoro in auto. Il problema di gran lunga più rilevante per entrambi i gruppi è il traffico, che viene citato in misura leggermente maggiore da automobilisti e motociclisti. In secondo luogo, il costo del carburante viene identificato come problematico da circa un quarto degli utenti, e da una percentuale relativamente più elevata (31%) di non utenti: in questo senso, si può ipotizzare che il costo del carburante sia un importante fattore scoraggiante rispetto all’uso dell’automobile. Lo stesso sembra poter essere affermato per l’inquinamento, citato dal 22% dei non utenti ma solo dal 13% di
116
automobilisti e motociclisti, e per “difficoltà/costo del parcheggio”, piuttosto rilevante come fattore scoraggiante ma poco citato dagli utenti. La situazione sembra presentarsi in maniera inversa per quanto riguarda il pericolo di incidenti e (soprattutto) le condizioni atmosferiche, entrambi segnalati in misura maggiore dagli utenti. Grafico 19 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte alle domande “Normalmente, con l'auto / motociclo, quali sono le difficoltà che incontra nello spostamento casa lavoro?” (rivolta agli utenti di auto e motociclo nello spostamento casa-lavoro) e “Se dovesse utilizzare l’auto per lo spostamento verso la sede di lavoro, quali delle seguenti difficoltà pensa che incontrerebbe?” (rivolta agli altri), risposta multipla (n=243 utenti, 86 altri)
Il Grafico 20 presenta lo stesso tipo di analisi per i mezzi di trasporto pubblico. In questo caso gli scostamenti tra utenti e non utenti sono più accentuati, e aprono interessanti spazi all’interpretazione. Innanzitutto, anche in questo caso sono gli utenti ad aver scelto in misura maggiore rispetto ai non utenti la risposta “nessuna difficoltà”, anche se su un livello più ridotto (23%) rispetto a quello degli automobilisti. Le principali difficoltà dichiarate dagli utenti sono peraltro, nell’ordine, i ritardi e la scarsa puntualità dei mezzi (più del 50% di risposte), l’affollamento e il viaggio troppo lungo. I principali fattori scoraggianti (ovvero dichiarati come difficoltà in misura notevolmente maggiore da chi non usa il trasporto pubblico) sono invece gli orari e le frequenze inadeguate, le scarse coincidenze e i troppi cambi, il viaggio troppo lungo, i ritardi e la scarsa puntualità e la difficoltà di raggiungimento della fermata/stazione di trasporto pubblico; quest’ultimo è peraltro il fattore per il quale lo scarto tra le risposte di utenti e non utenti è maggiore, un risultato probabilmente legato al fatto che una buona accessibilità del TPL da casa costituisce una conditio sine qua non per l’utilizzo dei mezzi pubblici. Grafico 20 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte alle domande “Normalmente, con i mezzi pubblici, quali sono le difficoltà che incontra nello spostamento casa lavoro?” (rivolta agli utenti dei mezzi pubblici nello spostamento casa-lavoro) e “Se dovesse utilizzare il
117
trasporto pubblico per lo spostamento verso la sede di lavoro, quali delle seguenti difficoltà pensa che incontrerebbe?” (rivolta agli altri), risposta multipla (n=35 utenti, 283 non utenti)
In Grafico 21 viene presentato l’analogo confronto per quanto riguarda le difficoltà nel raggiungere il luogo di lavoro in bicicletta. In questo caso – a parte il 26% di quanti dichiarano di non incontrare “nessuna difficoltà” – i principali ostacoli incontrati dai ciclisti sono la mancanza di piste ciclabili (più di metà del campione), le condizioni atmosferiche, il pericolo di incidenti e quello di furti. Anche la mancanza di rastrelliere e spazi riparati per il parcheggio viene segnalata dal 19% dei ciclisti.
118
I principali fattori scoraggianti dall’utilizzo della bicicletta sono invece innanzitutto l’eccessiva lunghezza del viaggio (segnalata da quasi metà dei non utenti ma da nessuno dei ciclisti), che sembra quindi essere il principale fattore di ostacolo alla mobilità ciclistica, la mancanza di piste ciclabili (segnalata da metà dei non utenti, anche se in misura inferiore rispetto agli utenti), il pericolo di incidenti e le condizioni atmosferiche. Anche i livelli di inquinamento sembrano essere un fattore particolarmente scoraggiante, in quanto vengono segnalati dal 23% dei non utenti e solo dal 6% dei ciclisti; analogamente per la mancanza di un servizio di trasporto della bici sui mezzi pubblici (segnalato dal 10% dei non utenti) che si pone quindi come possibile fattore esplicativo di quella scarsissima diffusione delle combinazioni multimodali che si è riscontrata nel commento ai dati precedenti Grafico 21 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte alle domande “Normalmente, con la bicicletta, quali sono le difficoltà che incontra nello spostamento casa lavoro?” (rivolta agli utenti della bicicletta nello spostamento casa-lavoro) e “Se dovesse utilizzare la bicicletta per lo spostamento verso la sede di lavoro, quali delle seguenti difficoltà pensa che incontrerebbe?” (rivolta agli altri), risposta multipla (n=27 utenti, 307 non utenti)
Complessivamente, la soddisfazione media degli utenti per lo spostamento casa-lavoro (Grafico 22) si aggira poco sopra alla sufficienza (6,4), e varia leggermente tra i dipendenti dei diversi enti partecipanti: raggiunge infatti il suo massimo tra i dipendenti del Comune di Garbagnate Milanese (7,4) mentre ha valori minimi tra i dipendenti di Pero e dell’azienda privata Solvay Solexis.
119
Grafico 22 Distribuzione del valore medio delle risposte alla domanda “Quanto è soddisfatto/a complessivamente da 1 a 10 dello spostamento casa-lavoro?” per ente partecipante (n=337)
Più variabilità si riscontra esaminando i valori medi della soddisfazione per mezzo utilizzato (Grafico 23): essi raggiungono il loro massimo per gli spostamenti a piedi e con le due ruote (motorizzate o meno), mentre hanno valori minimi, appena sufficienti, per automobile e mezzi pubblici Grafico 23 Distribuzione del valore medio delle risposte alla domanda “Quanto è soddisfatto/a complessivamente da 1 a 10 dello spostamento casa-lavoro?” per mezzo principale utilizzato nello spostamento casa-lavoro (n=332)
Complessivamente, la soddisfazione sembra essere anche correlata con la distanza dell’abitazione dal luogo di lavoro, e quindi con la distanza da percorrere per raggiungerlo: come mostra il Grafico 24, infatti, coloro che abitano nello stesso comune in cui lavorano esprimono punteggi
120
considerevolmente più alti di coloro che risiedono in un comune non partecipante all’indagine, per i quali il valore medio scende addirittura al di sotto della sufficienza. Grafico 24 Valore medio delle risposte alla domanda “Quanto è soddisfatto/a complessivamente da 1 a 10 dello spostamento casa-lavoro?” per tipo di comune di domicilio (n=323)
Il Grafico 25 rappresenta graficamente le risposte ad una domanda sintetica, posta soltanto a chi utilizza auto o motociclo come unico mezzo di spostamento per raggiungere il lavoro e volta ad identificare il motivo più grave per il mancato utilizzo del trasporto pubblico. Come si può vedere, le ragioni di tipo strutturale, legate cioè a carenze delle infrastrutture e del servizio (la frequenza dei mezzi, il numero di cambi necessari e, soprattutto, l’assenza di mezzi di trasporto adeguati) sembrano considerevolmente più importanti di ragioni legate a questioni economiche o percettive (costo e qualità del trasporto pubblico). Grafico 25 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte alla domanda “Quale dei seguenti elementi è il motivo più grave per cui non utilizza il mezzo pubblico nello spostamento casa-lavoro?” (domanda posta solo a chi utilizza l’auto o il motociclo per lo spostamento casa-lavoro) (n=229)
121
L’esame della distribuzione delle risposte a quest’ultima domanda per ente partecipante (Tabella 14) mette in evidenza alcune differenze rilevanti: l’assenza di mezzi di trasporto pubblico adeguati viene segnalata infatti da quasi tre quarti degli automobilisti e motociclisti di Arese, mentre il numero di cambi risulta relativamente più importante nelle due aziende private coinvolte. D’altra parte il costo dell’utilizzo dei mezzi, pur se secondario come fattore scoraggiante, risulta relativamente più importante nelle aziende private, mentre le questioni riguardanti l’accessibilità delle stazioni sembrano essere pertinenti più a Bollate e (soprattutto) a Garbagnate Milanese. Tabella 14 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte alla domanda “Quale dei seguenti elementi è il motivo più grave per cui non utilizza il mezzo pubblico nello spostamento casa-lavoro?” (domanda posta solo a chi utilizza l’auto o il motociclo per lo spostamento casa-lavoro) per ente partecipante (n=227)
“Quale dei seguenti elementi è il motivo più grave per cui non utilizza il mezzo pubblico nello spostamento casa-lavoro?”
Accessibilità alle
stazioni/fermate (ad es.:
mancanza o costo dei
parcheggi in prossimità delle
stazioni)
Costo Frequenza Qualità Numero
di cambi
Non esistono mezzi di trasporto pubblico adeguati
Totale
Arese 0% 3% 14% 3% 8% 72% 100%Bollate comune 12% 3% 21% 12% 18% 35% 100%
Garbagnate Milanese 19% 3% 17% 8% 14% 39% 100%
Lainate 0% 0% 60% 20% 0% 20% 100%Pero 0% 10% 30% 20% 0% 40% 100%CSI 8% 8% 16% 4% 28% 36% 100%
Azienda
Solvay Solexis 10% 7% 10% 9% 31% 33% 100%
Totale 9% 5% 16% 8% 20% 41% 100% Il Grafico 26 rappresenta la distribuzione delle risposte alla domanda “Quali delle seguenti innovazioni in tema di mobilità valuta come utili?”, per la quale era prevista la possibilità di risposta multipla. Le opzioni scelte con più frequenza sono quelle legate a possibili miglioramenti tecnologici che rendano l’utilizzo dell’automobile meno inquinante come la diffusione di nuovi carburanti e forme di alimentazione (GPL/Metano e elettricità). Seguono le misure volte a rendere più economico l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, mentre solo circa un quinto del campione mostra interesse per, rispettivamente, car sharing, car pooling e bike sharing. La distribuzione delle risposte per ente partecipante (Tabella 15) mostra alcune variazioni interessanti nell’interesse per le varie proposte elencate. Le “soluzioni tecnologiche” risultano relativamente più apprezzate nel Comune di Pero e nelle aziende private (con l’eccezione del giudizio dei dipendenti della CSI per l’introduzione dell’auto elettrica). Le opzioni riguardanti il trasporto pubblico raccolgono più consensi a Bollate, Pero, Solvay Solexis e (in parte) Garbagnate
122
Milanese. Esprime interesse per il Car Pooling circa un terzo dei dipendenti delle due aziende private coinvolte, mentre solo l’11% dei dipendenti della Solvay Solexis si pronuncia a favore del bike sharing (il valore più basso tra tutti gli enti partecipanti). Il car sharing invece raccoglie i maggiori consensi nel Comune di Bollate e presso la Solvay Solexis. In generale comunque in ognuno degli enti partecipanti (tranne Lainate) la diffusione dell’auto elettrica o del GPL/Metano risulta l’innovazione più apprezzata. Grafico 26 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte alla domanda “Quali delle seguenti innovazioni in tema di mobilità valuta come utili?”, domanda a risposta multipla ( n=295)
Tabella 15 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte alla domanda “Quali delle seguenti innovazioni in tema di mobilità valuta come utili?” (domanda a risposta multipla) per ente partecipante (n=292)
“Quali delle seguenti innovazioni in tema di mobilità valuta come utili?”
Car sharing
Car pooling
Bike sharing
Integrazione tariffaria
per il trasporto pubblico
Diffusione auto
GPL/metano
Diffusione auto
elettrica
Attivazdi
convenzcon ser
di traspopubbl
Arese 13% 8% 19% 13% 35% 32% 30%Bollate comune 23% 14% 21,4% 25% 30% 50% 43%
Garbagnate Milanese 10% 10% 21% 17% 29% 45% 36%
Lainate 43% 29% 29% 0% 14% 14% 0%Pero 20% 0% 13% 40% 40% 53% 47%CSI 20% 28% 24% 16% 44% 24% 20%
Azienda
Solvay Solexis 29% 31% 12% 29% 38% 42% 32%
E’ interessante notare come la parte maschile del campione risulti sistematicamente più interessata alle proposte di innovazione della mobilità proposte (Grafico 27), fatta eccezione per la categoria di
123
risposta “attivazione di convenzioni con servizi di trasporto pubblico”, che raccoglie il consenso del 38% delle donne e di solo il 28% degli uomini. Grafico 27 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte alla domanda “Quali delle seguenti innovazioni in tema di mobilità valuta come utili?” (domanda a risposta multipla) per genere (n=294)
Per quanto riguarda la distribuzione delle risposte in relazione all’età (Tabella 16), fatta eccezione per le persone con meno di 24 anni (che non sono sufficientemente numerose per consentire un’interpretazione affidabile dei dati), si riscontra un maggiore interesse per le iniziative riguardanti il trasporto pubblico al crescere dell’età, mentre una tendenza contraria sembra delinearsi per le proposte di innovazione tecnologica dell’auto. Analogamente, bike sharing, car pooling e car sharing non sembrano essere di particolare interesse per le fasce di età più anziane. Tabella 16 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte alla domanda “Quali delle seguenti innovazioni in tema di mobilità valuta come utili?” (domanda a risposta multipla) per fascia d’età (risposta multipla, n=293)
“Quali delle seguenti innovazioni in tema di mobilità valuta come utili?”
Car sharing
Car pooling
Bike sharing
Integrazione tariffaria
per il trasporto pubblico
Diffusione auto
GPL/metano
Diffusione auto
elettrica
Attivazione di
convenzioni con servizi
di trasporto pubblico
18-24 0% 0% 0% 0% 67% 67% 33% 25-34 28% 35% 21% 19% 33% 44% 33% 35-49 24% 19% 22% 23% 37% 42% 31%
Fascia d'età
50-64 10% 8% 5% 26% 31% 38% 39% L’apprezzamento per le diverse innovazioni proposte sembra variare notevolmente anche tra le diverse categorie di livello di istruzione, come illustrato in Tabella 17. Le due iniziative che prevedono una soluzione tecnologica all’impatto inquinante delle automobili hanno andamenti
124
speculari rispetto al livello di scolarizzazione: mentre la diffusione di GPL e metano è più apprezzata tra i laureati (42%), la diffusione dell’auto elettrica è molto più popolare tra i meno istruiti (58%). Le proposte legate al trasporto pubblico sono tendenzialmente più apprezzate da chi ha un titolo di studio basso, anche se l’integrazione tariffaria riscuote il maggiore successo tra i laureati (28%). Car sharing e car pooling sono scarsissimamente apprezzate dai meno istruiti (che forse non conoscono con precisione le iniziative in questione), mentre il bike sharing è ugualmente popolare tra tutte le fasce di livello di istruzione. Ad ogni modo, in ognuna delle tre categorie la soluzione preferita ai problemi della mobilità è l’innovazione tecnologica dell’auto, mentre le varie forme di de-privatizzazione dei mezzi di trasporto (car sharing, car pooling e bike sharing) risultano sistematicamente le meno apprezzate. Tabella 17 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte alla domanda “Quali delle seguenti innovazioni in tema di mobilità valuta come utili?” (domanda a risposta multipla) per titolo di studio (n=292)
“Quali delle seguenti innovazioni in tema di mobilità valuta come utili?”
Car sharing
Car pooling
Bike sharing
Integrazione tariffaria
per il trasporto pubblico
Diffusione auto
GPL/metano
Diffusione auto
elettrica
Attivazione di
convenzioni con servizi
di trasporto pubblico
Scuola dell'obbligo 0% 3% 19% 26% 29% 58% 39% Diploma di scuola
media superiore/maturità
19% 16% 17% 16% 31% 42% 33%
Laurea 28% 25% 18% 28% 42% 37% 32% Il Grafico 28 rappresenta le risposte alla domanda a risposta multipla “Quali delle seguenti scelte potrebbe fare nei prossimi anni?”. Anche in questo caso è una soluzione tecnologica a prevalere – l’acquisto di un auto a GPL/metano (38%) – che a quanto pare viene ritenuta una possibilità più concreta dell’acquisto di un’auto elettrica (scelta solo dal 21% dei rispondenti a fronte del 42% che la ritiene un’ “innovazione utile”). Un maggiore utilizzo della bicicletta viene previsto da più di un terzo dei rispondenti, mentre una percentuale inferiore (22%) pensa di utilizzare di più i mezzi pubblici. Infine, soltanto un intervistato su dieci si dichiara intenzionato a “non usare più l’auto”.
125
Grafico 28 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte alla domanda “Quali delle seguenti scelte potrebbe fare nei prossimi anni?” (domanda a risposta multipla, n=292)
L’esame della distribuzione per sede di lavoro delle risposte alla domanda sulle intenzioni mette in evidenza che la volontà di incrementare l’utilizzo della bicicletta è più marcata in quei comuni (Bollate e Garbagnate Milanese) dove la bicicletta assorbe già oggi una quota consistente di spostamenti casa-lavoro. In particolare, i dipendenti del Comune di Bollate sembrano essere quelli meglio predisposti verso i mezzi alternativi all’automobile, in quanto il 29% di loro esprime anche l’intenzione di “usare di più i mezzi pubblici” nei prossimi anni, una percentuale nettamente maggiore di quella riscontrata negli altri enti partecipanti, anche se circa un quarto dei dipendenti di entrambe le aziende private esprime la stessa intenzione. Tuttavia, in tutti gli enti partecipanti tranne Bollate e Garbagnate Milanese l’intenzione più citata è quella di acquistare un auto con caratteristiche di alimentazione meno inquinanti (gas o elettricità): in particolare, il GPL risulta molto popolare tra i dipendenti delle aziende private e del Comune di Arese, mentre l’auto elettrica riscuote il consenso della maggioranza relativa di coloro che lavorano presso il Comune di Pero.
126
Tabella 18 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte alla domanda “Quali delle seguenti scelte potrebbe fare nei prossimi anni?” per ente partecipante (domanda a risposta multipla, n=290)
Esaminando la distribuzione delle risposte alla medesima domanda per fascia d’età (Tabella 19), si possono notare due tendenze principali: da un lato, la volontà di usare maggiormente mezzi alternativi all’automobile (bicicletta e mezzi pubblici) sembra relativamente più diffusa tra le generazioni di lavoratori più anziani; dall’altro, tutte le modalità di risposta che prevedono l’acquisto di un’auto (tranne quella relativa alle micro-auto) riscuotono maggiore successo presso le fasce di età più giovani. Per interpretare correttamente questo dato è necessario ricordare che i dipendenti delle aziende private sono allo stesso tempo mediamente più giovani e più propensi all’utilizzo dell’auto, mentre coloro che lavorano presso le aziende comunali sono più anziani e allo stesso tempo utilizzano in misura maggiore i mezzi alternativi all’auto. Tabella 19 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte alla domanda “Quali delle seguenti scelte potrebbe fare nei prossimi anni?” per fascia d’età (domanda a risposta multipla, n=290)
“Quali delle seguenti scelte potrebbe fare nei prossimi anni?”
Acquistare un SUV
Acquistare una
micro-auto (tipo
Smart)
Acquistare un'auto a
GPL/metano
Acquistare un'auto elettrica
Non usare più
l'auto
Usare di più i mezzi
pubblici
Usare di più la
bicicletta
18-24 33% 0% 33% 0% 0% 33% 0% 25-34 7% 2% 46% 25% 9% 23% 29% 35-49 4% 3% 37% 25% 9% 18% 37%
Fascia d'età
50-64 0% 5% 33% 11% 10% 28% 40% In relazione al titolo di studio (Tabella 20), si può osservare che i laureati mostrano intenzioni più accentuate di acquistare una nuova auto, mentre i meno istruiti (coloro che arrivano fino alla scuola
“Quali delle seguenti scelte potrebbe fare nei prossimi anni?”
Acquistare un SUV
Acquistare una
micro-auto (tipo
Smart)
Acquistare un'auto a
GPL/metano
Acquistare un'auto elettrica
Non usare più
l'auto
Usare di più i mezzi
pubblici
Usare di più la
bicicletta
Arese 0% 5% 42% 18% 16% 8% 32% Bollate comune 3% 2% 26% 18% 8% 29% 52%
Garbagnate Milanese 4% 4% 25% 16% 12% 19% 54%
Lainate 0% 0% 43% 29% 0% 14% 14% Pero 6% 0% 31% 44% 13% 19% 19% CSI 0% 4% 46% 21% 25% 25% 33%
Solvay Solexis 7% 2% 51% 22% 2% 24% 22%
127
dell’obbligo) sono più propensi ad immaginare di utilizzare di più i mezzi alternativi, ma anche di acquistare una micro-auto (tipo Smart). Tabella 20 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte alla domanda “Quali delle seguenti scelte potrebbe fare nei prossimi anni?” per titolo di studio (domanda a risposta multipla, n=289)
“Quali delle seguenti scelte potrebbe fare nei prossimi anni?”
Acquistare un SUV
Acquistare una
micro-auto (tipo
Smart)
Acquistare un'auto a
GPL/metano
Acquistare un'auto elettrica
Non usare più
l'auto
Usare di più i mezzi
pubblici
Usare di più la
bicicletta
Scuola dell'obbligo 3% 10% 16% 16% 10% 26% 42% Diploma di scuola
media superiore/maturità
3% 4% 36% 17% 10% 21% 40%
Laurea 5% 0% 45% 26% 9% 22% 31% 9.6 - Orari e spostamenti in orario di lavoro Il tipo di orario di lavoro dei dipendenti è una variabile importante per spiegare i comportamenti di mobilità dei dipendenti, e per questo motivo i dati relativi agli orari vengono brevemente sintetizzati in questa sezione. Nell’insieme del campione (Grafico 29), la forma di orario prevalente è di gran lunga lo “spezzato con intervallo” (quasi il 60% dei casi), seguito da circa un quarto di casi di “orario continuato” e da percentuali residuali per le altre modalità. La situazione è tuttavia fortemente variabile a seconda dell’ente in questione (Tabella 21): infatti, mentre l’orario spezzato con intervallo sembra essere particolarmente predominante nei comuni di Arese e Garbagnate Milanese, l’orario continuato è più diffuso nel comune di Pero, oltre che nelle due aziende private. Il part time orizzontale costituisce una realtà degna di nota solo nei comuni di Pero e Bollate (dove circa un quinto dei dipendenti ha questa forma contrattuale), mentre il part time verticale sembra esistere soltanto tra i dipendenti della CSI.
128
Grafico 29 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte per tipo di orario di lavoro (n=358)
Tabella 21 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte per tipo di orario di lavoro e per ente partecipante (n=354)
Tipo di orario di lavoro Spezzato
con intervallo
ContinuatoPart time
verticale
Part time orizzontale
Con turni
Gestito autonomamente
Tota
Arese 67% 14% 0% 5% 14% 0% 100Bollate 55% 16% 0% 20% 8% 1% 100
Garbagnate Milanese 70% 9% 0% 8% 12% 1% 100
Lainate 14% 0% 0% 0% 86% 0% 100Pero 29% 35% 0% 18% 12% 6% 100CSI 59% 33% 4% 4% 0% 0% 100
Azienda
Solvay Solexis 59% 41% 0% 0% 0% 0% 100
Totale 59% 24% 0% 8% 8% 1% 100 Esaminando la distribuzione per genere (Tabella 22) si scopre che il part time orizzontale riguarda principalmente la quota femminile del campione, mentre orario continuato e a turnazione sembrano essere relativamente più frequenti tra i maschi. Analogamente, per quanto riguarda il titolo di studio (Tabella 23) si osserva come l’orario continuato sia relativamente più diffuso tra i dipendenti più istruiti (concentrati a loro volta prevalentemente nelle aziende private), mentre i tipi del part-time orizzontale e – in misura minore – dell’orario con turni sembrano essere una prerogativa dei lavoratori con meno qualifiche in termini di istruzione formale. Tabella 22 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte per tipo di orario di lavoro e per genere (n=357)
Tipo di orario di lavoro Totale
129
Spezzato con
intervallo Continuato
Part time
verticale
Part time orizzontale
Con turni
Gestito autonomamente
Maschio 58% 29% 1% 1% 10% 1% 100% Sesso Femmina 59% 21% 0% 12% 7% 0% 100%
Totale 59% 24% 0% 8% 8% 1% 100% Tabella 23 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte per tipo di orario di lavoro e per titolo di studio (n=355)
Tipo di orario di lavoro Spezzato
con intervallo
ContinuatoPart time
verticale
Part time orizzontale
Con turni
Gestito autonomamente
Total
Scuola dell'obbligo 59% 12% 0% 18% 12% 0% 100%
Diploma 60% 18% 0% 8% 13% 1% 100%
Qual è il suo titolo
di studio? Laurea 57% 34% 1% 5% 2% 1% 100%
Totale 59% 24% 0% 8% 8% 1% 100% Nel complesso del campione, circa un terzo dei dipendenti dichiara di spostarsi dalla sede di lavoro durante la pausa pranzo (Grafico 30). Questa quota risulta più ridotta tra chi lavora nelle aziende private (solo l’1% nella Solvay Solexis), mentre è tendenzialmente più elevata tra i dipendenti dei Comuni, in particolare ad Arese e Garbagnate Milanese (dove più del 50% dei lavoratori effettua questo spostamento). La destinazione è nella metà dei casi l’abitazione (Grafico 31) e in secondo luogo una mensa esterna. Piuttosto residuale la quota di quanti si recano presso bar, ristoranti o centri commerciali all’esterno della sede di lavoro. In particolare il ritorno a casa è particolarmente diffuso nel Comune di Garbagnate Milanese, dove ben 21 rispondenti sui 38 che si spostano tornano presso la propria abitazione (Tabella 24).
130
Grafico 30 Distribuzione di frequenza percentuale dei dipendenti che si spostano dalla sede di lavoro durante la pausa pranzo per ente partecipante (n=330)
Grafico 31 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte alla domanda “Normalmente durante la pausa pranzo si reca..” (domanda posta solo a chi si sposta dalla sede di lavoro durante la pausa) (n=89)
Tabella 24 Distribuzione di frequenza assoluta delle risposte alla domanda “Normalmente durante la pausa pranzo si reca..” (domanda posta solo a chi si sposta dalla sede di lavoro durante la pausa) per ente partecipante (n=89)
Normalmente durante la pausa pranzo si reca:
A casa Alla mensa
In un bar / ristorante
esterno
In un centro
commerciale
Totale
Arese 9 9 1 1 20 Bollate comune 9 9 2 0 20
Azienda
Garbagnate 21 9 6 2 38
131
Milanese Lainate 0 1 0 0 1
Pero 2 3 0 0 5 CSI 2 2 0 0 4
Solvay Solexis 1 0 0 0 1 Totale 44 33 9 3 89
9.7 - Mezzi e consumi per la mobilità Il Grafico 32 rappresenta la spesa media specifica mensile per carburante calcolata tra coloro che spendono una parte del loro denaro a questo scopo (i casi che non dichiaravano spesa o dichiaravano spesa pari a 0 euro sono stati esclusi dall’elaborazione). Si può notare come il livello di spesa più elevato si riscontri tra i dipendenti della Solvey Solexis, seguiti ad una certa distanza da quelli del Comune di Pero, della CSI e del Comune di Garbagnate Milanese. Si pongono su livelli più ridotti invece le spese per il carburante tra i dipendenti dei comuni di Arese e Bollate. Grafico 32 Distribuzione della spesa media specifica mensile per carburante (in euro), per ente partecipante (n=214)
Solo il 14% del campione dichiara di possedere un abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico (Grafico 33). Tale percentuale è più elevata tra i dipendenti di Bollate, Pero e Solvay Solexis, mentre è sotto la media presso CSI, Comune di Arese e Comune di Garbagnate Milanese. Inoltre, quasi un uomo su cinque risulta possedere un abbonamento, contro poco più del 10% delle donne (Grafico 34). Analogamente, la fascia di età 25-34 sembra abbonarsi al trasporto pubblico in misura minore rispetto a quelle più anziane, e in particolare rispetto alla fascia 35-49 (Grafico 35).
132
Grafico 33 Distribuzione di frequenza percentuale dei dipendenti in possesso di un abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico per ente partecipante (n=329)
Grafico 34 Distribuzione di frequenza percentuale dei dipendenti in possesso di un abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico per genere (n=332)
133
Grafico 35 Distribuzione di frequenza percentuale dei dipendenti in possesso di un abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico per fascia d’età (n=328)
Il gruppo di coloro che possiedono un abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico è, come appare chiaramente in Tabella 25, più ampio di quello degli effettivi utenti dei trasporti pubblici. Ben il 13% degli abbonati si reca infatti al lavoro con l’auto, mentre il 16% sceglie i modi della mobilità lenta. Questo dato fa pensare che i rispondenti utilizzino i mezzi pubblici più spesso per spostamenti diversi da quello pendolare. Per contro, soltanto l’1% dei non abbonati risulta utilizzare i mezzi pubblici. Tabella 25 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte alla domanda “Possiede un abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico?” per mezzo principale utilizzato nello spostamento casa-lavoro (n=322)
Mezzo principale utilizzato nello spostamento casa-lavoro
Piedi Bicicletta Moto / Scooter Auto Mezzi
pubblici
Totale
Sì 9% 7% 0% 13% 72% 100% Possesso abbonamento NO 8% 8% 1% 82% 1% 100%
Totale 8% 8% 1% 72% 11% 100% Il Grafico 36 rappresenta il numero di auto a disposizione del nucleo familiare dei rispondenti. Più di metà delle famiglie risulta possedere due auto, mentre il 39% ne possiede solo una. Soltanto il 3% dei rispondenti vive in famiglie sprovviste di auto.
134
Grafico 36 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte per numero di auto a disposizione del nucleo familiare (n=334)
L’analisi della distribuzione di frequenza dei dipendenti per numero di auto a disposizione dei nuclei familiari e per ente partecipante (Tabella 26) mette in evidenza alcune differenze: Arese è allo stesso tempo il comune con la più alta percentuale di nuclei familiari senza auto (8%) e con un parco auto costituito da tre o più vetture (complessivamente 18%). A Garbagnate Milanese, per contro, la quasi totalità dei dipendenti possiede una o due auto. Tra i dipendenti del Comune di Pero nessuno possiede più di due auto, mentre neanche un dipendente della Solvey Solexis risulta sprovvisto di un autoveicolo. Tabella 26 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte per numero di auto a disposizione del nucleo familiare e per ente partecipante (n=330)
N° di auto a disposizione del nucleo familiare
0 1 2 3 4 Totale
Arese 8% 30% 45% 13% 5% 100% Bollate comune 4% 36% 51% 7% 1% 100%
Garbagnate Milanese 2% 48% 49% 1% 0% 100% Lainate 0% 43% 43% 14% 0% 100%
Pero 6% 44% 50% 0% 0% 100% CSI 4% 41% 48% 7% 0% 100%
Azienda
Solvay Solexis 0% 39% 60% 1% 0% 100% Totale 3% 39% 52% 5% 1% 100,0%
Il Grafico 37 presenta la distribuzione di un indice calcolato dividendo il numero di auto possedute dal nucleo familiare per il numero di componenti, per ente partecipante. Come si può notare, nelle famiglie dei dipendenti delle aziende private ci sono all’incirca tre auto ogni quattro componenti familiari (compresi i ovviamente i minori), un valore che scende fino a sotto 0,6 per la maggior parte dei comuni, escluso Arese dove il valore è in linea con la media totale del campione, che si situa all’incirca a due automobili per ogni tre componenti familiari.
135
Grafico 37 Distribuzione del valore medio del rapporto n° auto / n°componenti della famiglia per ente partecipante (n=327)
Il valore dell’indice è ancora più variabile a seconda dei tipi di famiglia (Grafico 38): tra i single esso raggiunge quasi un’auto per persona, mentre le coppie con figli tendono in media ad avere circa un auto ogni due componenti familiari. Le coppie senza figli, per contro, presentano valori molto elevati dell’indice, quasi prossimi alla saturazione. Grafico 38 Distribuzione del valore medio del rapporto n° auto / n° componenti della famiglia per composizione del nucleo familiare (n=330)
La Tabella 27 permette di osservare la composizione del parco auto di coloro che raggiungono la sede di lavoro con l’automobile, in termini di tipo di motore, per i diversi enti partecipanti. Questo dato è importante perché a tipi diversi di alimentazione delle automobili corrispondono emissioni di gas inquinanti diverse. Da questo punto di vista, si può notare come le vetture con carburanti alternativi (GPL, metano, ibrido) siano più diffuse nelle aziende private e tra i dipendenti del Comune di Pero, mentre rappresentano soltanto circa il 10% delle vetture tra i dipendenti dei comuni di Bollate e Garbagnate Milanese. La quota di veicoli alimentati a Diesel (con o senza filtro
136
antiparticolato) è particolarmente elevata presso le due aziende private (rispettivamente 35% e 46%), mentre è più ridotta nei comuni di Bollate e Garbagnate Milanese. Tabella 27 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte per tipo di motore dell’auto utilizzata per lo spostamento casa-lavoro e per ente partecipante (n=222)
Tipo di motore dell’auto
Benzina Diesel
Carburanti alternativi (GPL, Metano, Ibrido,
Elettrico)
Totale
Arese 55% 29% 16% 100% Bollate comune 59% 30% 11% 100%
Garbagnate Milanese 67% 24% 9% 100%
Lainate 60% 20% 20% 100% Pero 80% 0% 20% 100% CSI 43% 35% 22% 100%
Azienda
Solvay Solexis 37% 46% 17% 100%
Totale 51% 34% 15% 100% L’età media dei veicoli utilizzati da coloro che si recano al lavoro in automobile è rappresentata nel Grafico 39, che ne rappresenta la variazione tra i dipendenti delle diverse sedi. Come si può osservare, l’età media è più alta nei comuni di Bollate, Garbagnate Milanese e tra i dipendenti dell’azienda privata CSI, dove sfiora i sei anni. Per contro i valori risultano più bassi (sotto i cinque anni) tra i dipendenti della Solvay Solexis e dei comuni di Pero ed Arese. Grafico 39 Distribuzione del valore medio dell’età del veicolo (automobile o motociclo/scooter) utilizzato per lo spostamento casa-lavoro, per ente partecipante (n=227)
137
Analogamente alle variabili poc’anzi esaminate, anche la cilindrata dell’automobile è un fattore di rilevante importanza nel determinare l’entità delle emissioni inquinanti. Grazie ai dati riportati in Tabella 28, è possibile osservare come le vetture con cilindrata oltre 2000cc siano diffuse soprattutto Tabella 28 tra i dipendenti delle due aziende private coinvolte, anche se nemmeno in questi due contesti la loro quota supera il 10% del totale. Allo stesso modo, le automobili di cilindrata media (tra i 1401 e i 2000cc) sono relativamente più diffuse tra i dipendenti della CSI (dove sono il 50% delle vetture), mentre rappresentano soltanto un quarto dei mezzi degli automobilisti che lavorano al Comune di Bollate, tra i quali peraltro ben quasi tre auto su quattro sono di piccola cilindrata (1400cc). Questa categoria di cilindrate presenta infine valori superiori alla media del campione a Garbagnate Milanese, Bollate ed Arese (oltre che nel Comune di Pero dove però il dato sembra anomalo ed attribuibile alla scarsa entità del campione). Tabella 28 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte per cilindrata dell’automobile utilizzata per lo spostamento casa-lavoro e per ente partecipante (n=219)
Cilindrata
Fino a 1400
cc
Da 1401 cc a 2000
cc
Oltre 2000
cc
Totale
Arese 55% 41% 3% 100% Bollate comune 72% 25% 3% 100%
Garbagnate Milanese 58% 39% 3% 100%
Lainate 60% 40% 0% 100% Pero 91% 9% 0% 100% CSI 41% 50% 9% 100%
Azienda
Solvay Solexis 45% 48% 7% 100%
Totale 55% 40% 5% 100% La Tabella 29 presenta la composizione del parco macchine tra i rispondenti automobilisti di ogni azienda, suddiviso nelle varie categorie Euro esistenti. Come si può notare, gli Euro 4 costituiscono da soli circa metà del totale del campione, con un restante quarto concentrato nella categoria degli Euro 3. Le variazioni tra i diversi enti partecipanti, tuttavia, sono degne di nota: la proporzione di Euro 4 è infatti più alta della media a Pero e tra i dipendenti della Solvey Solexis, mentre scende sotto la metà del campione nei comuni di Bollate e Garbagnate Milanese. In questi due comuni, cosi come nella CSI, si nota una quota consistente di auto Euro 2 e 3, che costituiscono più della metà del parco macchine.
138
Tabella 29 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte per veicolo (automobile o motociclo/scooter) utilizzato nello spostamento casa-lavoro e per ente partecipante (n=220)
Categoria Euro Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5
Totale
Arese 0% 7% 7% 29% 50% 7% 100% Bollate comune 0% 0% 31% 22% 44% 3% 100%
Garbagnate Milanese 0% 3% 16% 38% 38% 6% 100%
Lainate 0% 0% 20% 40% 20% 20% 100% Pero 9% 9% 0% 18% 64% 0% 100% CSI 0% 0% 23% 23% 50% 5% 100%
Azienda
Solvay Solexis 1% 2% 7% 22% 60% 7% 100%
Totale 1% 3% 14% 25% 51% 6% 100% Per quanto riguarda le due ruote motorizzate, va notato che la maggior parte dei nuclei familiari (tre quarti circa) risulta sprovvisto di motocicli e/o scooter, come può essere osservato nel Grafico 40. Grafico 40 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte per numero di motocicli / scooter a disposizione del nucleo familiare (n=334)
Le famiglie sprovviste di biciclette sono, come risulta dal Grafico 41, soltanto il 16% del campione. La diffusione delle biciclette sembra dunque essere molto più ampia di quanto lo sia l’utilizzo di questo mezzo per lo spostamento casa-lavoro, un dato che potrebbe sostenere l’ipotesi che la mobilità ciclistica in queste famiglie avvenga prevalentemente a fini ricreativi.
139
Grafico 41 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte per numero di biciclette a disposizione del nucleo familiare (n=334)
Si può osservare infine che soltanto l’1% del campione risulta sprovvisto di patente di guida (Grafico 42). Grafico 42 Distribuzione di frequenza percentuale delle risposte alla domanda “Possiede una patente di guida?” (n=334)
9.8 - Morfologia della mobilità – ipotesi di approfondimento Nel questionario è stata chiesta la disponibilità ad aderire ad una seconda fase dell’indagine – in corso di definizione - che prevede l’installazione di un navigatore satellitare sulla vettura di un piccolo campione di automobilisti. Gli aderenti risultano essere in totale 68 (Tabella 30), distribuiti in maniera molto disomogenea tra i diversi enti partecipanti.
140
Tabella 30 Distribuzione di frequenza assoluta degli aderenti alla fase successiva dell’indagine (GPS) per ente partecipante (n=68)
N° partecipanti
Arese 8
Bollate comune 7
Garbagnate Milanese 6
Lainate 4
Pero 3
CSI 7
Azienda
Solvay Solexis 33
Totale 68
9.8.1 - Profilo socio-territoriale delle emissioni inquinanti La metodologia utilizzata per la stima delle emissioni, illustrata in dettaglio nella sezione 4.2 del presente rapporto, fornisce come risultato un valore medio per chilometro, denominato fattore di emissione, che è rappresentativo della tipologia del veicolo, caratteristico del campione utilizzato per effettuare la stima e da considerarsi esclusivamente come valore medio. Pertanto, esso non permette a rigore di andare a stimare nel dettaglio la produzione di emissioni di un singolo percorso, né di generalizzare i risultati ad altre popolazioni con diverse caratteristiche. In questa sezione del rapporto tuttavia, verranno presentate alcune elaborazioni basate sul calcolo delle emissioni per ogni singolo percorso. Esse sono state ottenute moltiplicando il fattore emissione medio per chilometro del veicolo utilizzato per due (per tenere conto del percorso di ritorno), per 213 (una stima del numero medio di giorni all’anno in cui vengono fatti gli spostamenti casa-lavoro) e infine per il numero di chilometri percorsi da quel caso nello spostamento casa-lavoro; quest’ultimo dato è stato a sua volta calcolato utilizzando lo strumento messo a disposizione dal sito web Viamichelin, e può quindi differire in maniera anche sostanziale dai dati sulle distanze dichiarate illustrati nella sezione precedente del rapporto. Va precisato che tale utilizzo delle stime delle emissioni non è rigoroso e porta a notevoli approssimazioni che tendono a ridurre la vicinanza della stima al dato reale. I dati prodotti in questo modo permettono però di rendere il dato sulla stima delle emissioni più leggibile e di produrre alcune analisi di maggiore interesse per gli amministratori e i mobility manager degli enti coinvolti, anche in vista della programmazione di eventuali politiche future. In questo senso, la perdita di rigore insita in questo utilizzo parzialmente scorretto delle stime delle emissioni viene compensato, ci sembra, dalla maggiore leggibilità e potenziale fecondità pratica del dato. 9.8.2 - Campione Come illustrato in maggiore dettaglio nella sezione ad essa dedicata, la stima delle emissioni è stata effettuata su un sottocampione di automobilisti e motociclisti pari a 101 casi; esso è costituito per la
141
quasi totalità (98 casi) di record che fanno riferimento a tragitti casa-lavoro compiuti in automobile (i restanti tre in motociclo/scooter). La composizione del sottocampione per sede di lavoro è riportata in Grafico 43 e mostra come la stima delle emissioni abbia interessato soltanto il personale degli enti pubblici (fanno eccezione due casi corrispondenti a dipendenti della Solvay Solexis). Grafico 43 Distribuzione di frequenza assoluta dei dipendenti per i quali è stata effettuata la stima delle emissioni (n=101)
Il Grafico 44 mostra il tasso di copertura della stima di emissioni per ente partecipante: esso è stato calcolato dividendo il numero di stime effettuate per il totale dei rispondenti di quell’ente che effettuano lo spostamento casa lavoro con l’auto o con un motociclo/scooter. Come si può notare, il tasso di copertura è piuttosto elevato (sopra il 70%) per tutti gli enti pubblici partecipanti, mentre è estremamente basso per le aziende private. Tenendo conto di questo dato e del tasso di risposta per ente partecipante (riportato nel Grafico 2) si può concludere che le stime delle emissioni presentate in questa sezione possono essere un’immagine piuttosto accurata della situazione nei comuni di Garbagnate Milanese e Bollate, ma non degli altri comuni coinvolti né – a maggior ragione – per le aziende private. Grafico 44 Tasso di copertura della stima delle emissioni (sul totale dei rispondenti che effettuano lo spostamento casa-lavoro con auto o moto), per ente partecipante
142
9.8.3 - Caratteristiche dei veicoli Per una corretta interpretazione dei dati riportati in questa sezione, è necessario tenere presente che le tre principali caratteristiche dei veicoli utilizzate per stimare le emissioni (cilindrata, categoria euro e tipo di motore) hanno forti relazioni l’una con l’altra nel sottocampione in esame. Per esempio, come illustrato in Tabella 31, la cilindrata media delle vetture tende ad essere associata positivamente con la categoria Euro – con la parziale eccezione degli Euro 2. In questo senso, le automobili di più recente immatricolazione nel campione tendono anche ad avere cilindrate più elevate, con possibili effetti sulle emissioni inquinanti. Tabella 31 Distribuzione di frequenza percentuale per cilindrata dei veicoli utilizzati per lo spostamento casa lavoro per i quali è stata effettuata la stima delle emissioni, per categoria Euro (n=101)
Cilindrata dell’automobile
Fino a 1400 cc
Da 1401 cc a 2000
cc oltre
2000 cc
Totale
Euro 1
75% 25% 0% 100%
Euro 2
89% 11% 0% 100%
Euro 3
62% 38% 0% 100%
Euro 4
57% 39% 4% 100%
Categoria Euro
Euro 5
100% 0% 0% 100%
Totale 65% 33% 2% 100% Analogamente, come illustrato in Tabella 32, mentre le automobili alimentate a benzina tendono ad essere prevalentemente di piccola cilindrata (fino a 1400 cc), quelle a diesel sono invece concentrate in misura maggiore nella classe di cilindrata successiva, compresa tra 1401 e 2000cc (le numerosità delle celle per gli altri tipi di alimentazione non permettono invece di trarre alcuna conclusione sensata sul tipo di cilindrata prevalente). Tabella 32 Distribuzione di frequenza percentuale per cilindrata dei veicoli utilizzati per lo spostamento casa-lavoro
Cilindrata dell’auto
Fino a 1400 cc
Da 1401 cc a 2000
cc oltre
2000 cc
Totale
benzina 84% 16% 0% 100% Tipo di alimentazione auto
A benzina
50% 25% 25% 100%
143
GDI
Diesel 33% 67% 0% 100% Diesel FAP
25% 75% 0% 100%
A gpl 60% 30% 10% 100% A metano
0% 100% 0% 100%
ibrido 100% 0% 0% 100% Totale 65% 33% 2% 100%
9.8.4 - Emissioni di CO2 Le emissioni di CO2 sono tra i principali gas che contribuiscono al riscaldamento globale del pianeta e al cambiamento climatico: in questo senso, il loro impatto negativo sull’ambiente è più a scala globale (e dilazionato nel tempo) rispetto a quello di altri inquinanti (come il PM, che verrà considerato nella prossima sezione) che tendono influire negativamente ad una scala più locale (regionale) e prevalentemente sulla salute degli abitanti. Come può essere notato nel Grafico 45, il valore medio delle emissioni di CO2 al km dei veicoli non varia in maniera particolarmente significativa al variare della distanza dell’abitazione dalla sede di lavoro, anche se si nota una leggera tendenza all’utilizzo di automobili meno inquinanti tra chi abita e lavora nello stesso comune. Grafico 45 Distribuzione del valore medio delle emissioni di CO2 (g/km) dei veicoli utilizzati, per tipo di comune di domicilio (n=102)
Il Grafico 46 presenta invece la variazione del valore medio delle emissioni annuali di CO2 in tonnellate, al variare della tipologia del comune di domicilio. Come già ricordato, tale variabile è stata calcolata moltiplicando il valore delle emissioni g/km per il numero di km percorsi nel tragitto casa lavoro (stimato a partire dagli indirizzi indicati dai rispondenti nel questionario), per due (per tenere conto del tragitto di ritorno) e per 213 (il numero medio stimato di giorni lavorativi annui). In questo modo si ottiene una stima di quante emissioni ogni lavoratore produce annualmente per effettuare lo spostamento casa-lavoro con la vettura indicata (senza tenere conto però di eventuali spostamenti durante l’orario di lavoro, ad esempio per la pausa pranzo).
144
Come si può osservare dalla figura, i valori di questo indicare tendono ad essere fortemente differenziati a seconda del tipo di comune di domicilio: essi raddoppiano infatti nel passaggio da i dipendenti che vivono e lavorano nello stesso comune (circa 200kg di CO2 all’anno) a coloro che vivono in un comune coinvolto nell’indagine ma lavorano in un altro, per poi raddoppiare nuovamente tra coloro che risiedono in un comune esterno all’area di indagine. Tenuti considerati i risultati riportati nel Grafico 45, si desume che le il maggior numero di chilometri percorsi mediamente da chi abita più lontano dalla sede di lavoro tende ad influire in maniera cruciale sulle emissioni di CO2 prodotte. Grafico 46 Distribuzione del valore medio delle emissioni di CO2 annuali (in tonnellate), per tipo di comune di domicilio (n=102)
Nel Grafico 47 e nel Grafico 48 viene rappresentato un apparente paradosso: le automobili di categoria Euro più recente presenti nel campione tendono in media a produrre più CO2 di quelle più anziane. Ciò è spiegato da due fattori: in primo luogo, gli standard europei sulle emissioni che sottendono la tipologia “Euro” non sono intesi a limitare le emissioni di CO2 ma quelle di altri inquinanti (tra cui il PM) con impatto su scala più locale; in secondo luogo, c’è un’interazione tra le caratteristiche dei veicoli, illustrata nella sezione precedente, per la quale generalmente ad auto di categoria Euro più recente si associa una cilindrata maggiore. Tale differenza controintuitiva viene esasperata dall’esame delle emissioni annuali di CO2 per categoria Euro che mostra come, fatta eccezione per la categoria Euro 1, nel campione in esame ad auto con certificazioni più recenti si associno valori di emissioni annuali considerevolmente più alte: le automobili Euro 4 presenti nel campione producono ad esempio in media quasi una tonnellata di CO2 l’anno, un valore quasi triplo rispetto a quello delle vetture Euro 2. Ciò è dovuto probabilmente ad un’associazione negativa esistente tra la lunghezza del percorso casa-lavoro e l’età del veicolo utilizzato. In altri termini: coloro che abitano più lontano tendono probabilmente a cambiare auto più spesso, e quindi a possedere modelli più recenti, potenzialmente meno inquinanti (anche se spesso di cilindrata maggiore).
145
Grafico 47 Distribuzione del valore medio delle emissioni di CO2 (g/km) dei veicoli utilizzati, per categoria Euro (n=103)
Grafico 48 Distribuzione del valore medio delle emissioni di CO2 annuali (in tonnellate), per categoria Euro (n=103)
Il Grafico 49 e il Grafico 50 illustrano un fenomeno simile, legato in questo caso però alla cilindrata. Le automobili di cilindrata più elevata presenti nel campione tendono infatti ad emettere più CO2 al km, e questa differenza viene amplificata se si tiene conto dei valori delle emissioni annuali; tale risultato che suggerisce un’associazione positiva tra numero di km da percorrere giornalmente per raggiungere la sede di lavoro e il volume del motore – una correlazione che potrebbe ovviamente essere mediata da altri fattori (ad es., livello di qualificazione, reddito, ecc.).
146
Grafico 49 Distribuzione del valore medio delle emissioni di CO2 (g/km) dei veicoli utilizzati, per cilindrata dell’automobile (n=100)
Grafico 50 Distribuzione del valore medio delle emissioni di CO2 annuali (in tonnellate), per cilindrata dell’automobile (n=100)
I valori riportati nel Grafico 51 e nel Grafico 52 possono essere commentati in maniera analoga: com’è possibile osservare, infatti, le automobili alimentate a diesel presenti nel campione sono le più inquinanti in termini di emissioni di CO2 al km, fatta eccezione per le auto a benzina a iniezione diretta, che però costituiscono un numero molto esiguo di veicoli nel campione). Tale differenza viene tuttavia estremamente amplificata dalle distanze percorse, e risulta quindi in valori di emissioni annuali medie per le automobili diesel superiori alla tonnellata e più che doppie rispetto alle auto a benzina (più che quadruple rispetto ai veicoli ibridi). Ciò può essere spiegato in vari modi: è plausibile ipotizzare ad esempio che coloro che devono percorrere tragitti casa-lavoro più lunghi siano più attratti dall’acquisto di un auto a diesel (che permette risparmi in termini di spesa per carburante sui lunghi tragitti); allo stesso tempo, come si è illustrato, i diesel presenti nel campione tendono ad essere concentrati nella categoria intermedia di cilindrata del motore, e non in quella inferiore come i veicoli a benzina.
147
Grafico 51 Distribuzione del valore medio delle emissioni di CO2 (g/km) dei veicoli utilizzati, per tipo di alimentazione dell’automobile (n=100)
Grafico 52 Distribuzione del valore medio delle emissioni di CO2 annuali (in tonnellate), per tipo di alimentazione dell’automobile (n=100)
Se si mettono a confronto i parchi veicoli dei diversi enti partecipanti, si nota che in termini di emissioni di CO2 al km non vi sono differenze particolarmente pronunciate (Grafico 53). In altri termini, le auto dei dipendenti di Garbagnate Milanese inquinano in media meno al km rispetto a quelle degli altri comuni, ma non in maniera considerevole. Le differenze si fanno invece degne di nota se si considerano le emissioni di diossido di carbonio annuali (Grafico 54): in questo caso lo scarto tra i dipendenti del Comune di Garbagnate Milanese e quelli degli altri comuni coinvolti (in particolare Bollate) si fa ampio ed è riconducibile in primo luogo al maggior numero di km percorsi in media nel percorso casa-lavoro dai dipendenti degli altri enti partecipanti.
148
Grafico 53 Distribuzione del valore medio delle emissioni di CO2 (g/km) dei veicoli utilizzati, per ente partecipante (n=103)
Grafico 54 Distribuzione del valore medio delle emissioni di CO2 annuali (in tonnellate), per ente partecipante (n=103)
Un commento analogo è possibile per le differenze di genere (Grafico 55 e Grafico 56): mentre il valore di emissioni di CO2 al km è assolutamente identico tra automobilisti uomini e donne, infatti, differenze degne di nota emergono se si prende in considerazione il valore medio delle emissioni annuali; in questo caso, le donne risultano inquinare mediamente di più, in una misura che è in larga parte riconducibile dunque alla maggiore lunghezza dei loro spostamenti casa-lavoro.
149
Grafico 55 Distribuzione del valore medio delle emissioni di CO2 (g/km) dei veicoli utilizzati, per genere (n=103)
Grafico 56 Distribuzione del valore medio delle emissioni di CO2 annuali (in tonnellate), per genere (n=103)
Differenze analoghe emergono in termini di fascia d’età (Grafico 57 e Grafico 58): a valori di emissioni per km poco differenti corrispondono infatti differenze in termini di tonnellate di CO2 all’anno più marcati, che tendono a mettere in evidenza un maggior impatto ambientale degli automobilisti nelle fasce centrali d’età, presumibilmente riconducibile ad una maggiore lunghezza degli spostamenti casa-lavoro.
150
Grafico 57 Distribuzione del valore medio delle emissioni di CO2 (g/km) dei veicoli utilizzati, per fascia d’età (n=102)
Grafico 58 Distribuzione del valore medio delle emissioni di CO2 annuali (in tonnellate), per fascia d’età (n=102)
Lo stesso tipo di intreccio di determinanti è probabilmente all’opera nello spiegare i risultati illustrati nel Grafico 59 e nel Grafico 60: le differenze tra le diverse tipologie familiari sono infatti degne di nota se si considerano le emissioni annuali di diossido di carbonio, e mettono in evidenza in particolare un maggiore impatto ambientale dei single e delle coppie senza figli rispetto a quelle con figli. D’altra parte, le differenze tra i diversi tipi di famiglia in termini di emissioni medie dei veicoli al km non sembrano giustificare questo stato di cose, che è dunque con ogni probabilità da attribuire a differenze nel numero di chilometri da percorrere per raggiungere la sede di lavoro. I dati illustrati nel Grafico 61 e nel Grafico 62 sembrano confermare queste deduzioni, mostrando come i soggetti senza figli tendano ad emettere annualmente molti più kg di CO2 rispetto ai dipendenti con prole, nonostante valori medi di emissioni al km sostanzialmente identici tra le due categorie.
151
Grafico 59 Distribuzione del valore medio delle emissioni di CO2 (g/km) dei veicoli utilizzati, per condizione familiare (n=103)
Grafico 60 Distribuzione del valore medio delle emissioni di CO2 annuali (in tonnellate), per condizione familiare (n=103)
152
Grafico 61 Distribuzione del valore medio delle emissioni di CO2 (g/km) dei veicoli utilizzati, per presenza di figli (n=102)
Grafico 62 Distribuzione del valore medio delle emissioni di CO2 annuali (in tonnellate), per presenza di figli (n=102)
L’esame delle variazione delle due variabili in relazione al titolo di studio (Grafico 63 e Grafico 64) mostra un caso ancora più pronunciato di associazione: chi ha raggiunto la laurea risulta emettere annualmente per lo spostamento casa-lavoro in auto o moto una quantità di CO2 più che doppia rispetto ai meno istruiti; tale differenza è probabilmente da ricondurre ad un maggior numero medio di km da percorrere quotidianamente, in quanto le differenze in termini di g/km di anidride carbonica, seppur presenti, non risultano particolarmente rilevanti.
153
Grafico 63 Distribuzione del valore medio delle emissioni di CO2 (g/km) dei veicoli utilizzati, per titolo di studio (n=102)
Grafico 64 Distribuzione del valore medio delle emissioni di CO2 annuali (in tonnellate), per titolo di studio (n=102)
E’ interessante infine notare che gli automobilisti che durante il periodo estivo cambiano mezzo di spostamento (e riducono quindi presumibilmente il proprio impatto ambientale) sono anche coloro che emettono annualmente (stando alla stima che presuppone, va specificato, che il mezzo sia lo stesso durante tutto l’anno) molto meno CO2 (Grafico 66). Ciò è dovuto con ogni probabilità al fatto che chi cambia mezzo durante il periodo estivo abita tendenzialmente ad una distanza inferiore dalla propria sede di lavoro rispetto a chi non lo cambia, in quanto l’esame delle emissioni medie al km (Grafico 65) non mette in evidenza differenze notevoli tra i due gruppi. Questo risultato è importante per le sue conseguenze: nonostante lo spostamento nel periodo estivo di una parte dei dipendenti da mezzi inquinanti ad altri meno inquinanti sia in linea di principio positivo, il suo effetto concreto rischia di essere molto contenuto, in quanto si tratta di una nicchia di automobilisti che percorrono pochi chilometri per recarsi al lavoro, e quindi contribuiscono in maniera notevolmente inferiore alle emissioni nocive.
154
Grafico 65 Distribuzione del valore medio delle emissioni di CO2 (g/km) dei veicoli utilizzati, per risposta alla domanda “Nel periodo estivo, per recarsi al lavoro, utilizza gli stessi mezzi?” (n=100)
Grafico 66 Distribuzione del valore medio delle emissioni di CO2 annuali (in tonnellate), per risposta alla domanda “Nel periodo estivo, per recarsi al lavoro, utilizza gli stessi mezzi?” (n=102)
9.8.5 - Emissioni di PM In questa sezione, viene presentata l’analisi dei dati relativi alle emissioni di PM. Si tratta in questo caso di particolato fine, dunque di un inquinante i cui effetti ricadono prevalentemente sulla salute dell’uomo e a scala locale/regionale. Il Grafico 67 e il Grafico 68 illustrano una situazione simile, ma più accentuata, rispetto a quella descritta per le emissioni di CO2. Tra chi abita più lontano dalla sede di lavoro (in comuni non partecipanti all’indagine), i veicoli producono in media circa il 50% in più di PM tot al km. Questa
155
differenza viene amplificata a tal punto dalla diversa lunghezza dei percorsi casa-lavoro che, su base annuale, le emissioni di chi risiede in un comune non partecipante risultano essere più di sette volte tanto quelle degli automobilisti e motociclisti che abitano e lavorano nello stesso comune. Grafico 67 Distribuzione del valore medio delle emissioni di PM tot (mg/km) dei veicoli utilizzati, per tipo di comune di domicilio (n=102)
Grafico 68 Distribuzione del valore medio delle emissioni annuali di PM tot (in grammi), per tipo di comune di domicilio (n=102)
Il Grafico 69 e il Grafico 70 mostrano che, nel sottocampione considerato, le automobili e i motocicli appartenenti alle categorie Euro più recenti risultano effettivamente produrre meno emissioni di PM tot sia per km che su base annuale (considerando quindi anche i chilometraggi effettivamente percorsi per lo spostamento casa-lavoro).
156
Grafico 69 Distribuzione del valore medio delle emissioni di PM tot (mg/km) dei veicoli utilizzati, per categoria Euro (n=103)
Grafico 70 Distribuzione del valore medio delle emissioni di PM tot annuali (in grammi), per categoria Euro (n=103)
Dall’esame del Grafico 71 e del Grafico 72 emerge per contro che i veicoli che più contribuiscono alle emissioni di PM sono quelli di cilindrata media (1401-2000cc), una differenza che si presenta in maniera ancora più accentuata se si considera il totale delle emissioni annuali medie, invece del valore medio di emissione per km.
157
Grafico 71 Distribuzione del valore medio delle emissioni di PM tot (mg/km) dei veicoli utilizzati, per cilindrata dell’automobile (n=100)
Grafico 72 Distribuzione del valore medio delle emissioni di PM tot annuali (in grammi), per cilindrata dell’automobile (n=100)
Nel Grafico 73 e nel Grafico 74, infine vengono riportati i valori delle emissioni di PM a seconda del tipo di motore del veicolo. Come si può notare, i veicoli diesel senza filtro FAP risultano di gran lunga i più inquinanti da questo punto di vista – un fatto che si nota con ancora maggiore chiarezza se si prendono in considerazione le emissioni medie di PM su base annuale. Ciò avviene presumibilmente perché le automobili alimentate a diesel tendono ad appartenere ai dipendenti che abitano più lontano dalla propria sede di lavoro, e dunque a percorrere un maggior numero di chilometri quotidianamente per raggiungerla. Da notare inoltre che le differenze tra questo tipo di alimentazione e gli altri risultano molto più accentuate nel caso del PM che delle emissioni di CO2, precedentemente illustrate.
158
Grafico 73 Distribuzione del valore medio delle emissioni di PM tot (mg/km) dei veicoli utilizzati, per tipo di alimentazione dell’automobile (n=100)
Grafico 74 Distribuzione del valore medio delle emissioni di PM tot annuali (in grammi), per tipo di alimentazione dell’automobile (n=100)
Come mostra Grafico 76, le variazioni nel livello di emissioni annuali medie di PM tot tra i diversi enti partecipanti sono degne di nota: non considerando il dato relativo ai dipendenti della Solvay Solexis (che corrisponde a troppo pochi casi per poter essere ritenuto anche minimamente affidabile), infatti, si può notare come i dipendenti dei comuni di Arese e, soprattutto, Bollate producano annualmente in media una quantità considerevolmente maggiore di PM tot. Ciò sembra essere dovuto (come indica l’esame del Grafico 75) più a differenze nei chilometri percorsi che nei valori delle emissioni medie per km. Il dato relativo al Comune di Bollate in particolare desta alcune perplessità, in quanto il valore mediano della distanza percorsa dai suoi dipendenti risulta essere tra i più bassi (come illustrato nel Grafico 5). Si può ipotizzare a questo proposito che la distanza casa-lavoro dei soli automobilisti e motociclisti (che a Bollate costituiscono soltanto il 56% dei rispondenti) si discosti in maniera considerevole dal valore mediano del resto dei dipendenti di quel comune.
159
Grafico 75 Distribuzione del valore medio delle emissioni di PM tot (mg/km) dei veicoli utilizzati, per ente partecipante (n=103)
Grafico 76 Distribuzione del valore medio delle emissioni di PM tot annuali (in grammi), per ente partecipante (n=103)
Analogamente a quanto illustrato per il CO2, le differenze in termini di emissioni di PM tra donne e uomini sembrano indicare un minore impatto ambientale di questi ultimi, soprattutto se si considerano le emissioni medie annuali (Grafico 77). Si riscontra tuttavia anche una discreta differenza in termini di emissioni medie per km percorso, segno che la parte femminile del sottocampione considerato tende a guidare automobili e motocicli mediamente più inquinanti, in termini di emissioni di particolato, di quelli utilizzati dalla controparte maschile (Grafico 78).
160
Grafico 77 Distribuzione del valore medio delle emissioni di PM tot (mg/km) dei veicoli utilizzati, per genere (n=103)
Grafico 78 Distribuzione del valore medio delle emissioni di PM tot annuali (in grammi), per genere (n=103)
Inoltre, gli automobilisti e i motociclisti con figli producono su base annuale, in media, leggermente più PM di quanto facciano quelli senza figli (Grafico 79), nonostante il fatto che i primi conducano in genere veicoli più inquinanti in termini di emissioni di PM per chilometro (Grafico 80). Sembra dunque ragionevole supporre che i dipendenti senza figli percorrano in media un numero di chilometri maggiore per raggiungere la sede di lavoro.
161
Grafico 79 Distribuzione del valore medio delle emissioni di PM tot (mg/km) dei veicoli utilizzati, per presenza di figli (n=102)
Grafico 80 Distribuzione del valore medio delle emissioni di PM tot annuali (in grammi), per presenza di figli (n=102)
Analogamente a quanto rilevato per le emissioni di CO2, all’interno del campione considerato i soggetti con laurea emettono in media, su base annuale, una quantità più che doppia di PM rispetto ai meno istruiti, anche se soltanto di poco superiore rispetto a quanti si fermano al diploma superiore (Grafico 82). Ciò è dovuto in primo luogo alla maggiore distanza che separa in genere le abitazioni dei più istruiti dai loro luoghi di lavoro, anche se riscontra pure un maggiore impatto dei veicoli dei laureati in termini di grammi di PM per chilometro (Grafico 81).
162
Grafico 81 Distribuzione del valore medio delle emissioni di PM tot (mg/km) dei veicoli utilizzati, per titolo di studio (n=102)
Grafico 82 Distribuzione del valore medio delle emissioni di PM tot annuali (in grammi), per titolo di studio (n=102)
Si può notare infine come, anche per quanto riguarda il PM, l’impatto ambientale (soprattutto su base annua) di chi dichiara di cambiare mezzo di trasporto durante il periodo estivo sia (se stimato considerando una sola modalità di spostamento per tutto l’anno) considerevolmente più basso di chi invece utilizza in estate lo stesso mezzo impiegato durante il resto dell’anno (Grafico 83 e Grafico 84). Ciò sembra essere dovuto prevalentemente alla maggiore lunghezza dei tragitti casa-lavoro di chi non cambia mezzo, anche se si riscontra anche un (lieve) maggior impatto ambientale in termini di emissioni di PM per km tra i veicoli di chi non varia la propria scelta modale secondo le stagioni.
163
Grafico 83 Distribuzione del valore medio delle emissioni di PM tot (mg/km) dei veicoli utilizzati, per risposta alla domanda “Nel periodo estivo, per recarsi al lavoro, utilizza gli stessi mezzi?” (n=100)
Grafico 84 Distribuzione del valore medio delle emissioni di PM tot annuali (in grammi), per risposta alla domanda “Nel periodo estivo, per recarsi al lavoro, utilizza gli stessi mezzi) (n=100)
9.8.6 - Stima delle emissioni territoriali I dati elaborati nella sezione precedente possono essere utilizzati per produrre delle stime a livello di ente partecipante delle emissioni prodotte dagli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti. Queste stime sono evidentemente estremamente grossolane, implicano una serie di assunti molto restrittivi (che verranno esplicitati più avanti) e contravvengono ovviamente alle indicazioni rigorose della metodologia utilizzata per la stima iniziale delle emissioni, presentata nella parte del presente rapporto denominata “Elaborazione dei dati sulle emissioni prodotte dai trasporti”.
164
Le stime proposte in questa sezione sono state ottenute nel seguente modo: innanzitutto si è calcolato il valore medio delle emissioni annuali (di PM e CO2) per il sotto-campione di automobilisti e ciclisti in ogni ente partecipante (i relativi valori sono riportati nel Grafico 54 e nel Grafico 76); a questi corrispondono i valori (a1) e (a2) riportati in Tabella 33.
Tabella 33 Indicatori utilizzati per la stima delle emissioni annuali a livello di ente per i comuni di Bollate e Garbagnate Milanese.
Bollate Garbagnate Milanese
(a1) Emissioni PM tot - anno pro capite (auto e moto) (g) 107,99 46,67(a2) Emissioni CO2 anno pro capite (auto e moto) (ton) 0,645 0,451(b) Share modale auto + moto 0,56 0,59(c1) Stima emissioni PM pro capite (per ogni dipendente) (g) 60,474 27,535(c2) Stima emissioni CO2 pro capite (per ogni dipendente) (ton) 0,361 0,266(d) n° dipendenti 259 135(e1) Stima emissioni PM tot anno per l'ente (kg) 15,663 3,717(e2) Stima emissioni C02 anno per l'ente (ton) 93,536 35,946 Successivamente si è moltiplicato questo valore per lo share modale di auto e moto considerate congiuntamente (ricavato dalla Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.): in questo modo si sono ottenuti gli indicatori (c1) e (c2) che, accettando una serie di assunti molto stringenti e un certo livello di approssimazione metodologica possono essere considerati come stime della media delle emissioni pro-capite per ogni dipendente dell’ente partecipante in questione che ha risposto all’indagine. Quindi:
(c1) = (a1)*(b) (c2) = (a2)*(b)
In seguito, moltiplicando questi ultimi valori per il n° totale dei dipendenti si ottiene una stima molto grossolana di quelle che potrebbero essere le emissioni totali prodotte in un anno a livello di ente per lo spostamento casa-lavoro dei propri dipendenti. In questo senso:
(e1) = (c1)*(d) (e2) = (c2)*(d)
E quindi:
(e1) = (a1)*(b)*(d) (e2) = (a2)*(b)*(d)
La stima è stata realizzata per i soli comuni di Bollate e Garbagnate Milanese, perché risultano essere gli unici enti con valori soddisfacenti per, contemporaneamente, numero assoluto di risposte all’indagine (Grafico 1), tasso di risposta all’indagine (Grafico 2) e tasso di copertura delle stime delle emissioni rispetto al totale degli automobilisti / motociclisti (Grafico 44). Le stime effettuate implicano evidentemente una serie di assunti molto stringenti e scarsamente plausibili, che si elencano nel seguito:
‐ che il campione di rispondenti sia rappresentativo del totale dei dipendenti dell’azienda
165
‐ che il sotto-campione di casi utilizzati per la stima delle emissioni sia rappresentativo del totale degli automobilisti / motociclisti nel campione
‐ che a tragitti casa-lavoro effettuati con mezzi diversi dall’auto e la moto corrispondano emissioni pari a zero
‐ che i tragitti casa-lavoro vengano effettuati da ogni dipendente durante tutto l’anno con lo stesso mezzo e seguendo lo stesso percorso (ad esempio, nessun cambiamento estivo di mezzo, nessun ritorno a casa durante la pausa pranzo)
‐ che le caratteristiche dei veicoli e dei percorsi per i casi di spostamenti in “auto come passeggero” corrispondano in media a quelle dei casi considerati nella stima delle emissioni
‐ che gli spostamenti “auto come passeggero” non comportino mai l’accompagnamento di un dipendente dell’ente da parte di un collega Nonostante le evidenti limitazioni che derivano da questi forti assunti e dall’utilizzo non rigoroso dei dati prodotti dalla stima delle emissioni per veicolo, gli indicatori proposti possono risultare utili alle amministrazioni e ai mobility manager dei due comuni per calcolare in futuro, a fronte di eventuali variazioni nello share modale di auto e moto, una stima delle conseguenti variazioni in termini di emissioni prodotte annualmente dai dipendenti dell’ente per compiere il tragitto casa-lavoro-casa. Ad esempio, immaginando una riduzione nell’anno 2011 dello share modale di auto e moto del 10% tra i dipendenti del comune di Bollate, le risultanti emissioni di PM tot dovrebbero essere calcolate nel seguente modo:
107,99*(0,56-0,10)*259=12,866kg
Si potrebbe affermare dunque, sulla base della stima effettuata, che una riduzione di 10 punti percentuali nella quota di dipendenti che si recano al lavoro in auto o moto determina una riduzione di circa 3kg annuali di PM tot prodotti dai dipendenti nel loro insieme per effettuare lo spostamento casa-lavoro. Va detto tuttavia che, come conseguenza degli assunti poc’anzi ricordati, una stima di questo tipo rischia di essere doppiamente sovrastimata, e deve essere dunque considerata come un limite massimo della riduzione possibile; questo perché:
‐ lo spostamento di una quota di dipendenti dai mezzi auto/moto ad un altro mezzo risulterà – in tutti i casi in cui il nuovo mezzo è il trasporto pubblico – in una riduzione inferiore a quella stimata del livello di emissioni (in quanto le emissioni dei mezzi pubblici sono diverse da 0)
‐ è plausibile che eventuali rinunce all’auto per lo spostamento casa-lavoro coinvolgano prima degli altri (o in misura maggiore), quei dipendenti che già attualmente percorrono i tragitti casa-lavoro più brevi, e quindi contribuiscono di meno alle emissioni 9.9 - Sintesi dei principali risultati In quest’ultima sezione della parte del rapporto dedicata all’elaborazione dei dati, viene proposta un’analisi riassuntiva, per punti principali, dei risultati più importanti dell’analisi. Nella prima parte viene proposta una sintesi per mezzi di trasporto, mentre nella seconda si cercano di tracciare dei profili sintetici di due gruppi di enti collocati agli estremi opposti per quanto riguarda la mobilità casa-lavoro: le aziende private e i comuni. In primo luogo, per quanto riguarda l’auto:
166
il predominio dell’automobile è incontrastato: il 72% degli spostamenti casa-lavoro (più della media nazionale: 59%);
in nessun ente la quota modale dell’auto scende sotto il 50%, tra le aziende private tocca anche il 90%;
particolarmente auto-dipendenti gli spostamenti casa-lavoro di chi abita in un comune aderente al Piano Intercomunale ma lavora in un altro (94%);
metà degli spostamenti casa-lavoro in automobile sono sotto la mezz’ora; in tre quarti dei casi l’auto è occupata dal solo conducente; la scelta dell’automobile non sembra motivata in modo particolare dall’esigenza di combinare in
maniera flessibile diverse attività e soste sul tragitto casa-lavoro-casa; utilizzata in particolare da laureati e da chi ha figli sotto i 14 anni; più della metà delle famiglie possiede due auto o più – solo il 3% nessuna; il tasso di motorizzazione medio delle famiglie intervistate (66 auto ogni 100 abitanti) è superiore
alla media italiana (60) e milanese (64); le più importanti difficoltà incontrate dagli automobilisti nello spostamento casa-lavoro sono:
traffico (63%), costo del carburante (25%) e pericolo di incidenti (18%); la spesa mensile media per carburante è di circa 96 euro; per quasi un terzo degli automobilisti lo spostamento casa-lavoro si svolge “senza nessuna
difficoltà” (percentuale leggermente maggiore rispetto a ciclisti e utenti dei mezzi pubblici); solo 3 automobilisti su 100 lamentano la difficoltà o il costo del parcheggio; circa il 70% degli automobilisti intervistati trova parcheggio libero o riservato all’interno
dell’azienda; solo l’1% degli automobilisti utilizza abitualmente i parcheggi di interscambio; gli automobilisti sono i meno soddisfatti del proprio spostamento casa-lavoro (voto medio 6/10); i principali fattori che scoraggiano dall’utilizzo dell’automobile sono il traffico (55%), il costo del
carburante (31%), l’inquinamento (22%) e il costo del parcheggio (17%); le innovazioni in tema di mobilità preferite dagli intervistati sono soluzioni tecnologiche che
rendano l’utilizzo dell’automobile meno inquinante (auto elettrica, GPL/metano); un intervistato su dieci dichiara che potrebbe smettere di usare l’auto nei prossimi anni; il livello di emissioni inquinanti di chi viene in auto dall’esterno dell’area di studio è molto più
elevato a causa del maggior numero di chilometri percorsi e della diffusione del diesel (più inquinante) tra chi abita più lontano dalla sede di lavoro; Per quanto riguarda i mezzi pubblici:
gli spostamenti casa-lavoro con i mezzi pubblici sono in media l’11% (dato sotto la media nazionale: 16%);
sopra la media solo tra i dipendenti dei comuni di Bollate, Pero e della Solvay Solexis; scarsamente competitivi per i tragitti intra-comunali (2%) e tra un comune aderente e l’altro (3%); maggiore competitività (18%) per gli spostamenti casa-lavoro più lunghi, che hanno origine in
comuni esterni all’area di studio; più di metà degli spostamenti coi mezzi pubblici durano più di 50 minuti; la velocità percepita dei mezzi pubblici è inferiore a quella dell’auto (valore mediano 17km/h contro
24km/h); la combinazione tra mezzi pubblici e altri mezzi di trasporto (multimodalità) è ad oggi un fenomeno
praticamente inesistente (2%); nel periodo estivo i mezzi pubblici sono il mezzo che perde più utenza, a favore di bicicletta, moto e
auto (share modale estivo: 9%);
167
la percentuale di dipendenti abbonati ai mezzi (14%) è superiore a quella di quanti lo utilizzano effettivamente nello spostamento casa-lavoro (11%);
le principali difficoltà incontrate dagli utenti dei mezzi pubblici sono ritardi e scarsa puntualità (54%), affollamento (31%) e lunghezza del viaggio (20%);
gli utenti dei mezzi pubblici sono i meno soddisfatti del proprio spostamento casa-lavoro (6/10); i principali fattori che scoraggiano dall’uso dei mezzi pubblici sono orari e frequenze inadeguate
(42%), scarse coincidenze e troppi cambi (39%), lunghezza del viaggio (34%) e ritardi e scarsa puntualità (33%);
le principali ragioni dichiarate del mancato utilizzo dei mezzi pubblici sono di tipo strutturale, legate a carenze in infrastrutture e servizi (assenza di collegamenti adeguati, numero di cambi necessari e frequenza corse). Per quanto riguarda la mobilità lenta (bicicletta e spostamenti a piedi):
complessivamente comprende circa il 16% degli spostamenti: 8% piedi (sotto la media nazionale del 17%) e 8% bicicletta (sopra la media nazionale del 3%);
è essenzialmente di prossimità: il 50% degli spostamenti a piedi sono sotto gli 800m; la metà dei tragitti in bicicletta non superano i 2km;
nel periodo estivo ha uno share modale più che doppio rispetto ai mezzi pubblici (21%) e assorbe il 60% degli spostamenti casa-lavoro intra-comunali;
pedoni e ciclisti sono i più soddisfatti del loro spostamento casa-lavoro (voto 8/10); il 36% degli intervistati pensa che potrebbe usare di più la bicicletta nei prossimi anni; l’84% delle famiglie possiede almeno una bicicletta; la volontà di incrementare l’utilizzo della bicicletta è più forte in quei comuni (Bollate, Garbagnate
Milanese) dove l’utilizzo delle due ruote è già più diffuso; le principali difficoltà incontrate dai ciclisti sono la mancanza di piste ciclabili (59%), le condizioni
atmosferiche (36%) e il pericolo di incidenti (30%); i principali fattori che scoraggiano dall’utilizzo della bicicletta sono la lunghezza del viaggio (48%),
la mancanza di piste ciclabili (48%) e il pericolo di incidenti (39%); l’utilizzo combinato di bici e trasporto pubblico è rarissimo (1%) (cfr. §0, Grafico 6, p.102) e un
non-ciclista su 10 denuncia la mancanza di servizi adeguati per il trasporto della bici sui mezzi pubblici; L’analisi dei dati svolta in questa sezione tende a indicare che comuni e aziende private si contrappongono per: caratteristiche socio-demografiche e residenziali dei dipendenti, comportamenti di mobilità e impatto ambientale13. Infatti, tra i dipendenti dei comuni:
prevalgono donne, le persone con figli, i lavoratori più anziani e meno istruiti; circa il 50% dei dipendenti risiedono nello stesso comune in cui lavorano; anche se più della metà degli spostamenti viene effettuata in auto, tra il 30 e il 40% avviene a piedi
o in bicicletta; i mezzi pubblici sono una realtà consistente solo a Bollate (15%); circa la metà degli spostamenti da e per la sede di lavoro dura meno di 15-20 minuti;
13 In questa sede, tra i gli enti comunali vengono tenuti in considerazione soltanto Bollate e Garbagnate Milanese, in
quanto sono gli unici per i quali la numerosità assoluta del campione e il tasso di risposta permettono di giungere a conclusioni plausibili. Le caratteristiche e i comportamenti di mobilità dei dipendenti degli altri comuni presentano tendenzialmente caratteristiche intermedie tra le amministrazioni comunali citate e le aziende private: tuttavia i dati sono troppo incerti per permettere una sintesi conclusiva.
168
il 50% degli spostamenti copre meno di 3-4 chilometri; la totalità degli automobilisti di Bollate usufruisce di un parcheggio libero o riservato all’interno
dell’azienda (solo il 28% a Garbagnate Milanese); il tasso di motorizzazione dei nuclei familiari dei dipendenti è particolarmente basso (circa 58 auto
ogni 100 abitanti) rispetto al resto del campione; più del 60% delle automobili sono a benzina; i carburanti alternativi contano solo per il 10%; sono prevalenti le vetture di piccola cilindrata (più del 60%); l’età media dei veicoli utilizzati è più elevata della media (6 anni circa); la spesa mensile media per carburante degli automobilisti è particolarmente bassa a Bollate (77€)
rispetto agli altri enti; a Garbagnate Milanese il 62% dei lavoratori si sposta della sede di lavoro durante la pausa pranzo
(e per la maggior parte torna a casa); solo un dipendente su tre a Bollate; Garbagnate Milanese è l’ente dove la soddisfazione per lo spostamento casa-lavoro è più alta
(7,4/10); non così a Bollate (6,3/10); citano più della media l’accessibilità di stazioni e fermate (circa 15%) come ragione per il mancato
utilizzo dei mezzi pubblici; più della metà dei dipendenti potrebbe usare di più la bicicletta nei prossimi anni gli unici enti dove l’intenzione di acquistare una nuova auto nei prossimi anni non è predominante; l’impatto medio pro-capite in termini di emissioni annuali di PM e CO2 è particolarmente basso a
Garbagnate Milanese, ma non a Bollate. Tra i dipendenti delle aziende private, per contro:
prevalgono gli uomini, i lavoratori più giovani, i laureati e le persone senza figli; tra l’80 e il 90% dei dipendenti è domiciliato in comuni esterni all’area di studio; tra l’80 e il 90% degli spostamenti è effettuato con l’automobile; praticamente nessun dipendente raggiunge la sede di lavoro a piedi o in bicicletta; i mezzi pubblici sono una realtà consistente solo presso la Solvay Solexis (16%); nel periodo estivo un dipendente su cinque della CSI utilizza il motociclo/scooter la durata mediana
degli spostamenti da e per la sede di lavoro è compresa tra 20 e 45 minuti; il valore mediano della distanza percorsa è compreso tra i 13 e i 18 chilometri; la totalità degli automobilisti usufruisce di un parcheggio libero o riservato all’interno dell’azienda; il tasso di motorizzazione dei nuclei familiari dei dipendenti è particolarmente elevato (circa 75 auto
ogni cento abitanti); più di metà delle auto sono di cilindrata medio/alta; circa il 40% dei veicoli utilizzati sono alimentati a diesel; una percentuale notevole (20% circa)
utilizza carburanti alternativi; la spesa mensile per carburante degli automobilisti è più alta che negli altri enti, soprattutto presso
la Solvay Solexis (116€); una percentuale molto bassa (praticamente nulla presso la Solvay Solexis) si sposta dalla sede di
lavoro durante la pausa pranzo; la soddisfazione per lo spostamento casa-lavoro è tendenzialmente più bassa che negli altri enti
(circa 6/10); il numero di cambi necessari (circa 30%) è citato più della media come ragione per il mancato
utilizzo dei mezzi pubblici; tra le innovazioni in tema di mobilità preferite vengono citate più che negli altri enti la diffusione di
auto a GPL/Metano (circa 40%) e il car pooling (30%); circa la metà dei dipendenti potrebbe acquistare un auto a GPL/metano nei prossimi anni.
169
9.10 - Conclusioni L’indagine ha messo in evidenza differenti elementi che consentono di delineare i contorni di tre quadri sintetici. 1) Il primo riguarda l’utilizzo dell’automobile. Il fatto che esso sia consistente, e molto superiore alla media nazionale, non sorprende, essendo le fasce peri-urbane delle aree metropolitane del nord Italia connotate dalla presenza di molti insediamenti (residenziali, produttivi e di servizio), la dispersione territoriale dei quali è motivo prioritario alla base della scelta di utilizzo dell’auto privata. L’area territoriale in esame non si discosta da ciò, facendo rilevare una quota significativa di addetti provenienti da comuni diversi da quello di lavoro (in particolare nelle aziende private indagate). Si tratta di un dato che segna il primo elemento di novità rispetto al passato, allorquando i dipendenti delle amministrazioni comunali abitavano nello stesso comune in cui lavoravano e si spostavano a piedi o in bicicletta. Ad eccezione dei dipendenti delle aziende private però quelli dei comuni non abitano così distanti dal luogo di lavoro da giustificare l’uso quasi esclusivo dell’auto, tanto è vero che il tempo trascorso durante gli spostamenti è breve, inferiore alla mezz’ora. Se mezz’ora è un tempo superiore a quello, normalmente, ritenuto accettabile per raggiungere il luogo di lavoro a piedi o in bicicletta non lo è per gli spostamenti fatti con i mezzi di trasporto pubblico. La scelta dell’auto rinvia allora a fattori diversi dalla distanza, quali la maggiore comodità del mezzo e l’assenza di alternative ritenute accettabili. A vantaggio del primo fattore si muovono l’ottima disponibilità di auto in famiglia e i giudizi sulla assenza di difficoltà negli spostamenti in auto, sul costo contenuto del carburante e sulla possibilità di parcheggiare gratuitamente all’interno o in prossimità del luogo di lavoro. Si muovono invece in direzione del giudizio sull’assenza di alternative la mancanza di parcheggi di interscambio. A differenza di quanto emerso in altre indagini, le persone interrogate scelgono l’auto quale mezzo migliore per recarsi al lavoro indipendentemente dal fatto di doverlo fare per accompagnare altre persone o per svolgere attività diverse e, non a caso, solo in un caso su dieci affermano di intendere cambiare scelta nei prossimi anni. Si delinea, così, il contorno di un quadro caratterizzato dalla presenza di comportamenti difficilmente modificabili (in assenza di interventi strutturali di tipo infrastrutturale o regolativo) e che per il breve periodo suggerisce di intervenire sui pochi elementi di fragilità sottesi alla scelta dell’utilizzo esclusivo dell’auto. Le difficoltà dovute alla presenza del traffico sono le più importanti e risultano talmente rilevanti da determinare il livello più basso di soddisfazione degli automobilisti nei confronti della scelta modale. Non è noto se in assenza di traffico il livello di soddisfazione di chi usa l’auto sarebbe più alto, così come la - già consistente - quota di chi fa questa scelta modale, tuttavia l’associazione tra auto e insoddisfazione apre il campo ad azioni orientate a migliorare la qualità delle modalità alternative di spostamento per aumentare i rispettivi giudizi di soddisfazione. Un ulteriore campo di intervento, oltre al traffico, rinvia alla consapevolezza nei confronti dell’inquinamento dell’ambiente. Una quota discreta di chi usa l’auto sembra consapevole delle conseguenze negative della loro scelta in termini di aumento di inquinamento e, infatti, dichiara interesse nei confronti di innovazioni che rimandano all’utilizzo di auto elettriche o a gpl/metano. Come noto l’offerta di queste ultime è oggi ancora insufficiente per rispondere da sola all’obiettivo di limitare i danni causati dall’uso dell’auto; le auto alimentate con fonti di energia innovative poi non risolvono il problema del traffico e del depauperamento dell’ambiente urbano. Tuttavia la presenza, rispetto al passato, di un maggior livello di consapevolezza nei riguardi dell’insostenibilità collettiva delle scelte private crea il contesto favorevole in cui collocare azioni orientate a mettere in evidenza anche i vantaggi personali che potrebbero arrivare dal cambio delle abitudini di mobilità.
170
2) Il secondo quadro rinvia alla scelta di spostarsi con i mezzi pubblici o con modalità lente (bicicletta e spostamenti a piedi). Il mezzo pubblico è la modalità scelta per gli spostamenti casa-lavoro da un dipendente su dieci, ancor meno della giù risicata quota di utilizzatori dei servizi pubblici che si registra a livello nazionale. La localizzazione privilegiata delle residenze o all’interno del territorio comunale o nei comuni limitrofi, non ne favorisce la scelta, a vantaggio - come già osservato - dell’automobile. Similmente ai risultati di altre indagini, sono i lavoratori che risiedono più lontano a preferire il mezzo pubblico, che con tutta evidenza diventa competitivo rispetto all’auto solo quando i costi di quest’ultima sono considerati eccessivi (in termini non solo di spesa ma di tempo e di disagi connessi al traffico). Il tempo maggiore speso negli spostamenti con i mezzi pubblici, così come la loro minore velocità percepita rispetto alle automobili, non sembrano essere fattori deterrenti nella scelta modale. La lunghezza del viaggio viene, infatti, considerata la principale difficoltà da due persone su cinque, una quota inferiore di quella che lamenta scarsa puntualità e eccessivo affollamento. Anche in questa indagine viene quindi confermato che i principali elementi di debolezza dei mezzi trasporto pubblico non siano i tempi e le distanze troppo lunghe ma le carenze nel sistema di offerta e nelle infrastrutture (orari e frequenze inadeguate, scarse coincidenze, assenza di collegamenti adeguati, ritardi e scarsa puntualità). Non sorprende, quindi, scoprire che la quota di chi utilizza i mezzi pubblici per andare al lavoro sia inferiore a quella di chi possiede un abbonamento (che viene utilizzato per svolgere attività diverse), che quasi nessuno pratichi la multi modalità e che gli utenti dei mezzi pubblici siano, assieme agli automobilisti, i meno soddisfatti del proprio spostamento casa-lavoro. I più soddisfatti del modo in cui vanno al lavoro sono coloro che si spostano a piedi e in bicicletta. Sono pochi, circa 16 persone su 100, equamente distribuiti tra chi si muove a piedi (una quota molto inferiore alla media nazionale) e chi lo fa in bicicletta (una proporzione superiore alla media nazionale). Si tratta di persone che risiedono nel comune in cui lavorano e che percorrono distanze molto brevi, anche in bicicletta (non superiori ai due chilometri). La quota molto contenuta di spostamenti a piedi rinvia sia alla presenza di cattive abitudini, quali la scarsa propensione a camminare, sia alla percezione di scarsa qualità dell’ambiente urbano. La carenza di piste ciclabili (e il conseguente maggiore rischio di incidenti) sembra disincentivare la mobilità ciclistica inter-comunale, così come il ricorso all’utilizzo combinato di bicicletta e mezzi di trasporto pubblico. In tali condizioni, anche viaggi di lunghezza non elevata vengono considerati troppo lunghi per essere fatti in bicicletta. Tuttavia le famiglie di quasi tutte le persone intervistate possiedono una bicicletta e molti dichiarano di volerla usare di più nei prossimi anni per andare al lavoro. Esistono quindi le condizioni favorevoli affinché, apportando migliorie al sistema di offerta (in particolare alle piste ciclabili inter-comunali, alle opzioni per l’intermodalità e all’arredo urbano specifico), si possa ottenere un incremento degli spostamenti con le modalità lente, socialmente più sostenibili. 3) Il terzo quadro di sintesi interessa il tipo di luogo di lavoro (amministrazione comunale o azienda). Nelle amministrazioni comunali lavorano soprattutto donne sposate e con figli che risiedono nello stesso comune in cui sono impiegate e che, nonostante ciò, si spostano in un caso su due in auto. Si tratta, soprattutto, di spostamenti di prossimità, di breve durata (inferiore ai 20 minuti) e di distanza contenuta (meno di 4 chilometri).Gli spostamenti in auto vengono fatti su veicoli di piccola cilindrata, alimentati a benzina e relativamente vecchi (sei anni). La combinazione di breve percorrenza in ambiente urbano e assenza di sistemi di alimentazione alternativi incide negativamente sulla qualità dell’ambiente. Nonostante tra i comuni vi siano differenze (per esempio nella distribuzione delle scelte modali o nei giudizi sul livello di soddisfazione nei confronti degli spostamenti casa-lavoro), si rileva una comune predisposizione a voler modificare le pratiche di spostamento a vantaggio di modalità più sostenibili. La presenza di migliori condizioni di accesso alle fermate e alle stazioni viene però addotta come condizione prevalente per potersi muovere in tale direzione.
171
Nelle poche aziende private coinvolte nell’indagine lavorano soprattutto uomini, di età giovane, non coniugati, con titoli di studio più elevati che risiedono in comuni diversi da quelli in cui sono impiegati. Si spostano quasi tutti in auto e, durante il periodo estivo, anche in motocicletta. Rispetto ai dipendenti comunali fanno viaggi più lunghi, con autovetture di cilindrata medio-alta, alimentate a diesel, benzina e, in due casi su dieci, con carburanti alternativi. Queste condizioni si declinano in una spesa per l’utilizzo dell’auto più consistente di quella dei dipendenti comunali e in un livello di soddisfazione per il modo in cui raggiungono il luogo di lavoro più basso della media del campione generale. Nel loro caso l’insoddisfazione sembra meno associata al tipo di scelta modale e più alla spesa, infatti dichiarano di volere acquistare un’auto alimentata a gpl/metano nei prossimi anni. Se in tre casi su dieci la diffusione del car pooling viene indicata come una delle innovazioni in tema di mobilità, quella preferita riguarda ancora l’acquisto di autovetture meno inquinanti e, nel lungo periodo, meno costose. Il ricorso al mezzo di trasporto pubblico è raramente preso in considerazione dalle persone interrogate, esibendo motivazioni associate al numero eccessivo di cambi necessari per raggiungere il posto di lavoro e, ancora, alla presenza di carenze organizzative e infrastrutturali.
4) Infine, i dati sulle emissioni inquinanti prodotte dagli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti sono stati utilizzati per produrre delle stime delle emissioni totali annuali a livello di ente partecipante (utili in senso orientativo). Gli indicatori ottenuti e le formule indicate nel rapporto, nonostante le limitazioni, possono risultare utili alle amministrazioni e ai mobility manager dei comuni di Bollate e Garbagnate Milanese (i soli per cui sia stata effettuata la stima) per calcolare in futuro, a fronte di eventuali variazioni nello share modale di auto e moto, una stima delle conseguenti variazioni in termini di emissioni prodotte annualmente dai dipendenti dell’ente per compiere il tragitto casa-lavoro-casa. Si stima ad esempio che per l’ente comunale di Bollate, una riduzione di 10 punti percentuali nella quota di dipendenti che si recano al lavoro in auto o moto determinerebbe una riduzione di circa 3kg annuali di PM (valore da considerarsi come limite massimo).
172
10 - ANALISI TERRITORIALE Mappa 1 - Bacino di mobilità dei dipendenti delle aziende pubbliche - Arese, Bollate, Garbagnate Milanese
173
Mappa 2 - Bacino di mobilità dei dipendenti di aziende private - CSI, Solvay Solexys
LINEE Di AZIONE
LE PRATICHE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE PRESENTI NEL TERRITORIO
174
11 – LINEE DI AZIONE 11.1 - Buone pratiche nei comuni Obiettivo di questa parte del lavoro è riportare delle brevi considerazioni sulla situazione della pianificazione nei territori di interesse e indicare modo sintetico le buone pratiche che ciascuna amministrazione comunale ha prodotto in materia di mobilità sostenibile, con la finalità di replicarle con esito positivo e veicolarne la diffusione presso gli altri enti. Tutti i Comuni si sono dotati degli strumenti di settore (PUT – PGTU) previsti dalla normativa. Tali strumenti sono stati esaminati, in particolare ponendo attenzione ai dati e alle caratteristiche dei flussi di traffico, alla mobilità ciclopedonale alle politiche di regolamentazione della sosta. Si è riscontrato che gli strumenti non trattano il tema della mobilità sostenibile in modo sistemico e piuttosto che orientare le scelte modali delle persone verso modalità sostenibili di trasporto sono portati a razionalizzare il traffico veicolare e gestirne le esternalità. Pertanto, il Piano Intercomunale della Mobilità Sostenibile si propone come utile momento di riflessione per affrontare le questioni della “mobilità” in modo organico e in ottica sovra-comunale. Tab.1. Prospetto delle principali buone pratiche rinvenute nel contesto territoriale di riferimento. INTERVENTO \ COMUNE Arese Bollate Garbagnate Lainate Pero ottimizzazione servizi TP comunali X valorizzazione navette aziendali X rinnovo parco veicolare ecologico X X comunicazione X bike sharing X estensione rete ciclabile X X pedibus X X In considerazione dell’attuale situazione che sta attraversando il comparto del Trasporto Pubblico Locale, con riferimento alla D.G.R. Lombardia 1204/2010 (il cosiddetto “Deliberone Cattaneo”) e atti successivi emanati dalle Province, non sembrano esserci margini di manovra, né economici né di altra natura, tali da poter intravvedere un miglioramento dell’offerta e un incremento della sostenibilità nel sistema dei trasporti agendo con operazioni di ottimizzazione della rete. Potrebbero ottenere un riscontro positivo politiche di eco-incentivi volti a ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera (rinnovo del parco veicolare con criteri di eco-compatibilità dei mezzi) e a diminuire la dipendenza dall’utilizzo del mezzo privato motorizzato, soprattutto se accompagnate da adeguate campagne di comunicazione e sensibilizzazione. Pare utile ricordare in questa sede gli importanti riscontri maturati negli anni scorsi con le esperienze dei progetti “Gasati” (incentivi per la trasformazione di veicoli a Gpl/metano) e “Eco_spes@” (spesa on-line), promossi dalla Provincia di Milano. Dal quadro in esame, emerge che i progetti connotati da maggior efficacia e incisività si concentrano nell’area della mobilità ciclo-pedonale, intesa sia come incremento dell’offerta infrastrutturale (estensione della rete ciclabile e messa in sicurezza dei percorsi), sia come offerta di servizi finalizzati a orientare la domanda (pedibus scolastico, realizzazione di postazioni di bike
175
sharing). Tali progetti paiono, peraltro, i più appropriati per un possibile inserimento nei PGT - Piano dei Servizi – comunali, avendo peraltro già trovato questa collocazione in diverse esperienze. 11.2 – Aree problematiche e proposte operative Vengono nella sezione che segue messe in evidenza le seguenti aree problematiche, rispetto alle quali sono formulate alcune proposte operative:
1) Elevato utilizzo dell’auto, nonostante la presenza di distanze e di tempi contenuti degli spostamenti. Proposte: 1.1) costruzione di parcheggi presso le stazioni di treni, metropolitane e autobus (di
origine e di destinazione), anche con possibilità di utilizzo gratuito per chi in possesso di un abbonamento dei mezzi pubblici;
1.2) realizzazione e/o ampliamento delle aree di sosta per mezzi a due ruote presso i nodi di interscambio;
1.3) creazione di nuovi servizi di trasporto pubblico aziendali tra i comuni, con il potenziamento (aumento di frequenza) dei servizi esistenti, soprattutto di quelli tra i comuni (tramite forme differenziate di finanziamento, sovvenzioni e partenariato con soggetti privati);
1.4) disincentivazione della possibilità di parcheggiare presso le sedi di lavoro e, contestuale, incentivazione tramite la presenza di posti riservati a categorie particolari di utenti;
1.5) attivazione di politiche di ZTL, creazione di Zone30, chiusura dei centri cittadini per favorire gli spostamenti di pedoni e ciclisti.
2) Debole ricorso alle modalità di spostamento lente.
Proposte: 2.1) incremento del sistema infrastrutturale ciclo-pedonale per migliorare la qualità
dell’ambiente urbano, in particolare nei comuni più piccoli; 2.2) realizzazione di punti di noleggio biciclette, ciclofficine, ciclostazioni, servizi di bike
sharing, anche in corrispondenza di stazioni ferroviarie; 2.3) realizzazione di interventi di ergonomia ambientale finalizzati a valorizzare le
infrastrutture per la mobilità lenta (percorsi segnalati, informazioni sulle distanze pedonali, ringhiere pedonali…).
3) Utilizzo di auto molto inquinanti, in particolare per chi proviene da più lontano.
Proposte: 3.1) creazione di sistemi di incentivo all’acquisto di veicoli con alimentazione meno
inquinante; 3.2) promozione di abbonamenti al trasporto pubblico a prezzi agevolati; 3.3) disponibilità di un’auto (car sharing) per completare l’ultimo tratto del viaggio da
parte di chi proviene da Milano.
4) Scarso livello di consapevolezza sulle conseguenze negative dell’uso dell’automobile.
176
Proposte: 4.1) avvio di azioni mirate a consentire la valutazione critica dei propri comportamenti di
mobilità (esempio “misuriamo le emissioni”, migliore utilizzo delle tecnologie e delle apparecchiature);
4.2) consulting personale e avvio di interventi informavi e formativi di breve periodo mirati ai soggetti più sensibili al cambiamento (communities, per es. lavoratori neo-assunti, giovani e bambini, nuovi residenti, immigrati) per supportare i cittadini nell’individuazione delle alternative di viaggio;
4.3) promozione dell’utilizzo di tecnologie di comunicazione mobile a supporto della mobilità sostenibile.
11.3 – Analisi delle proposte operative per area problematica
Con attenzione alle aree problematiche sopra descritte, al termine del progetto è stato realizzato un censimento presso le amministrazioni comunali coinvolte finalizzato a rilevare la presenza di interventi pertinenti e a metterne in evidenza le principali caratteristiche. È stata definita e distribuita ai Comuni una “scheda di rilevazione” per censire gli interventi di mobilità sostenibili, già realizzati o in progetto, e approfondirne contenuti e caratteristiche, con l’obiettivo di valutarne l’efficacia e selezionare le azioni replicabili con maggiori possibilità di successo nel territorio di riferimento. La scheda è stata strutturata in forma matriciale, richiedendo al compilatore di indicare:
- Stato di avanzamento dell’intervento (se già realizzato o in corso di progettazione). - Anno di attivazione dell’intervento (con orizzonte temporale comunque non più addietro di
tre anni fa). - Quantificazione numerica degli interventi di riferimento. - Inserimento/presenza dell’intervento in documenti di pianificazione. - Portata territoriale, intesa sia come scala di attuazione (che potrebbe coinvolgere più
amministrazioni e/o attori pubblici/privati) sia come vastità delle ricadute del progetto (comunale, sovracomunale).
- Eventuali riferimenti normativi, in relazione anche a Piani/Programmi previsti dalle leggi in materia.
Più in dettaglio la scheda di rilevazione utilizzata è riportata nella sezione che segue. Scheda di rilevazione Comune di: …………………………………………… Con attenzione agli ultimi 3 anni, per ogni intervento di mobilità sostenibile indicare:
Se l’intervento è presente, indicare:
Stato intervento
Anno di attivazione
Numero di interventi
Documenti di pianificazione
in cui è inserito
Portata territoriale
(es. comunale,
sovra-comunale…)
Riferimenti normativi
1) Problema
177
Elevato utilizzo dell’auto, nonostante la presenza di distanze e di tempi contenuti degli spostamenti Interventi:
costruzione di parcheggi per auto di scambio con treni, metropolitane e autobus
Esistente
Non esistente In progetto
costruzione di parcheggi per motociclette di scambio con treni, metropolitane e autobus
Esistente
Non esistente In progetto
costruzione di parcheggi per biciclette con treni, metropolitane e autobus
Esistente
Non esistente In progetto
possibilità di utilizzo gratuito dei parcheggi per chi in possesso di un abbonamento dei mezzi pubblici
Esistente
Non esistente In progetto
creazione di nuovi servizi di trasporto aziendali tra i comuni con il potenziamento (aumento di frequenza) dei servizi esistenti, soprattutto di quelli tra i comuni (tramite forme differenziate di finanziamento, sovvenzioni e partenariato con soggetti privati)
Esistente
Non esistente In progetto
disincentivazione della possibilità di parcheggiare presso le sedi di lavoro e, contestuale attivazione di politiche di ZTL
Esistente
Non esistente In progetto
creazione di Zone 30
Esistente
Non esistente In progetto
chiusura dei centri cittadini al traffico veicolare per favorire gli
Esistente
Non esistente
178
spostamenti di pedoni e ciclisti
In progetto
2) Problema Debole ricorso alle modalità di spostamento lente
Interventi:
incremento del sistema infrastrutturale ciclo-pedonale
Esistente
Non esistente In progetto
realizzazione di punti di noleggio biciclette, ciclofficine, realizzazione di ciclostazioni, servizi di bike sharing;
Esistente
Non esistente In progetto
realizzazione di interventi di ergonomia ambientale e di arredo urbano finalizzati a valorizzare le infrastrutture per la mobilità lenta (percorsi segnalati, informazioni sulle distanze pedonali, ringhiere pedonali…).
Esistente
Non esistente In progetto
3) Problema Utilizzo di auto molto inquinanti, in particolare per chi proviene da più lontano.
Interventi:
creazione di infrastrutture di alimentazione meno inquinante (GAS, gpl)
Esistente
Non esistente In progetto
promozione di abbonamenti al trasporto pubblico a prezzi agevolati
Esistente
Non esistente In progetto
creazione di un punto di car sharing
Esistente
Non esistente In progetto
4) Problema
179
Scarso livello di consapevolezza sulle conseguenze negative dell’uso dell’automobile Interventi:
avvio di azioni mirate a consentire la valutazione critica dei propri comportamenti di mobilità (esempio “misuriamo le emissioni”, migliore utilizzo delle tecnologie e delle apparecchiature)
Esistente
Non esistente In progetto
consulting personale e avvio di interventi informavi e formativi di breve periodo mirati ai soggetti più sensibili al cambiamento (communities, per es. lavoratori neo-assunti, giovani e bambini, nuovi residenti, immigrati) per supportare i cittadini nell’individuazione delle alternative di viaggio
Esistente
Non esistente In progetto
promozione dell’utilizzo di tecnologie di comunicazione mobile a supporto della mobilità sostenibile (esempi: pannelli informativi sullo stato del traffico, parcheggi disponibili…)
Esistente
Non esistente In progetto
La rielaborazione delle schede di rilevazione, contenenti i progetti di mobilità sostenibile indicati dai responsabili/referenti comunali, mostra la seguente fotografia. I Comuni hanno una forte abitudine ad intervenire nell’area 2 “debole ricorso alle modalità di spostamento lente” (in particolare con riferimento alla realizzazione di piste ciclabili), in quanto è un’area problematica rispetto alla quale si interviene con modalità operative afferenti alla sfera dei Lavori Pubblici, nella quale gli uffici tecnici degli enti locali possono sicuramente vantare una lunga tradizione e competenze consolidate. I Comuni hanno anche consuetudine ad intraprendere iniziative, anche di rilievo, nell’area 1 “elevato utilizzo dell’auto”: anche in quest’area, si rileva che le amministrazioni hanno sviluppato
180
soprattutto progetti di carattere infrastrutturale (in particolare, realizzazione di parcheggi) piuttosto che aver definito politiche per il governo della mobilità (ad esempio, provvedimenti di regolamentazione del traffico). Più limitate sono le esperienze nelle aree 3 “utilizzo di auto molto inquinanti” e 4 “scarso livello di consapevolezza”, rispetto alle quali non è forse ancora maturata la giusta consapevolezza e di conseguenza non vi sono progetti organici per affrontare i problemi rilevati. Nel complesso, le azioni dei Comuni appaiono piuttosto robuste ma disarticolate se le si considera in un’ottica sovracomunale in quanto, anche quando più Comuni applicano i medesimi interventi, questi sono a volte temporalmente disallineati. N.B. Il Comune di Pero risulta inserito sempre nella colonna “non indicato” perché non è stata restituita la scheda di rilevazione compilata. Come prospettive di intervento, pare significativo fare emergere e consolidare le connessioni tra le aree problematiche e le risposte date dai Comuni: ad esempio rispetto alle aree 1 “elevato utilizzo dell’auto” e 2 “debole ricorso alle modalità di spostamento lente”, ed alle rispettive risposte individuate e più praticate, realizzazione di parcheggi per auto e per bici da un lato e realizzazione di piste ciclabili dall’altro, occorre intensificare gli sforzi affinché il disegno della rete complessiva dei percorsi ciclabili preveda come itinerari portanti le direttrici verso i nodi di interscambio (concentrando le risorse disponibili a completare i tratti mancanti) e non vada a confliggere con la maglia viaria di adduzione alle stazioni e ai parcheggi di prossimità per le automobili. È auspicabile che questi interventi siano accompagnati da un rafforzamento delle politiche di gestione dei flussi nel reticolo viario, sviluppando parallelamente iniziative di “consulting” volte a diffondere un uso appropriato e civile dei diversi mezzi di trasporto e a fare maturare la consapevolezza dell’impatto che gli spostamenti che ogni individuo effettua hanno sulla qualità della propria vita (in termini di inquinamento atmosferico, consumi energetici, dispersione di tempo che potrebbe essere dedicato ad altre attività o alla vita personale). Le iniziative di “consulting” potrebbero costituire anche occasione per diffondere e promuovere tra i cittadini l’utilizzo delle ITC, le tecnologie di comunicazione mobile a supporto della mobilità sostenibile, mentre per favorire la diffusione delle buone pratiche nel territorio, un’azione specifica mirata ai tecnici degli uffici comunali (indicazione emersa anche nei tavoli di lavoro) può essere la costituzione di una banca data comune informatizzata, da mantenere costantemente aggiornata.
Tabella - Prospetto delle azioni per Comune
Non indicato Non esistente In progetto Esistente 1) Problema Elevato utilizzo dell’auto, nonostante la presenza di distanze e di tempi contenuti degli spostamenti
Interventi:
costruzione di parcheggi per auto di scambio con treni, metropolitane e autobus
PERO ARESE LAINATE
BOLLATE GARBAGNATE
costruzione di parcheggi per motociclette di scambio con treni, metropolitane e autobus
PERO ARESE BOLLATE LAINATE
GARBAGNATE
181
costruzione di parcheggi per biciclette con treni, metropolitane e autobus
PERO ARESE BOLLATE
GARBAGNATE LAINATE
possibilità di utilizzo gratuito dei parcheggi per chi in possesso di un abbonamento dei mezzi pubblici
PERO ARESE BOLLATE LAINATE
GARBAGNATE
creazione di nuovi servizi di trasporto aziendali tra i comuni con il potenziamento (aumento di frequenza) dei servizi esistenti, soprattutto di quelli tra i comuni (tramite forme differenziate di finanziamento, sovvenzioni e partenariato con soggetti privati)
PERO ARESE BOLLATE GARBAGNATE
LAINATE
disincentivazione della possibilità di parcheggiare presso le sedi di lavoro e, contestuale attivazione di politiche di ZTL
PERO ARESE GARBAGNATE LAINATE
BOLLATE
creazione di Zone 30
PERO ARESE BOLLATE GARBAGNATE LAINATE
chiusura dei centri cittadini al traffico veicolare per favorire gli spostamenti di pedoni e ciclisti
PERO ARESE LAINATE BOLLATE GARBAGNATE
2) Problema Debole ricorso alle modalità di spostamento lente
Interventi:
incremento del sistema infrastrutturale ciclo-pedonale
PERO ARESE ARESE BOLLATE
GARBAGNATE LAINATE
realizzazione di punti di noleggio biciclette, ciclofficine, realizzazione di ciclostazioni, servizi di bike sharing;
PERO GARBAGNATE LAINATE ARESE BOLLATE
realizzazione di interventi di ergonomia ambientale e di arredo urbano finalizzati a valorizzare le infrastrutture per la mobilità lenta
PERO ARESE BOLLATE LAINATE GARBAGNATE
182
(percorsi segnalati, informazioni sulle distanze pedonali, ringhiere pedonali…).
3) Problema Utilizzo di auto molto inquinanti, in particolare per chi proviene da più lontano.
Interventi:
creazione di infrastrutture di alimentazione meno inquinante (GAS, gpl)
ARESE LAINATE PERO
BOLLATE GARBAGNATE
promozione di abbonamenti al trasporto pubblico a prezzi agevolati
ARESE GARBAGNATE LAINATE
PERO
BOLLATE
creazione di un punto di car sharing
ARESE LAINATE PERO
BOLLATE GARBAGNATE
4) Problema Scarso livello di consapevolezza sulle conseguenze negative dell’uso dell’automobile
Interventi:
avvio di azioni mirate a consentire la valutazione critica dei propri comportamenti di mobilità (esempio “misuriamo le emissioni”, migliore utilizzo delle tecnologie e delle apparecchiature)
ARESE LAINATE PERO
BOLLATE GARBAGNATE
consulting personale e avvio di interventi informavi e formativi di breve periodo mirati ai soggetti più sensibili al cambiamento (communities, per es. lavoratori neo-assunti, giovani e bambini, nuovi residenti, immigrati) per supportare i cittadini nell’individuazione delle alternative di viaggio
ARESE LAINATE PERO
BOLLATE GARBAGNATE
promozione dell’utilizzo di tecnologie di comunicazione
ARESE PERO
GARBAGNATE BOLLATE LAINATE