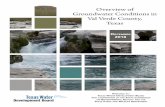La Intuición como vórtice. Las propuestas pedagógicas de José Val del Omar
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia (2014)
-
Upload
multiagent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia (2014)
RIVISTA ITALIANADI
NVMISMATICAE SCIENZE AFFINI
FONDATA DA SOLONE AMBROSOLI NEL 1888EDITA DALLA SOCIETA NUMISMATICA ITALIANA ONLUS - MILANO
VOL. CXV
2014
Estratto
INDICE
MATERIALI
F.M. VANNI, I reperti provenienti dal busto reliquiario di San Do-nato: monete e medagliette di pieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15
L. GIANAZZA, F. FORNACCA, Conii e punzoni nelle raccolte del comu-ne di Masserano e degli archivi Alberti La Marmora . . . . . » 39
SAGGI CRITICI
L. LAZZARINI, Cirene. Note sull’inizio della monetazione, su una pic-cola collezione di nummi enei e su due inediti . . . . . . . . . . » 91
P. VISONA, Out of Africa. The Movement of Coins of Massinissa andhis Successors across the Mediterranean. Part Two . . . . . . . » 107
C. PERASSI, Le cavigliere di Heliodora. Fonti scritte per lo studio dellagioielleria monetale romana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 139
R. ARICO, L’emissione occidentale del follis anonimo di classe C » 173
C. CUCINI TIZZONI, La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 185
F. PIGOZZO, Un tesoretto di solidi aurei rinvenuto nel XV secolo » 231
MEDAGLISTICA
A. BERNARDELLI, Un elenco di conii delle medaglie di Valerio Belli » 243
W. HAHN, G. GIROLA, Paranumismatica of Amedeo, Duke of Aosta,Viceroy of Ethiopia (1937-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 283
NOTE E DISCUSSIONI
A. SAVIO, A. CAVAGNA, Appunti di numismatica alessandrina II.Alessandria e Nomoı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 291
A. GIULIANI, La ‘‘maesta cattolica’’ e il nuovo ufficio della zecca aqui-lana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 329
T. LUCCHELLI, Dal Cairo a Brera: una moneta del nomo Ombites inuna lettera di Eduard Ruppell a Gaetano Cattaneo (1822) » 335
RECENSIONI E SEGNALAZIONI
T. LUCCHELLI: M. Asolati, G. Gorini (a cura di), I ritrovamentimonetali e i processi storico-economici nel mondo antico . . . » 349
G. GORINI: E. Kolnıkova, Nemcice. Ein Macht-, Industrie- undHandelszentrum der Latenzeit in Mahren und Siedlungenam ihren Rande. Kommentierter Fundkatalog. Munzen . . . » 351
G. GIROLA: I. Vecchi, Etruscan Coinage. Part 1. A Corpus of theStruck Coinage of the Rasna, together with an Historical andEconomic Commentary on the Issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 357
A. CAVAGNA: P. Aydemir, M. Ozsaygi, G. Semeraro, A. Travagli-ni, Museo di I
.zmir. III. Monete greche . . . . . . . . . . . . . . . » 359
T. LUCCHELLI: F. Sinisi, Sylloge Nummorum parthicorum, NewYork - Paris - London - Vienna - Teheran - Berlin, VII, Vo-logases I - Pacorus II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 360
A. SAVIO: F. Catalli, Sylloge Nummorum Romanorum Italia, Firen-ze, Monetiere del Museo Archeologico Nazionale, volume I,Caesar Augustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 363
R. FONTANA: S. Bani, M. Benci, A. Vanni (a cura di), I medaglioniromani provinciali e contorniati nelle raccolte del Museo Ar-cheologico Nazionale di Firenze, I-II . . . . . . . . . . . . . . . . . » 367
L. TRAVAINI: F. Gambarotta, L. Polansky, Italian Coins in the Na-tional Museum of Prague, I.1. Old Collection. Middle Agesand Early Modern Period (IX-XVI centuries) . . . . . . . . . . . » 369
M. GIONFINI: A. Toffanin, Monete Italiane Regionali. Vol. XI - Mi-lano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 370
L. TRAVAINI: M. Biddle (ed. by), The Winchester Mint and Coinsand Related Finds from the Excavations of 1961-71 . . . . . » 370
Indice10
C. PERASSI: A. Crisa, Numismatic and Archaeological Collecting inNorthern Sicily during the First Half of the Nineteenth Centu-ry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 373
G. GIROLA: A. Modesti, Leone XIII nella medaglia (1878-1903) » 377
IN MEMORIA DI CESARE JOHNSON
R. JOHNSON e M. JOHNSON: Cesare Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . » 381
G. GIROLA: Cesare Johnson e i suoi rapporti con la Societa Numi-smatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 387
E.A. ARSLAN: Ricordo di Cesare Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 393
G. GORINI: Cesare Johnson collezionista e studioso di medaglie . . » 395
P. CRIPPA: Cesare Johnson raccontato da un commerciante numisma-tico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 401
ELENCO COLLABORATORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 407
ELENCO SOCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 409
Indice 11
RIN 115 (2014) pp. 185-230
COSTANZA CUCINI TIZZONI
LA ZECCA DEI TRIVULZIO IN VAL MESOLCINA (1526-1530).INVENTARI E TECNOLOGIA
La localizzazione della zecca dei Trivulzio in Valle Mesolcina ha costituito finodai primi decenni dell’Ottocento uno dei principali problemi storiografici di nu-mismatica trivulziana. Il recente rinvenimento di due documenti inediti all’Ar-chivio di Stato di Milano permette all’Autrice di apportare un contributo riso-lutivo alla questione. Con l’analisi dei due inventari viene ricostruita l’articola-zione interna della zecca di Roveredo e viene dimostrato che la zecca di Mesocco(inteso come luogo) non e mai esistita. Altri documenti inediti dell’archivio mi-lanese concernono i possedimenti di miniere e forni metallurgici di Gian Giaco-mo Trivulzio: viene ricostruita cosı la sua attivita come imprenditore, soprattuttonel ramo siderurgico, nella zona grigionese e nell’alto Lario, finora del tutto sco-nosciuta nella storiografia.
This paper examines a series of documents recently found in the State Archive ofMilan. Two of these provide definitive evidence to solve the lost-standing problemof the localisation of the mint of the Trivulzio family. These documents alwaysprovide information concerning the organisation of the mint of Roveredo and de-monstrate that the mint of Mesocco never existed. Other documents relate to themines and metallurgical ovens owned by Gian Giacomo Trivulzio. These docu-ments contain previously unknown information regarding his entrepreneurial ac-tivity in the siderurgy sector in the areas of Grisons and and high Lake Como.
La localisation de l’atelier des Trivulzio dans la Vallee Mesolcina a constitue,depuis les premieres decennies du XIXeme siecle, un considerable probleme histo-riographique pour la numismatique de la famille Trivulzio. La recente decou-verte de deux documents inedits aux Archives d’Etat de Milan a permis a l’auteur
d’y apporter une contribution decisive. En particulier, l’analyse des deux inven-taires a donne le moyen a l’auteur de reconstruire le fonctionnement interieur del’atelier de Roveredo et de montrer que, en realite, l’atelier de Mesocco n’a jamaisexiste. L’activite d’entrepreneur, surtout dans le milieu siderurgique, de GianGiacomo Trivulzio, jusqu’a present meconnue par l’historiographie, a pu etre re-construite grace a des documents inedits des Archives milanais, concernent ses pos-sessions des mines et fours metallurgiques dans la zone des Grisons et du HautLario.
Le zecche di Mesocco e di Roveredo: una annosa questione (1)
L’identificazione della zecca mesolcinese dei Trivulzio costituisce unodei principali problemi storiografici di numismatica trivulziana, almeno dalsecondo decennio dell’Ottocento (2).
Ricorderemo che il problema verte sostanzialmente sulla localizzazionedella zecca per il feudo di Mesocco in Val Mesolcina, nella stessa Mesocco oa Roveredo. Francesco ed Ercole Gnecchi nel 1887 (3) ritenevano che a Me-socco si battesse moneta fino al 1526, quando i Grigioni distrussero o dan-neggiarono il castello per liberarsi della signoria dei Trivulzio e in conseguen-za di cio Gian Francesco trasporto la zecca a Roveredo, dove rimase operantefino al 1549. Nel 1890 Emilio Tagliabue concludeva invece che la zecca diMesocco intesa come luogo non sarebbe mai esistita, mentre la zecca del feu-do di Mesocco andava localizzata a Roveredo (4). Negli anni recenti il proble-ma e stato di nuovo affrontato, senza tuttavia sostanziali novita.
Costanza Cucini Tizzoni186
(1) Desidero ringraziare sentitamente la dottoressa Maila Chiaravalle, che ha presentatoquesto mio contributo alla ‘‘Rivista Italiana di Numismatica’’, per i preziosi consigli.
(2) La questione e ben riassunta in CHIARAVALLE 1996, pp. 3-10, a cui si rimanda perl’approfondimento dei termini della discussione critica, per i documenti d’archivio e la biblio-grafia. Si veda anche ROSSINI 2011, pp. 1364-1365.
(3) GNECCHI 1887, pp. XXIV-XXVI.(4) TAGLIABUE 1890.
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia 187
FIG. 1 - Carta delle principali localitacon indicazione delle aree minerarie citate nel testo.
La Val Mesolcina (fig. 1), oggi appartenente al Canton Grigioni dellaConfederazione Elvetica, percorsa dal fiume Moesa tributario del Ticino, euna valle alpina orientata NE-SO chiusa da alte catene montuose e posta sot-to il passo del San Bernardino. Per la sua posizione in relazione a questo im-portante sbocco, essa ha sempre costituito un corridoio diretto di comunica-zione – militare e non – fra la Lombardia e le aree di lingua tedesca (5). I duecentri principali e capoluoghi di Vicariato, Mesocco (alt. 791 m. s.l.m.) eRoveredo (alt. 292 m s.l.m.), distano in linea d’aria 17,5 km circa ed eranoun tempo collegati da una strada che correva nel fondovalle, sulla sponda de-stra del fiume. Per quattro secoli la Val Mesolcina e la vicina e parallela ValCalanca costituirono il feudo della famiglia dei de Sacco (o Freiherren vonSax), che lo cedettero a Gian Giacomo Trivulzio nel 1480 (6). Nel 1493 que-st’ultimo comprese nei suoi domini negli attuali Grigioni l’alta valle del Reno(Rheinwald) e la valle di Stossavia (Safiental), situate al di la del passo del SanBernardino (7). Tutte queste acquisizioni avvennero con l’appoggio e nell’in-teresse dello stato di Milano, che aspirava ad estendere, tramite il Trivulzio,la propria influenza e controllo militare su questa zona di confine (8).
Il castello di Mesocco (9) sorge quasi in fondo alla Val Mesolcina in ter-
Costanza Cucini Tizzoni188
(5) Sulle peculiari caratteristiche di questa valle di confine linguistico, politico e religio-so nel ’500 e ’600 si veda DI FILIPPO BAREGGI 2006, in particolare pp. 41-44.
(6) Il 20 novembre 1480 il Trivulzio formalizzo l’acquisto del feudo, ratificato poi dal-l’imperatore Federico III d’Asburgo l’11 novembre 1487 (TAGLIABUE 1889, p. 234). La vicen-da e riassunta da ROSSINI 2011, pp. 1361-1362. La valle faceva parte della Lega Grigia gia dal1424, contraente Giovanni De Sacco; sotto i De Sacco e i Sax-Mesocco la Mesolcina seguıinfatti le sorti delle altre comunita alpine coeve che daranno poi vita alla Lega Grigia (DI FI-
LIPPO BAREGGI 2006, p. 44).(7) Il Trivulzio acquisto queste due signorie dal conte Giorgio di Werdemberg e Sar-
gans (TAGLIABUE 1890, p. 390; TAGLIABUE 1927, pp. 20-21, 23-24; ROSSINI 2011, p. 1362).Tale acquisto, effettuato contro la volonta della Lega Grigia, garantiva pero, ai comuni, libertadi azione politica; su queste complesse vicende si veda da ultimo ARCANGELI 2003, p. 36 e nota106.
(8) Tuttavia, dopo la rottura con Ludovico il Moro nel 1494, il Trivulzio divenne ade-rente dei Grigioni; avendo stipulato con questi ultimi, due anni dopo, un patto di alleanza eaiuto reciproco, si era impegnato ‘‘a fare del castello di Mesocco ‘casa aperta’ per la Lega e a for-nire artiglierie e grano in cambio della difesa armata dei suoi possedimenti: e questo nell’interessedella Francia’’ (ARCANGELI 2003, pp. 36-37). Sullo scorcio del XV sec. (anni 1496-1498) GianGiacomo Trivulzio era dunque, contemporaneamente, feudatario imperiale per la Mesolcina eper Mesocco, feudatario del vescovo di Coira per il Rheinwald e il Safiental, membro dellaLega Grigia, nonche cittadino di Milano e titolare di baronie nel Regno di Napoli e in Fran-cia.
(9) Si tratta della fortezza piu importante del Canton Grigioni e una delle principalidella Svizzera. La sua articolazione interna comprendeva il palazzo comitale a tre piani, duechiese, il mastio a sette piani, cisterna, prestino, magazzini e fucina (TAGLIABUE 1889, p. 238).
ritorio aspro e montuoso, in posizione dominante a controllo della strada, suuno sperone roccioso e dirupato che attraversa la valle stessa, di cui costituisceun possente sbarramento naturale. Il castello, considerato inespugnabile, sor-geva a controllo dell’importante via del San Bernardino che collegava la Lom-bardia ducale alla valle del Reno (10). Il problema principale concernente l’e-sistenza o meno di una zecca a Mesocco riguarda la mancanza, nei documentidell’epoca, di un’esplicita menzione di una o piu stanze del castello adibite aquesto scopo. Due inventari citano tuttavia la presenza di strumenti da zecca:il 18 marzo 1511 vengono menzionati un armadio ‘‘con crosoli 12 per la zecha’’e ‘‘cassa una piena de feramenta de la Zecha, ingiodata [...] nella camera bian-cha’’ del castello, stessa cassa che ritroviamo, nella stessa camera bianca e an-cora inchiodata, il 1 settembre 1517 (11). Mentre la citazione della zecca diMesocco nei diplomi imperiali viene per lo piu considerata generica e da ri-ferirsi a tutto il feudo omonimo (12), vi e comunque una notizia documentariaconsiderata piu significativa. Il 12 febbraio 1499 il podesta Leonardo Bottascriveva a Ludovico il Moro circa il soggiorno ad Angera di un mulattieredi Gian Giacomo Trivulzio che trasportava, per suo conto, quattro casse pienedi ‘‘croxoli da fondere arzento [...] a Mesocho per adoperarli a la Cecha’’ (13).
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia 189
(10) Tramite la via del Vogelberg o San Bernardino transitavano le merci e i prodottidel Milanese, provenienti dal passo di San Jorio, dal Monte Ceneri e dal Lago Maggiore, versola valle del Reno e l’Oberland grigionese (TAGLIABUE 1927, p. 6). Gian Giacomo Trivulzio, daluogotenente regio, aveva inoltre esteso i suoi possessi su Chiavenna, che controllava la stradadei Grigioni e collegava la Val Bregaglia a Milano; come membro della Lega Grigia, e signoredi uno stato confinante con gli Svizzeri, egli offriva alla Francia la possibilita di interveniremilitarmente o diplomaticamente in una zona con strade di importanza vitale, ma cio lo ren-deva pericoloso e infido agli occhi dei Grigioni: su tutto cio ARCANGELI 2003, pp. 55 e 57-58.
(11) TAGLIABUE 1890, p. 386; SANTI 1988, p. 138; CHIARAVALLE 1996, p. 6 nota 18; daultimo ROSSINI 2011, p. 1364.
(12) I quattro diplomi imperiali a cui fanno riferimento tutti gli autori che si sono oc-cupati della questione sono i seguenti: 1) 18 novembre 1487: l’imperatore Federico III d’A-sburgo, stando in Norimberga, ratificava l’acquisto della Mesolcina da parte di Gian GiacomoTrivulzio e gli concedeva l’investitura del feudo di Mesocco, compreso ‘‘il diritto di batter mo-neta d’oro e d’argento in detto castello o nel suo territorio’’; 2) 2 marzo 1496: Luigi d’Orleans,allora duca di Milano (e futuro re Luigi XII), stando in Amboise rilasciava a Gian GiacomoTrivulzio patenti per battere moneta allo stampo e bonta di quelle di Asti e di Francia ‘‘inCechia sua Mesochi’’; 3) 1501: l’imperatore Massimiliano I conferma al Trivulzio il dirittodi battere moneta nella zecca di Mesocco; 4) 1 maggio 1512: Luigi XII, ormai re di Francia,stando in Blois, concedeva a Gian Giacomo Trivulzio di aprire zecca a Musso e di coniarvimonete d’oro e d’argento, come gia faceva ‘‘au lieu de Mesoc’’ e alla bonta di quelle di Milano.Questo privilegio fu confermato il 1 gennaio 1515 dal re di Francia Francesco I di Valois aParigi, e poi ratificato l’8 marzo dello stesso anno dal Senato di Milano. Per tutto cio CHIA-
RAVALLE 1996, p. 5, con riferimenti archivistici e bibliografia; ROSSINI 2011, p. 1367.(13) TAGLIABUE 1890, p. 373 e nota 16; lo studioso riteneva che i crogioli servissero a
fondere metalli o per fare assaggi di minerali argentiferi, pp. 385-386. Sulle vicende di questo
Roveredo e invece al centro della Bassa Mesolcina, detta anche VallePiana, in territorio ben piu agevole per l’insediamento umano e piu favore-vole ai commerci e alle comunicazioni con il Ducato di Milano e i Confe-derati. Qui Gian Giacomo aveva acquisito dai de Sax un palazzo fortificato,che divenne la residenza dei Trivulzio, mentre la sede della zecca era postanelle vicinanze in un possente edificio conservato fino agli inizi del Novecen-to, in testa al Ponte di Valle (14): nessun dubbio quindi sull’esistenza di unazecca in questa localita. Qui risiedevano anche i Commissari amministrativi efiscali dei Trivulzio (15). Inoltre Roveredo e molto vicina – 18 km in linead’aria – al castello e al feudo di Musso, che Gian Giacomo aveva ricevutoin dono dai Malacrida nel 1508, dove aveva aperto una zecca e batteva mo-neta dal 1517 (16): le due localita sono separate da una dorsale alpina, ma pos-sono comunicare direttamente tramite il passo del San Jorio (17) (alt. 2014 ms.l.m.) e la valle Albano.
Finora la questione della zecca mesolcinese e rimasta sostanzialmenteaperta, in mancanza di elementi probanti definitivi, documentari o numi-smatici che fossero. Il recente rinvenimento, nell’Archivio di Stato di Mila-no, di due documenti inediti risalenti agli anni Venti del Cinquecento ap-porta un nuovo contributo alla questione finora ritenuta di impossibile solu-zione (18). Si tratta di due inventari, redatti certamente negli stessi anni. Il
Costanza Cucini Tizzoni190
documento CHIARAVALLE 1996, p. 5 nota 11. Non e possibile stabilire se questi siano gli stessicrogioli ancora presenti nel 1511.
(14) TAGLIABUE 1890, p. 378. Cessato l’utilizzo originario nel 1549, l’edificio divennesede del tribunale criminale e poi prigione, sebbene continuasse ad essere chiamato ‘‘zecca’’;all’inizio del XX secolo si conservavano ancora, nei suoi sotterranei, conii e attrezzi da zecca(ROSSINI 2011 p. 1366). Il palazzo era un raro esempio, nei Grigioni, di castello di pianuracircondato dal fossato, con torre d’entrata, giardini e peschiera; si vedano le ricostruzioni gra-fiche fatte dagli archeologi di fine ’800 - primi ’900 in MARCACCI 2011, con bibliografia es-senziale. Di esso resta soltanto un lacerto di muro della torre.
(15) Per tutto cio CHIARAVALLE 1996, p. 19 nota 75.(16) Il Trivulzio era stato autorizzato a battere moneta a Musso nel 1512 col diploma
sopra citato di Luigi XII. Sulla zecca di Musso si vedano GIROLA 2003, p. 329 e GIROLA 2011.Il possessore Biagio Malacrida dono Musso al Trivulzio per scongiurare la confisca francese;l’apertura di una zecca in questa localita sarebbe avvenuta a compenso della perdita di quelladi Mesocco, occupato dai Grigioni (TAGLIABUE 1927, p. 30 nota); si sarebbe trattato comun-que di un intervento indiretto dei francesi in una zona d’influenza svizzero-grigiona. Per tuttocio ARCANGELI 2003, p. 55 nota 160 e p. 56.
(17) Il passo del San Jorio, oggi in disuso, un tempo era di notevole importanza permettere in comunicazione il Lago di Como con Bellinzona e la Mesolcina. Il castello di Mussopasso nel 1523 a Gian Giacomo de’ Medici detto il Medeghino, che ne fece il centro del suopotere e da dove scateno una serie di guerre che interessarono per anni, con pesanti ripercus-sioni, tutta la zona in oggetto, dette appunto ‘‘guerre di Musso’’.
(18) CHIARAVALLE 1996, pp. 8-9.
primo e un Quinternetto dele robe portate fora di castelo 1526 et vendute (19) esi riferisce a Mesocco. Il secondo documento, senza data, ma contenuto inuna cartelletta con l’indicazione 15.., e relativo a Roveredo (20); vedremoche esso venne redatto poco prima che questa zecca, nel 1529, venisse datain appalto a Dionigi Besson di Lione da parte di Gian Giorgio Albriono, pro-curatore del marchese Gian Francesco Trivulzio.
Per facilitare la comprensione della complessa vicenda e preferibile tut-tavia analizzare per primo il documento relativo a Roveredo.
La zecca di Roveredo: l’organizzazione e la tecnologia
La zecca di Roveredo viene descritta nell’‘‘Inventario de le stampe asia-menti et ferramenti usidelj et altre cose’’ di spettanza della zecca stessa che sitrovavano, al momento della redazione, nella ‘‘casa de lo Illustrissimo signormarchese conte de Musocho quale ha in Rovereto et dove se fa lavorare la Ce-
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia 191
(19) ASMi, Famiglia Trivulzio, fondo detto Archivio Novarese, cart. 34. Non e certoprobabile che i due documenti siano sfuggiti a studiosi attenti come gli Gnecchi, il Tagliabueed il Motta: e vero che si tratta di due inventari di soggetto tecnologico e quindi poco inte-ressanti per la storiografia della fine dell’Ottocento; ma soprattutto essi sono di lettura assaidifficoltosa a causa del lessico tecnico molto specialistico. Non si puo escludere quindi chegli Gnecchi abbiano visto l’inventario del 1526: la loro tesi secondo la quale la zecca di Me-socco fu attiva fino a quell’anno, quando il castello venne distrutto dai Grigioni e Gian Fran-cesco trasferı la sua zecca a Roveredo, puo essere ben supportata dal documento in esame(GNECCHI 1887, pp. XXV-XXVI). Anche Emilio TAGLIABUE 1890, pp. 382, 387 fa riferimentoa questo trasferimento. Il documento fu certamente visto da Savina TAGLIABUE 1927 p. 39, chelo utilizza e ne riporta alcuni stralci. All’epoca esso era conservato nel fondo archivistico dettoLuogo Pio Trivulzio, cartella 34, poi divenuto Archivio Trivulzio detto Novarese, anche se ilnumero della cartella rimase invariato. Il documento e parte integrante di un fascicoletto con-tenente, oltre alla parte relativa alle attrezzature di zecca, anche vari elenchi di armi e muni-zioni aggiunti a piu riprese in vari periodi. Sembra che il documento sia stato edito da EmilioMotta in un numero unico della rivista grigionese ‘‘Il San Bernardino’’ del 12.9.1926, coltitolo Quinterneto de le robe portate fora del castello vendute et mandate a Rovere al Seraval. Taleedizione e citata solo da SANTI 1988: nessuno degli studiosi che si sono occupati dei Trivulziovi fa riferimento; la ricerca nelle biblioteche lombarde e svizzere non ha dato finora risultati.Riteniamo quindi utile fornire qui l’edizione del documento, per la parte concernente la zecca,visto che quella del Motta risulta irreperibile (Appendice, documento I).
(20) ASMi, Famiglia Trivulzio, fondo detto Archivio Novarese, cart. 34. Il documentoe inserito in una cartelletta ottocentesca sul cui frontespizio si legge ‘‘Zecca di Misocco. 15..’’.Il documento doveva costituire la minuta dell’inventario, infatti reca cancellazioni e correzio-ni. Si notano inoltre alcune note e trascrizioni eseguite a matita di alcune parole di difficilelettura, spesso pero sciolte erroneamente, redatte in una calligrafia riconducibile alla finedell’’800 o primi ’900. Il documento risulta finora inedito. Per l’edizione si veda Appendice,documento II.
cha’’ (21). Quindi all’epoca della stesura del documento, a Roveredo esistevauna casa dei Trivulzio dove era attiva una zecca. In realta, l’esistenza di taleimpianto e attestata gia a partire dal 1497 (22). L’edificio tuttavia doveva aversubıto dei danni, non sappiamo di quale entita, a seguito di un incendio: in-fatti mancavano i fornelli per fare gli assaggi che erano ‘‘stati desfati quando sebruso dita casa’’. Sappiamo in effetti che nel 1511 vi furono a Roveredo varieincursioni dei Confederati e dei Grigioni, in seguito alle quali sembra venissebruciato il palazzo dei Trivulzio (23) . Inoltre la zecca dovette essere abbando-nata per un certo tempo, poiche un grosso mantice risultava ‘‘mangiato darati’’ e doveva essere riparato. Forse la zecca doveva essere riattata e rimessain funzione dopo un periodo di – forzata? – inattivita, poiche l’inventariovenne redatto per essere inviato al maestro che verosimilmente doveva lavo-rarvi (24). Inoltre l’estensore del documento esprime alcune considerazionipersonali nell’ultimo foglio (25), a proposito di dove reperire comodamenteabili maestranze da impiegare nella zecca mostrandosi al riguardo ottimistae concludendo che, anche se fosse andato tutto storto, il maestro avrebbe co-munque potuto prendere i suoi lavoranti dove avesse voluto, in piena liberta.
Dal documento possiamo ricostruire con discreta approssimazione l’ar-ticolazione interna della zecca di Roveredo, che si sviluppava su due livelli, unpianterreno e un primo piano. Come attestato per altri impianti produttivicoevi (26), all’epoca le maestranze vivevano all’interno dell’edificio, dove ave-
Costanza Cucini Tizzoni192
(21) Appendice, documento II.(22) Il 23 giugno 1497 Azino da Lecco, procuratore di Gian Giacomo Trivulzio e abi-
tante nella zecca di Roveredo, stipula un contratto rogato ‘‘in Pasquedo Roveredi in domo ze-che’’: TAGLIABUE 1890, p. 413, documento n. 3. Ancora, il 17 marzo 1509, un atto con cuiPaolo Gentili da Serravalle, procuratore di Gian Giacomo Trivulzio, da in affitto la decimadi Verdebbio, viene rogato ‘‘in Roveredi in Pasquedo in cecha’’; fra i testi e presente anche Za-netto, mastro di zecca: TAGLIABUE 1890, p. 415, documento n. 6. Si veda CHIARAVALLE 1996,p. 8.
(23) TAGLIABUE 1890, pp. 386-387; TAGLIABUE 1927, pp. 29-30; CHIARAVALLE 1996,p. 6 nota 18. Il documento qui discusso e la prova che effettivamente vi fu un incendio dellazecca.
(24) Sul retro del documento, lo stesso estensore annota che l’inventario viene ‘‘man-dato al maestro de la Cecha’’ e lo sigla forse con le proprie iniziali, AA. L’inattivita della zeccaper un certo periodo dopo l’incendio del 1511 era gia stata ipotizzata da TAGLIABUE 1890,pp. 386-387. Dopo la sconfitta dell’esercito francese, comandato da Gian Giacomo Trivulzio,il 20 giugno 1512, le Tre Leghe occuparono la Mesolcina, ad eccezione del castello di Me-socco. Tutta la zona rimase sotto il commissariamento della Lega Grigia per quattro anni;nel 1515, dopo la battaglia di Marignano in cui il Trivulzio sconfisse il duca di Milano, laLega Grigia gli restituı i feudi confiscati (ROSSINI 2011, p. 1362).
(25) Evidentemente aggiunto a questo scopo, perche l’inventario vero e proprio si fer-ma al foglio precedente.
(26) Ad esempio gli altoforni e le fucine da ferro preindustriali lombarde (CUCINI TIZ-
vano a disposizione locali di servizio – la cucina – e di abitazione – le camere.Non deve stupire quindi che l’inventario prenda in considerazione tutto quel-lo che esisteva all’interno della zecca, comprendendo sia strumenti e impianti,sia arredi di uso comune. Data la particolarita delle lavorazioni, con i connessiproblemi di sicurezza, e gli orari prolungati di lavoro, era infatti piu comodorisiedere non solo nello stesso stabile della zecca, ma anche in stanze adiacentie contigue a quelle dove si svolgevano le attivita produttive (27).
Per la zecca di Roveredo, l’inventario sembra seguire un ordine dal piano disopra a quello inferiore. Al primo piano vi erano due camere dove aveva abitatoGiovanni Andrea Carati di Vercelli, ‘‘maestro de le stampe’’; si passa poi al pian-terreno dove si trovavano la cucina e gli impianti, data la presenza di focolare,forni e fornelli. Presso la cucina c’era ‘‘la camera de soto’’ e, presso la porta d’in-gresso, ‘‘la camera dove dormiva el fonditore’’. Sempre al pianterreno troviamo ilocali sede degli impianti e delle lavorazioni: la ‘‘Assazoria’’, presso la quale c’era ildeposito del carbone, la ‘‘Maestrisa’’ e la ‘‘Fondaria’’, dove si svolgevano le fasi piudelicate della fabbricazione delle monete, a cui seguivano la ‘‘Stamperia’’ e la‘‘Sbateria’’. Qui di seguito prenderemo in esame solo gli ambienti produttivi.
Nelle due camere ‘‘de sopra’’ il precedente occupante, mastro GiovanniAndrea Carati, aveva lasciato – oltre a qualche elemento d’arredo – una cassacontenente molti strumenti propri della sua arte. Ricorderemo che il maestrodelle stampe era l’incisore che aveva l’importante e delicato incarico di rea-lizzare i conii, cioe di incidervi il tipo che veniva poi stampigliato sulla mo-neta. L’incisione riguardava la faccia in acciaio temperato del conio di ferroed era realizzata in negativo per imprimere in positivo e in rilievo il tipo.Quello dell’incisore era quindi un lavoro altamente specializzato, affidato ge-neralmente a buoni orefici, incisori di gemme e sigilli, che spesso si traman-davano il mestiere di padre in figlio (28). Non sappiamo se questi strumentifossero stati di sua proprieta e mastro Giovanni Andrea li avesse abbandona-ti (29), ma e piu probabile che facessero parte integrante delle dotazioni dellazecca di Roveredo.
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia 193
ZONI 1995 e CUCINI TIZZONI 1997). Anche nella zecca di Bologna nel 1574 il piano superioreera adibito ad abitazione dello zecchiere (CHIMIENTI 2001, p. 260). Piu tardi, nella Milano te-resiana, gli assaggiatori vivevano nella zecca (CUCINI TIZZONI 2010, pp. 275-276 e nota 33).
(27) Ancora il 10 marzo 1546 viene fatto l’inventario dei mobili consegnati al Com-missario Antonio Maria Gentili, mobili esistenti nella zecca di Roveredo nei locali destinatia sua abitazione (TAGLIABUE 1890, pp. 420-421 documento n. 9).
(28) TRAVAINI 2007b, pp. 29-30, 44-48.(29) Talvolta i contratti che legavano i mastri metallieri ai loro datori di lavoro veni-
vano bruscamente rescissi per cause esterne o per dissapori e litigi; e il caso, proprio qui nellazecca di Roveredo, di Dionigi Besson di Lione (TAGLIABUE 1890, pp. 393-401). Si veda inquesto contributo, testo corrispondente alle note 51-53.
Infatti nella cassa in questione si trovava innanzitutto ‘‘la spontanariavecchia’’ del signor Gian Giacomo Trivulzio. Questo particolare termine, or-mai totalmente desueto nei dialetti lombardi, era gia in disuso in questa ac-cezione nella prima meta dell’Ottocento (30). Esso serve evidentemente ad in-dicare una grossa spina di ferro, che pero doveva avere un’importanza parti-colare anche se ‘‘vecchia’’, poiche connessa strettamente a Gian GiacomoTrivulzio. L’identificazione piu probabile per questo oggetto – o forse ungruppo di oggetti – e che si tratti dei punzoni recanti l’arma o la sigla delcondottiero, che dovevano essere utilizzati per preparare il conio delle mone-te battute nelle sue zecche (31).
Nella medesima cassa erano conservate molte lime, martelli e altri uten-sili non specificati impiegati ‘‘per farer stampe’’, nonche molti torselli e pilenon lavorati. Com’e noto, il torsello e il conio di martello, o di rovescio,mentre la pila e il conio d’incudine, o di diritto, cosiddetto perche la sua baseappuntita veniva inserita nell’incudine e su di esso era posto il tondello dimetallo; al di sopra di quest’ultimo veniva appoggiato il torsello. Il colpodel martello permetteva cosı di imprimere contemporaneamente le due im-pronte sulle due facce della moneta (32). Completavano l’attrezzatura tre ban-chetti corredati dai loro torselli e ‘‘torgij’’, cioe gli incastri o morse dove in-serire e stringere i conii di incudine nel banco di lavoro, e un piccolo man-ticello. Infatti nel Cinquecento viene introdotto l’uso di banchi allungatidotati di schienale, che sostituiscono gli sgabelli impiegati nel Medioevo (33).Dentro tali banchi si custodivano anche gli attrezzi da lavoro.
L’Assazoria, cioe il locale dove venivano eseguiti gli assaggi, doveva aversubito notevoli danni, dato che risulta sguarnito e parzialmente distrutto.L’inventario elenca solo quattro pietre da fondere e i banchetti, mentre man-cavano i fornelli per fare gli assaggi che erano stati distrutti nell’incendio dellacasa della zecca. Vicino all’Assazoria c’era il deposito del carbone.
Dietro si trovava la Maestrisa, ovvero una delle sezioni piu importantidelle zecche preindustriali. Essa deve il suo nome probabilmente al fatto che
Costanza Cucini Tizzoni194
(30) Infatti il CHERUBINI 1843, s.v. Sponton e di rimando s.v. Spongignera o Spontonera,lo designa come termine dei fabbri ferrai e dei carrozzieri ad intendere uno spuntone, un ferroallungato e acuminato, o come termine dei gabellieri e panierai come una grossa spina di fer-ro. Gli spuntonieri erano invece negli eserciti dell’epoca, anche francesi, un corpo armato dispiedi da guerra, in mancanza di armi da fuoco, Nouveau Larousse Illustre, s.v. Esponton.
(31) Ci sembra francamente da escludere che si tratti di un’arma, non solo perche trop-po personale e non legata alla zecca dove era conservata, ma perche un condottiero del calibroe dell’importanza di Gian Giacomo Trivulzio non era certo armato di spiedo!
(32) Per tutto cio TRAVAINI 2007a, pp. 28-30.(33) TRAVAINI 2007b, p. 265.
vi lavorava il maestro zecchiere; la presenza di questo locale e attestata nellazecca di Mantova fino ai primi del Settecento, mentre scompare, almenocon questa denominazione, nella nuova zecca austriaca di Milano, impian-tata a partire dal 1777 (34). Piu che un’officina con impianti produttivi, laMaestrisa di Roveredo sembra una sorta di ufficio del maestro. Vi troviamoin effetti una serie di strumenti di precisione e di attrezzi e accessori propridel mastro zecchiere. Innanzitutto vari tipi di bilance di dimensioni diffe-renti – ‘‘di honesta grandeza’’, altre ‘‘molto magiori’’, ‘‘balanzeti’’ – e pesi didiversi tipi – uno grande ‘‘da marche’’, uno piccolo di ottone, pesi di piombodi varie grandezze, un peso ‘‘da pesare denarj di varie sorti’’. La bilancia e,assieme a pile e torselli, lo strumento piu importante del lavoro di zecca,tanto da risultare nell’iconografia medievale e rinascimentale identificativadella fabbricazione della moneta (35). Era essenziale infatti pesare tondellie monete in tutte le fasi della lavorazione, accertando che corrispondesseroal peso legale determinato. Evidentemente in questo locale venivano custo-diti gli strumenti essenziali alla monetazione: oltre alle bilance, soprattuttopile e torselli, conservati in una cassetta dove la guardia teneva ‘‘li stampi etlibro de li contj’’. L’inventario elenca infatti un buon numero di conii, alcuniforse non ancora recanti inciso il tipo, poiche generici; altri invece indicatiin base alle monete che dovevano fabbricare: testoni della Madonna, mezzedoppie, quattrini, soldini, cornoni, cavallotti, monete da tre soldi – le tril-line; quelli raffiguranti un ‘‘homo armato’’ recavano evidentemente S. Gior-gio che trafigge il drago (36).
Ricorderemo che la guardia, che custodiva i conii ed il libro dei conti,non era un guardiano nel senso moderno del termine. Si trattava invece diun mastro esperto che doveva controllare l’assaggiatore, infatti nell’inventarioin oggetto l’estensore scrive dapprima ‘‘assazatore’’ e poi lo cancella con untratto di penna e corregge con ‘‘guardia’’. Era infatti importante il controlloe la stretta sorveglianza nella fase delicata degli assaggi, affinche le operazionisi svolgessero correttamente, nonche l’attenta custodia dei libri contabili e dei
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia 195
(34) ASMi Finanza p.a. cart. 845, 1777 ottobre 26. La zecca di Mantova venne di-smessa nello stesso anno; alcuni macchinari e utensili furono trasportati a Milano nella nuovazecca voluta dall’imperatrice Maria Teresa (CUCINI TIZZONI 2010). ‘‘Maestrisa’’ sembra un vo-cabolo lombardo o della zona alpina, dato che e sconosciuto ad esempio a Bologna (CHIMIENTI
2001).(35) TRAVAINI 2007b, pp. 260 e 284.(36) Raffigurazione tipica del rovescio delle monete trivulziane. Non sappiamo se S.
Giorgio fosse a cavallo in armatura con elmo e lancia, o stante in armatura, con scudo, lanciae elmo (CHIARAVALLE 1996, p. 85). I ‘‘cornoni’’ del documento sono l’imitazione dei Cornabodel Monferrato (TAGLIABUE 1890, pp. 397-398, nota 91 con bibliografia).
cunei (37). E proprio relativi alla contabilita devono essere i due ‘‘carimali’’,cioe i calamai, elencati.
Nella Maestrisa si svolgevano anche altre operazioni: vi era infatti unbanco di noce dove si contavano le monete, che potevano essere tirate sucon una paletta di rame apposita, due ‘‘basneti’’ di rame (cioe due bacili)e molti vassoietti di legno, usati per trasportare i tondelli da un’officina al-l’altra (38). Infine vi si trovava poco rame ‘‘granato’’ fuso, cioe rame fuso ri-dotto in grani per essere meglio utilizzato nella formazione di una lega pre-cisa.
Ben piu attrezzata risulta la Fondaria, che costituisce la parte piu com-pleta e accessoriata della zecca di Roveredo. Qui troviamo una serie di piccoliforni di uso diverso: un fornello per fondere l’argento in crogiolo, un altroper fondere l’argento con i mantici, uno per fondere l’oro completo di unpiccolo mantice e un fornello ‘‘de fero disfato’’. Il documento non indica co-m’erano fatti questi forni, se non che erano di ferro: possiamo solo arguireche si trattasse di semplici focolari di riscaldo piu che di forni fusori veri epropri. Infatti i metalli dovevano arrivare alla zecca gia ridotti in fino e forsetitolati, non sappiamo se in lingotti o in barre; non dimentichiamo inoltreche questa di Roveredo era una fabbrica di monete erose (39), quindi granparte del metallo trattato proveniva dal riciclaggio di monete di altri stati einoltre si impiegavano gli scarti della fabbricazione (40). In ogni caso, i metallivenivano quindi solo liquefatti ed eventualmente mescolati per formare la le-ga richiesta. Oltre che per liquefare i metalli per gettarli in forme, i fornelliservivano anche a ricuocere le monete nelle varie fasi della fabbricazione. Sipuo pensare che i fornelli in questione fossero del tipo attestato nella zecca di
Costanza Cucini Tizzoni196
(37) Si veda, sempre per la zecca di Roveredo, il contratto stipulato il 4 agosto 1529 fraGiovanni Giorgio Albriono agente di Gian Francesco Trivulzio, e il mastro Dionigi Besson diLione, ASMi Archivio Novarese, cart. 29 doc. 20, edito dagli GNECCHI 1887, documento n. 1;il contratto venne redatto a Mesocco. Piu di recente ne e stato fatto un riassunto in italiano,anche se con molte inesattezze ed erronee interpretazioni: SANTI 1994. La presenza di uno opiu esperti che controllavano gli assaggi e testimoniata, pochi decenni piu tardi, nella zecca deiTizzoni nel castello di Desana (Vercelli): il 16 marzo 1567 Giovanni Pietro di Francesco Pre-vostino di Vercelli, orefice, controguardia e assaggiatore di quella zecca, assieme a GiovanniPietro Calza di Vercelli guardia della medesima zecca, ritrovano il libro delle deliberanze del1564. Anche in questo caso i due personaggi aprono il ‘‘coffano’’ – forse una cassa – conte-nente oltre al libro contabile anche pile, torselli e stampe (GAZZERA 1842, p. 100).
(38) CHIMIENTI 2001, p. 264.(39) Come e stato dimostrato da TAGLIABUE 1890, pp. 396-399, che ha studiato l’ar-
gento lavorato nel periodo dell’appalto a Dionigi Besson.(40) TAGLIABUE 1890, p. 396, Prospetto dell’argento lavorato nella zecca di Roveredo dal
23 Agosto 1529 al 15 Maggio 1530: oltre al metallo monetato si usa anche la cesaglia, cioeritagli e limature.
Bologna (41), dove con questo termine si indicavano delle strutture di ferromobili e di ridotte dimensioni rispetto ai forni in muratura fissi e piu grandi.Dato che la zecca di Roveredo doveva essere nel complesso piccola rispettoalle grandi zecche cittadine, e possibile che vi venissero impiegati solo dei for-nelli mobili, del tipo di quelli illustrati da Lazarus Ercker nel 1563 (42).
I crogioli erano per la maggior parte di creta ‘‘portati de piera’’, cioe in-seriti in un supporto di pietra; ve ne erano anche di ferro. La presenza di duesacchetti in cui era conservata la creta sembra indicare che essi fossero foggia-ti secondo il bisogno nella stessa zecca. Venivano maneggiati con l’ausilio ditenaglie di ferro ‘‘da tuore susa croxolj’’, piccole per i crogioli da oro, o grandi.
Una volta fuso, il metallo era colato con il crogiolo o con una cazza nelle‘‘prede da fondere’’ complete dei loro ferri da ogni lato, detti ‘‘intromezari’’,cioe distanziatori forse per ottenere lamine di spessore uniforme, e chiuseda ‘‘torgij’’, cioe come abbiamo visto delle piccole morse. Questi stampi inpietra, che servivano a realizzare lamine d’argento e d’oro, erano piuttosto in-gombranti e dovevano venire alloggiati in una fossa scavata nel suolo, avevanoin genere il difetto di perdere uniformita con l’utilizzo ripetuto e l’esposizioneal forte calore. Forse per questo motivo l’oro fuso veniva gettato in ‘‘doi piasterlarghe di ferro’’, che erano piu funzionali e meno soggette a usura. Sia le pietreche le piastre di ferro dovevano essere ben unte di grasso o di liscivia per fa-cilitare lo scorrimento uniforme del metallo fuso e ottenere quindi la volutasottigliezza, nonche il distacco della lamina di metallo dopo il raffreddamento,come sappiamo anche dai trattati dell’epoca (43). Le lamine erano poi tagliateai bordi per regolarizzarle, o per ricavarne due strisce di larghezza minore daritagliare in quadrelli, con dei forbicioni di ferro di varie misure – ‘‘forfesegrande da tagliari le lami de argento quando e fonduto ben in ordine’’ e piccoli.
Nella fonderia si trovavano mazze e mazzette di ferro e tenaglie piccole,impiegate per spianare le lamine e i quadrelli, mentre badili e paletta di ferroservivano probabilmente per tirarli su; l’inventario non e esplicito su questopunto, ma e probabile che lamine e quadrelli venissero sottoposti a una o piucotture per renderle piu malleabili ed evitare che si crepassero durante lospianamento. Completavano l’attrezzatura un setaccio, vagli di rame, unasecchia di legno cerchiata di ferro, una piu piccola di rame per conservareacqua e ‘‘uno gran pistono de ferro’’ mancante del relativo mortaio (44). Questi
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia 197
(41) CHIMIENTI 2001, pp. 262-263.(42) ERCKER 1563 (1968), pp. 299, 301, 302.(43) BIRINGUCCIO 1540, c. 133v-134 r. Anche MARINI 2007, pp. 88-89.(44) Si confronti l’inventario della zecca di Bologna del 15 novembre 1574 in CHIMIEN-
TI 2001 p. 268.
ultimi servivano a pestare le scorie prodotte durante le lavorazioni per recu-perare tutto il metallo e, come mostrava anche l’Encyclopedie (45), essendo digrandi dimensioni, venivano impiegati tramite l’ausilio di un bilico, cioe diun semplice meccanismo ad altalena a cui era collegato il pesante pestello,per percuotere le scorie entro il grosso mortaio poggiato sul pavimento dellafonderia.
Nella Stamparia le attrezzature risultano molto ridotte, dato che consi-stono soltanto in alcuni banchi ‘‘da stampari’’, due padelle ‘‘da purgare da-narj’’ dotate di un lungo manico per facilitare il lavoro dell’addetto al fornel-lo, una mazza di ferro e forse il sostegno in legno della bilancia – ‘‘certy li-gnamj da metter per pesare li danari’’. Era necessario ‘‘purgare’’ le monetepoiche, contenendo una certa quantita di rame, perdevano il colore dell’oroo dell’argento dato che durante la ricottura il rame diventa nero (46).
L’inventario distingue l’operazione del battere da quella di stampare;nella Sbateria si trovavano solo sette banchi per battere e cuocere le monete,anche se ne sarebbero serviti nove; vi si trovavano anche molti altri utensili‘‘prontj’’ non specificati. E probabile comunque che l’estensore del documen-to si sia confuso, dato che sembra estremamente improbabile che dei banchida lavoro servissero per cuocere le monete.
Quest’ultima parte dell’inventario risulta in effetti redatta frettolosamen-te, oppure la Stamperia e la Sbateria risultavano davvero piuttosto sguarnite.
Come si e accennato, all’inventario vero e proprio viene aggiunto unsesto foglio su cui l’estensore annota – come per se stesso – alcune conside-razioni sulle maestranze da impiegare. Sul retro il foglio reca l’intestazione‘‘Instrumenti de li beni et cose sono in la Cecha mandato al maestro de la Cecha’’e la sigla ‘‘AA ’’.
Chi e l’estensore dell’inventario? Se non e di mano di Gian Giorgio Al-briono, certo e stato fatto sotto la sua dettatura. Ma propenderei piuttostoper la prima ipotesi, dato che le considerazioni personali espresse nell’ultimofoglio costituiscono non solo delle precise indicazioni per il mastro cheavrebbe dovuto evidentemente gestire la zecca di Roveredo, ma direi ancheuna sorta di promemoria per chi avrebbe dovuto riorganizzarla, e quindi luistesso. Del resto, non si capisce come un semplice segretario o un notaioavrebbe potuto conoscere cosı bene la disponibilita di manodopera specializ-zata nella zona, o tantomeno avrebbe potuto esprimere un parere cosı perso-nale su questo aspetto organizzativo tanto delicato. E lecito pensare dunque
Costanza Cucini Tizzoni198
(45) Encyclopedie 1983, p. 532.(46) Per tutto cio, anche se riferito alla zecca austriaca di Milano, CUCINI TIZZONI
2010, p. 286.
che sia lo stesso Albriono, che proprio in quegli anni era stato nominato daGian Francesco Trivulzio Commissario della Mesolcina, ad occuparsi perso-nalmente anche del controllo delle attrezzature esistenti nella zecca di Rove-redo (47). Dal libro di conti della zecca di Roveredo da lui tenuto, sappiamoche egli spese per le riparazioni e il riordino della stessa zecca, lire imperiali623, soldi 13 e denari 9 (48). E proprio lui doveva essere la persona piu esper-ta, anche dal punto di vista tecnico, sulle lavorazioni che si svolgevano in unaofficina di questo tipo.
Infatti il 4 agosto 1529 l’Albriono, come procuratore e agente di GianFrancesco, stipula un contratto d’investitura e convenzioni per la zecca diRoveredo con mastro Dionigi Besson di Lione (49): quest’ultimo avrebbe pre-so in appalto la zecca per sei anni per fabbricare monete d’oro e d’argento.Fra le varie clausole del contratto, ve ne sono alcune che ricalcano in modopreciso l’inventario sopra analizzato. Ad esempio il Trivulzio si obbligava afar consegnare al mastro Besson ‘‘tuti gli asiamenti et ferramenti qualli se usinone la dicta cecha per el passato qualle se retroanno al presente toiendoli per in-ventario’’. Il Besson avrebbe poi riconsegnato tutto alla fine della sua locazio-ne. Inoltre il Besson avrebbe potuto prendere ‘‘maistri di stampe operarij mo-netarij che li piacerano facendo a piazer al prefato signor de Core da li paesani ethabitanti in la dicta valle piu che potera non derogando pero alla volunta deldicto magistro’’: in questo caso si riprendono puntualmente le osservazionifatte sull’ultimo foglio dell’inventario stesso, che risulta in effetti un prome-moria di quanto far inserire nel contratto.
Ci sono poi le clausole che riguardano la presenza di una guardia, cioecome abbiamo visto un esperto assaggiatore che avrebbe dovuto essere sem-pre presente a tutte le operazioni di saggio e di fabbricazione delle monete,‘‘tanto di giorne quante di nocte acadendo il bisogno’’. Questa guardia, pagatasei denari imperiali per ogni marco d’opera d’argento, era proprio lo stessoAlbriono (50), che quindi risulta altamente qualificato per tutte le operazionipiu delicate che si svolgevano in zecca. Questo spiega il ruolo di primo piano,anche sotto il profilo dell’esperienza tecnica e del saper fare specialistico, cheegli svolge in tutta la vicenda della zecca di Roveredo.
Le vicende successive di tale impianto sono note (51). Dal libro dei conti
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia 199
(47) Come dimostra l’atto del 4 Agosto 1529, citato sopra alla nota 37. L’Albriono erastato segretario di Gian Giacomo Trivulzio (TAGLIABUE 1927, pp. 44, 53).
(48) TAGLIABUE 1890, p. 395.(49) Si tratta del documento che abbiamo citato piu volte sopra, note 37 e 47.(50) TAGLIABUE 1890, p. 395.(51) TAGLIABUE 1890, pp. 403-404.
che si riferisce alla lavorazione del Besson, redatto dall’Albriono (52), sappia-mo che il mastro lionese aveva preso come compagno e socio Gabriele Tat-ti (53): in questo periodo lavoravano nella zecca diverse maestranze di Bellin-zona e della Mesolcina. Non entreremo nel merito della monetazione delBesson, non e questa la sede. In considerazione delle difficolta di esportarele monete battute sia per la pessima lega sia per la quantita eccessiva, a cuisi aggiungevano le gride milanesi che lamentavano il titolo al quale venivanoemesse, la produzione della zecca diminuı finche il mastro scappo il 16 mag-gio 1530, forse fiutando il pericolo. Laconico e il resoconto dell’Albriono:mastro Dionigi se ne e ‘‘fugito et la Cecha non ha poi piu lavorato’’. Le sueannotazioni sul libro dei conti si fermano al 15 maggio 1530, anche se l’Al-briono continuo ad amministrare i possessi dei Trivulzio fino al 1543. An-cora nel 1537 la zecca di Roveredo venne data in locazione a mastro Giovan-ni Battista d’Appiano e pare che fosse in attivita almeno fino al 1542 (54).Dopo di che ebbe inizio la decadenza, anche del palazzo che ospitava gli im-pianti (55).
Le attrezzature di zecca portate via da Mesocco
Dobbiamo ora fare un passo indietro: tre anni prima che la zecca di Ro-veredo venisse riattata e appaltata, abbiamo notizia di un trasferimento di at-trezzature dal castello di Mesocco. Mentre l’erede di Gian Giacomo, il nipoteabbiatico Gian Francesco Trivulzio, era in quel periodo riparato in Franciadopo la prigionia, la Lega Grigia aveva decretato lo smantellamento del ca-stello di Mesocco, concluso nel marzo 1526. Paolo Gentili da Serravalle, al-lora commissario dei Trivulzio, ne fu il supervisore riuscendo a limitare idanni alla fortificazione, che infatti non venne distrutta, ma solo spogliatae sguarnita (56).
Costanza Cucini Tizzoni200
(52) Il marchese Gian Francesco si appoggio completamente all’Albriono, che ammi-nistrava i possessi dei Trivulzio meticolosamente (ROSSINI 2011, p. 1363).
(53) Gabriele Tatti di Bellinzona sara poi zecchiere a Roveredo nel 1536 (ROSSINI
2011, p. 1366).(54) GNECCHI 1887, Appendice, documento II. In questo contratto si ritrovano alcune
clausole riprese dal precedente del 1529 con qualche errore di copiatura, a proposito degli‘‘assimenti et feramenti’’ e per quanto concerne la guardia o assaggiatore; tuttavia manca qual-siasi accenno al problema di reperire i lavoranti in zona; non si puo quindi pensare che l’in-ventario del 15.. sia da riferire a questo appalto.
(55) TAGLIABUE 1890, pp. 404-407.(56) Come aveva ipotizzato TAGLIABUE 1890, p. 382. Per tutte queste complesse vicen-
de TAGLIABUE 1927, pp. 35-39. Si veda anche ROSSINI 2011, p. 1363.
Il primo documento rinvenuto nell’Archivio di Stato di Milano e uninventario ‘‘dele robe portate fora di castelo 1526 et vendute’’, mandate o con-segnate ‘‘al Seraval’’ per la zecca, oppure mandate a ‘‘Rovore al Seraval’’ o a‘‘Rovore’’ a ‘‘messer Gioangeorgio’’, che ovviamente va identificato con il nostroGian Giorgio Albriono (57). Non e certo invece cosa si intenda con il nome‘‘Seraval’’, se un nome geografico e quindi lo sbarramento della valle costitui-to dalle mura del castello di Mesocco, oppure un nome di persona: in questocaso Paolo Gentili da Serravalle. Questa seconda possibilita ci sembra senzadubbio la piu plausibile e logica.
L’inventario elenca per la maggior parte attrezzature di zecca, ma vi so-no anche elementi d’arredo e utensili da cucina e da dispensa, materiali edi-lizi e strutturali, nonche vari manufatti di ferro di diverse forme e dimensioniper realizzare parti delle artiglierie. Nella penultima pagina troviamo un’ag-giunta redatta il 14 marzo 1531 in cui si parla di archibugi dati a Balzarinode Boso e a Giacomo Toscano ‘‘a nome dela comunita de Mixoco per andare inVoltolina contra lo Medichino a Morbinio’’, a cui segue un elenco di armi emunizioni per i soldati di Mesocco e per una serie di personaggi citati espres-samente – e quindi ben noti all’epoca nei possessi dei Trivulzio. Si specificaanche che alcune munizioni erano ‘‘per li canoni che erano a Musso’’ (58).
Per la sua stessa natura – un elenco di attrezzature, armi e materiali ete-rogenei smantellati e spediti via da Mesocco – il documento del 1526 nonpermette di entrare nel vivo della fabbricazione delle monete o di ricostruireil lavoro di una zecca in modo organico. Cercheremo qui di seguito di inter-pretare l’inventario e di ricostruire gli ambiti produttivi a cui sono pertinentii singoli materiali e utensili, seguendo il filo logico delle fasi tecniche di rea-lizzazione delle monete secondo la tecnologia dell’epoca, quale appare anchedai trattati coevi (59): dopo la presa in consegna dei metalli si eseguiva il sag-
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia 201
(57) ASMi Fondo Trivulzio, Archivio detto Novarese, cart. 34, 1526. Se ne da l’edi-zione, limitatamente alla parte concernente il trasferimento degli attrezzi di zecca, in Appen-dice, documento I. Come si e detto sopra, nota 19, non e stato possibile reperire l’edizionefattane da Emilio Motta nel 1926.
(58) Gian Giacomo Medici detto il Medeghino tentava in quegli anni di formarsi unostato fra il Lago di Como, la Valtellina e Chiavenna, che avesse come centro il suo castello diMusso. Nel 1531 scoppio una guerra tra il Medeghino stesso e i Grigioni, alleati del duca diMilano; la Lega Grigia si fece prestare l’artiglieria del castello di Mesocco dal Trivulzio, che futrasportata con fatica e disagi su per i dirupi sovrastanti la rocca di Musso, il che contribuı allaresa del Medeghino (TAGLIABUE 1927, p. 45; ROSSINI 2011, p. 1363).
(59) E il caso ad esempio del Trattato dell’affinare, redatto da un anonimo mastro dizecca, o comunque un saggiatore o affinatore che operava nell’ambito di una zecca di stato– probabilmente quella di Firenze – alla meta del Quattrocento (MARINI 2007). Tale operaci e pervenuta in quattro manoscritti diversi, evidentemente poiche costituiva un prezioso va-demecum per le maestranze specializzate delle zecche italiane.
gio, poi se necessario l’affinazione e quindi si procedeva alla preparazione deitondelli e alla loro impressione con il tipo (60).
La questione e complicata dal fatto che, tra le attrezzature eterogeneeelencate, compaiono anche strumenti e materiali per fabbricare artiglierie equelli relativi alla fucina del castello: in certi casi risulta difficile stabilire aquale dei diversi ambiti produttivi metallurgici vadano riferiti certi utensili.Tuttavia gli inventari del castello di Mesocco redatti in precedenza ci sono divalido aiuto (61).
Cominciamo a considerare le attrezzature per realizzare il saggio e l’af-finazione dei metalli, fasi tanto piu necessarie in una fabbrica di monete ero-se com’era la zecca dei Trivulzio. Infatti, poiche come si e detto il metalloproveniva in gran parte da monete battute da zecche di stato, era necessariosaggiarne il titolo e procedere poi alla partizione e all’affinazione, cioe allaseparazione dell’oro e dell’argento ed eventualmente alla loro purificazione,per ottenere metallo da monetare (62). L’oro e l’argento provenienti da mo-nete di emissioni ‘‘statali’’ non erano comunque puri, ma legati ad un certoquantitativo di rame (63).
Possono essere relativi a queste fasi la forma per fare le coppelle, almenouno dei tassi – cioe incudini – elencati, alcuni crogioli, alcune piccole bilancee almeno un fornello; la caldaia per fare il salnitro e lo zolfo sono invece re-lativi alla produzione di polvere da sparo per le artiglierie.
Ricorderemo che l’operazione sperimentale degli assaggi, con cui si ri-conosce l’oro e l’argento e se ne determina il titolo, e una delle piu delicatefra quelle che si compiono in una zecca (64): richiede grandissima esperienzatecnica e precisione, nonche personale di provata onesta (65). All’epoca di cuici occupiamo vi erano varie metodologie possibili: con la pietra di paragone,
Costanza Cucini Tizzoni202
(60) MARINI 2007, p. 65. Si vedano anche, per la zecca austriaca di Milano, le consi-derazioni di chi scrive, CUCINI TIZZONI 2010, p. 294, testo corrispondente alla nota 130.
(61) Se si mettono a confronto gli inventari del 1503 (TAGLIABUE 1889), 1511 e 1517(SANTI 1988) si vede che gli ultimi due sono sostanzialmente identici, anche nell’ordine dielencazione delle varie stanze; le armi, le munizioni. i materiali e gli utensili per la loro fab-bricazione e riparazione nella fucina ci permettono di epurare l’elenco del 1526 da molte am-biguita.
(62) Per queste operazioni altamente specializzate si veda CUCINI TIZZONI 2010,pp. 293-300.
(63) Per ottenere una maggior durezza e risparmiare sul fino (CUCINI TIZZONI 2010,p. 277).
(64) CUCINI TIZZONI 2010, pp. 298-300.(65) Dato che le frodi avevano luogo soprattutto in questa fase. Infatti nel contratto del
1529 piu volte citato si specifica che il Besson avrebbe dovuto eseguire i saggi assistito da una‘‘guardia’’, cioe come si e detto un mastro assaggiatore esperto che controllasse il suo operato.Si veda sopra, testo corrispondente alla nota 50.
per coppellazione e con l’acquaforte; tutte impiegavano una minima quantitadi metallo.
L’inventario del 1526 fa espresso riferimento al processo di coppellazio-ne (66), effettuato tramite l’uso di coppelle, recipienti fatti con cenere d’ossa edi corno. Servono a questo scopo la forma per fare le coppelle, una piccolabilancia, un fornello e un piccolo tasso su cui battere il metallo fino ad ot-tenere un nastro sottile.
Non sembra invece che l’inventario faccia riferimento all’uso della pietradi paragone, un metodo piuttosto impreciso anche se in uso fino alla meta delQuattrocento. Fra le attrezzature mandate al Serravalle troviamo, e vero, unpezzo di ferro ‘‘per fare lo grafio’’, che potrebbe forse essere interpretato comeun accenno ai saggi fatti con questa pietra (67). Infatti un semplice modo d’im-piego e quello in cui l’orefice o il mastro zecchiere riconosce per approssima-zione il titolo di un pezzo d’oro sfregandolo contro la pietra di paragone e con-frontando poi la traccia metallica che vi resta con il colore di un’altra tracciavicina eseguita con il metallo fino. Piu preciso e il saggio ‘‘alla tocca’’, eseguitotoccando la traccia metallica che resta sulla pietra di paragone con una gocciad’acquaforte: l’azione di questo acido scioglie e porta via la lega, cioe il ramecontenuto nell’oro, e sbiadisce quindi la traccia che poi viene confrontata conil ‘‘provino’’, uno strumento apposito composto da varie stecche di rame.Tuttavia ci sembra altamente improbabile che il ferro per fare il graffio sia re-lativo a questo metodo di assaggio: si potrebbe trattare semplicemente di unostrumento da orefice per sgraffiare, cioe per segnare e separare con linee tra-sversali i vari campi di lavorazione di un pezzo d’oro (68).
Per quanto concerne il metodo di saggio con l’acquaforte, cioe l’acidonitrico (69), che si ottiene distillando una soluzione di salnitro e allume di roc-ca (solfato di alluminio e potassio), rileveremo che l’inventario non fa alcunamenzione di quest’ultimo, che e un ingrediente indispensabile. Il saggio e lapartizione con l’acquaforte assicuravano vantaggi notevoli rispetto a tutti glialtri metodi, dato che garantivano il recupero completo dell’argento dopo lareazione di separazione dell’oro. Tuttavia non ci sono sufficienti elementi peraffermare che fra le attrezzature portate via da Mesocco ci fossero tutti gliingredienti per la preparazione dell’acquaforte.
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia 203
(66) Non ci dilungheremo sul procedimento, gia ampiamente trattato per la zecca au-striaca di Milano in CUCINI TIZZONI 2010, pp. 298-299 e a cui si rimanda.
(67) CARENA 1859, s.v. Saggio alla tocca, nel capitolo relativo a Orefice, Argentiere,Gioielliere; MARINI 2007, p. 96.
(68) CARENA 1859, s.v. Sgraffiare.(69) Su questo acido e il metodo di partizione dell’oro e dell’argento CUCINI TIZZONI
2010, pp. 294-296.
Una ‘‘caldera rota che faceva lo salnitrio’’, presente fra le attrezzature delcastello fin dal 1503, era stata tagliata per aggiustare quella ‘‘de rogio’’ (70). Ilsalnitro, oltre che essere parte integrante della ricetta dell’acquaforte, potevaessere usato nelle zecche anche per imbianchire le monete in lega d’argen-to (71). Tuttavia esso, seguito dallo zolfo, e il componente principale dellapolvere da sparo e non e quindi relativo alla zecca (72).
L’inventario elenca invece tutta una serie di attrezzature specifiche per lafabbricazione delle monete, espressamente consegnate al Serravalle per la zec-ca. Un lotto e costituito da torselli, pile e ‘‘spontonaria de piu sorte’’, quindi daconii e punzoni per la monetazione, ma in quantita molto consistente: si trat-ta di 176 pile, 207 torselli e in totale quasi dodici chili di punzoni. Fra le pri-me cose viene citato un torsello di bronzo mandato espressamente a ‘‘messer locommissario’’. Questo particolare e degno di nota: mentre nell’antichita eranodi bronzo, dal Medioevo in poi i conii erano in ferro con la faccia in acciaio,per resistere all’usura a cui erano sottoposti durante la coniazione (73). A qualescopo, dunque, troviamo trattato con particolare riguardo un torsello di bron-zo? Probabilmente perche si trattava di un modello per i conii in ferro, da con-segnare agli incisori per la realizzazione degli esemplari in ferro di uso comu-ne. Ed essendo il modello per le monete dei Trivulzio, eccolo inviato al com-missario in persona, cioe come abbiamo visto a Paolo Gentili da Serravalle.
Troviamo poi elencate le solite attrezzature, quelle specifiche di una zec-ca: setacci, bilance in ottone, marchi con i loro pesi, alcuni tassi, un peso dipiombo di oltre cinque chili. Per quanto concerne la fonderia, abbiamo un for-nello di ferro, il piccolo mantice del ‘‘forneto’’, l’ugello del mantice, vari tassi dicui uno solo espressamente citato come relativo alla zecca, crogioli di ferro e lerelative grandi tenaglie per toglierli dal fuoco, una particolare tenaglia dettamoietta, catini di rame, canali (cioe forme) di ferro per gettare l’argento, forbi-cioni per tagliare le lamine ottenute, pale di ferro. Da notare che una moietta eraffigurata nella celebre pala d’altare della chiesa di St. Annen ad Annaberg: neldipinto possiamo vedere un monetiere che conia e un aiutante che porta i ton-delli su un vassoio, mentre la moietta e appoggiata sul banco di lavoro (74).
Costanza Cucini Tizzoni204
(70) Si veda la ricetta per la purificazione del salnitro attraverso la bollitura in caldaianel Trattato dell’affinare, manoscritto Marciano cc. 122v-125r in MARINI 2007, p. 104.
(71) MARINI 2007, p. 107, manoscritto Palatino 929.(72) CARENA 1859, s.v. Polvere da guerra, nel capitolo Armaiolo o Archibusere: la polvere
da sparo e composta per tre quarti da salnitro, per un ottavo da zolfo e per un ottavo da car-bone.
(73) TRAVAINI 2007a, pp. 29-36.(74) Per l’edizione del dipinto, una delle fonti iconografiche piu famose che rappresen-
tino scene di zecca, da ultimo TRAVAINI 2007a, n. 37.
Assieme ad esse troviamo mescolate anche le attrezzature per fabbricarele artiglierie, ad esempio numerosi bastoni a sezione rotonda o quadra, foratio meno, per le ‘‘anime dele artalarie’’. Queste ultime, consegnate o inviate aRoveredo al Serravalle, sono costituite da archibugi di bronzo e di ferro, spin-garde di bronzo e di ferro, piccole corazze ed alcune segrete. Le munizionisono ‘‘balote’’, cioe palle di piombo realizzate per fusione in forme, e tribo-li (75), i chiodi a tre punte impiegati contro la cavalleria. Bisogna chiarire co-munque che questo di Mesocco non era un vero e proprio arsenale destinatoa produrre artiglierie in tutte le loro parti e in grandi quantita. Il documentosi riferisce solo alla realizzazione delle canne degli archibugi, peraltro assaicomplessa e specialistica (76): forse nel castello si riparavano gli archibugi so-stituendo la canna, e poi vi si assemblavano i pezzi di ferro ‘‘che vanno sopra lerode’’, cioe sopra al meccanismo d’accensione a ruota, e le altre componentiche pero erano fabbricate altrove (77).
Le attrezzature di zecca del documento del 1526 rivestono dunque uninteresse particolare, dato che risultano in gran parte diversificate e comple-mentari di quelle presenti pochi anni dopo nella zecca di Roveredo.
I Trivulzio come imprenditori metallurgici
Al pari di altre importanti famiglie della nobilta milanese e piu in gene-rale lombarda (78), anche i Trivulzio sembrano ben presto interessati ad inse-
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia 205
(75) ‘‘Uno barile de tripori’’ e presente negli inventari del castello dal 1503 (TAGLIABUE
1889, p. 245 e nota 58) al 1517 (SANTI 1988, p. 158); tuttavia i triboli sono sempre stati er-roneamente interpretati come ‘‘polvere di Tripoli’’ o farina fossile, assolutamente impossibileper l’epoca!
(76) Si doveva realizzare un tubo di ferro che veniva poi otturato ad una estremita edinfine montato su una cassa lignea. Si partiva da un semilavorato di ferro detto lama, che ve-niva stirato fino alla lunghezza della canna e poi forgiato al maglio formando una specie ditegola. La lavorazione proseguiva sull’incudine, sempre scaldando il ferro ad alta temperatura:si sovrapponevano e si saldavano i bordi, si introduceva nel foro l’anima cilindrica e appog-giando la canna su una sagoma semicilindrica si saldavano per ribattitura i bordi (CERINO BA-
DONE 2006, pp. 74-75).(77) CERINO BADONE 2006, pp. 76, 79.(78) Una delle principali famiglie e quella dei marchesi d’Adda Salvaterra, proprietari
per duecento anni delle miniere d’oro del Monte Rosa e aggressivi imprenditori del ferro con iloro altoforni di Locarno Valsesia e di Buggiolo (TIZZONI 1986 e TIZZONI 1988). Si pensi poiai Borromeo, feudatari della Val d’Ossola, dove detenevano i diritti, fra le altre, anche sulleminiere d’oro di Pestarena dal 1463 e che nel 1533 avevano una societa per lo scavo di mi-nerale di ferro e la sua lavorazione (PISONI, FRIGERIO 1983, pp. 5-6). Anche i Manzoni nellanatıa Valsassina possedevano nei secoli XV-XVII ricche miniere di ferro e altoforni (TIZZONI
rirsi nel lucroso settore minerario e metallurgico. E proprio Gian Giacomo,dotato di intraprendenza e abilita finanziaria, a fondare le basi dei possessiminerari e metallurgici della famiglia (79).
Sembra che inizialmente egli fosse interessato all’estrazione e alla lavo-razione dei metalli nobili, poiche il 12 febbraio 1499, quando inviava comeabbiamo visto crogioli per fondere argento nella zecca a Mesocco, ‘‘havevatrovato in quelli paesi una vena de arzento’’ (80). Inoltre, negli inventari del ca-stello di Mesocco dal 1503 al 1517 si trovavano un ‘‘picone da cavar arzento’’o ‘‘vena’’ e ‘‘feri per cavar vena d’argento’’ (81). Sappiamo che alla fine del ’400si effettuavano scavi minerari nel Rheintal, signoria del Trivulzio, e che GianGiacomo aveva cercato di acquistare il Landschaft di Schams e di Rhezunsdove si trovavano filoni argentiferi (82). Inoltre il possesso di Chiavenna, ot-tenuto quando divenne luogotenente regio, poteva assicurargli il controllodelle miniere di piombo argentifero poste oltre il passo del Maloja a Plaz, Silse Grevasalvas, nonche di quelle d’argento del territorio di Gordona, sfruttatedal 1464 (83).
Costanza Cucini Tizzoni206
1998). La prima attestazione di possesso di miniere in Valsassina da parte dei Manzoni diBarzio e del 1590; per tutto il primo quarto del ’600 essi incrementarono i loro possedimentiminerari e metallurgici, che vennero estesi anche alla Valtorta da Giacomo Maria Manzoni, ilvero artefice della ricchezza siderurgica della famiglia.
(79) Come anche di gran parte dell’esteso patrimonio fondiario familiare, che e statooggetto di importanti studi storiografici: si veda ad esempio ROVEDA 2012. I nuclei maggiorierano posti nella Bassa Milanese e nel Lodigiano, zone molto fertili che i Trivulzio contribui-rono a bonificare e dove abbatterono boschi e costruirono rogge e cascine. Altre proprieta era-no poste nella zona asciutta del Milanese, presso Vimercate, nel Cremonese, nel Novarese,intorno a Borgomanero e piu tardi nella Geradadda. Finora pero le proprieta metallurgicherisultavano quasi sconosciute alla storiografia trivulziana, o quantomeno inedite; solo ARCAN-
GELI 2003 p. 55 nota 160 e p. 56 vi accenna brevemente.(80) Si tratta del documento citato sopra, alla nota 13.(81) TAGLIABUE 1889, p. 247; TAGLIABUE 1890, pp. 385-386 con indicazione delle fon-
ti. SANTI 1988, pp. 138, 148.(82) TAGLIABUE 1890, p. 385. CHIARAVALLE 1996, p. 5 nota 11.(83) A Plaz, a nord di Sils Baselgia, sono visibili miniere antiche dette localmente ‘‘fora
da canaps’’, cioe le gallerie dei canopi (l’antica denominazione tedesca dei minatori); nel 1578-1579 il Vicario J. Von Salis estraeva minerale presso Sils e sul Bernina, poi trasportato ai fornidi Filisur, da cui il metallo prodotto proseguiva per Chiavenna. Nel XVII secolo la famigliaPlanta di Zuoz scavava da questa miniera minerale di piombo e argento. A Plaz sono tuttoravisibili quattro brevi gallerie cilindriche, del diametro di circa m 1,5. Una ‘‘cava’’ di fahlerz(minerale di rame, ferro, zinco, argento) fra Sils e Grevasalvas e indicata nella Carta geognosticadel 1835 di Heinrich Schopfer. Quattro piccoli giacimenti di ferro, piombo, zinco e arsenicosono situati a nord-est della Forcola di Grevasalvas. Per tutte queste notizie, MAURIZIO 1972,pp. 60-61. Invece le scorie di rame rinvenute dall’Autore in due localita, a Mota Farun e inVal Parossa, sembrano riferibili, in base alla descrizione, alla preistoria: si tratta in effetti diuna tipologia di scorie ben nota nella zona alpina lombarda e svizzera, si veda CUCINI et alii
In effetti, in eta ducale, notizie di miniere d’argento nella diocesi diCoira si hanno dal 1462, mentre nel 1491 e citato ‘‘uno forno dargento chee in Capodelago i soto le confine de Vostra Signoria’’ (84), forse da identificarecon Capolago in Engadina, non lontano da Chiavenna, o piu probabilmenteda porre sul lago di Poschiavo.
In Val Mesolcina e in Val Calanca sono presenti filoni di piombo argen-tifero poco prima del passo di San Bernardino e, sempre presso Mesocco,nelle Gole della Golmagna si trovano mineralizzazioni di piombo e ferro;nella dolomia della sinclinale della Mesolcina si situano inoltre piccole venee depositi di galena e quarzo (85). Puo darsi che fossero queste le miniere d’ar-gento di Gian Giacomo Trivulzio. Inoltre al San Bernardino sono segnalatigiacimenti di zolfo, vetriolo e allume oggi non piu rintracciabili (86).
Successivamente, vari documenti finora inediti attestano come GianGiacomo Trivulzio avesse concentrato i suoi investimenti nel ben piu sicuroe redditizio campo siderurgico. Infatti nel 1508 egli acquisto, per 200 scudid’oro, dai fratelli Giovanni Giacomo e Agostino del fu Giovanni Antonio diDesio, vari beni tra cui le miniere di ferro di Dongo (87). L’acquisto compren-deva un terreno e un bosco siti presso Dongo, una ‘‘bogia’’ presso Dongo‘‘ubi dicitur ad busam della Ferrera’’ ed un ‘‘bassum [...] ubi dicitur ad ferre-ram’’ con diritto di acque; ed inoltre ogni diritto su tutte le vene metallifereche potessero contenere oro, e su tutte le pietre preziose esistenti in dettoterritorio, in particolare nella zona ‘‘supra Barbiganum et ad ferrariam de De-
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia 207
2012 con bibliografia. Per quanto concerne le miniere d’argento e forse anche l’oro della ValCrezza, situata tra Gordona e Menarola, esse vennero date in concessione dal conte GabrieleBalbiani e dalla moglie di suo fratello Giovanni, Apollonia Spinola, ad un gruppo di soci dellazona con atto del 13 marzo 1464, PALAZZO TRIVELLI 1994 con bibliografia; e interessante no-tare che il documento fa riferimento alla produzione di metallo prezioso per coppallazione,‘‘cineratio’’.
(84) ASMi, Sforzesco cart. 720, 25 giugno 1462: il vescovo di Coira da una parte e iPiantani dall’altra; Sforzesco cart. 1153: il 4 novembre 1491 Donato di Solario scrive al ducache il Vescovo di Coira era giunto a Poschiavo, dove aveva dimorato e da dove si era poi spin-to fino al forno suddetto. Non deve stupire l’assenza di notizie successive sulla prosecuzioneeventuale dei lavori: e un fenomeno comune alla quasi totalita dei documenti analoghi del’400 e ’500 nel Ducato (TIZZONI 2004, p. 260).
(85) WENGER, STEIGER, BIANCONI 1994, pp. 6-7, 37, Lista dei Giacimenti delle materieprime minerali nn. 113, 175, e al di la del passo del San Bernardino nn. 105, 157, 161.
(86) KRAHENBUHL 2001, cartina a p. 3.(87) L’atto e conservato in due diverse copie notarili, che presentano alcune discrepan-
ze dovute ai copisti: ASMi, Fondo Trivulzio detto Archivio Milanese, cart. 141, 1 dicembre1508 e ASMi Fondo Trivulzio detto Archivio Novarese, cart. 12, 1 settembre 1508 (quest’ul-timo documento e citato da ARCANGELI 2003, p. 55 nota 160). I venditori erano della parroc-chia di S. Babila in Milano. Cenni in FRUMENTO 1963, p. 40.
gano’’ come da privilegio ducale del 16 gennaio 1495 (88). Anche in questaattivita imprenditoriale Gian Giacomo Trivulzio sembra sostituirsi ai de Sac-co di Mesolcina: infatti nel 1404 l’imperatore Sigismondo aveva concesso lo-ro l’investitura per la ferriera del monte di Dongo, investitura rinnovata nel1496, quando i de Sacco erano riusciti momentaneamente a recuperare lacontea di Mesocco (89). E evidente che Gian Giacomo acquistava non solole miniere di ferro vere e proprie (90), ma anche vari terreni adiacenti dovecostruire gli impianti siderurgici per il loro sfruttamento, nonche un boscoper l’approvvigionamento di combustibile e il diritto di sfruttare l’acquaper muovere le ruote idrauliche per fornire la necessaria energia.
Questa ‘‘riconversione’’ del Trivulzio dai metalli non ferrosi alla siderur-gia non e un caso isolato: si inserisce a pieno titolo nel trend generale dell’e-poca, avente lo scopo di tamponare gli effetti della crisi che travolse i metallinobili nel XV secolo. Il fenomeno e stato osservato nel Ducato di Milano, inPiemonte e in Toscana (91).
Le miniere di Dongo, fra le piu importanti del bacino minerario lombar-do, sono di siderite o ferro spatico di ottima qualita, ideale per produrre ghisagrigia particolarmente adatta per fusioni. In particolare, la miniera di Deganoe forse la piu importante del comprensorio. Il giacimento e piuttosto irrego-lare e questo, all’epoca di cui ci stiamo occupando, poteva causare qualche dif-ficolta di sfruttamento, ma la sua posizione quasi sulla sponda del lago di Co-mo lo rendeva di enorme interesse (92). Tutta la zona in esame e comunque di
Costanza Cucini Tizzoni208
(88) Nel documento in Archivio Milanese, cart. 141, essi allegano tale privilegio duca-le: esso elenca tutta una serie di pietre preziose e dure, ‘‘de omnibus venis videlicet roche de ru-binis, de granatis, de zaffiris, de iaspidis, calcedonijs, porfido seu spetie porfidi, et specia de serpen-tino, et alterius vene que videt esse auri ammisculata et de alabastro’’; si fa evidente riferimento aigranati verdi e rossi della zona.
(89) Le miniere di Dongo erano state donate da Ludovico il Moro a Giovanni Antonioda Desio nel 1495, vedi nota precedente; la tradizione vuole che un suo antenato, Giacomo oAntonio da Desio, ne fosse stato lo scopritore nel 1430, ma un documento del 1412 gia lecitava (FRUMENTO 1963, p. 18). L’anno successivo alla caduta del Moro (ovvero nel 1500)il conte Pietro Sacco di Mesocco chiese la riconferma dell’antica investitura (MAINONI
2001, pp. 426-427; FRUMENTO 1963, pp. 19-22).(90) Ricorderemo che nei documenti lombardi coevi le miniere di ferro sono dette ‘‘fer-
rere’’ e gli imbocchi minerari ‘‘buse’’, mentre i giacimenti minerari e il minerale stesso sonochiamati ‘‘vena’’.
(91) TIZZONI 2004, pp. 256-260.(92) Come aveva gia notato FRUMENTO 1963, p. 18. A differenza degli altri minerali di
ferro delle Alpi lombarde, la siderite di Dongo contiene poco manganese. Le miniere di Crot-to e Degano, gia note in epoca viscontea, furono secoli piu tardi coltivate dalla ditta Rubini eScalini nel 1865 ed in seguito dai Falck. Per tutto cio JERVIS 1873-1889, vol. I, Provincia diComo, 632, 634. Si veda anche VANDELLI 1763, pp. 194, 198, 201.
primaria importanza dal punto di vista delle miniere di ferro, si pensi alla ValCavargna e alla zona di Porlezza. E l’acquisizione nello stesso anno, da partedel Trivulzio, del feudo di Musso dai precedenti feudatari, i Malacrida, avevaevidentemente anche lo scopo di controllare tutta la vicina zona mineraria (93).
Quando Gian Giacomo Trivulzio si affaccia sulla scena mineraria del-l’alto Lario, si era da poco conclusa l’avventura imprenditoriale dei da Mug-giasca in Valle Morobbia (Canton Ticino, Svizzera), esattamente sul versanteopposto della crinale alpina del passo di San Jorio rispetto a Dongo. Infattinel 1463 Bartolomeo di Ambrogio, del ramo bellinzonese della famiglia diComo, aveva gettato le basi di una grande impresa siderurgica a Carena.La societa mineraria intraprese grandi lavori per la realizzazione di forno, fu-cine, acquedotto, edifici e per la sistemazione della mulattiera che lungo laValle Morobbia giungeva al valico di San Jorio, collegando il contado bellin-zonese all’alto Lario (94). Tuttavia l’elevato volume di spese e l’esaurimentodelle vene portarono ben presto alla cessazione delle attivita (95). Sembra
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia 209
(93) Si veda supra, testo corrispondente alla nota 16. I Malacrida, originari di Musso, neerano stati infeudati da Giovanni Maria Visconti, ASMi Fondo Famiglie 109. Essi avevano do-nato il feudo nel 1508 a Gian Giacomo Trivulzio (GIROLA 2003, p. 329; GIROLA 2011; ROSSINI
2011, p. 1367). Biagio Malacrida tenne poi il castello per conto del Trivulzio. Nell’inventariodel castello di Mesocco del 1511, piu volte citato, e indicata inoltre la ‘‘camerata dove sta SymoneMalacrida’’. Secondo ARCANGELI 2003, p. 56, l’interesse per la ferriera di Dongo sarebbe forsedovuto al progetto di produrre artiglierie. Non sappiamo se sia degna di fede la notizia, riportatada FRUMENTO 1963, p. 40, che nel 1517 furono realizzate nel castello di Musso una fonte diacqua perenne e delle officine per fondere il minerale o lavorare la ghisa prodotta a Dongo oa Barbignano; la strada da Musso a Dongo sarebbe stata protetta da ‘‘ridotti avanzati fino al vil-laggio di Barbignano, dove era una munitissima torre’’; anche le miniere sarebbero state difese.
(94) Come abbiamo accennato, nella seconda meta del Quattrocento questa strada ri-vestiva un ruolo importante per i mercanti e i comuni della zona, tanto che il duca FrancescoSforza, su richiesta delle autorita di Como, approvo l’8 maggio 1465 lavori di miglioramento econcesse la riscossione di un pedaggio, da cui era esente comunque il ferro, L’industria delferro 1883, p. 39; dal valico di San Jorio ‘‘in 13 km di cammino si giunge a Gravedona in rivaal Lario [...] in altri tempi [...] esso era la strada commerciale dell’Oberland bernese per l’Italia perlo scambio dei formaggi e dei cereali’’ (L’industria del ferro 1889, p. 282). Si veda anche CHIESI
1999. L’impianto siderurgico di Carena e stato oggetto di scavo archeologico da parte dell’U-niversita di Bergamo, TIZZONI, CUCINI TIZZONI 1999. Sulla geologia della Val Morobbia WEN-
GER, STEIGER, BIANCONI 1994, pp. 28-29.(95) Bartolomeo da Muggiasca si ritiro nel 1471, cedendo la sua quota al suo socio e
cugino comasco Nicola da Muggiasca; quest’ultimo continuo a far funzionare i forni dellaValle Morobbia fino al 1480. Ma nel 1478 alcuni reparti delle truppe svizzere che, calatedal S. Gottardo, assediavano Bellinzona, si spinsero lungo la via del San Jorio per aggirarele difese lombarde e dettero fuoco agli impianti siderurgici di Carena (CHIESI 1999). Nicolada Muggiasca aveva scoperto anche le miniere di ferro del monte di Introzzo, sulla spondaopposta del Lario rispetto a Dongo. Il 17 giugno 1464 infatti il duca di Milano ingiungevaal podesta di Corenno e Introzzo di costringere gli uomini della comunita a lavorare in tali
che Nicola da Muggiasca avesse rilevato inoltre da Antonio detto Brieta diRumo di Dongo la miniera di ferro che egli possedeva nel territorio di Don-go, e nella quale detto Antonio aveva investito notevoli capitali (96).
Negli anni successivi Gian Giacomo Trivulzio ampliava i suoi possessisiderurgici nella zona di Dongo. Il 3 ottobre 1511, tramite il suo agente Ga-leazzo de Tortis, acquistava per Lire 1000 imperiali da Martino del fu Gia-como Malacrida di Dongo un terreno con una casa col tetto di piode doveerano stati attivi una ‘‘rexicha’’ e ‘‘paria tria molarum, furnum unum, pistauna’’ con acquedotto e diritti e ‘‘in quo sedimine et baxo noviter edifficati suntfurnum unum [...] fornace et mallia duo a ferro’’ (97), tutti siti in territorio diDongo nel luogo un tempo detto ‘‘ad molandinum’’ di Martino Malacrida e‘‘nunc vocatur ad furnum ferri’’. In questo caso Gian Giacomo aveva compra-to degli impianti gia esistenti, anzi costruiti da poco, in sostituzione o a fian-co di altri piu antichi. Inizialmente notiamo la convivenza di una sega, tremole forse del mulino, un forno e probabilmente un pestaloppe (98); mentrepoco prima dell’acquisto da parte del Trivulzio erano stati realizzati un forno,una fornace cioe una fucina e due magli da ferro.
Gian Giacomo dovette investire notevoli capitali nella sua impresa side-rurgica; infatti il 19 giugno 1518, tramite il suo procuratore Giorgio Curtodi Gravedona, affittava per nove anni a Bontempo de Stropiolis della ValTrompia una serie di impianti siti nel territorio di Dongo comprendentiun forno da ferro dotato di mantici, fucine grosse con relativi mantici, fucinepiccole con sei incudini e mantici, maglio, carbonile e reglana (99), nonche leminiere di ferro, al prezzo annuo di 350 scudi d’oro (100). Evidentemente, a
Costanza Cucini Tizzoni210
miniere per Nicola da Muggiasca, dato che quest’ultimo aveva ricevuto minacce, insulti e ag-gressioni da parte dei suoi avversari (ASMi Sforzesco, Missive 65, cart. 416).
(96) L’industria del ferro 1883, pp. 91-92: il 3 febbraio 1472 Nicola da Muggiasca, cheaveva chiesto di scavare minerale ‘‘nel loco appellato More territorio di Cavargna pieve de Por-letia et in altri loci de dicta pieve nel monte de Dongho et nel contado de Berinzona’’, riceveva dalduca l’autorizzazione per ‘‘fodendi et cavandi ac fode et cavari faciendo in locis et montibus Moreterritorj Cavargne plebis Porletie, et montis Dongi et locis comitatus Berinzone’’ e vendere il ferroprodotto (ASMi, registro Ducale 47, 229). Si veda anche FRUMENTO 1963, p. 20.
(97) La pergamena originale e conservata in ASMi Fondo Trivulzio detto Archivio Mi-lanese, cart. 141.
(98) E questo verosimilmente il significato di ‘‘pista’’. Questo particolare tipo di im-pianto, impiegato all’epoca quasi esclusivamente nelle Alpi italiane dato il tipo di mineraletrattato, era un macchinario utilizzato per frantumare le scorie prodotte dall’altoforno allo sco-po di recuperarne il ‘‘ferrino’’, cioe le sferule di metallo; si veda CUCINI TIZZONI 2008,pp. 244-246. Non si puo comunque escludere che l’impianto servisse a frantumare il mineralegrezzo per ridurlo in pezzatura e poi immetterlo nel forno.
(99) Cioe il forno per l’arrostimento del minerale grezzo: TIZZONI 1997, pp. 43-44.(100) ASMi, Fondo Trivulzio detto Archivio Novarese, cart. 12, 1518 giugno 19.
giudicare dalla cifra esorbitante che costituiva il canone d’affitto, Gian Gia-como aveva realizzato importanti migliorie, ampliamenti e ammodernamentinella sua proprieta. Il complesso siderurgico risulta in effetti di notevole en-tita, poiche comprendeva tutti gli impianti necessari alla produzione di semi-lavorati di ferro a partire dal minerale grezzo. Si trattava di un altoforno percolare il minerale di ferro e trasformarlo in ghisa, che veniva poi decarburatanelle adiacenti fucine grosse e trasformata cosı in ferro malleabile, che venivaforgiato al maglio grosso in semilavorati grossi quali i quadroni e la reggia,successivamente trasformati in semilavorati piu fini come la vergella, o anchein prodotti finiti, nelle annesse fucine piccole o sotiladore (101).
Insomma a Dongo troviamo la filiera completa, secondo la tecnologiasiderurgica messa a punto nei secoli precedenti nelle valli lombarde, nellequali l’invenzione dell’altoforno fu estremamente precoce rispetto al restod’Europa (102).
Il settore in cui Gian Giacomo Trivulzio aveva investito i suoi capitaliera all’epoca uno dei piu solidi e trainanti dell’economia delle valli lombarde,praticamente non soggetto a crisi, anche grazie alle continue guerre e alla ne-cessita di armamenti in grandissima quantita, che spinse i sovrani d’Europaad affrontare spese enormi. Ed egli doveva averlo ben chiaro, dato che ancoranello stesso 1518 aveva ottenuto in affitto perpetuo dal prevosto della chiesadi S. Giovanni Battista di Domaso ‘‘la ragione de cavare la vena di ferro’’ indue appezzamenti situati l’uno nel comune di Vercana e l’altro nel territoriodi Domaso (103). Entrambe queste localita dell’alto Lario sono vicinissime aDongo (fig. 1).
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia 211
(101) Per la catena operativa e produttiva nella siderurgia indiretta CUCINI TIZZONI
1997.(102) Dal V-VI sec. d.C. in Val Camonica, con un anticipo di circa otto secoli rispetto
all’area germanica (CUCINI TIZZONI, TIZZONI 2006; CUCINI 2012, pp. 47-54). Significativa e, aquesto proposito, la provenienza dell’affittuario, Bontempo de Stropiolis: la Val Trompia euna delle zone minerarie e siderurgiche piu importanti del bacino ferrifero lombardo, dovesi formavano maestranze altamente specializzate nella conduzione dell’altoforno e delle fucine.
(103) Un documento inedito dell’ASMi, Fondo Commercio p.a. 208, databile al1519, e costituito dalla minuta di una lettera senza data, indirizzata da un anonimo estensoreal Referendario di Como; la minuta venne stesa frettolosamente, con molte cancellazioni ederrori, fra cui anche la data della morte del Trivulzio: ‘‘l’anno 1508 proximo passato el quondamsignor Io. Iacobo Trivultio overo soi agenti a suo nome furno investiti a livello perpetuo dal pre-posito de la giesa de Sancto Jo. Baptista da Domasio de la ragione de cavare la vena di ferro in duepezze di terra una situata nel co(mune) de Vercana et l’altra nel territorio de Domaxio, et perchevoressimo sapere se il dicto quondam signor Io. Iacobo e stato in possesso de tal cossa et se may si etexcavato tale effecto si al tempo che esso viveva, come per sui heredi et successori doppo la sua morte.Pero cautamente con il modo vi parera non mancherete di ogni diligenza per bene informarvi de laverita et per vostre lettere subito ne dareti adviso’’.
Tuttavia la morte del Maresciallo poco tempo dopo l’affitto del1518 (104) dovette causare l’inizio del declino delle attivita siderurgiche dellafamiglia. Poiche il figlio di Gian Giacomo, Nicolo, era morto improvvisa-mente nel 1512, fu il nipote Gian Francesco a ereditarne i possessi. Quest’ul-timo pero, per le sue personali vicende (105) o per mancanza di capacita im-prenditoriale, non sembra essersi curato dei possedimenti minerari e metal-lurgici di famiglia.
Chi invece vi era molto interessato era il Magistrato Camerale dello Sta-to di Milano, che poco dopo la morte di Gian Giacomo svolgeva caute in-dagini volte a stabilire se egli o i suoi eredi e successori avessero detenuto ilpossesso sulle miniere di Domaso e Vercana e se vi avessero effettivamentecavato minerale (106).
Le fortune dei Trivulzio nel settore siderurgico, che iniziava allora a de-collare, sarebbero state comunque ben maggiori e durature senza l’avventodel Medeghino che, dal 1523, con la conquista di Musso dette origine adun periodo convulso di guerre e disordini in tutto l’alto Lario, che coinvol-sero anche la vicina Dongo rendendo di fatto quasi impossibili le attivitaestrattive e fusorie (107). Gian Francesco insomma finı col rinunciare sostan-zialmente a sfruttare i suoi possessi siderurgici. E non si puo escludere che ilMedeghino stesso avesse scelto proprio Musso come centro del suo potereanche per appropriarsi delle vicine miniere.
Sta di fatto che nella seconda meta del ’500 gli impianti siderurgici delterritorio di Dongo risultavano in abbandono da molti anni e addirittura fattioggetto di pesanti spoliazioni di materiale edilizio. Un documento privo didata, ma certo anteriore al 1575 (108), ce li descrive in completa rovina: Gian
Costanza Cucini Tizzoni212
(104) Gian Giacomo Trivulzio morı in Francia il 5 dicembre 1518.(105) Dopo l’entrata in Milano delle truppe spagnole nel 1521 e la proclamazione di
Francesco Maria Sforza duca di Milano, Gian Francesco fu imprigionato e privato di tutti ipossedimenti e titoli. Mentre era riparato in Francia, la Lega Grigia smantello come abbiamovisto il castello di Mesocco nel marzo 1526. Successivamente la rocca di Musso, prima occu-pata dal Medeghino, fu distrutta dai Grigioni nel 1532, che distrussero anche gli impiantisiderurgici (FRUMENTO 1963, p. 47). Infine nel 1549 Gian Francesco cedette la Val Mesolcinaai suoi abitanti (TAGLIABUE 1927, pp. 34-35, 53-65).
(106) E il documento citato alla nota 103.(107) Come si e sopra piu volte accennato. Il Medeghino, con le sue incursioni e sac-
cheggi, inflisse un duro colpo a tutto il vicino e ricco comprensorio minerario della Valsassina,che si riprese poi con qualche lentezza (TIZZONI 1998, p. 34). Secondo FRUMENTO 1963, p. 47,il Medeghino cerco di ritagliarsi una signoria in una zona talmente nodale per la produzionesiderurgica che, se ci fosse riuscito, tutto il ferro milanese sarebbe stato nelle sue mani; nellarocca di Musso ‘‘eresse officine per fabbricare spade, alabarde e archibugi’’.
(108) ASMi Fondo Trivulzio, detto Archivio Novarese, cart. 12. Dall’incipit del docu-mento ‘‘Nel tempo che viveva la felice memoria dell’illustrissimo signor Giacomo Trivulzio’’ sievince che dovevano essere passati almeno alcuni decenni dalla morte del condottiero.
Giacomo Trivulzio aveva comprato alcune miniere di ferro nel territorio diDongo ‘‘dove si dice a Balbignano o vero Assergrigho’’. Vi aveva acquistato purel’acquedotto e un terreno dove aveva fatto edificare un forno per colare lavena e un maglio per battere il ferro nel luogo dove si dice al maglio: ‘‘qualtutte minere, terreni, acquedutti, forno, maiio, et case sono rovinate et cavatosino alle pietre’’. Si supplicava quindi il marchese (109) di affittare tali possessia uomini suoi fedeli servitori, per non perdere i diritti sulle miniere di ferro.Sul documento si legge, aggiunto da mano diversa da quella dell’estensore:‘‘il nome di colui che vorrebbe le miniere non lo so, eccetto di colui che negoziae chiede Pompeo della Croce’’. Non sappiamo dunque chi si celasse dietro que-sto tentativo di acquisizione.
In ogni caso, anche i successivi eredi Trivulzio non seppero o non vol-lero dedicarsi alla siderurgia.
L’epilogo delle vicende minerarie della famiglia si ha nel 1581 (110),quando Teodoro detto Raffaele Trivulzio del fu marchese Gian Francesco,a nome suo, di suo fratello Nicola e della sorella Barbara moglie del conteLudovico Balbiani di Belgioioso, vende per 60 Lire imperiali a Giovanni Bat-tista Capello del fu Bernardo di Como, agente per conto di Tomaso Odescal-chi, tutti i loro beni siti in territorio di Dongo e tutti i diritti sulle ‘‘fodinismetallorum’’ esistenti cola ‘‘sive alibi in episcopatu Comi’’. Il prezzo di venditavenne stabilito da Nicola Arrigoni del fu Cosimo di Barzio e dal nobile Fran-cesco da Ello del fu Francesco di Bellano, arbitri e amici comuni scelti dalledue parti, e che gia avevano agito per loro conto nel 1575 (111). Su richiesta diNicola Cipriano figlio di Nicola, abitante a Milano nella parrocchia di S. Vit-tore e i Quaranta Martiri, ‘‘qui successit in locum dicti illustrissimi domini’’Giovanni Tomaso Odescalchi, i due arbitri erano andati inizialmente a fareun sopralluogo (112) nel territorio di Balbignano e di Degano dove si trovava-
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia 213
(109) Anche se non citato espressamente, si deve trattare di Gian Francesco, marchesedi Vigevano in quanto erede di Gian Giacomo; Gian Francesco morı il 14 luglio 1573.
(110) Si conservano due copie del documento: ASMi Fondo Trivulzio, detto ArchivioMilanese, cart. 141, 1581 ottobre 18 e Archivio detto Novarese cart. 12, 1581 novembre 6.
(111) Come da atto rogato dal notaio Giovanni Andrea Besozzi di Milano; il docu-mento non e piu reperibile fra le filze conservate all’ASMi.
(112) Ibidem: ‘‘qui prius accesserunt ad territorium Balbignani et Degani in predicto ter-ritorio Donghi ubi adsunt diversa foramina vulgo appellata buse, et cave antiquitus facta ex quibusfosse fuere seu cavata vena a ferro et videri dixere diversa vestigia fodinarum seu minerarum ferri etvisa etiam fuere ut dixerunt diversa frustola dictarum venarum, antiquitus fossarum et excavata-rum. Non valenter videret aliquod corpus seu filorum venarum ex quo vere iudicare et declararepossint et valeant vera qualitatem et quantitatem ipsarum venarum, que ex ipsis foraminibus seubusis fodi possent ob repletionem et obturationem ipsarum venarum. Consideratis taxaturis et fru-stulis venarum mixtis cum marchesatis que dicti suprascripti reperiuntur fossa et excavata ex dictis
no diversi imbocchi minerari, volgarmente detti buse, ed escavazioni fatte inantico, dalle quali era stata cavata vena di ferro. I due arbitri avevano vistoanche diverse vestigia di miniere di ferro e molti frammenti di minerale sca-vato in antico; ma non avevano assolutamente potuto vedere il corpo o filonedelle vene metallifere, e non potevano quindi stimare, dichiarare o valutare laeffettiva qualita e quantita di minerale esistente, essendo le gallerie e gli im-bocchi minerari riempiti e otturati. I due esperti avevano dovuto quindi ba-sare la loro perizia su altre considerazioni. Innanzitutto avevano consideratoil minerale frantumato in pezzatura e mescolato a solfuri (113) che avevano re-perito cavato dalle suddette miniere, il costo all’epoca del carbone sul lago diComo, in Valsassina e a Porlezza, di cui era necessaria una quantita ‘‘ad usumet beneficium operis seu impresie ferri conficiendi’’, la ‘‘comoditate’’ per traspor-tare il minerale dalle miniere al lago, l’‘‘exitu seu fine qui ex eis fieri seu sortiriposse’’, ed anche l’‘‘incertitudine huiusmodi negotii seu impresie’’; ed inoltreavevano considerato che per lo sfruttamento di queste miniere ‘‘opus esset ma-ximas impensas facere’’ sia per lo scavo di nuove gallerie, sia per sgombrarequelle otturate. Nel complesso, essi prendevano in considerazione tutti gliscenari possibili: qualcosa di buono si poteva trovare qua e la ‘‘modica impen-sa reperiri possent vene bone et maxima in quantitate et notabilis valoris’’, maanche si poteva non trovare nulla, dato che erano passati oltre quaranta annia memoria d’uomo dacche queste miniere erano attive. Considerata quindil’incertezza dell’impresa, dichiarano che Nicola Cipriano (114) ‘‘possi a propriespese, et risico, far lavorare et cavare et a sua volonta benefficiar et beneplacitodisponere delle vene cavate et che cavera over fara cavare et delle materie e veneche cavera e fara cavare ne habbi da dare la vintena parte cioe d’ogni vinti somedi vena una somma a detti signori venditori et suoi heredi’’ (115). Per questo iTrivulzio avrebbero ricevuto dunque da Nicola Cipriano la vigesima del mi-nerale scavato; o, se non volevano aspettare l’evento di ‘‘questo negotio’’, po-tevano farsi pagare una tantum 50 scudi d’oro. In questa cifra non eranocompresi tutti i terreni, ‘‘busi da forno, vigne, selve et altre cose’’ poiche di essii due periti non avevano informazioni, ma si riservavano di dichiararle a ogni
Costanza Cucini Tizzoni214
foraminibus seu busis’’. La vena taxata era quella gia ridotta in pezzatura, pronta per essere ca-ricata nell’altoforno.
(113) Con il nome di marchesetta si intendevano le diverse forme di solfuro di ferro.(114) Il notaio estensore dell’atto passa a questo punto all’italiano.(115) La vigesima doveva ‘‘esser consegnata nel loco et supra le boche ove alla prima estrat-
tione delle buse, et cave, se reponera avanti se levino dalli conduttori et cavalanti della quale dettisignori venditori, o suoi heredi, ne possino fare il loro arbitrio’’. Il Cipriano Denti era tenuto aversare loro la vigesima poiche quello dei Trivulzio era un feudo imperiale; sui diritti minerari,che costituiscono ‘‘un ginepraio storico’’, MAINONI 2001, in particolare pp. 420-421.
richiesta delle parti. Il documento riguardava quindi solo le miniere, non glialtri possedimenti siderurgici dei Trivulzio. L’atto venne stipulato in Bellano,a casa di Nicola Cipriano senior.
Su questo documento si possono fare molte considerazioni. I protago-nisti, innanzitutto: Nicola Arrigoni e Nicola Cipriano Denti junior apparte-nevano entrambi al ceto di maggiorenti locali che nel Cinquecento raggiun-sero il controllo della produzione siderurgica della Valsassina, riuscendo difatto a monopolizzare il settore (116). Le straordinarie e spregiudicate iniziativeimprenditoriali nella produzione del ferro furono all’origine delle grandi for-tune economiche delle rispettive famiglie. Nicola Cipriano Denti, in partico-lare, la cui famiglia si era arricchita enormemente con le commesse d’armi emunizioni fabbricate nelle loro fucine di Bellano (117), riuscı proprio in questianni ad impossessarsi totalmente delle ricche miniere del Varrone, per assi-curarsi un costante rifornimento di metallo (118). I Cipriano Denti, desiderosidi inurbarsi, con i loro ingenti capitali avevano acquistato case in Milano eottennero importanti cariche nel Ducato (119).
Non sappiamo se e quando gli Odescalchi avessero iniziato a interessarsi disiderurgia, ma e interessante notare che qui Tomaso Odescalchi e il prestanome– submissa persona – di Nicola Cipriano. Degna di nota e poi la cifra estrema-mente ridotta alla quale vengono vendute le miniere dei Trivulzio: certo NicolaCipriano concludeva cosı un affare per lui estremamente vantaggioso.
Francesco da Ello, dal canto suo, era un esponente dei Negroni da Ellodetti Missaglia, la piu importante e ricca famiglia di armaioli milanesi che nelQuattrocento, per ricchezza e potenza, e stata paragonata ai Fugger. I Missa-glia, gia proprietari delle miniere di ferro e del forno di Canzo (Como) fra il1462 e il 1499, all’epoca di cui ci stiamo occupando versavano in precariecondizioni finanziarie (120). Dal documento in esame Francesco da Ello risul-
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia 215
(116) Tramite un lungo e spregiudicato rastrellamento di quote di miniere e impiantiproduttivi per diventarne esclusivi proprietari, TIZZONI 1998, pp. 27-29. Il processo si conclu-se alla fine del Cinquecento. I due protagonisti, e i loro antenati, sono attestati in centinaia diatti di compravendita, affitto di miniere, forni e fucine, trasporto di minerale e carbone; i re-gesti dei documenti d’archivio conservati all’ASMi sono in TIZZONI 1998.
(117) FRUMENTO 1963, pp. 65, 68: Nicola Cipriano Denti aveva una ‘‘fabrica di tutte learme ofensive et difensive’’.
(118) La famiglia Cipriano Denti era proprietaria del primo forno fusorio valsassinesegia nel Duecento (TIZZONI 1998, p. 36). Gli Arrigoni di Barzio risultano attivi imprenditorisiderurgici almeno dagli inizi del Trecento (TIZZONI 1998, albero genealogico).
(119) Per i notabili valsassinesi, l’accesso alle cariche pubbliche e l’ammissione nellaristretta cerchia degli aristocratici milanesi serviva anche a coprire meglio i loro abusi perpe-trati nella valle (TIZZONI 1998, pp. 29-30).
(120) Le fortune della famiglia si devono soprattutto a Tomaso (morto nel 1469) e a
ta residente a Bellano: forse collaborava in qualche forma col Cipriano Dentinelle fabbriche d’armi; in questo caso, come arbitro imparziale ci sembrereb-be piuttosto discutibile. Nello stesso 1581, il nostro Missaglia aveva chiestoal governatore spagnolo, don Sancio de Guevara y Padilla, di poter cercare ecavare qualunque miniera e vena metallifera nello Stato di Milano e di po-terla ridurre, di poter costruire a tale scopo edifici e artifici, strade e roggee di poter fabbricare armi, con vari privilegi ed esenzioni, come quelli cheerano stati concessi ad altri fabbricanti d’armi come appunto Nicola Cipria-no Denti. Il governatore lo autorizzo, a patto che pagasse la decima (121).
Insomma, e il gotha della siderurgia lombarda dell’epoca quello che ve-diamo agire a Dongo nel 1581. Come si vede, un intreccio indissolubile fraaffari, finanza e capitali, fortune imprenditoriali e famiglie in fase di ascesa odi decaduta di decadenza, produttori di armi e controllo delle materie primesta dietro l’epilogo dell’impresa siderurgica dei Trivulzio. Gli anni Ottantadel Cinquecento segnarono l’apice dello sviluppo della siderurgia lombarda,prima della sua inarrestabile crisi (122).
Conclusioni
Come si e visto, e molto difficile districare la matassa e mettere ordinenella serie di eventi che coinvolsero le zecche dei Trivulzio. La documenta-zione d’archivio e infatti lacunosa, spesso ambigua o ambivalente e sembraporre piu domande di quante risposte possa fornire.
Consideriamo innanzitutto i due inventari del 1526 e del 15.. (1529).Dal loro esame possiamo arguire i seguenti dati di fatto:
– nel 1529 a Roveredo l’Assazoria risultava pressoche vuota e danneg-giata dall’incendio del 1511, mentre la Stamparia e la Sbateria eranofortemente sguarnite e non operative;
– nel 1526 il nucleo maggiore delle attrezzature di zecca portate via daMesocco e costituito da strumenti per gli assaggi e dagli attrezzi piuimportanti per battere e stampare le monete.
Cio conferma quanto gia sapevamo da altre fonti: dopo l’incendio del
Costanza Cucini Tizzoni216
uno dei suoi figli, Antonio (morto nel 1496 o 1497); dopo di lui si ebbe il rapidissimo declinodella famiglia, a causa delle liti tra gli eredi; la crisi subı un’accelerazione dopo la deposizionedi Ludovico il Moro (TIZZONI 1989, p. 144). La loro fabbrica d’armi a Milano, la cosiddettaCasa dell’Inferno, era ubicata all’angolo fra via Spadari e la attuale via Victor Hugo, ma ave-vano filiali in molte localita (FRUMENTO 1963, pp. 12-15).
(121) Tutta la questione e pubblicata ampiamente da FRUMENTO 1963, pp. 70-76.(122) TIZZONI 2004, p. 261.
1511 a Roveredo, nello stesso anno compare a Mesocco una cassa inchiodatapiena di attrezzature di zecca; la cassa rimane nel castello, nella stessa stanza eancora inchiodata, almeno fino al 1517. E lecito dedurre quindi che nel1511 erano state portate via da Roveredo, e messe al sicuro a Mesocco, leattrezzature (123) piu importanti e trasportabili, mentre quelle piu ingombran-ti o forse desuete erano state lasciate nei locali della zecca. Risulta evidenteinoltre che dal 1511 al 1529 la zecca di Roveredo rimase inattiva – perben diciotto anni – e che venne riattivata solo per essere data in appalto alBesson, mentre la cassa di attrezzature non venne utilizzata nel castello, al-meno fino al 1517.
Che fine fecero i materiali portati via da Mesocco nel 1526? Arredi eartiglierie vennero mandati a Roveredo al Serravalle; poche artiglierie venne-ro messe in un cassone e consegnate all’Albriono. Le attrezzature di zeccavennero mandate o consegnate a Paolo Gentili da Serravalle; la cassa venneevidentemente aperta per farne l’inventario e trasportarne il contenuto. Nonci sono indicazioni che le attrezzature di zecca siano state portate a Roveredo.Vennero effettivamente vendute? Non e dato saperlo. Certo che esse non fi-gurano nell’inventario del 1529: se vennero davvero mandate a Roveredo,vennero tenute a parte, forse ancora imballate, finche l’Albriono non redassel’inventario dell’esistente nella zecca. Ci sono forti probabilita che questa ipo-tesi sia corretta, poiche come abbiamo rilevato le attrezzature portate via daMesocco sono per la maggior parte complementari e non doppioni di quellerimaste a Roveredo (Tabella 1). E la loro complementarieta esclude, in quan-to tale, che i materiali elencati nell’inventario del 1526 siano riferibili ad unazecca operante a Mesocco, alla cui esistenza nessuno dei due inventari fa ri-ferimento espressamente, come anche era gia stato notato per i documentifinora noti. Se ci fosse stata una zecca a Mesocco, le attrezzature relative sa-rebbero state sgombrate dal castello nel 1526 e costituirebbero un nucleoben piu corposo di quello inventariato.
Possiamo dunque concludere che la zecca di Mesocco non e mai esisti-ta, come aveva compreso il Tagliabue.
Estendiamo poi lo sguardo alla vicina zecca di Musso. Essa risulta attivaper sei anni, dal 1517 al 1523, quando cadde in mano al Medeghino. Le duezecche, di Roveredo e di Musso, risultano complementari, ma anche se vici-nissime, i loro ‘‘bacini di utenza’’ erano differenziati e distinti: da una parte ilmondo germanico e dei Grigioni, tramite la via del San Bernardino; dall’altral’alto Lario e gli intensi traffici siderurgici che vi si svolgevano.
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia 217
(123) Come per altro aveva gia ipotizzato TAGLIABUE 1890, pp. 386-387; vedi sopra,testo corrispondente alla nota 24.
E dietro l’impianto delle sue zecche si puo forse intravedere un disegnoimprenditoriale e speculativo di Gian Giacomo Trivulzio, fin dall’inizio cor-relato allo sfruttamento dei giacimenti minerari delle due zone. La successio-ne cronologica degli eventi non lascia molti dubbi: nel 1480-1487 Gian Gia-como otteneva il possesso del feudo della Val Mesolcina, nel 1499 procuravacrogioli per fondere argento a Mesocco dove dal 1503 al 1517 c’erano attrez-zi per cavare questo minerale. I suoi precoci interessi per le miniere d’argentoposte sui due versanti del San Bernardino sono documentati, mentre la zeccadi Roveredo esisteva almeno dal 1497. Dal 1508 lo troviamo attivo nella si-derurgia: in quell’anno egli ottenne il feudo di Musso e acquisto miniere eimpianti di ferro a Dongo. Nel 1511 egli ampliava i suoi possessi in questalocalita, dal 1518 controllava i giacimenti di Vercana e Domaso, mentre nelfrattempo impiantava la zecca a Musso.
Sono i giacimenti minerari, quindi, l’obiettivo della sua politica impren-ditoriale, alla quale le zecche fornirono un ulteriore strumento per integrare epotenziare i suoi introiti in una delle aree siderurgiche piu importanti e no-dali del Ducato di Milano.
Costanza Cucini Tizzoni218
IL LESSICO
Nel lessico seguente si sono riportate tutte le voci e le varianti grafiche degli strumentida zecca elencati nei due inventari, rimandando per la definizione alla prima in ordine alfa-betico. Si e specificato in quale documento e attestata ogni variante, definendoli documentoAI 1526 e AII 15..
ARAMO AII 15.. granato fonduto.Rame in grani. Nelle zecche i metalli erano ridotti in grani gettandoli fusi nell’acqua; inquesto modo risultava piu facile formare una lega esatta aggiungendo alla fusione la giu-sta quantita di metallo (CHIMIENTI 2001, p. 266). Secondo CARENA 1859, s.v. Granaglia-re: gli orefici, argentieri e gioiellieri riducono l’argento e l’oro ‘‘in granaglia spandendolofuso su carbon pesto, contenuto in un vasetto’’.
ASIAMENTI AII 15..Insieme degli utensili, forniture e strumenti relativi alla zecca e alle lavorazioni che vi sisvolgevano. Il termine e attestato in Piemonte per indicare la strumentazione di tipo-grafie o di cucine di taverne e osterie nel XVII-XVIII secolo (GRASSI 1804).
BADILLJ AII, 15..Badili. Impiegati nella fonderia, probabilmente per spalare il carbone, caricare e pulire iforni (CUCINI TIZZONI 1997, s.v. Badil ).
BALANZE; BALANZETE AI, 1526 ‘‘de latono’’; BALANZETI AII, 15.. ‘‘di honesta grande-za’’, ‘‘magiori’’.Bilance. Strumento di fondamentale importanza in una zecca, impiegato in quasi tuttele fasi della lavorazione. Sono attestate in varie misure, grandi e piccole, in ottone.
BANCHETI AII, 15..; BANCHI AII, 15.. ‘‘da stampari’’; ‘‘per bateri e coxere li danary’’.BANCHO AII, 15.. ‘‘di noce per numerare li denarj’’; AII, 15... BANCHETJ ‘‘cum li soi torsy
et torgij per poter lavorare’’.Banchi da lavoro allungati, dotati di schienale, dove si svolgono operazioni essenziali, comecontare o battere le monete; in quest’ultimo caso, sono dotati di morsetti per fissare coniie punzoni. In generale, nelle zecche si diffonde l’impiego di banchi allungati a partire dal Cin-quecento (TRAVAINI 2007b, p. 265).BASETO AII, 15..
Vasetto.BASNETI AII, 15.. ‘‘di aramo’’.
Forse e la grafia errata per Basla o Basletta: secondo CHERUBINI 1840, s.v. catino, ciotola,vaso grande e spaso di terracotta o di legno. In questo caso si tratterebbe di vasi di ramelarghi e ampi. Nella zecca austriaca di Milano le monete erano conservate in sacchetti,cassette e ‘‘baslotti’’ (CUCINI TIZZONI 2010, p. 307).
BRONZINO AI, 1526 ‘‘con lo pestono’’; AI 1526 BRONZO ‘‘grande roto nel fondo’’.Mortaio di bronzo, dove pestare i ceneracci o le coppelle per recuperarne tutto il me-tallo.
BUGNA AI, 15.. ‘‘de aramo’’.Impiegata nella fonderia.
CANALE AI, 1526 una ‘‘de fero’’. AI 15.. ‘‘feri sotili per gitare lo argento’’.Canaletta per gettare il metallo, lingottiera. CARENA 1849, s.v. Canale: ‘‘parallelepipedodi ferro, sulla cui faccia superiore e scavato un canale, in cui, come in una forma, si getta ilmetallo fuso’’; in quello ‘‘per lamine la cavita e pochissimo fonda e molto larga’’. CUCINI
TIZZONI 2010, p. 279.CAZA AII, 15.. ‘‘de aramo’’; di ferro; CAZAROLLA AII, 15..
Cazza. Sorta di grosso cucchiaio o mestolo, di rame o di ferro, impiegato per attingere
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia 219
liquidi, per saggiare i metalli fusi, per fondervi o gettare i metalli (CUCINI TIZZONI 1997,s.v. Caza, con bibliografia).
CHIERGI AII, 15.. ‘‘di ferro’’.Cerchi di ferro.
COPELE AI, 1526.Coppelle, piccoli recipienti porosi realizzati in ceneri di ossa e di corno pressate, lavate eliberate da tutti i residui carboniosi, poi setacciate e mescolate a polvere di mattoni (CU-
CINI TIZZONI 2010, pp. 298-299). Usate per fare assaggi, o per affinare piccole quantitadi metallo prezioso.CORZOLI AI, 1526 ‘‘de fero’’; CORXOLO AI, 1526 ‘‘de fero’’; CROSOLI..., CRO-
XOLJ AII, 15.. ‘‘di creda portati de pitra’’; di ferro.Crogioli, di ferro o di argilla.
CRIBIJ AI, 1526 ‘‘de latono’’; CRIBRY AII, 15.. ‘‘de aramo’’.Vagli, setacci di ottone o di rame.
FERI AI, 1526 ‘‘sotili per gitare lo argento’’; FERRJ AII, 15.. ‘‘contasiati su la cima per metere looro’’.Strumenti allungati di ferro per favorire il getto del metallo nelle canalette.
FORBEXO AI, 1526 ‘‘grande per la zecha’’; FORFESE AII, 15.. ‘‘grande da tagliari le lami deargento quando e fonduto ben in ordine’’; ‘‘grande da tagliare le lame de argento’’; FOR-FESI AII, 15.. ‘‘di ferro picoli’’; ‘‘uno paro [...] molir de ferro’’.Forbicioni per ritagliare le lamine d’oro e d’argento in strisce e in quadrelli. Usati ancoranella zecca austriaca di Milano (CUCINI TIZZONI 2010, p. 280).
FORMA AI, 1526 ‘‘per fare le copele’’.Stampo o anima, forse in legno, per realizzare le coppelle.
FORNELI AII, 15.. ‘‘per far li assazi’’.Fornelli, forni di riscaldo di piccole dimensioni, utilizzati per effettuare gli assaggi delleleghe impiegate.
FORNELO AII, 15.. ‘‘da fondere’’; ‘‘da fondere lo oro’’; AI, 1526 ‘‘de fero’’; FORNELLO AII,15.. ‘‘de ferro’’; da fondere.Forni di piccole dimensioni, di solito di ferro, in certi casi portatili, dove vengono li-quefatti i metalli che compongono la lega e dove si cuociono le monete nelle varie fasidella lavorazione.
INTROMEZARI AII, 15..CHERUBINI 1840, s.v. Intromiss: inframmesso, intromesso. Si tratta probabilmente dispessori in ferro. Sono relativi alle pietre da fondere.
LAME AII, 15.. ‘‘de argento’’; LAMI AII, 15.. ‘‘de argento’’.Lamine d’argento di spessore sottile e regolare, ottenute gettando il metallo liquefatto inuno stampo di pietra o di ferro fatto a canalina.
LIGNAMI AII, 15.. ‘‘da metter per pesare li danari’’.Forse l’incastellatura di legno che sostiene una grossa bilancia.
LIME AII, 15..Lima. Utensile utilizzato dal maestro delle Stampe per fare i conii.
MANTESI AII, 15..; MANTESO AII, 15..; MANTEXETO AI, 1526; MANTISELO AII,15... ‘‘al fornelo da fonder oro’’.Mantice, di solito se ne impiega una coppia per ottenere un flusso di vento continuo.Arnese in legno e pelle con cui si produce una rapida corrente d’aria e la si spinge sulfuoco per avviarlo o per ravvivarlo. Il mantice perenne produce un soffio continuo (CU-
CINI 1990). I mantici sono impiegati anche nei forni e nelle fucine da ferro e da rame(CUCINI TIZZONI 1997, s.v. Manteci).
MARCHO AI, 1526 ‘‘de latono con li soi pexi’’, ‘‘con dui pexi dentro’’.
Costanza Cucini Tizzoni220
Strumento per marcare o contrassegnare. CHERUBINI 1840, s.v. Marca: Marchio, marco,contrassegno, ‘‘Impressione che si fa sui lavori, utensili, strumenti per contrassegnarne ilfabbricatore. Marca dell’argento, dei pesi, delle misure’’. Vedi anche s.v. Peso da marche.A Bologna dal 1475 al 1709 i marchi sono i pesi delle bilance superiori alla libbra (CHI-
MIENTI 2001, p. 266).MARTELLI AII, 15.. ‘‘per uso di farer stampe’’.
Martelli impiegati dal maestro delle Stampe per realizzare i conii.MAZA AII, 15.. ‘‘di ferro groso’’; MAZETE AII, 15.. ‘‘di ferro’’.
Mazza, martello di ferro di peso variabile, usato per spianare le monete.MOIETA AI, 1526.
Molle di ferro, strumento simile alle tenaglie, ma di dimensioni maggiori, con diversitipi di bocche a seconda dell’impiego che se ne fa. Nelle fucine da ferro il termine indicadei grossi tenaglioni che somigliano alle corna dell’insetto detto rinoceronte (CUCINI
TIZZONI 1997, s.v. Moetta). Sono impiegate al fuoco del fornello per afferrare i manu-fatti incandescenti, forse per le lamine da infuocare; nelle zecche sono utilizzate ancheper tenere impilati i tondelli durante la lavorazione, come illustrato nella pala dell’altaredi St. Annen.
PADELA AII, 15.. ‘‘grande da purgare li denarj’’; PADELLA AII, 15.. ‘‘da purgare danarj cumil manico lungo’’; ‘‘di aramo’’.Padella di rame, con un lungo manico, usata per il decapaggio o sbiancatura delle mo-nete, cioe per far ricomparire il vero colore metallico (CUCINI TIZZONI 2010, p. 286).
PALE AI, 1526 ‘‘de fero’’. ‘‘Paleta grande’’; PALETA AII, 15.. ‘‘di aramo da tuor suso li danarj’’;di ferro.Paletta di ferro o di rame per tirare su le monete nelle varie fasi della lavorazione.
PESI AII, 15.. ‘‘de piombo’’; PESO AII, 15.. ‘‘grande da marche’’; ‘‘picolino di lotono’’; ‘‘da pe-sare denarj di varie sorti’’; PEXO AI, 1526 ‘‘de pomblo’’.Pesi di vario tipo, materiale – ottone, piombo – e misure, da usare con le bilance dellazecca.
PEZI AII, 15.. ‘‘de ferro longhi’’; PEZO AII, 15.. ‘‘di piombo’’; AII, 1526 ‘‘de fero per fare lografio’’.Pezzi di ferro o di piombo di vario utilizzo.
PIASTER AII, 15.. ‘‘larghe di ferro da meter lo oro’’.Piastre di ferro, canaline dove gettare l’oro liquefatto per ottenere lamine.
PIETRE AII, 15.. ‘‘da fonderi’’, ‘‘predre’’; PREDE AII, 15.. ‘‘da fondere con li soi ferry da ognacanto cioe intromezari’’.Stampi in pietra, con scavata una canalina sulla parte superiore, dove si gettano i metalliliquefatti per ottenere lamine. Sono dotati di spessori da tutti i lati, per ottenere lamineregolari.
PILETE AI, 1526 ‘‘de piu sorte’’; PILLI AII, 15..Pila, conio d’incudine.
PISTONO AII, 15.. ‘‘gran pistono de ferro’’.In BIRINGUCCIO 1540 pistone e il pestello (CARUGO 1977, s.v.). Nella zecca di Bolognanel 1574 e nel 1654 e il pestello del mortaio (CHIMIENTI 2001 pp. 268, 269). Anche neldialetto milanese, CHERUBINI 1840, s.v. Peston: pestello, pestatojo, pestone, ‘‘Stromentocol quale si pesta e dicesi piu particolarmente di quello del mortaio’’. Si veda l’Encyclopedie1983 p. 532: la tavola relativa al lavoro nelle zecche mostra il lavaggio del ceneraccio e,in primo piano, operai che pestano le scorie in grandi mortai con enormi pestelli azio-nati tramite un bilico.
SACHETI AII, 15.. ‘‘per conservar creta’’.Sacchi dove era conservata la creta per realizzare crogioli.
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia 221
SEDAZO AII, 15..Setaccio.
SEDELA AII, 15.. ‘‘de aramo’’; ‘‘da tener acqua’’.Piccolo secchio di rame per contenere acqua.
SEGIA AII, 15.. ‘‘de boscho ferrata’’.Secchia di legno incerchiata di ferro.
SPONTANARIA AII, 15.. ‘‘vecchia’’; SPONTONARIA AI, 1526 ‘‘de piu sorte pexata ad onze12 per lipra’’.Punzoni recanti l’arma o la sigla di Gian Giacomo Trivulzio, impiegati dall’incisore omaestro delle stampe per preparare il conio delle monete.
STAMPE; STAMPI AII, 15..Conii con inciso il tipo che doveva essere stampigliato sulle monete.
TASO AI, 1526 ‘‘de la zecha’’.Tasso, un tipo di incudine senza corni. Se di grandi dimensioni e piantato in un ceppodi legno, se e piccolo se ne stringe la coda in una morsa (CUCINI TIZZONI 1997, s.v. Ta-cello). Su di esso si battono le monete, o si lamina una piccola quantita di metallo per gliassaggi.
TENAGLI AII, 15.. ‘‘grandi da tuore susa croxolj’’; TENAGLIA AII, 15.. ‘‘picola di ferro’’;TENAGLIE AII, 15.. ‘‘picole de ferro da tuorsi su li crosoli da oro’’; ‘‘di ferro da tuore susacroxolj’’; TENAIE AI, 1526 ‘‘grande per levare li corxoli fora dil focho’’.Tenaglie, strumento di ferro. Ne esistono diversi tipi a seconda della grandezza e dellefasi della lavorazione in cui sono impiegate. Servono di solito per afferrare i crogioli do-ve vengono fusi i metalli, toglierli dal forno e gettare il metallo in uno stampo.
TORGIJ AII, 15.. dei banchetti; ‘‘per serrare le prede da fondere’’; TORGJ AII, 15..Secondo CHERUBINI 1840, s.v. Torcett: ‘‘termine de’ battiloro. Strettojo armato di ferro peristringere le scacciate’’. Il termine, piuttosto generico, sembra riferirsi a incastri o piccolimorsetti impiegati per fissare bene le pile o conii d’incudine al banco di lavoro; nellaseconda accezione, per chiudere in modo sicuro gli stampi di pietra dove veniva gettatoil metallo liquido per farne lamine.
TORSELJ AII, 15..; AII ‘‘torzelo de bronzo’’; TORSY AII, 15..Conio di martello, o di rovescio (TRAVAINI 2007a, pp. 28-30).
USIDELJ AII, 15..Utensili, attrezzature. Insieme di attrezzi impiegati nella zecca.
VASELJ AII, 15.. ‘‘di boso’’.Vasi di legno di varie dimensioni.
Costanza Cucini Tizzoni222
TABELLA 1: Prospetto riassuntivo delle attrezzature di Zecca di Mesocco e di Roveredo.
ATTREZZATURE MESOCCO 1526 ROVEREDO 1529
Torsello di bronzo 1
Torselli e pile (in totale) 383 151
Punzoni (‘‘spontonaria’’) 12 kg Si
Cribbi 2 7
Bilance 5 5
Marchi con pesi 2 1 ...
Forma per coppelle 1
Tassi 1
Crogioli di ferro 6 15
Crogioli di creta 120
Mantici 1 3
Conche di rame 2
Pale di ferro 4 5
Canali di ferro 25
Moietta 1
Fornelli di ferro 1 4
Forbicioni 1 6
Tenaglie per crogioli 3 7
Lime Si
Martelli per stampare Si
Mazze di ferro 4
Banchi con torsi e torgi Si
Pietre da fondere Si
Banco per numerare denari Si
Basneti di rame 3
Vasi di legno Si
Rame in grani Si
Torgi 2
Caldere di rame Si
Piastre da oro 2
Cazza di ferro Si
Padelle 3
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia 223
ATTREZZATURE MESOCCO 1526 ROVEREDO 1529
Secchie Si
Banchi per stampare e battere Si
Costanza Cucini Tizzoni224
APPENDICE
Archivio di Stato di Milano - Famiglia Trivulzio, detto Archivio Novarese.
CARTELLA 34
Documento I
Quinterneto dele robe portate fora di castelo 1526 et venduteF. 1 Primo Robe mandate a Rovore al Seraval / Leti dui pexano libre 4 - 4 ad onze 30 per lipra /Zerzi 28 de fero ligati con lo filo de fero / Axe X: grande / Tole 12 che erano ala porta de fora /Le barile del solfaro et lo sacho grande et li dui picoli pieni di solfaro / La ferata grande piegataet feri 14 / Una altra ferata piegata et feri 4 / Una altra ferata drita et feri 14 / F. 2 Robe man-date al Seraval / Item pezo 1 de fero per fare lo grafio a Petro darigazzo / Item mandato a messerlo commissario lo torzelo de bronzo / Item pilete de piu sorte numerate / Per Guielno conse-gniate al Seraval per la zecha sono a nº 176 / Item torseli a nº 207 / Spontonaria de piu sorte /Pexata ad onze 12 per lipra libre 36 / Cribij dui de latono pertuxati 2 / Balanzete 2 grande delatono 2 / Balanzete 3 - - 3 / Marcho 1 de latono con li soi pexi 1 / Marcho 1 con dui pexidentro 1 / Uno pexo de pomblo pexa liprete 16 1 / Forma 1 � per fare le copele / Una stafade bronzo / Lo bronzino con lo pestono / Tasi 3 et corzoli 5 de fero / F. 3 Robe consignate alSeraval / Lo mantexeto lo coperto dil forneto et tasi 2 / Item conche 2 daramo / Pale 3 de fero etuna canale de fero / Una moieta et la paleta grande / Uno corxolo de fero / Item dui bastoni defero pexano libre 47 � / Item lo fornelo de fero / Item uno forbexo grande per la zecha / Itemuna canale feri 24 sotili per gitare lo argento et tenaie 3 grande per levare li corxoli fora dil focho/ Item ferate 5 cum bastoni 58 / Item una ferata dui bastoni partuxati et bastoni 3 tondi / Itemuna altra ferata uno bastone partuxato et 5 quadri / Manezi 2 grandi da le caze de la artalaria /Dui cadenazi grandi uno tondo laltro quadro / Due axe grandi luna con lo zilio laltra no / F. 4Robe consigniate al Seraval / La lecarda la forcela dal focho / et lo cane de fero per le bote / Unofero da bandirola / Uno regiono de fero largo et longo et uno altro fero piegato / Item libre 15de giodi ala grosa / Dui tasi roti / Bastoni 4 largi et grosi che erano per la artalari / Uno ferolongo che era foreto per lartalaria / Item una ferata piegata venduta a Lorenzo da Sachio / Ba-stoni 2 quadri grosi per lartalaria / Lo lambicho de pomblo / Lo uxelo de bronzo per li mantexi/ Uno pezo de fero tondo per le anime dele artalarie / Serature 2 grande per le porte de castelo /et uno fero de verzela piegato / Pezi 5 de feri longi et largi per lartalaria / Pezi 2 de fero che vanosopra le rode / Una coda de springarda et una saratura / F. 5 Robe mandate al Seraval / Unopiumazo / Lo carelo dil molino con lo palfero / Pezi 3 de una anima de fero / La catena et lasegia dela cisterna / Pezi 7 de fero dele rode dela artalaria / Una ferata fornita sono bastoni X /La corazina coperta de veluto cilestro / Corazine 4: et secrete 5 / La barile deli tripoli / Lo bron-zo grande roto nel fondo / Lo taso dela zecha qual a roto la coda / Bronzo uno pexa libre 14 - /Item bronzo roto libre 39 / Item la campana dil relorio / Item la campana dela guarda / Item loleto con lo piumazo et una coperta rota mandati al commissario / Item la caldera grande chestaxeva al prestino data a Donato dil Marcha per commissione dil commissario per habere pro-curato a Rovore in criminal / F. 6 Robe mandate a Rovore al Seraval / La caldera rota che facevalo salnitrio et taiata per fare conzare la caldera de rozio che rota / Item mandato la zila tutaconsignata al Seraval / Item balote 100 da archabuxi / Mandate a Rovore a messer Gioangeor-gio / Item mandati lo bronzino a messere Gioangeorgio pexa libre 9 et lo pestono libre 10 emezzo posto a conto al Seraval / Item balote 100 da archabuxi dati a messer lo commissarioportate a RovoreItem mandato a Rovore per lo casone archabuxi 3 de bronzo et libre 19 e mezzo de pomblo etforma 1 da fare le balote consignato a messer Gioangeorgio Albriono
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia 225
Item 1531 adı 14 marzo per archabuxi 3 de bronzo et archabuxi 3 de fero dati a Balzarino daBoso et a Iacomo Toschano a nome dela comunita de Mixoco per andare in Voltolina contralo Medichino a Morbinio per commissione de messer lo commissario / Item libre 25 de pol-vere fina ala grosa / Item balote 500 da archabuxi et paira 4 de forme / Item balote 60 daarchabuxi ali soldati de Mixoco / Item balote 8 per li canoni che erano a Musso / F. 7 A mes-ser Donato del Marcha una spingarda de bronzo con lo suo cepo et coda de bronzo / A messerMartino Bonolino una spingarda de bronzo con lo suo cepo et sua coda de bronzo / A Bal-zarino de Boso uno archabuxo de bronzo / A Marchino del Marcha uno archabuxo de fero asuo fiolo / Al fiolo del Soazino uno archabuxo de fero / A Marchino uno archabuxo de bronzo/ Item uno altro archabuxo lavorato con lo suo manicho et de bronzo / A Iacomazo del Ban-diral una springarda de fero intrega senza coda / Item balote 30 de pomblo / Al Iona suo fra-tello una spingarda de bronzo con lo cepo et la coda de bronzo / Item una altra springarda defero con lo suo cepo et code 2 de fero et paira 2 de forme da fare le balote.
CARTELLA 34
Documento II
Frontespizio (ottocentesco?) di una cartelletta. Zecca. Misocco. 15.. (1529)Inventario delle stampe, assamenti e ferramenti usideli e altre cose spettanti a Zeca quale siritrovano a presente nella casa de lo Illustrissimo marchese conte de Misocco quale ha in Ro-vareto e dove si fa lavorare la zeca.F. 1 Inventario de le stampe asiamenti et ferramenti usidelj et altre cose aspettanti a la Cechaquale se ritrovano di presente In la casa de lo Illustrissimo signor marchese conte de Musochoquale ha in Rovareto et dove se fa lavorare la Cecha.Per primo in li doi cameri de sopra dove staseva mastro Ioanne Andrea di Carati di Vercellimaestro de le stampe che sono infrascripte cose / Una lettera senza letti et fornimenti (can-cellato) / Una caseta honesta voyda / Una casa in la quali li sono le infrascripte cose / Perprimo la spontanaria vecchia del signor Ioanni Iacomo Trivultio / Molte lime et martelli etaltry usidelj per uso di farer stampe / Molti torselj et pille non lavoiraty / Tri banchetjcum li soi torsy et torgij de poter lavorare / Uno mantiselo picolo / In la cusina / Una sedelade Aramo / Un’altra sedela de Aramo / Una caza de Aramo / Uno bacilo de aramo / Unapeltrera / Una catena da focho / Li soi arcibanchi alintorno de la cusina / F. 2 In la camerade soto presi la cusina / Una lettera / Una cazarolla / Una tavola / Una catedra da camera / Inla camera dove dormiva el fonditore quale e apreso la porta / Una (cancellato) / Una lettera /Uno bancheto / In la Assazoria / Quatro pietre da fonderi / Li soi banchetti / Li mancha liforneli per far li assazi per che sono stati desfati quando se bruso dita casa / Preso la Assazoria /Li e uno loco da tenere carboni / Dretro li e la maestrisa / In la maestrisa li sono li infrascripticosi / Uno bancho di noce per numerare li denarj / Uno paro de balanze di honesta grandeza /Uno altro paro de balanze molto magiori / Trj para de balanzeti / Uno gran(de) peso da mar-che / Uno peso picolino di lotono / F. 3 Quatro pesi de piombo tra picoli e grandi / Tri ba-sneti di aramo / Molti vaselj di boso tra picoli e grandi / Una paleta di aramo da tuor suso lidanarj / Doj carimali non tropo boni / Uno peso da pesare denarj di varie sorti / Uno grandepezo di piombo / Certo pocho Aramo granato fonduto (cancellato) / In una caseta dove laassazatore (cancellato) guardia li teniva li stampi et libro de li contj / Testoni de la Madonaet meze dobbi / Pilli et torselj nº 25 / Pilli et torseli de homo armato 7 / Da quatrini 20 /Soldini 20 / Cornoni 25 / Cavaloti 18 / Testati 34 / Da tri soldi 2 / F. 4 In la fondaria /Uno fornelo da fondere con li croxolj lo argento / Uno altro fornelo da fondere cum li mantesilo argento / Uno altro fornelo da fondere lo oro / Croxolj di creda portati de pitra (o piera) linº creta 120 / Croxolj di ferro nº 6/ Doi torgij per serrare le prede da fondere / Dette predre
Costanza Cucini Tizzoni226
da fondere con li soi ferry da ogna canto cioe / Intromezari / Cinqui (cancellato) Soy grandicalderi de Aramo / Cribry sei de Aramo / Una sedela de aramo da tener aqua / Uno mantesogrande mangiato da rati. Se potera far aconzare / Uno fornello de ferro disfato / Uno forfesegrande da tagliari le lami de argento quando e fonduto ben in ordine / Uno mantiselo ordi-nato al fornelo da fonder oro / Doi chiergi di ferro / Doi piaster larghe di ferro da meter lo oro/ Uno forfese grande da tagliare le lame de argento / Una caza di ferro / Una padela grande dapurgare li denarj / Doi tenaglie picole de ferro da tuorsi su li 9 crosoli da oro / Doi ferrj con-tasiati su la cima per metere lo oro / Una bugna de aramo picola / Uno baseto / F. 5 Tri torgj /Tri badillj / Una segia de boscho ferrata / Doi mazete di ferro / Tre tenaglie di ferro da tuoresusa croxolj / Tre forfesi di ferro picoli / Uno paro di forfesi molir de ferro / Una paleta diferro / Una sega (o segia) / Uno gran pistono de ferro / Uno sedazo / Doe tenagli grandi datuore susa croxolj / Una maza di ferro groso / Una tenaglia picola di ferro / Tri pezi de ferrolonghi / Doi sacheti dover pono conservar creta questa () di tropo / In la stamparia / Banchitrj cinque da stampari bonj / Una padella da purgare danarj cum il manico lungo / Una mazadi ferro / Certj lignamy da metter per pesare li danari / Una padella di Aramo senza manicho /In la Sbateria / Sete banchi et nove sol bisognara per bateri et / coxere li danary et multi altriusidelj prontj / F. 6 In Rovareto se trovara quatro maestri che sano batere et operare / In Bel-lizona se trovarano alcunj bonj stampatorj et operarij / Et penso che qui et sul contato se tro-varano alcunj fonditorij che/ A me pare sara molta comodita e tuta volta (cancellato) / Tutoper adverso / Tuta volta chel sia in liberta de torli dove li parera.Sul retro:Instrumenti de li beni et cose sono in la Ceca mandato al maestro de la CechaAA
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia 227
ABBREVIAZIONI E BIBLIOGRAFIA
ASMi: Archivio di Stato di MilanoARCANGELI L. 2003, Gian Giacomo Trivulzio marchese di Vigevano e il governo francese nello
stato di Milano (1499-1518), in L. ARCANGELI (a cura di), Gentiluomini di Lombar-dia: ricerche sull’aristocrazia padana nel Rinascimento, Milano, pp. 3-68
BIRINGUCCIO V. 1540, De la Pirotechnia, VeneziaCARENA G. 1859, Vocabolario italiano d’arti e mestieri, I-II, NapoliCARUGO A. 1977, Introduzione e Glossario in BIRINGUCCIO 1540, ristampa, MilanoCERINO BADONE G. 2006, A ferro e a fuoco. Soldati, societa, tecnologia e guerra agli inizi del XVI
secolo, in P.P. POGGIO, C. SIMONI (a cura di), Musei del ferro in Europa e in Italia. Attidel Convegno Brescia (Tavernole sul Mella, 24-25 settembre 2004), Brescia, pp. 63-80
CHERUBINI F. 1839-1843, Vocabolario milanese-italiano, MilanoCHIARAVALLE M. 1996, La monetazione dei Trivulzio nelle Civiche Raccolta Numismatiche di
Milano, MilanoCHIESI G. 1999, ‘‘Antique vene ferri’’. Imprese minerarie e siderurgiche nel sec. XV in Valle Mo-
robbia, ‘‘Minaria Helvetica’’ 19b, pp. 5-11CHIMIENTI M. 2001, La zecca di Bologna, evoluzione degli ambienti e delle attrezzature dedotta
da alcuni inventari, in I luoghi della moneta 2001, pp. 259-279CUCINI C. 1990, Alcune osservazioni intorno ad un antico mantice da fucina, ‘‘Archeologia Me-
dievale’’ 17, pp. 749-759CUCINI TIZZONI C. 1995, Gli altoforni dei d’Adda a Locarno Valsesia: inventari e tecnologia,
‘‘Archivi e storia’’ 13-14, pp. 67-106CUCINI TIZZONI C. 1997, Le fucine da ferro e i magli da rame delle Alpi lombarde, in M. TIZ-
ZONI, Il comprensorio minerario e metallurgico delle valli Brembana, Torta e Averaradal XV al XVII secolo, Bergamo, pp. 415-526
CUCINI TIZZONI C. 2008, Il maglio, la fucina, i forni e il pestaloppe della Valle delle Forme (Bien-no, Brescia), ‘‘Notizie Archeologiche Bergomensi’’ 16, pp. 227-248
CUCINI TIZZONI C. 2010, La zecca di Milano in eta austriaca. Reperti archeologici e documentid’archivio sulla tecnologia, ‘‘Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini’’ 111,pp. 267-322
CUCINI C. 2012, Venti anni di ricerche archeometallurgiche in Italia del nord, in C. CUCINI (acura di), Acta mineraria et metallurgica. Studi in onore di Marco Tizzoni, ‘‘NotizieArcheologiche Bergomensi’’ 20, Bergamo, pp. 39-56
CUCINI C., MESSIGA B., REBAY G., RICCARDI M.P. 2012, La riduzione del rame in Val Lanterna(Sondrio) nella prima eta del Ferro: studio petrografico delle scorie silicatiche, in C. CU-
CINI (a cura di), Acta mineraria et metallurgica. Studi in onore di Marco Tizzoni,‘‘Notizie Archeologiche Bergomensi’’ 20, Bergamo
CUCINI TIZZONI C., TIZZONI M. 2006, Alle origini dell’altoforno: i siti della Val Gabbia e dellaVal Grigna a Bienno in Valcamonica, in P.P. POGGIO, C. SIMONI (a cura di), Museidel ferro in Europa e in Italia. Atti del Convegno (Brescia-Tavernole sul Mella, 24-25settembre 2004), Brescia, pp. 21-42
DI FILIPPO BAREGGI C. 2006, Crinali alpini e passi, frontiere e confini linguistici, politici, religiosifra ’500 e ’600: la Val Mesolcina, in C. DONATI (a cura di), Alle frontiere della Lom-bardia: politica, guerra e religione nell’eta moderna, Milano, pp. 41-70
Encyclopedie 1983: J. PROUST (a cura di), Il mestiere e il sapere duecento anni fa. Tutte le tavoledell’Encyclopedie francaise, con note e commenti alle tavole di G. BUZZI, Milano1983
ERCKER LAZARUS 1563, Das Munzbuch, in P.R. BEIERLEIN (bearb. von), H. WINKELMANN (hrsg.von), Drei Schriften, Bochum 1968, pp. 267-326
Costanza Cucini Tizzoni228
FRUMENTO A. 1963, Imprese lombarde nella storia della siderurgia italiana, II. Il ferro milanesetra il 1450 e il 1796, Milano
GAZZERA C. 1842, Memorie storiche dei Tizzoni conti di Desana e notizia delle loro monete,‘‘Memorie Reale Accademia delle Scienze di Torino’’ ser. II, 4, Torino, pp. 1-246
GIROLA G. 2003, La zecca di Musso sul lago di Como: Gian Giacomo de Medici tra gli Sforza e ladominazione spagnola, ‘‘Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini’’ 104,pp. 329-368
GIROLA G. 2011, Musso, in L. TRAVAINI (a cura di), Le zecche italiane fino all’Unita, Roma, vol.2, pp. 919-921
GNECCHI F. ed E. 1887, Le monete dei Trivulzio, MilanoGRASSI G. 1804, Della tipografia in Mondovı, MondovıI luoghi della moneta 2001: I luoghi della moneta. Le sedi delle zecche dall’antichita all’eta mo-
derna. Atti del convegno internazionale (22-23 ottobre 1999), MilanoL’Industria del ferro 1883 - 1885 - 1889: L’industria del ferro nelle valli Morobbia, Dongo e
Cavargna e sul lago d’Orta, ‘‘Bollettino Storico della Svizzera Italiana’’ 1883,pp. 38-40, 91-94; 1885 pp. 118-119; 1889 pp. 282-283: anonimo (ma E. MOT-
TA)JERVIS G. 1873-1889, I tesori sotterranei dell’Italia, 4 voll., Torino (rist. anast. Milano 1979)KRAHENBUHL H. 2001, Schwefel - Vitriol - und Alaungewinnung auch in der Schweiz, ‘‘Bergk-
nappe’’ 2, pp. 3-6MAINONI P. 2001, La politica dell’argento e del ferro nella Lombardia Medievale, in PH. BRAUN-
STEIN (a cura di), La siderurgie alpine en Italie (XIIe-XVIIe siecle), Roma, pp. 417-453
MARCACCI M. 2011, Il palazzo o castello Trivulzio a Roveredo, ‘‘Il Moesano’’ (19 Agosto 2011)MARINI C. 2007, Due trattati di metallurgia della Biblioteca Marciana di Venezia. Tecniche di
estrazione e raffinamento dei metalli tra XV e XVI secolo, Martina FrancaMAURIZIO R. 1972, Indagini su vecchie cave e miniere in Bregaglia, ‘‘Quaderni Grigionitaliani’’
41/1-4, 71 pp.PALAZZI TRIVELLI F. 1994, Oro e argento in Valchiavenna nel 1464, ‘‘Clavenna’’ 33, pp. 87-94PISONI P.G., FRIGERIO P. 1983, I diritti borromei di sfruttamento minerario nei feudi verbanesi e
ossolani, ‘‘Bollettino Storico per la provincia di Novara’’ 74/1, pp. 5-44ROVEDA E. 2012, La formazione del patrimonio fondiario dei Trivulzio (XV-XVII secolo), in E.
ROVEDA, Uomini, terre e acque. Studi sull’agricoltura della ‘‘Bassa lombarda’’ tra XV eXVII secolo, Milano, pp. 114-126
ROSSINI F. 2011, Mesocco e Roveredo, in L. TRAVAINI (a cura di), Le zecche italiane fino all’U-nita, Roma, vol. 2, pp. 1361-1368
SANTI C. 1988, Fonti per la storia del castello di Mesocco, ‘‘Quaderni Grigioni Italiani’’ 57/2,pp. 135-163
SANTI C. 1994, L’appalto della zecca di Roveredo nel 1529, ‘‘Rivista Mesolcina e Calanca’’ 4[senza indicazione di pagine]
TAGLIABUE E. 1889, Il castello di Mesocco secondo un inventario del 1503, ‘‘Bollettino Storicodella Svizzera Italiana’’ 11/11-12, pp. 233-252
TAGLIABUE E. 1890, E davvero esistita la zecca di Mesocco?, ‘‘Rivista Italiana di Numismatica’’,pp. 369-424
TAGLIABUE S. 1927, La signoria dei Trivulzio in Valle Mesolcina, Rheinwald e Safiental, MilanoTIZZONI M. 1986, I d’Adda come metallieri, in M.G. CAGNA PAGNONE (a cura di), La famiglia
d’Adda Salvaterra e la Valsesia. Catalogo della mostra documentaria, Borgosesia,pp. 119-142
TIZZONI M. 1988, Gli agenti minerari dei d’Adda a Locarno nel XVII secolo, in Momenti del-l’attivita mineraria e metallurgica in Valsesia, Varallo Sesia, pp. 9-59
La zecca dei Trivulzio in Val Mesolcina (1526-1530). Inventari e tecnologia 229
TIZZONI M. 1989, Le miniere di Canzo (Como), ‘‘Rassegna di Studi del Civico Museo Archeo-logico e del Civico Gabinetto Numismatico di Milano’’ fasc. 43-44, pp. 143-155
TIZZONI M. 1997, Il comprensorio minerario e metallurgico delle Valli Brembana, Torta e Ave-rana dal XV al XVII secolo, Bergamo, pp. 1-414
TIZZONI M. 1998, Il comprensorio minerario e metallurgico valsassinese, Materiali - MonografiePeriodiche dei Musei Civici di Lecco, Lipomo
TIZZONI M. 2004, Verso la crisi: la produzione siderurgica del Ducato di Milano tra il XV e ilXVII secolo, in R. TASSER, E. WESTERMANN (hrsg von), Der Tiroler Bergbau und dieDepression der europaischen Montanwirtschaft im 14. Und 15. Jahrhundert, Inn-sbruck, pp. 255-262
TIZZONI M., CUCINI TIZZONI C. 1999, Carena - Localita ‘‘Il Maglio’’, campagne di scavo 1997 e1998, ‘‘Minaria Helvetica’’ 19b, pp. 12-24
TRAVAINI L. 2001, Sedi di zecca nell’Italia medievale, in I luoghi della moneta 2001, pp. 69-83TRAVAINI L. 2007a, I conii e le zecche, in L. TRAVAINI, A. BOLIS (a cura di), Conii e scene di
coniazione, Roma, pp. 27-66TRAVAINI L. 2007b, Le zecche illustrate: iconografia e interpretazione, in L. TRAVAINI, A. BOLIS (a
cura di), Conii e scene di coniazione, Roma, pp. 259-299VANDELLI D. 1763, Saggio d’istoria naturale del Lago di Como, della Valsasina e altri luoghi lom-
bardi, Milano 1989WENGER CH., STEIGER R., BIANCONI F. 1994, Carta delle materie prime minerali della Svizzera -
Karte der Vorkommen mineralischer Rohstoffe der Schweiz: Foglio/Blatt Ticino-Uri /Tessin-Uri, Zurigo.
Costanza Cucini Tizzoni230