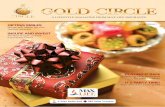ìl Segreto dì Max Lìnder
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of ìl Segreto dì Max Lìnder
Fabrizio Sebastian Caleffi
LA VERITA' SUL CASO LINDERromanzo-inchiesta:
come e perché una star del cinemamuto uccise la moglie prima
di togliersi la vita
INTRODUZIONETutti parlano e straparlano del rinnovamento radicale del medium cinema, soprattutto i conservatori: gattopardi borghesi convinti che cambiando tutto, soprattutto la confezione, il prodotto possa non cambiare affatto. Ecco che i ricorrenti proclami di ricerca di novità e di promozione dei giovani (ah, i gggiovani!) troppo spesso è soltanto retorica demagogica. Un discepolo chiese a Joshu:- Se lo spirito di Buddha è in ogni cosa, è anche nel cane? -Per tutta risposta, Joshu si mise ad abbaiare. Questo racconta Alejandro "El Topo" Jodorowsky, che a Città del Messico conobbe il maestro zen Ejo Takata, raccogliendone nel 1997 i koan. Un buon antidoto alla retorica consiste nel fare. Ma che fare? La domanda di sapore leninista prevede una risposta rivoluzionaria. Magari buddista...Per vedere più in là nel futuro, cominciare guardando indietro. "Ha qualcosa a che fare con il Codice Da Vinci. Sto parlando del cinema muto. Cinema è movimento (anche etimologicamente). Pittura è stupore. Dunque: cinema = figure in movimento + stupore delle emozioni. Insomma, il cinema è un'icona che cammina. Tutto dipende dalla velocità. Contemplare la leonardesca Ultima Cena e osservare che tra i commensali siede una ragazza, la girl friend del Protagonista, fa venir voglia di osservarla esistere, quindi muoversi. Il Codice Dan Brown è solo un’anticipazione, ancorché eclatante, del vero boom di questo soggetto: un serial sulla Super Coppia Gesù & Maddalena! Leonardo, che ha messo tutto in azione, è il padre (e la madre) di tutto l’action movie. Questo per introdurre il tema centrale: l’ accelerazione. Ha qualcosa a che fare con la Bomba Atomica. Movimento uguale Energia è la formula dominante dell’attualità. Ma restringiamo il campo al cinema. Le possibilità e il desiderio di visione in movimento aumentano in progressione esponenziale con l’avvento del computer portatile, della videofonia mobile, del dilagare dei “lettori”. Dallo zapping in poi, fino all’estensione della fruizione a banda larga, il fruitore si è abituato a
consumare immagini in movimento dappertutto, muovendosi a sua volta. La deambulazione è ormai comunemente accompagnata dall’ascolto dell’iPode dalla conversazione al cellulare; i tragitti sui mezzi (di trasporto) servono anche alla lettura di immagini in movimento.E la narrazione si adegua. Veniamo al punto. Il cinema, sosteneva Chaplin, è propriamente muto. Cioè, il parlato è superfluo, quando non nocivo al “piacere della lettura” di barthesiana memoria. Oggi, il parlato è superato. Può servire solo alla liturgia dei grandi rituali di sala su grande schermo. La misura del gag muto è ottimale per un percorso medio in taxi, per l’attesa di un convoglio in una stazione della metropolitana, durante il check in all’air terminal. Sviluppato in più “bobine” o “rulli”, in lungometraggio, insomma, diventa sequenza di quadri di un’esposizione: un Louvre, o un MoMa in movimento. Questo è il cinema del futuro, ormai prossimo. Uno dei fondamentali capolavori nascosti di tale tendenza è l’opera di Max Linder. Autore di un corpus di 500 lavori, la maggior parte dei quali perduti. Ma gli 82 “pezzi” superstiti rappresentano una Tavola della Legge Cinetica: una tavola-schermo specchiante, dove gli spettatori si riflettono in Comportamenti Comici che li riflettono. E li fanno riflettere. Non dimentichiamo che Max Linder è il creatore della mirror gag, poi mirabilmente sfruttata (e trasformata in Manifesto) dai Marx Bros. in “Duck soup” del 1933, 8 anni dopo la sua scomparsa. Uno spettro si aggira per l’Europa… Quello di un profeta, di un artista in anticipo sui tempi, di un uomo tragicomicamente misterioso. Ora il suo tempo è venuto.
INDICE
Prologo Capitolo primo Capitolo secondo Capitolo terzo Capitolo quarto Capitolo quinto Capitolo sesto Capitolo settimo Capitolo ottavo Capitolo nono Capitolo decimo
CAPITOLO PRIMO Un giorno di ottobre a Parigi non è mai un giorno qualunque. Né a Parigi né altrove. Anche se non cominciano o finiscono guerre, se non scoppia la pace, se non crollano la Borsa o muri o torri, per qualcuno è sempre una data fatidica: soprattutto per chi nasce e per chi muore. Nel 1925, Parigi era il palcoscenico più vasto e più bello del mondo. Una festa in movimento. Il 31 ottobre quella festa si sarebbe chiamata “giorno di Halloween”. Ma, in Europa, allora, non la festeggiava nessuno, neppure gli Espatriati, venuti dall’America. Però un francese che aveva avuto successo e fortuna a Hollywood si sentiva quel giorno più americano dell’intero popolo statunitense. Sentiva una strana sensazione sottopelle. Un bouquet, anzi, un cocktail micidiale di noia, rimpianto, eccitazione e disperazione. Quella notte, il 31 ottobre 1925, Max Linder avrebbe ucciso la moglie Ninette e si sarebbe tolto la vita. Forse, lo si sarebbe potuto definire un doppio suicidio. Senza spiegazioni. Perché ogni suicidio è un enigma senza soluzione. A meno che…
INFANZIA DI UN CLOWN Gabriel-Maximillien Leuville nasce in Gironda il 16 dicembre 1883 in una famiglia di vignaioli. Alla sua nascita, il padre festeggia offrendo agli amici le migliori bottiglie della sua cantina privata. Al culmine della bisboccia, il farmacista Duanel si accosta alla culla e, immerso l’indice in un calice di Borgogna, lo passa più volte sulle labbra del neonato. È probabilmente in questo preciso momento che lo spirito del Dio Burlone penetra nel corpo di Gabriel-Maximillien. Suo padre ride e se ne duole. Perché sa quanto il dono della buffoneria possa incendiare il destino di chi lo possieda fino a divorarlo con lingue di fuoco infernale. Ma scaccia subito il pensiero, attribuendolo a un istante di malinconia alcoolica. Gli tornerà in mente tra qualche anno: tra sei anni. Cinque anni dopo la sua nascita, Gabriel-Maximillien partecipa alla sua prima vendemmia. È un ricordo che gli resterà caro per tutta la vita. Ogni grappolo d’uva sembra rappresentare la maturazione dell’universo, ogni acino contenere una promessa. Il paesaggio girondino è solido e ragionevole, ben costruito e abilmente tinteggiato, quasi fosse ritratto da un pittore di mestiere che non s’azzardi a varcare i confini dell’arte. Per un bambino di cinque anni, rappresenta la rassicurante illustrazione della realtà: il paese, il campanile, i vigneti, l’orizzonte. Ma il piccolo Leuville riesce a percepire un’eccitazione nascosta, bacchica (anche se non la saprebbe, naturalmente, definire così), nella vendemmia e nei vendemmiatori, dei quali è la mascotte. La sensazione diventa acuta, quasi dolorosa, quando scopre una ragazzina accucciata ad orinare tra i filari. La giovinetta gli rivolge un sorriso insieme franco e intimidito. A Gabriel viene istintivo di muovere le braccia simulando il batter d’ali di una creatura che stia planando; il suo aspetto appare alla vendemmiatrice quello di un arcangelo, il più bello degli angeli di cui parla sempre il curato in chiesa. Ma chi dei due sta facendo un’annunciazione all’altro? La ragazzina si rialza e, scalza, le gambe nude già lunghe e affusolate, va verso il bambino, che trasforma la sua planata mimata in un precipitare rovinoso. Maximillien fa in modo di cadere proprio nella pozza di urina. La vendemmiatrice si piega in due dalle risate, poi, d’improvviso, scappa via.L’anno successivo, Monsieur Leuville riaccompagna il figlio alla raccolta dell’uva. Gabriel-Maximillien si diverte ancora, ma sa già che non sarà mai più come la prima
volta, la stagione precedente. Cerca qualcosa, qualcuno: la giovanissima vendemmiatrice con la quale non ha scambiato una sola parola, la ragazzina di cui ignora il nome. Non la trova, non è venuta, oppure è cresciuta tanto da non essere riconoscibile. E da non volerlo riconoscere. Comincia a piovere e la vendemmia viene sospesa. Il figlio del padrone studia le facce affaticate della gente e comincia ad imitarne le espressioni, divertendone alcuni, irritando altri, il cui dispetto diventa esilarante per tutti i presenti: Gabriel-Maximillien ha avuto la sua prima vendemmia, ora ha il suo primo pubblico. Il padre lo fa smettere, rimproverandolo. Ha ripensato al sedici dicembre di sei anni prima, quando suo figlio è venuto al mondo e il farmacista Duanel gli ha asperso laboccuccia col vino rosso. Come quasi tutti i farmacisti, l’amico Duanel è un libero pensatore. Per il resto, è una brava persona. Ma bisogna fare qualcosa, prendere dei provvedimenti d’urgenza. Papà Leuville ne parla con Mamma Leuville, cosa non tanto consueta nelle famiglie borghesi di fine Ottocento. Mamma Leuville sostiene che la scuola sistemerà tutto. Gabriel-Maximillien si trova bene a scuola e fuori dalla scuola: non serve dilungarsi sulla sua infanzia felice. Le infanzie felici si somigliano tutte. Sono quelle fatte di molti giorni e anni brevi. Lunghi giorni e stagioni sempre troppo corte per esplorare, scuola o non scuola, le caleidoscopiche possibilità del mondo in perenne mutamento e preparare con la fantasia così tante avventure che almeno un paio ti capiteranno davvero all’età giusta e non te le farai scappare,altrimenti che sarai vissuto a fare? Maximillien non è un ribelle: è un indisciplinato per insofferenza. Non disobbedisce, non trasgredisce: ignora le regole, che gli risultano incomprensibili e che lo annoiano. I bravi bambini, quando hanno il moccio al naso, se lo soffiano nel fazzoletto, i cattivi lo soffiano tra le dita, i tonti lo lasciano colare; Maximillien finge uno scoppio di starnuti per smoccolare sulla punta delle scarpe della maestra. E tutti ridono. E se ti buttano fuori dall’aula, tanto meglio: tutto quel che conta sta altrove. Lo sport. Il teatro. Nuovo consulto tra i genitori Leuville e invio del ragazzino per il proseguimento dei suoi studi a Bordeaux, dove sapranno bene come metterlo in riga. Ma, proprio a Bordeaux, Maximillien scopre il teatro. Lo scopre, come accade nel migliore (e nel peggiore) dei casi, grazie ad una donna.
FEMME FATALE È stata lei la prima a chiamarlo Max. E lei, come si chiamava lei? No, questo non lo sappiamo: il suo vero nome non lo scopriremo. Ma sappiamo che veniva da qualche angolo dell’immensa Russia, perciò chiamiamola Anja. Com’era arrivata a Bordeaux? Come si arriva nei porti di mare. Lo studentello la incontrava quasi tutti i giorni all’uscita dal collegio. Fino a quando cominciò a sospettare che la sconosciuta non fosse lì, ad un angolo di strada, per caso. Assunse allora l’aria più disinvolta, esperta, vissuta che gli riuscì di ottenere e si presentò alla donna con un accettabile baciamano: – Gabriel-Maximillien de Leauville, al vostro servizio, Madame –. La giovane signora, di una bellezza rara e discreta, irresistibile e un po’ inquietante, ammiccò al ragazzo: – Troppo lungo, mi pare. Il vostro nome, voglio dire. E il “de” credo proprio che non c’entri, che non ci stia. Probabilmente, il cognome era, in origine, Levy. Ma vi sconsiglio di riadottarlo. Ne troveremo uno più adatto ai tempi che si annunciano tempestosi. Come sempre, del resto. In quanto al nome, che ne dite di Max? – .Da quel pomeriggio, Anja e Max presero l’abitudine di bere un tè insieme un giorno sì un giorno no. Anja lo beveva alla russa, tenendo una zolletta di zucchero tra le
labbra perfettamente disegnate. Una volta, Max volle provare a sua volta: si scottò le labbra e seppe subito trasformare il bruciore in una smorfia davvero buffa. – Tu dovresti diventare attore, Max – .Erano passati al tu. Max s’intimidì e la donna decise di mostrargli il Teatro. Com’era ormai venuto a sapere il ragazzo, Anja gestiva a Bordeaux un atelier di recitazione dalla fama incerta, sospetta. La donna invitò Max a visitarlo. Il ragazzo pose un’unica condizione prima di accettare: in cambio, pretendeva d’insegnare ad Anja i rudimenti della nobile arte del pugilato.
LA NOBILE ARTE DEL PUGILATO Per esuberanza e insofferenza della routine scolastica, Max Leauville s’era iscritto ad una palestra dove il parigino Gaston iniziava i giovani alla boxe. Desiderando emulare il Maestro dai baffoni a manubrio, Max s’era lasciato crescere una leggera peluria sopra al labbro. Anja, brandendo un rasoio a mano libera, gliela modellò, assottigliandola fino alle dimensioni di una linea e trasformandola in un paio di baffetti impertinenti ed eleganti. L’operazione avvenne nell’atelier deserto. Poi, cominciano ad entrare gli allievi: una bizzarra compagnia. Anja presentò loro il giovane come Max Linder. In quel preciso istante, gli aveva trovato il nome con cui sarebbe diventato famoso. – Max Linder – mormorò tra sé, soddisfatto, l’ex Leauville junior. – Come i miei adepti già sanno, io non ho mai preso lezioni di Teatro. Quel che so e insegno, l’ho imparato andando a letto con Maitre Konstantin Stanislavskij –. Di lì a poco, Max avrebbe capito che la citazione dello sconosciuto dalle generalità insieme esotiche, pompose e dissolute serviva a promuovere un’attività parallela di Anja: l’esercizio della prostituzione. Alle sue prestazioni avevano accesso soltanto i discepoli. Ai quali fu subito chiesto di esibire al nuovo arrivato “un po’ di teatro”. Un omone dai modi autorevoli provò a protestare: il giovane, sostenne, era sicuramente minorenne! La legge non consentiva… – Giudice – lo zittì, perentoria, l’affascinante insegnante di recitazione – sapete bene che l’unica legge che conti qua dentro è il mio capriccio –. E il Giudice, che tale era solo nella finzione scenica, chinò il testone tormentandosi le manone da macellaio. Anja sedette al pianoforte, suonò un paio di accordi casuali, quindi annunciò: – Shakespeare: Tempesta! – .Il suo gruppo non riusciva ad imparare a memoria le battute del misterioso capolavoro del Bardo. Anja aveva però declamato per loro il copione in una lingua meravigliosamente melodiosa, così evocativa, malgrado risultasse incomprensibile agli allievi (era russo), che ognuno si vide davanti il proprio ruolo sull’Isola del Teatro: per esempio, un contabile s’era sentito Prospero, il mago dei libri e un farmacista (sicuramente, un altro libero pensatore…) s'era identificato con la figlia del mago, la mirabile Miranda, malgrado non avesse mai avvertito prima tendenze omosessuali, che continuò comunque a tener sopite tra le lenzuola della sua insegnante. Così la compagnia si mise a recitare in un gramelot che non era inglese shakespeariano, era stepposo dialetto cosacco inventato a orecchio, eppure sembrava il linguaggio più adatto ai personaggi di una vicenda che a Max risultò perfettamente comprensibile. Quando Anja interruppe quella narrazione che pareva un rito tribale, un gioco infantile, una liturgia segreta, disse: – Vedano, lor signori, che ho condotto presso di loro l’interprete del ruolo ancora vacante: Ariel –.
Si rivolse quindi a Max: – Monsieur Linder, volete essere Ariel? – – Madame, temo di non essere in grado di esprimere alcunché anche inventando suoni per le parole –. Anja tornò al tu: – Caro Max, Ariel è una creatura dell’aria che non si esprime con parole o suoni umani, è una creatura volatile, esiste solo nell’immaginazione del Principe, di Prospero, tu hai capito, sì? –. Quindi dispose che la recita riprendesse e Max Linder, quasi avesse davvero capito, partecipò, interpretando con silenziosa eloquenza la parte che gli era stata assegnata. Presto Anja interruppe di nuovo la prova: – Basta così, per oggi. Basta per tutti: io sono un po’ stanca-. Riluttanti, ma disciplinati, i seguaci lasciarono l’atelier e si dispersero. Max volle avere l’ultima parola: – Ora mantieni la tua promessa, poiché è il mio turno d’insegnarti qualcosa –. Capitare in palestra fuori orario fu come visitare uno zoo abbandonato: sentivi gli odori, percepivi la presenza delle fiere. Ma dei feroci assenti non c’era traccia: se n’erano andati via, nella vita vera e chissà se sarebbero mai tornati. Max precedette Anja, facendole strada nella palestra di pugilato di Papà Gaston. Sinuosa avanzava Anja, quasi danzando evitava di calpestare le ombre. Max si fermò presso un ring, poi salì sul quadrato e prese a pugni l’aria illuminata, Anja lo osservò e lo assecondò: finirono entrambi al tappeto e fu un match in molti rounds, finito il quale si ritrovarono entrambi sottosopra. Max aveva un nuovo cognome e la sua prima donna, di cui ignorava il vero nome, ma che poteva importargliene? Si rialzò, aiutò Anja a rialzarsi e la costrinse a cercare di colpirlo, respingendo facilmente ogni gancio, destro o sinistro che fosse. Per mostrarle come dovesse fare, fu il giovane uomo a colpire, piano, la donna, urlandole: – Guardia alta! Guardia alta! –- Ma un grido maschile risuonò improvvisamente perentorio e più adulto nella palestra: – Non toccare la femmina, ragazzo! –
LE PREMIÈRE CIGAR D’UN COLLÉGIEN Papà Gaston aveva gridato. Ed era contemporaneamente balzato sul ring con insospettabile agilità, facendo sobbalzare il suo birroso ventre a zampogna, evidenziato dalle strisce bianche e blu del pullover da marinaio. Prima che Max potesse rendersi conto della situazione, fu scaraventato alle corde da un manrovescio. – Non è per questo che ti ho concesso le chiavi della palestra, ragazzo. Ed ora ti darò una bella lezione gratuita a mani nude –. Era probabilmente il discorso più lungo pronunciato dal Parigino in vita sua. Venne postillato. – Puoi provare a difenderti –. Mosse passettini incerti e ubriachi Max, staccandosi dalle corde. Gaston stava per sferrargli un uno/due, quando, pantera, Anja si frappose, assorbendo i colpi. Sanguinò, dal labbro e dal naso. – Perché vi siete messa in mezzo, signora? Notate che vi do del voi e vi chiamo signora anche se siete una puttana – .Il vecchio stava diventando un campione di eloquenza. – Max non può essere sfiorato al volto: sapete, lui deve fare l’attore –.
Ritrovatosi improvvisamente a corto di parole, Gaston si limitò a borbottare. Poi si prodigò a tamponare Anja, che venne successivamente invitata, insieme al comune allievo, a “farsi una bella birra ghiacciata”. Odor di segatura, profumo di vera vita nel localetto dove si ritrovò lo strano trio. – Par quasi di essere a Pigalle – commentò Gaston. Quindi brindò al “giovane attore” e sentenziò che non dovesse farsi vedere mai più in palestra. Gli offrì un sigaro di consolazione e di festeggiamento della maturità virile. Anche Anja ne volle uno. Dopo pochi tiri, le première cigare d’un collégien fece il suo effetto: mentre l’insegnante di recitazione e il maestro di pugilato si godevano il loro, Max Linder vomitò tutto il sapore del suo primo sigaro. Se ne sarebbe ricordato, pochi anni dopo, dando il titolo di “Il primo sigaro di un collegiale” al suo quarto film.
CAPITOLO SECONDO
Un giorno di ottobre a Milano è sempre un giorno indeciso. Pioverà, non pioverà, chissà. Al piccolo party di gente della moda in corso Monforte erano arrivati quasi tutti con l’ombrello: un gran mazzo esotico di parapioggia alla moda riempiva di gioia il portaombrelli all’ingresso. Si cominciò a bere, con puntigliosa moderazione tutta milanese. Il cicaleccio riguardava complessi gossip a chiave che facevano scattare segrete serrature e qualche colpo di tosse. Non provando grande interesse ad entrare in alcuna di quelle stanze dei misteri mondani, finii aggrappato al braccio di una modella come un bastone da passeggio. In quella posa chapliniana da canna di bambù mi sorprese un giovane dandy. Il suo abbigliamento, a prima vista, poi la sua conversazione seppero risvegliare la mia curiosità. Indossava un completo bosco e sottobosco con il gilet, camicia bottondown, cravatta sottile quanto un’insinuazione. Mi ammirò le scarpe di pitone, mentre la modella slittava via verso un altro angolo del salone quasi che il pavimento si fosse inclinato sotto ai suoi tacchi a stiletto. Intanto il giovane dandy, avendomi forse riconosciuto per fama o per televisione, cominciò a parlarmi di cinema. Fu allora, fu così che mi appassionai al caso Max Linder. Non ricordo più il nome del giovanotto della festa in corso Monforte, ma Trevor gli si addice, dunque lo chiamerò così. Trevor mi descrisse brevemente la sua ammirazione per il divo del muto Max Linder. Annuendo puntualmente, cercavo di occultare la scarsa dimestichezza che, ai tempi, avevo dell’attore (e regista, sceneggiatore e produttore, come scoprii più avanti). Poi, repentinamente, Trevor rivelò di aver indagato invano per diverse stagioni sull’enigma della morte per suicidio di Max, preceduta dall’uccisione, a Parigi, della giovane moglie. Nessuno conosceva il motivo di quello che si usa sbrigativamente definire “insano gesto”. Mi distrassi, lo ammetto, ben presto, dalla conversazione con il giovane Trevor. Non saprei ridire, ora, quali fossero le motivazioni che l’avevano spinto fino alla Ville Lumière sulle tracce della meno conosciuta (almeno in Italia) tra le stelle del silent movie. So che decisi subito di assumermi il compito di ricostruire quella vita (e quella morte) da film. Così procedono gli scrittori.
GLI UOMINI NON SONO TUTTI UGUALI Niente, neppure la guerra, rende gli uomini uguali. L’Europa aveva dichiarato la guerra: aveva dichiarato guerra a se stessa. E la gente era impazzita. In Francia, avevano l’espressione giusta per descrivere quel clima
particolare: drole de guerre. Tamburi e pennacchi. Correva il quattordicesimo anno del Novecento. Correvano i bambini, ancora ignari che molti di loro si sarebbero ben presto ritrovati orfani, dietro alle bande militari. Correvano le ragazze alle finestre al passaggio dei dragoni. Gettavano baci, gettavano fiori, che sarebbero ben presto serviti ad intrecciare corone per funerali. Niente, neppure la battaglia, rende gli uomini uguali. Prima ancora di dividersi tra vincitori e vinti, si differenziano in eroi e vigliacchi. E morti e feriti. Uguale è, per tutti, il fetore. Le uniformi da parata marciscono in trincea. I più eleganti fanno gli aviatori, combattono tra cielo e terra, pilotano romantiche macchine sputafuoco, portano candidi foulard di seta intorno al collo, ma puzzano anche loro, puzzano di escrementi, puzzano di cronica dissenteria in quota provocata da esalazioni di carburante. E quando cabri, plani e mitragli, non puoi trattenere i sommovimenti delle viscere. I giorni passano lentissimi, gli anni tutti insieme, tutti d’un colpo, per chi si ritrova una baionetta piantata nello stomaco. Niente, tanto meno la rivoluzione, rende gli uomini uguali. Correva il diciassettesimo anno del secolo breve quando la stella rossa segnò la fronte di ogni suddito dello Zar Imperatore: cometa della speranza per qualcuno, marchio di arroganza per molti, costellazione di malasorte per i Romanov. Sarebbe stata l’arte cinematografica a celebrare con la Potemkin di Ejzenstein l’epica bolscevica. Intanto, al fronte combatteva anche un campione delle comiche del muto. Sul suono crucco del suo cognome, Linder, scherzavano i commilitoni. Conoscevano bene Max e Max era l’idolo di militari e civili. Linder li aveva fatti talmente ridere, prima della guerra mondiale. Gli dicevano per scherzo di cambiare cognome: era il loro Linder, l’attore protagonista delle avventure settimanali di Max che avevano tantevolte ammirato sullo schermo. Il soldato Leuvielle, comunque, la sua identità Linder se la teneva stretta: Max non aveva raccontato a nessuno perché aveva scelto il nuovo cognome, né da chi l’aveva ricevuto. Dove sarà, si chiedeva, dove sarà Anja? Anja era tornata in Russia e Max non lo poteva sapere. Tanto meno poteva immaginare quando e come sarebbe riapparsa nella sua vita. L’aveva persa di vista quand’era andato a Parigi, tanti anni prima. Una notte, a Pigalle, s’era imbattuto nell’ex pugilatore Gaston; avevano finito per bersi una birra ghiacciata insieme; Max gli aveva chiesto di Anja. – Questo è un quartiere di puttane ed io le conosco quasi tutte, ma quella tua Anja non s’è mai vista in giro da queste parti – . Linder aveva poi rivelato al suo maestro di boxe che stava cominciando a recitare in teatro. La reazione di Gaston era stata la stessa del padre vignaiolo: – Mai avuto bisogno di andare a teatro io! – .A teatro Max Linder si fece in fretta un certo nome. Nel dopo teatro, la sua fama di cortese, brillante seduttore s’impose ancora più rapidamente. Quel Bel Ami in versione bruna ottenne ruoli sempre più importanti. Entrava nei salotti a testa alta, il passo elastico e si annunciava con voce sicura e tono perentorio: – Max Linder, l’attore – . Ma il successo, ormai l’aveva capito, era un’altra cosa. Il successo, ormai lo sapeva, era entrare a testa alta, il passo elastico, nei salotti e sentire gli altri mormorare: – Max Linder, l’attore – . Però il successo, quello vero, a teatro arrivava tardi e se lo godevano quasi tutto i vecchi capocomici: lo sperperavano allegramente in compagnia delle attricette. A Max le amicizie femminili costavano più di quanto riuscisse a guadagnare in palcoscenico. E le amiche di una notte o di una settimana non erano mai Anja. All’eccitazione dei primi tempi e dei primi applausi a Parigi presto si mescolò un retrogusto amarognolo, il sapore della delusione. Poi, per caso, le cose cambiarono.
Era una di quelle sere d’estate in cui a Parigi manca l’aria. La città, calda come una stufa, pareva sudasse nella notte soffocante. Le fogne esalavano dalle bocche di granito aria pestilenziale e dalle finestre basse le cucine sotterranee rovesciavano per strada miasmi infami di rigovernatura e salse rancide. I portieri, in maniche di camicia, a cavalcioni sulla loro sedia di paglia, fumavano la pipa sulla soglia dei portoni e i passanti si muovevano fiaccamente, a testa scoperta, con il cappello in mano. Fiaccamente, a capo scoperto, passeggiava Linder. Dai tavolini all’aperto dei caffè lungo i boulevard, nessuno lo additava, sussurrando il suo nome. – Max! Max Linder! – Max si fermò di colpo, guardandosi attorno. Dal marciapiedi opposto, qualcuno si sbracciava per attirare la sua attenzione. Era Forestier, un collega con cui Max aveva recitato un paio di volte. Forestier attraversò la strada, venendogli incontro. Impossibile evitarlo. Max temette che l’altro avesse in animo di chiedergli qualche franco in prestito. Ma Forestier pareva euforico: lo prese sottobraccio, offrendogli un sigaro. Per qualche isolato, come usano fare gli attori, i due ricordarono esperienze comuni e citarono comuni conoscenze. Quindi Linder si sentì invitare a cena da “certa gente interessante”. L’invenzione dei Fratelli Lumière aveva da non molto cominciato a proiettare il suo fascio di luce sulla ribalta più appropriata: la Ville Lumière. Forestier condusse dunque Max a casa Walter. Xavier Walter, nato Isaia Wlaterwsky a Cracovia, cresciuto a Nizza, s’era trasferito recentemente a Parigi per “entrare nel ramo cinema”. Altri ebrei, ashkenazi e sefarditi, ma soprattutto ashkenazi, dall’altra parte dell’Atlantico, avevano aperto la porta dei retrobottega delle loro drogherie e sartorie di New York, a Manhattan e a Brooklyn, al nickelodeon, la proiezione su un telone di scenette cinematografiche visibili al costo di un nickel, per migrare presto ad ovest, a fondare nella soleggiata, selvaggia California l’industria dei sogni. Max Linder, con il suo nickname che poteva suonare ebraico, fu presentato a Monsieur Walter, a Madame Walter e agli altri ospiti. Si bevve champagne. E la serata si concluse con un brindisi a Max Linder, proclamato da Walter, con la sua voce bassa e solenne, pur se afona, possente quanto il suono dello sofar, Attore Comico del Cinematografo. Come vorrebbe, ora, un sorso, un solo sorso di quello champagne, anche tiepido, il soldato Max! Gli manca l’aria. Gli par di soffocare nella sua buca, calda come una stufa. Le trincee esalano il respiro rancido, pestilenziale, dell’attesa, della paura, della rabbia e della noia. Eppure quest’aria mefitica sarà tra poco un rimpianto per l’esercito di topi in uniforme attaccato e stanato con i gas. Boccheggianti come pesci rovesciati fuori dalle cassette al mercato del pesce, aspireranno a quell’umidità che li aveva fatti fin lì se non respirare almeno sopravvivere, sussultare, sospirare. Molti moriranno. Max Linder quasi. Intossicato dai gas, Max Linder venne ricoverato in un ospedale nelle retrovie. Annegato nel suo stesso sudore sotto le lenzuola incrostate di sangue altrui di un lettino in corsia, Max non sapeva più nemmeno bene chi fosse. Ma quando, gorgogliando, il torso umano alla sua destra, le braccia e le gambe amputate, la testa completamente fasciata in bende da mummia, riuscì a chiedergli: – Chi sei? – subito rispose: – Max Linder – – Max Linder l’att…l’attore?! – .Con voce affiorante direttamente dall’ombelico dell’inferno, il torso balbettante si mise ad elencare a Max titoli dei suoi film, “Première sortie d’un collégien”, il primo, “Les Débuts d’un patineur”, l’elenco della serie “Max”, “Max dans sa
famille” del 1911, “Max a un duel”, “Max et le crepes”, “Max bandit par amour”, “Max peintre par amour”, “Max et la doctoresse”, che in America conoscevano come “Max and tje Lady Doctor”, “Max toréador”, “Max au convent”, “Max illusionniste”…: era una gag allucinante e Linder, dopo aver cercato invano di trattenersi, scoppiò in una risata pazza. Rise a suo modo anche la mummia e, ridendo, si liberò dal dolore, emettendo con un sibilo l’anima, che s’involò verso un improbabile ma non impossibile paradiso. Se esiste la drole de guerre, perché non esiste anche la drole de paix? Perché il rullare dei tamburi della vittoria lascia presto il posto agli incubi notturni delle cannonate, perché è difficile riaccogliere chi si è aspettato con tanta trepidazione, perché è facile vergognarsi di esser tornati davanti agli assenti, perché le medaglie arrugginiscono, perché tutto quel che doveva cambiare è restato come prima e quello che doveva rimanere uguale, intatto non c’è più o si è rotto. Era il diciottesimo anno del Novecento e i ragazzi d’Europa si ritrovarono reduci maggiorenni. Passeggiava lentamente, a capo scoperto, Max Linder lungo la Promenade des Anglais. Per lui, la guerra era finita prima. Nel 1916, quella che può essere considerata la prima stella del cinema internazionale, semiguarita dall’intossicazione dei gas, era ripartita per gli Stati Uniti, con un magnifico contratto con gli Essanay Studios, da cui s’era appena staccato Charlie Chaplin. La carriera cinematografica di Max Linder, iniziata con il produttore Walter, partita nel 1905 con un film Pathé, s’era impennata nel diagramma del trionfo. Ma negli States Max era rimasto poco, girando solo tre dei dodici film previsti dal contratto (anche quei tre sono scomparsi: dove saranno mai finiti?), costretto dal suo fragile stato di salute a tornare in Francia, per ricevere ulteriori cure mediche. Convalescente, la sua buona stella collassata, la carriera apparentemente finita, Linder era planato a Nizza come un precoce pensionato. Stava a villa Walter, ospite di Xavier: ospite pagante. Il conflitto aveva travolto gli affari del produttore: anche lui, tornato a Sud, conduceva l’esistenza del pensionato, fingendo di non sentirsi un fallito. E Max, proprio Max gli era sembrato la carta perduta, l’asso mancante per la mano fortunata al tavolo da poker del mondo del cinema. Per un certo periodo, Walter l’aveva ritenuto responsabile dei suoi insuccessi. Poi, come spesso accade, vedendolo tornare infelice dall’America e avendo bisogno di un suo contributo economico, gli era tornato paternamente amico. Finita la guerra, entrambi gli uomini presero l’abitudine di percorrere insieme la Promenade des Anglais e la strada della propria esistenza lamentando la propria sconfitta malgrado appartenessero ad una Nazione vincitrice. Ma, per una volta, Max aveva deciso di fare la sua passeggiata da solo e questo giovò al suo umore e alla sua sorte.
MES PENSÉES, MES CATINS Mes pensées, ce sont mes catins (Diderot). Percorreva Max la fiorita Promenade des Anglais tenendo sottobraccio i suoi pensieri e i suoi pensieri gli sussurravano all’orecchio generose, maliziose disponibilità puttane. Il pensiero intermittente di Anja gli metteva addosso la nostalgia della sua prima volta a teatro, nella scuola-bordello di Bordeaux. Il pensiero americano insinuava il rimpianto per quell’immenso bordello di opportunità. Max aveva dovuto lasciarlo e tornare in Europa per ragioni di salute. Ma non soltanto per i persistenti postumi dell’intossicazione da gas bellico. Un’altra era la sua malattia: si chiama depressione, ma, a quei tempi, la definivano malinconia. E non c’è niente di peggio di un clown triste. Linder non ne aveva mai sopportato la retorica; tanto meno, accettava di rappresentare, al cinema e nella vita, quel ruolo patetico. Si sentì
stanco. Al cerone del pagliaccio affascinante dall’alto degli schermi e vis a vis ai garden parties aveva sovrapposto la cipria del Bel Ami disincantato, ritiratosi a vita privata, ma, sotto al doppio strato di trucco, a Max pareva di soffocare. Dovette sedersi al tavolino di un café. Si fece portare un fin a l’eau. Nuotava nel bicchiere il pesciolino rosso di un altro pensiero, o forse una sirena da richiamo; gli entrò in corpo, bevendo e fu la liquefatta madeline dei cocktails californiani, del successo perduto, dell’ammirazione in piena luce, una luce abbagliante… Il cameriere gli portò il conto… garcon, l’addition!… un conto troppo alto…era segnato tutto, poiché tutto si paga, dalla vendemmia in Gironda allo sbarco in America…avez-vous de la monnaie? Max Linder, il volto percorso dalla scossa di un tic, assunse l’espressione perplessa di chi non ha soldi per pagare: l’espressione di uno sketch fondamentale di Charlot. Charlie l’Inglese s’era ripreso il suo posto a Hollywood e sul trono del silent movie sedeva lui. Non c’era più posto per Max. Perché dunque la sirenetta in abito da sera lo invitava ad un altro giro di danza in quel piccolo caffè sulla Promenade des Anglais?
LE PETIT CAFÉ Nel diciannovesimo anno del secolo breve e frenetico, il fato, come diceva Lord Byron, avrebbe cambiato ancora una volta cavalli. Un cocchio dorato avrebbe riportato Max Linder a Los Angeles e all’apice, su, al vertice, accanto al trono di King Charles, Re Chaplin Primo, sovrano ebreo con una bombetta per corona. Intanto, nella sua villa delabrè, il buon vecchio Walter aveva un affare da proporre al caro vecchio Max. Bevendo panaché, Xavier espose la sua idea all’amico. Riguardava i tre film americani di Linder. In tavola, arrivarono rillettes, una terrine de fois, gallettes, moules marinières, boudin noir, cioè carne trita di maiale cotta nello strutto, pasticcio di fegato di maiale, cozze all’aglio, sanguinaccio con le prugne cotte, tutti cibi rigorosamente non kosher: la vendetta della cuoca, sempre in arretrato con il percepimento degli emolumenti. Marie, insomma, non veniva pagata e si vendicava cucinando quelle cibarie, che, per altro, Monsieur Walter gradiva assai. Molto di più di Madame Walter, che s’era messa in testa di atteggiarsi ad ortodossa al punto da uscir di casa con la parrucca in capo! Eppure Marie era talmente affezionata ai “padroni” che avrebbe dato la vita per loro. Di lì a qualche anno, avrebbe avuto occasione di farlo davvero e non per modo di dire… Al dessert, tarte tatin, pain au raisin e verveine, ecco il progetto di Xavier. Si trattava d’importare i tre film americani di Max e di distribuirli in Europa, questo il senso, anche se propriamente di distribuzione allora non si parlava ancora. Rientro in pista per Walter, rilancio per Linder: buona idea. Ma quanto valgono le buone idee senza capitale? Molto di più del capitale senza idee. Max Linder cominciò a pensare al suo ritorno in California. Anche se non aveva ancora abbastanza denaro per andarci, né Walter a sufficienza per rimandarcelo. Se non hai soldi per pagarti la puttana che ti piace, puoi cominciare a pensarla (i miei pensieri sono le mie puttane, sosteneva Diderot) e, pensa oggi pensa domani, magari te ne innamori. Passò del tempo prima che Max Linder potesse tornare a Los Angeles. Che si chiama così perché gli angeli l’hanno fatta su modello del Paradiso. Ma chi ha fretta di correre in Paradiso, a parte i suicidi, a cui, pare, è vietato l’ingresso?
CAPITOLO TERZO Los Angels non è una città, Los Angels è LA città. A N.Y.C. l’energia è celeste, a L.A. tellurica. A Manhattan, a Time square, al tramonto, tutta la luce del mondo, mandata in orbita da ogni inesausto sguardo in avanti e riflessa dallo specchio dell’universo ti colpisce dall’alto. Sul Sunset blvd., al tramonto o in qualsiasi altro momento del giorno e della notte, la scossa ti sale su dalla suola delle scarpe e c’è sempre il rischio che, sotto ai tuoi piedi, il guscio si spacchi, rotto da Aquila Calva (il simbolo araldico degli Stati Uniti con un nome da capo pellerossa) a colpi di becco e che tu diventi di colpo lapillo, cenere, polvere, sale, Pompei. Lasci l’impronta delle mani nel cemento, ma sai che devi essere sempre pronto a depositare il calco completo del tuo Ego ipertrofico ai primi segnali del codice 79 AD. Difficile concentrarsi su qualcosa che non sia tu stesso qui. Una semplice scritta sulla montagna…datemi una H, datemi una O, datemi una L, datemene un’altra, datemi HOLLYWOOD…una semplice scritta è il titolo della Saga più appassionante della nostra civiltà ed è rotolata giù da ogni lettera in forma di Tavola della Legge del Successo, insieme ad un Vitello d’Oro chiamato Oscar©. Questa scritta non diventerà mai il Partenone. Non verranno in comitiva a queste rovine. Non ci saranno pinacoteche di fotogrammi di difficile attribuzione. Non si saprà più nulla dei Faraoni della Dinastia Paramount, del ruggito del Leone della Metro, di un Ventesimo Secolo targato Fox. Ci saranno solo gomitoli di radici mobili rotolanti dal deserto, spinti dal vento lungo Melrose… Qui abitava il Presente, adesso che è passato si tramanda solo per tradizione orale, trascritta sui rotoli del gossip. Qui regnava il Presente, ora che è passato puoi sedere al Brown Derby, che non c’è più, ad aspettare il ritorno degli dei: di Max Linder, per esempio. Ricordando, con William Faulkner, che “il passato non è morto e non è nemmeno passato”. Bene, mi siedo al Brown Derby, oppure al Coconut Grove e ordino un Golden wedding, un whiskey liscio, come si diceva nel ’47. E vedo Max Linder arrivare per la seconda volta a Hollywood. È un reduce e non solo un reduce di guerra. “I film sono un campo di battaglia, dove le emozioni sono i cannoni e i personaggi gli eserciti che si scontrano” come sostiene il regista Samuel Fuller.
LA LEGGENDA DI MAX LINDER A HOLLYWOOD “Tra la realtà dei fatti e la leggenda, si dovrebbe sempre privilegiare la leggenda” : così parlò John Ford, il leggendario. Tornato negli Stati Uniti, Max Linder scrisse, produsse, diresse e interpretò tre film in due anni, dal 1921 al 1922. Il primo, contro ogni cabala, si intitolava “Seven Years Bad Luck”: sette anni di sfortuna per uno specchio rotto. Nell’immutabile limpidezza losangelina pre-smog, le giornate erano interminabili rulli di pellicola nella scatola delle “pizze” dalla temperatura e dalla forma del sole. Ogni giorno, qualcuno saliva con la sua cabriolet ad altezze vertiginose, avvicinandosi troppo al calore solare e diventava palla di fuoco: ogni giorno, si bruciavano molti destini, ma anche questo serviva a rendere più luminoso lo spettacolo. La vita era un film a colori prima che il cinema inventasse il colore. Max stava per inventare il suo capolavoro: The Mirror Gag, il numero dello specchio. Linder era in tutto e per tutto un dandy e dava un tocco autenticamente francese alla ronde dello show perpetuo nella capitale dello show biz. Tableau vivant di un’epoca: uomini e freaks in abiti chiari si svegliavano tardi la mattina, facevano colazione con abbondanti spremute d’arancia della California per combattere l’emicrania superalcoolica, s’incontravano nei lounge bar con ragazze-sirena fresche
e salate dell’oceano da cui parevano essere appena uscite e con le Donne Serpente in Paradiso, accendevano sigari smisurati soffiando promesse al vento, progettavano pellicole sempre più ambizione, si ubriacavano educatamente solo dopo le 5 p.m., indossavano il white tuxedo (lo smoking dalla giacca bianca dell’estate perenne) per andare a festeggiare un nuovo film, poi crollavano addormentati dimenticando tutto per ricominciare da capo l’indomani.Il sesso era solo un profumo intensissimo e segreto. Quando il profumo del sesso si faceva troppo inebriante, i segreti diventavano incubi, gli incubi drammi, i drammi finivano in pasto al pubblico cannibale e ogni angelo di Los Angeles diventava diavolo dell’inferno. L’omino Charlot, il poeta del cinematografo, l’Omero del silent movie si metteva in caccia di ninfette e l’omone Arbuckle, il ciccione, il grande Fatty sarebbe stato accusato ingiustamente di aver-ne uccisa una, violentandola con una bottiglia di coca-cola. Sul palcoscenico hollywoodiano sarebbe salita la bellezza statuaria di Keta, portata qui dal suo Moje: Mauritz Stiller, il Pigmalione, Greta, chiamata da piccola Keta, la Divina, giunti dalla Svezia e separati dall’implacabile gioco del destino; il regista poliglotta ricorre al polacco per trovare un cognome adatto alla ragazzona impacciata che spaccia per star e Garbo diventerà la Star, Stiller verrà accantonato, Greta sarà manipolata dalla passione intelligente e maligna di lesbiche come Mercedes de Acosta, Moje finirà per dire non ho che due cose veramente mie, solamente mie: la paura dei topi e la mia morte. La Città degli Angeli avrebbe visto delitti e castighi, scandali e fughe, Satana Manson che massacra la bella moglie di Polanski, Sharon Tate, a Bel Air, Roman Polanski, insieme a Jack Nicholson, caduto nella trappola di una Lolita, costretto all’esilio in Europa, la splendida nipote di Hemingway dal nome di vino francese, Margaux, annegare in uno smisurato bicchiere e togliersi, come Papa, gravato oltre il sopportabile dall’importanza di chiamarsi Ernest, la vita. Ma intanto, mentre in Europa Miss Tinguette diventava Mistinguett, les jambes les plus sprituelles de Paris, creando la mistica del music hall e l’illusione che non ci sarebbero mai state più guerre, negli States il cinema silenzioso esprimeva la genialità delle sue pantomime surreali al suono di un pianoforte e a farrumore, il più umano dei rumori, erano gli spettatori con le loro sonore risate.
La risata argentina di una frotta di fanciulle in fiore accoglie Max Linder, l’attore che si muove come se le lettere del suo nome fossero scritte nel magico alfabeto di Ertè (il russo Romain de Tirtoff, maesto della grafica antropomorfa, delle lettere in forma di silfidi) mentre illustra la sua gag dello specchio. In mezzo a loro, Max spera sempre di scorgere Anja, la russa che ha inventato Linder: il cinema va dappertutto, potrebbe scovare anche lei e indurla a raggiungere il suo allievo di Bordeaux, che, per questo, ha voluto la fama e vuole la celebrità.
THE MIRROR GAG Sono i critici a individuare gli elementi che costituiscono un capolavoro. Per un attore, come per i pittori, è solo una trovata (io non cerco, trovo diceva Pablo Picasso) e un gesto nell’aria.
La gag dello specchio: c’è una grande specchiera a figura intera, davanti alla quale il Gentiluomo usa fare la sua toilette mattutina; il suo servo, o butler, Leporello o Sganarello, rompe accidentalmente lo specchio; il Gentiluomo ancora assonnato si presente puntualmente davanti alla specchiera e il servo, per non rivelare il danno, imita minuziosamente i suoi gesti e le sue smorfie, facendogli da specchio. Ecco dunque che nel momento di massima intimità e di preparazione della propria
immagine e identità, il Padrone si rispecchia nel suo Doppio, nel Servo appunto, fino a riconoscersi, o, quanto meno, a non distinguersi più da lui. Imitazione come svelamento. L’Altro lo conosce bene, lo conosce meglio di quanto lui stesso si conosca e, imitandolo, lo mette in ridicolo, nel contempo elevandolo a modello definitivo. La fonte è quella, antichissima, del Servo Padrone. Più profondamente di quanto faccia il Barbiere del “Grande Dittatore”, che, attraverso la somiglianza gemellare, monozigotica con il tiranno Hinkel (il Doppio del caporale Hitler) ne disinnesca la pericolosità rendendola grottesca per capovolgerne poi il messaggio aggressivo attraverso la “redenzione del linguaggio”, Linder costruisce un’identità attraverso lo sdoppiamento e la ricomposizione speculare. Processo raffinatissimo, che funziona perfettamente soltanto perché sia l’Autore che lo Spettatore ne ignorano il significato. L’Autore intuisce, inventa e rappresenta: lo Spettatore ride. L’uno si specchia nell’altro. La superficialità del loro rapporto determina la profondità dell’effetto (e dell’affetto). Ciascuno, sdoppiandosi, ride di sé.
Max Linder, utopista fourieriano, troverà nei Marx bros il suo Karl Marx collettivo, che della gag dello specchio farà (in “Zuppa d’Anatra”, 1933) il Manifesto dell’Assurdo: irregolari di tutto il mondo, unitevi! Niente di tutto questo, naturalmente, al cospetto delle ragazze di Hollywood: nient’altro che gesti nell’aria e mimica facciale.
KING OF THE CIRCUS A Hollywood, California, o sei un genio, o sei una bellezza, oppure continui a servire caffè nei bicchieri di carta finché morte non ti separa, dalle tue idee geniali o dalle tue gambe da ballerina. Ma, se t’incoronano Re del Circo, diventi immortale. Max Linder, girondino rivoluzionario, fu incoronato. La corte (del miracolo) lo applaudì, tributandogli una standing ovation. Tutti, al cospetto della sua corona di cartone, si toglievano invisibili cappelli di paglia. E il Re del Circo non smise di cercare tra la folla la sua trapezista russa, svanita nel nulla. Intanto, però, non se ne stava con le mani in mano. Stringeva mani, formava alleanze, stipulava contratti. Secondo il Libro, il Creatore fece la luce. E luce fu. Fu una creazione maliziosa. Sul palco illuminato, l’Attore, investito dalla luce, proiettava l’Ombra. Una strana, instabile, inafferrabile identità parallela. E l’Ombra, proiettata sullo schermo, fu il Cinema. Elegante, divertente e divertita era l’ombra proiettata sullo schermo da Max Linder, l’Attore. Incoronato Regista. Disinvolto sceneggiatore. Produttore plenipotenziario. Film producer, screenwriter, director and leading actor: questo era diventato Max Linder a Hollywood. Un autentico, potentissimo protagonista. Non suscitava grandi invidie, perché era Francese, esotico e per nulla esoso di riconoscimenti (li accettava come tributi, senza discutere mai sul prezzo delle cose); non suscitava odio, perché non faceva paura; non faceva paura ad altri che a se stesso… Il Re Rivale, Charles Spencer Chaplin la sua paura l’avrebbe rappresentata ed esorcizzata nel Gioco del Mappamondo, una scena-topos del film “Il Grande Dittatore”: Hinkel lancia e riprende il pallone del mondo che pensa di possedere e il pallone gli scoppia in mano; molti anni prima dell’ Hitler bambino inginocchiato in preghiera in un angolo di Palazzo Grassi (ammirato alla mostra della collezione Pinaud, “Where are we going?”), opera-monstre di Maurizio Cattelan e della sartriana infanzia di un Capo descritta in un racconto della raccolta “Le mur” (La metamorfosi era compiuta: in quel caffè, un’ora prima, era entrato un adolescente
grazioso e incerto; un uomo ne usciva, un capo tra i francesi… ma lo specchio non gli rimandò che un grazioso visetto ostinato che ancora non era abbastanza terribile. “Mi lascerò crescere i baffi” decise), Charlot seppe cogliere l’orrore totale del delirio regressivo e vendicativo del Piccolo in Punizione. Linder, Maestro dell’Ombra, non ci pensava. Trascurava la sua paura, progettava gag e film e, per distrarsi, aveva a disposizione tutte le aspiranti attrici, le angeliche tentatrici con i loro bicchieri di carta colmi di caffè americano serviti ad ogni bancone in città. Poi Max ne incontrò una e la scelse tra le altre: la scelse per il suo aspetto sano e forte, la scelse per il suo accento sassoso e per il nome con cui si presentò.
MASHA Ci sono ragazze che hanno monete d’oro tintinnanti nella voce e ragazze che snocciolano frasi a cascate di pietra. Ma, a saper ascoltare, tra quelle pietre puoi trovare auree pepite. Ora è raro incontrarne dell’uno e dell’altro tipo. Ora la corsa all’oro è finita. Allora, a Hollywood, invece, i cercatori d’oro andavano di moda: raccontando la ricerca, trovavano il tesoro; Jack London, nato a San Francisco nel 1876, divenne celebre con la descrizione delle avventure in cerca dell’oro in Alaska, che Charlot, ancora lui, seppe parodiare e celebrare in quello che, forse, è il più importante dei suoi film, “La febbre dell’oro”. Max inciampò in Masha un pomeriggio, all’ora del primo whiskey della giornata. Per Linder non era il primo. Masha non era Anja, ma aveva un nome russo e l’accento slavo. – Be my wife! – le disse. Glielo disse cinque minuti dopo aver bevuto con lei, cameriera fuori servizio. Era solo una battuta delle 5 p.m. E sarebbe diventato il titolo del secondo film americano di Max Linder, “Be My Wife” (1921). Masha non riprese a servire caffè, ma non divenne moglie di Max e neppure una delle sue attrici. I piedi lunghi ben piantati per terra, non si lasciò travolgere dal Francese. Ebbe un abito da sera di seta rossa per accompagnarlo alle anteprime. Fu la sua fiamma. Alimentò l’ispirazione creativa e l’abilità organizzativa di Linder. Sorrideva sempre Masha. Un anno di sorrisi produsse “The Three Must-Get-Theres” (1922), che Max considerò il migliore dei suoi film e non solo perché era l’ultimo che aveva realizzato, il terzo della seconda serie americana.
THE LAST PARTY Quando bevi una coppa di champagne, senti, sul fondo, un retrogusto, un secondo gusto segreto: i viticultori della regione dello Champagne lo chiamano l’Addio. Max Linder è figlio di un viticultore. Max lo sa, Max assapora l’Addio. E lo fa assaporare, quel retrogusto, a Masha, accanto a lui in abito da sera di seta rossa al “The Three Must-Get-Theres Party” a Hollywood: adieu, sweetheart, adieu. Il sapore dell’Addio diventa una lacrima che cola nel flut, una lacrima che cristallizza un anno di sorrisi. Farewell, ma églantine, farewell. I white tuxedos, i candidi smoking dell’estate senza fine, fanno ala alla coppia che divorzia senza essersi mai sposata. Max Linder è spossato. Uomini e freaks in abiti chiari credono che Max stia lasciando la sua ragazza paziente dal nome russo e dall’abito rosso. Non possono credere che Max stia per lasciare Hollywood. Un giocatore su un milione si alza dal tavolo della roulette mentre sta vincendo. Ma Linder sta soffocando. I gas della passata guerra gli hanno riempito di nuovo i polmoni. E i crampi di un altro avvelenamento non diagnosticato gli straziano il sistema nervoso. Un’ultima coppa di champagne e… adieu. Max sta per andare a Losanna, la lussuosa anticamera dell’eternità secondo i
Bravi Borghesi. Parte una raffica di tappi di champagne, il brindisi di una futile fucilazione alla schiena, una gag edonista, mentre Linder si allontana. Sembra un finale e pare un finale alla Charlot. Ma non è un finale: è solo l’Addio.
CAPITOLO QUARTO A Losanna, anche i bambini sono vecchietti ben educati. Tutta la Svizzera è il loro giardino. Un giardino d’infanzia per studenti a vita di correttezza e buone maniere. Il denaro, blindato nel caveau delle banche, è la decorosa sepoltura data all’incertezza, alla varietà, alla conquista e all’avventura. La pace, naturalmente, è la pace dei sepolcri. La croce della bandiera è la croce rossa della passione inferma. La Svizzera è tutta una metafora e il suo simbolo è la corriera postale gialla che si annuncia dietro ad ogni tornante con il suono del corno di bue: la corriera giocattolo recapita di valle in valle solo lettere di credito e cartoline souvenir di una gita ad alta quota. Di elevato, in Svizzera, non ci sono che le montagne. Lo spettacolo delle vacche all’alpeggio è la rappresentazione della sessualità ridotta a maternità permanente: le risorse dell’allattamento perpetuo paiono inesauribili. Ma torniamo a Losanna. Con il lago, placebo dell’ego. A Losanna, tutto è predisposto per la convalescenza. Le malattie dell’esistere si stemperano nella cauta riappropriazione rituale della presunta innocenza infantile. Naturalmente, neppure in Svizzera, neppure a Losanna, neppure in riva al lago sei al riparo dall’eros!
HERR DOKTOR LINDER CURA SE STESSO A Losanna, il convalescente Max divenne Herr Doktor Linder. Si autoimpose una sorta di germanizzazione terapeutica del nome d’arte. Cercò di assumere gli atteggiamenti di un Leuvielle commerciante di vini in sovrapposizione al divino mondano “Max lance la mode” (film del 1912). A Hollywood, mentre si dava da fare sul corpo ben apparecchiato di Masha, gli era venuto un conato, un rigurgito di disgusto: il ritorno del rimosso, la nausea del reduce sopravvissuto ai gas. Così Max era dovuto partire alla volta della pacifica Svizzera. S’era trascinato dietro sul transatlantico in rotta da New York a Southampton e poi sul treno europeo i pesanti bauli dove le camicie inamidate dell’attore dandy stavano rinchiuse nelle bobine dei film girati. A Losanna, in riva allo stesso lago dove Charlot, in costume da Sir Charles S. Chaplin, sarebbe venuto a vivere il suo lungo, sereno tramonto per essere poi sepolto a Vevey e vendicarsi dell’ineluttabile epilogo beffandolo con l’estrema gag del rapimento del suo cadavere, Max assunse passo e atteggiamento di Herr Doktor Linder, il giovanissimo nonno di se stesso. Herr Doktor Linder, il gentiluomo che passeggia. Ma un attore è sempre un attore. E un comico cerca sempre con lo sguardo la buccia di banana su cui scivolare.
LAFIGLIADI ANJA La Russia era esplosa, dopo che i bolscevichi avevano dato fuoco alle sue tradizioni e alla sua stessa anima imperiale. Schegge di Russia erano schizzate in tutto il mondo, da Shangai alle Americhe. Per qualcuno, era stata un’implosione: allo scoppio della rivoluzione, la francesizzata Anja era tornata a Mosca, dove, dopo molte vicissitudini, aveva finito per indossare la giacca di cuoio nero della polizia politica, la Ceka. Il pugile Gaston non l’aveva mai incontrata a Pigalle, ma Anja aveva abitato per alcuni anni a Parigi, la metropoli dove tutti, prima a poi, si ritrovano, ma che è fatta anche per proteggere il segreto di ogni solitudine. La russa bianca che aveva insegnato teatro e sesso a Bordeaux visse dunque a Parigi
con una bambina, la sua: Nadja. Aveva scelto da sola il nome per la figlia, poiché il papà, Alexander – Grigorovich knjaes (principe) Roman****, nato a San Pietroburgo, ma di stirpe originaria della valle della Loira, sesto Herzog von Leuch*****, Altezza Imperiale, capitano del reggimento degli ussari della guardia, aiutante di campo dello Zar, cavaliere dell’Ordine di Sant’Andrea, dalla nascita della piccola aveva smesso di trascorrere sei mesi all’anno in Francia, tra la Costa Azzurra, Parigi, Deauville e Biarritz; nel maggio del 1912 era ripassato nella capitale, dove, il giorno 3, aveva cessato di vivere il di lui padre, il duca Georges, evitando tuttavia d’incontrare Anja e la di lei quasi anagrammatica Nadja, sua figlia. Spinta in ugual misura da risentimento e passione, personale e politica, Anja partì per la bollente Santa Madre Russia con la principessina non ufficiale di nove anni. Quello che trovarono non era di certo adatto ad una ragazzina di nobili origini, quello che non avrebbero trovato era SAI Alexander-Grigorovich, nascosto in attesa di una possibilità di fuga via Odessa insieme alla moglie, Yvonne Léonie Pauline Marie Ghislaine née baronne de Villen****de Sorin***, sposata a Bruxelles nel mese di luglio del 1910. Per proteggere Nadja, per vendicarsi di ogni aristocratico le rammentasse von Leuch*****, vagheggiando tuttavia d’intercettarlo e di salvargli la pelle, riportandolo a sé, Anja aderì alla violenza leninista e se ne fece feroce rappresentante. Gli eventi successivi, gli eccessi, la carestia che aveva portato milioni di russi all’antropofagia indussero la donna indurita come il cuoio del suo sinistro giaccone a mescolarsi all’emigrazione: giunta rocambolescamente ai confini delle Repubbliche dei Soviet, affidò la tredicenne Nadja al sedicente pope Dimitri, che, forse, era il figlio di Sua Altezza Serenissima la principessa moscovita Dolgorou**, oppure era veramente un prete ortodosso deciso a spacciarsi per principe e a giovarsene una volta giunto a Berlino. Anja si congedò dalla figlia e si fece inghiottire di nuovo dalla Storia. Nadja compì gli anni, senza festeggiarli, in Svizzera, dov’era approdata dopo un breve soggiorno in Germania: non a Losanna, però. A Zurigo, la città dadaista nella quale il conte Ulianov, in arte Lenin, aveva lanciato al Cabaret Voltaire, in un passato che pareva remotissimo, i primi dadi del suo azzardo politico, tenendo banco con teorie che di lì a poco si sarebbero trasformate in una pratica terribile.
LA DUCHESSA DI ZAGAROLO Max Linder fece la conoscenza di Maria Laura Mac***** S*****, nata a Cincinnati nel 1890, residente a Parigi con il marito, il romano Francesco Luigi Giuseppe principe Ros******, duca di Zagarolo, marchese di Giuliana, che non aveva accompagnato la moglie italo-americana in Svizzera, grazie ad una gag, ma non quella classica della buccia di banana. Incrociata la signora sul lungolago, Max cominciò a pedinarla, imitandone con discrezione l’ombra, tra i composti sorrisi elvetici dei passanti, anticipando così lo scherzo-base dei mimi nostri contemporanei che nella piazza antistante il Beaubourg burlano i visitatori del Centre Pompidou. Accortasi dello scherzo, Maria Laura si voltò di scatto e prontamente Linder simulò una zuffa in sua difesa con uno scippatore immaginario, sostenendo, naturalmente, entrambi i ruoli. La marchesa di Cincinnati, appassionata di cinematografo, identificò subito la gag principale di “Be my Wife”, dove il produttore-regista, nei panni del Fiancè finge di difendersi da uno scassinatore, che è lui stesso. - Ma io non somiglio affatto ad Alta Allen – precisò l’Americana, alludendo alla protagonista femminile della pellicola. – Rimedierò subito comprandomi un fox terrier che chiamerò Pal, come il cane del vostro film. Mi accompagnate a sceglierne uno? – aggiunse Laura nel suo francese impossibile. Ebbero subito il cucciolo. E quasi subito una relazione.
La princesse Ros****** era spiritosa, arguta. – Non trovate che una nativa dell’Ohio sia la più adeguata delle spose per il duca di Zagarolo? – . Illustrava poi vivacemente lo stile alto/basso del marito romano, descrivendone il lignaggio contrapposto al linguaggio, al gusto di comportarsi e di esprimersi alla maniera di un fruttarolo di Campo de' Fiori o di un burino ciociaro. Niente di più diverso da Max, che si liberò a guisa di serpente in muta della patina “Herr Doktor Linder” per tornare il Top Silk Hat Dandy, l’attore con il cilindro di seta e, all’occorrenza, il monocolo. La coppia d’aspetto aristocratico, acquisito (e quindi perfetto) dalla signora di Cincinnati per matrimonio e dall’attore francese per talento interpretativo, era un fuoriprogramma a Losanna. Il “Conte Max”, grande prototipo del magnifico personaggio interpretato due volte da Vittorio De Sica nell’omonimo film e nel suo primo remake, una volta come aspirante alla nobiltà, l’altra come decaduto Pigmalione di Alberto Sordi, si pavoneggiava con la nobildonna Maria Laura. Per lei, Linder rappresentava il sofisticato europeo che aveva sognato prima di lasciarsi sedurre dal principe romano e, insieme, il divo diventato ad Hollywood quasi suo scanzonato connazionale. Non si annoiavano mai quei due! Ma furono costantemente consapevoli di vivere un entr’act.
A GRAM FROM NYC – Telegramma per Monsieur Lindèr! Telegramma per Monsieur Lindèr! – . “Tuo film est grande successo a New York stop Critiche trionfali stop Congratulazioni stop Tuo amico Douglas Fairbanks della United Artists”. Non c’è che lo champagne per festeggiare una buona notizia. Non c’è che una lunga notte d’amore per lasciarsi in amicizia. L’intervallo di Losanna è finito. La storia con Maria Laura anche. Max Linder torna in azione: action! Entrambi si apprestano a tornare a Parigi. Ma ciascuno per suo conto. Tra non molto, anche Nadja la Russa finirà a Paris… Girerà il mondo, vivrà molto a lungo, conoscerà tutti, conserverà un segreto, non si presenterà ad un primo appuntamento all’Harry’s bar di calle Vallaresso a Venezia.
CAPITOLO QUINTOVenezia è una città come tutte le altre. Non puoi girarla in macchina, è vero, ma l’effetto è quello di una domenica di stop alle auto in funzione anti-inquinamento. Per il resto, Venezia è piena di topi, di odori e di turisti. Però, in certe ore, in certe zone, in certi momenti, Venezia è la città di “Morte a Venezia”: la città dove il capolavoro è ancora possibile. La morte a Venezia: puoi sciogliere la tua vita come una zolletta di zucchero tenuta tra le labbra bevendo alla russa il tè delle cinque dal samovar della passione e assaporare la fine come un veleno dolcissimo, in un pomeriggio lunghissimo, interminabile. “Non c’è ora migliore dell’ora del tè” sosteneva Henry James; io bevo caffè qui nella città che ha avuto il primo caffè d’Europa, il Florian. Tutt’ora l’unico dove, in certe ore, in certi momenti, in certe circostanze, il caffè sia ancora un peccato nero, amaro. Intanto, mi sfilano davanti i pellegrini innocenti del Limbo veneziano, relegati alla contemplazione di un paradiso che non raggiungeranno, di un inferno dove non precipiteranno: su di loro, dai balconi dei palazzi, si riversano la menzogna e la dissimulazione. Di tutte le fotografie scattate resterà solo un’ombra ingannevole della Serenissima. Io sono qui nella mia Venezia per cercar di svelare il segreto di
Max Linder, l’attore. Per seguire una traccia, per perseguire un obbiettivo, per poterlo raggiungere, spesso bisogna distrarsi. Per distrarmi, ho a disposizione il transito di frotte di ragazzine tenute a rimorchio, o al guinzaglio, dai genitori: le ragazzine aspettano solo un imprevisto, per seguire itinerari inusuali in compagnia di guide disinvolte e scherzose. Glielo leggi negli occhi, sbarrati davanti alle videocamere dei padri capobranco e delle madri femmine alfa. Ma è poi una piccola cicatrice orizzontale proprio sopra al ginocchio della gamba destra, lunga, dritta e soda quanto la sinistra e come quella stretta negli stivali di cuoio intrecciato da gladiatore a catturare la mia attenzione. La giovane dalla piccola cicatrice sopra al ginocchio ha un corpo perfettamente confezionato nelle linee della sfrontatezza. Il suo torso antico è di quelle statue che si ripescano in mare: se si tuffasse in laguna da una gondola, conserverebbe fascino intatto per almeno un millennio. Si china verso una coetanea bionda e compatta seduta sui gradini di un ponte sul canal, scoprendo così un po’ un paio di seni refrattari ad ogni costrizione; per un pezzo, non avranno bisogno di sostegno. Mi alzo per andare incontro alla coppia, che già si sono accorte e incrociano sguardi di curiosità e diffidenza, mascherata da indifferenza. Poi attraverso il ponte senza fermarmi, solo voltandomi di tre quarti per una svelta, muta promessa: se v’incontrerò di nuovo domani, amiche mie, qualcosa accadrà. Ora ho altri pensieri da assecondare, del tempo da perdere, dei Fontana da ammirare e un mezzo appuntamento all’ Harry’s bar con una vecchia signora che non sarà mai una signora vecchia.
TRAIN DE VIE POUR PARIS “ Your movie is a big success in New York, enthusiastic critics, congratulations. Sincereley, Douglas Fairbanks”: il telegramma dall’America ha riportato Max ai nastri di partenza: a Parigi, a Parigi. Il campione si rimette in corsa, si rimette in gara:rinuncia alla rinuncia. Interrompe la convalescenza, non sa se e da cosa è guarito, ma non gli importa più, non sa neppure se è mai stato malato. Douglas Elton Thomas Ulman, nato in Colorado nel 1883, conosciuto come Douglas Fairbanks, non è uno qualunque: nel 1915 ha fondato, con Mary Pickford, Chaplin e D.W. Griffith, la United Artist, grande distribuzione indipendente di film: Mary e Douglas regnano su Hollywood come una coppia reale. Linder si congedò da Maria Laura come se fosse il finale di uno dei suoi primi film: “Max in fuga dall’amante americana”. Era un gioco, non era una fuga. L’addio ebbe il gusto dell’ultimo sorso di champagne. Max si ritrovò sul treno per Parigi con un cagnetto in braccio. Pal era toccato a lui. Semiassopito nella promettenteincubatrice dello scompartimento di prima classe, il fox terrier sulle ginocchia, Max semisognava carnagioni intatte indossate da gambe adolescenti. Attraversò il confine senza perdere la patina elvetica che lo preservava dal passato: per Linder e per il suo mondo, la prima guerra mondiale non era mai scoppiata. Alla seconda, Max non avrebbe assistito.
PARIS IS NOW Parigi è adesso. Parigi ha i tempi di un set cinematografico. Del resto, è qui che è nato il cinema. I parigini sanno fare i parigini: fanno scena. E si sentono tutti molto importanti: un giorno, prima o poi, ognuno di loro sarà il regista e l’attore di un Grande Amore. Attore e regista, Linder, creatore di Max, la sorprendente figura elegante disegnata per la cinetica cinematografica, unica nella storia delle Ombre Appassionanti a saper sedurre divertendo e divertire seducendo, prese presto possesso del set della gaitè parisienne. Si muoveva perfettamente a suo agio da sofisticato europeo patinato di
Nuovo Mondo tra i connazionali e da tipico gentiluomo francese dai vasti orizzonti cosmopoliti tra gli espatriati. Con questi ultimi, con gli espatriati, leggendari protagonisti del radicale rinnovamento del panorama artistico-culturale mondiale, Linder si mescolava volentieri. Quando sentiva nostalgia degli Stati Uniti, i suoi Stati Uniti semplificati dal mito, riassunti in idee-guida, Miss Libertà dispensatrice di Opportunità sulle soglie dell’accoglienza nello spazio simbolico di Ellis Island, visualizzati in immagini-totem, la prateria dietro ad ogni angolo di strada, celebrati in comandamenti-slogan, non avrai altro successo che quello che vorrai, Max Linder s’immergeva nella festa mobile della Rive Gauche e beveva una birra ghiacciata con Ernest Hemingway. Tra di loro, parlavano fitto fitto di amici comuni che nessuno dei due conosceva, parlavano e sparlavano di Scott Fitzgerald come di Turgenev e Max improvvisava per l’altro squisite imitazioni di Zelda come di Anna Karenina. A poche ore e a pochi isolati di distanza, Max esilarava poi la buona società con pantomime hemingwayane, fingendosi soldato sotto pressione che invocava ed evocava la Grazia a Caporetto nell’atmosfera dell’addio alle armi (grace under pressure la chiamava l’apprendista Grande Scrittore corrispondente del Toronto Star che avrebbe pubblicato il suo romanzo “Farwell to arms” nel 1929) e così facendo esorcizzava i fantasmi dei suoi mesi e delle sue notti in trincea. Oppure si sbizzarriva nel doppio ruolo di Ernest e Gertrude che prendono il tè dalla Stein in rue de Fleurus, quando d’un tratto irrompe Alice Toklas e… e Max era anche Alice e una rosa è una rosa è una rosa e un attore è un attore che fa l’attore che fa l’attore. Esistenze leggendarie in rotta di collisione: il Giovane H. (Holedengway?) e l’Anziana Collezionista, Gertrude Stein, fidanzata di Miss Toklas, a cui attribuirà la sua divertentissima autobiografia. – L’attore è un torero che deve interpretare anche la parte del toro – disse un giorno il vecchio Hemingstein (gli sarebbe piaciuto essere ebreo e si divertiva a farsi chiamare così) al caro vecchio Linder. Un’altra lezione fondamentale, dopo quelle ricevute da Anja.
PARIS IN OUR TIMES Per vie traverse, Nadja tornò nella sua città natale. Della madre Anja non sapeva più nulla. Di Zurigo non ne poteva più. Giunse a Parigi in compagnia di una falsa zia. Era costei uno strano ebreo che si faceva chiamare Venusque: in Russia, aveva abitato in uno shtetl trasformato in villaggio di Potemkin; un contadino gentile s’era finto aristocratico e si era offerto in sacrificio alla Ceka (il corpo di polizia sovietico di cui aveva fatto parte anche Anja) per salvare il falso villaggio felice chagalliano da dove Venusque era fuggito, per rifugiarsi temporaneamente in Turkmenistan, dormendo in un cinema, riuscendo poi ad arrivare in Svizzera. Che rapporti intratteneva con la “nipotina”? Perché l’aveva portata in Francia? Sollevando il capo dal Moleskine, dove incideva con la forza di volontà le sue storie il maggior fabbro della prosa novecentesca, la vide entrare nel petit cafè Mister Hemingway: quando riabbassò la testa sul suo taccuino, il bell’americano iniziò un racconto nuovo in cima ad una pagina pulita. Sua moglie l’avrebbe perso, insieme a molti altri battuti a macchina in copia unica, alla Gare de Lyon. Della ragazzina Ernest ignorava nome e peripezie: la chiamò Charlotte e chiamò l’ambigua signora che l’accompagnava Madame Zulawski. Se avesse saputo la loro storia, ne avrebbe probabilmente tratto un romanzo e il sole di “The sun also rises” sarebbe sorto a Parigi con Venusque al posto di Lady (“Fiesta” è il titolo con cui è conosciuto in Italia il libro del 1926) Brett o del conte greco o come figura unica che li fondesse in un solo personaggio. Se avesse avuto accanto l’amico di bevute di birra, il caro Linder,
di Max avrebbe fatto un Jordan mutilato di guerra vanamente innamorato di “Charlotte”. Max Linder, invece, sedeva solo in un altro caffè. E la ragazzina che vide passare si chiamava Ninette e dovette alzarsi per seguirla lungo i boulevard. Ma il destino aveva comunque già deciso di mettere Nadja sulle sue tracce. Intanto, la giovinetta lanciò inconsciamente un languido sguardo d’amore al bell’americano, mentre la “zia” la trascinava fuori dal petit cafè, dove si era appena scolata un Calvà. Come avrebbe potuto immaginare Nadja che, un giorno, avrebbe letto di sé in un racconto perduto di Hemingway, trovandosi restituita all’adolescenza e corrisposta segretamente nel suo sguardo, accettato, decifrato e restituito dall’Americano a Parigi.
AN AMERICAN IN PARIS Come un Americano a Parigi, un po’ per l’esperienza hollywoodiana un po’ per la frequentazione hemingwayana, si comportava nella sua capitale luminosa il francesissimo Max Lindèr. – Quando aspetti qualcuno, siediti lungo gli Champs Elysée: prima o poi passerà – gli aveva detto Ernest. Max non aspettava qualcuno in particolare, aspettava l’attesa: aspettava qualcosa per cui valesse la pena di essere una star del cinema. Che cosa lo colpì nella giovanissima Ninette che passava, che cosa lo indusse, lo spinse, lo costrinse ad alzarsi e a seguirla? Non ce lo chiediamo, perché sicuramente in una simile circostanza neppure Max se lo domandò. Max puntò su Ninette come un giocatore punta su un cavallo al tondino: se è un cavallo vincente, la sua intuizione sembrerà chiarissima dopo il traguardo a tutti tranne che al giocatore stesso; se si è sbagliato, gli altri gli spiegheranno con dovizia di particolari l’errore e come evitarlo in futuro, ma il giocatore, del tutto disinteressato all’argomento, non li ascolterà, già distratto da un’altra scommessa. Max avvicinò Ninette come un giocatore si avvicina al tavolo verde: con disinvoltura e finta distrazione, chinandosi impercettibilmente verso la roulette, senza sognarsi di sfiorare la pallina che gira. Max corteggiò la diciassettenne Ninette Peters, dopo aver appreso null’altro che il suo nome al primo incontro, come si corteggia la pallina della roulette: fissandola intensamente senza perderla d’occhio e senza che il suo vorticoso girare ti faccia girare la testa.
L’AMORE PERFETTO NON È QUASI MAI QUELLO CHE DURA “C’était un sèducteur volage mon père!” dirà Maud, figlia di Ninette e di Max, del babbo, conosciuto soltanto al cinema. “Che volubile seduttore è stato mio padre!”. Un vero incantatore fu Max con Ninette, poiché la trovava incantevole. Le disse, baciandola sulla bocca, che risentiva sulle sue labbra il sapore dell’uva di una lontana vendemmia in Gironde. Bevette avidamente il suo fiato e le sussurrò che sapeva di mosto. Insegnò rapidamente alla sua lingua a trasmettere l’ebbrezza del vino novello. Ninette Peters vide in lui il divo charmant, impeccabile e ironico, quasi incorporeo nell’eleganza curatissima e così carnale negli abbracci, sdrammatizzati però dall’enfasi di una gag. Le sembrò uscito dallo schermo, come nella “Rosa purpurea del Cairo” di Woody Allen. Lui la fece sentire dentro al suo film. Max Linder e Ninette Peters si unirono in matrimonio. Erano a Parigi, era il 1923 e Parigi era una festa in movimento, non erano poveri ed erano felici. Presto sarebbe nata Maud. Presto si sarebbero sviluppati importanti progetti creativi. Presto, troppo presto, tutto sarebbe finito.
CAPITOLO SESTO “Venezia era tutta d’oro” quando, nel 1961, Lucio Fontana la espresse nel suo concetto spaziale così intitolato.
Venezia è tutta d’oro in questa estate calda. È l’oro sbiondato delle nordiche in visita, sbiottate dall’afa subtropicale. Con le loro gambe a compasso che misurano il mondo (così fece dire al suo Uomo Che Amava Le Donne il regista Truffaut, “l’uomo più felice del mondo”), le ragazze d’oro percorrono calli, attraversano campielli. Sotto i pantaloni corti, i jeans tagliati sopra al ginocchio, le gonnelline minime si muovono e mormorano incessantemente le labbra del loro “taglio di Fontana”. Invano gli orridi sandali carrarmato di autodifesa ai piedi cercano di deviare più in basso sguardi e cattivi pensieri. Il cielo si copre di nubi patinate, ma le nordiche rimangono scoperte: ridono di loro, accorte ed esperte, le non meno bionde veneziane. Sanno che l’amore può deflagrare ad ogni istante. E che ogni amore può andare in pezzi in un attimo. Siedo sotto l’albero di Yoko Ono a cui sono poeticamente appesi bigliettini con mille messaggini nel cortile di Peggy Guggenheim a Palazzo Venier dei Leoni. Poi mi sposto a Palazzo Grassi, a rivedere il Piccolo Hitler in preghiera, inginocchiato in un angolo: è di Cattelan, è la Pietà del Terzo Millennio. In un’altra sala, la scrofa in rianimazione di Paul McCarthy respira attaccata alla sua macchina, mentre le vacche fatte a pezzi da Damien Hirst continuano a morire. Su un teleschermo, passa e ripassa a loop il video delle avventure erotiche di Inochi, la piccola creatura fallica in fibra di vetro, acciaio, acrilico e tessuto alta 1,40 di Takashi Murakami: un telefilm del futuro prossimo venturo che ha lo spirito di Max Linder nel Dna. L’eccezionalità, l’eccentricità espressiva di Linder fanno di lui il padre nobile della rivoluzione mediatica in atto: la sua continuità narrativa nella frammentazione della serialità (cinquecento opere mute: dall’ottantina rimasta se ne percepisce la straordinaria eloquenza), una coerenza ottenuta attraverso la centralità dell’Icona Max nello sviluppo di un’opera continua fruibile in qualsiasi punto dell’intera filmografia. Oggi un prodotto visivo va concepito nella molteplicità poliarticolata della distribuzione: lo stesso lungometraggio da sala, evento promozionale, dev’essere consumabile e godibile nella miniserie da minischermo (telefonia mobile), sugli schermi degli air terminal, sul pc e così via. Il cinema perde la centralità da megascreen e conquista la globalità moltiplicandosi e accentuando una delle sue caratteristiche costitutive: la velocità. Se Max ci appare contemporaneo di Inochi, Linder ha, rispetto a Murakami, l’attitudine alla popolarità. E questa è la differenza sostanziale tra videoarte e nuovo cinema. La libera, sterminata nuova frontiera della cinematografia indipendente è percorribile dalle scorribande del free cinema, inteso in senso analogo al fenomeno free press. La carovana del free movie è assalita dalle Ombre Rosse degli Indiani Sponsorizzatori, i suoi indispensabili alleati, che lanciano a bersaglio (il target) le frecce del messaggio promozionale, integrato al plot dall’abilità di sceneggiatura che sfrutta la potenzialità espressiva e produttiva, creativa ed economica, del product placement: insieme, fanno spettacolo. Scrive il grande critico letterario George Steiner: “Quale romanzo oggi può competere con i migliori reportage, o con le migliori narrazioni dirette?”. L’affascinante quesito è trasferibile pari pari al mondo dell’immagine: l’immaginario ai tempi della sfida del reality e della potenziale narrazione diretta, quando basta una webcam a fare del teatro per la platea totale.
DER ZIRKUSKONIG AUS LIEBE Il Re del Circo giunse a Vienna nel 1924. A Parigi erano restate la Regina Ninette e la Principessina Maud. A Vienna Re Max fu accolto come un imperatore, un Re Magio portatore del dono prezioso dell’allegria in una capitale nervosa, depressa, declassata. Der Linder Koning visitò la città, dove piccoli caporali frustrati sognavano di entrare all’Accademia di Belle Arti e antiaccademici pittori post-adolescenziali incestuosi ritraevano con scarna, furiosa eleganza ninfette pre-nabokoviane. C’era una strana atmosfera eccitata e malata in Cacania (definizione di Musil, l’autore dell’emblematico, indigesto romanzo L’uomo senza qualità). Max Linder a Vienna avvertiva un leggero, ma persistente, fastidioso disagio: lì erano pazzi di lui per nostalgia della lievità che incarnava, però Max si sentiva superato, inadeguato a quel che percepiva della complessità del presente. Il circo che doveva interpretare e filmare con lo spirito del clown innamorato (“Clown aus Liebe” fu uno dei titoli con cui uscì il suo ultimo film, insieme a “Der Zirkuskoning”, “Circusmania” nel Regno Unito e “King of the Circus” negli Stati Uniti) era abitato da ombre già espressioniste, gli ometti con i baffetti che sgomberavano la pista dagli escrementi delle fiere ammaestrate covavano devastanti rancori e i bambini sugli spalti somigliavano a quelli seduti sui banchi della kantoriana “Classe Morta”. Lo spirito del clown innamorato era ancora in sintonia con lo spirito dei tempi? Al divo Max resero omaggio artisti e aristocratici, modelle e banchieri. Ma non incontrò il dottor Sigmund Freud. Non pose piede nello studio in Bergasse. Probabilmente, un colloquio con l’esploratore dell’inconscio gli avrebbe salvato la vita. Fu invece accompagnato in gita a Mayerling. Qualcosa dell’oscuro dramma gli si insinuò nella mente.
UN POMERIGGIO A MAYERLING Due atteggiamenti si contrappongono nei confronti della tragedia di Mayerling, così come di analoghe situazioni dove s’incrocia ragion di Stato e irragionevolezze del cuore: uno storicismo tignoso che legge tutto in chiave complottistica e un sentimentalismo scatenato, con retrogusto vagamente iettatorio. Dodi e Diana: la teoria dell’incidente è formulata e accettata solo da chi conosce il complesso disegno del caso. Sono pochissimi. Rodolfo principe ereditario, eroe di un presunto separatismo ungherese, intenzionato a sedere sul trono di Budapest spezzando l’unità della Doppia Corona o ribelle disperato in rotta di collisione con l’augusta volontà paterna? I fatti sono noti: nella residenza di Mayerling, poi fatta demolire dall’Imperatore per cancellare il luogo del dolore, Rodolfo uccide la fidanzata magiara e si toglie la vita. Un plot decisamente cinematografico. Per attitudine tecnica, il Max Linder sceneggiatore, regista e produttore e non il Max attore, sentito il romanticissimo e dietrologico racconto di Mayerling dalla sua guida, provò a pensare la vicenda in termini filmici. Forse, quel pomeriggio fuori Vienna, Linder stava cercando d’intuire dove stesse andando il mercato dello show biz prima di tornare sul set di “Il Re del Circo”. Forse, addirittura, vagheggiò di rinnovare il suo personaggio di Max al punto di dare al comico (“Max Linder: il più grande uomo di cinema francese; lui solo, prima di tutti gli altri, ha capito l’indispensabile semplicità del cinema; è un vero comico e un vero umorista” dice di lui Charlie Chaplin) una struttura drammatica, o, nell’accezione migliore del termine, melodrammatica. Max: un Rodolfo del muto, con colonna sonora adeguata e la credibilità fisica e strutturalmente elegante e affascinante. L’ambizione di ogni comico e un’ipotesi davvero suggestiva. In realtà, Max Linder lasciò Mayerling con un carico di malinconia che fugò facendo il buffone
per la circusmania, ma sarebbe stata l’esistenza ad attribuirgli di lì a poco il ruolo di Rodolfo nello screenplay di una Mayerling domestica.
D’ARTAGNAN AL TELEFONO
– Herr Linder al telefono, Herr Linder al telefono – . Ma non c’era nessuno al telefono. Anzi, non c’era nessuno che annunciasse a Max alcuna chiamata telefonica. C’era solo il silenzio innaturale della fine delle riprese: anche i set del silent movie erano chiassosi, ancora più rumorosi di quelli dell’era del film parlato, poiché le indicazioni tecniche e registiche venivano dettate al megafono in diretta. Max aspettava sempre qualche minuto prima di struccarsi: prima di uscire dalla parte, restava in compagnia di se stesso, a verificare che la gag dello specchio tra il suo Es e il Superego funzionasse ancora. Nel silenzio della fine delle riprese, isolato dalla troupe, il Re del Circo, detronizzato allo spegnersi delle luci e della camera, sentì un telefono squillare nella sua testa. Era un suo personaggio a chiamarlo da un film americano realizzato due anni prima a Hollywood: un film sui Tre Moschettieri, il solo film di cappa e spada dove D’Artagnan faccia una telefonata. Una soluzione di straordinaria post-modernità. L’anacronismo comico come destabilizzazione ucronica della “normalità”: che cosa sarebbe accaduto se Fabrizio Del Dongo a Waterloo avesse potuto scattare foto con il suo telefono portatile? Non avrebbe capito meglio le dinamiche della battaglia, ma noi capiremmo meglio Stendhal e la Certosa di Parma. Napoleone avrebbe perso lo stesso anche avendo a disposizione oltre alla Vecchia Guardia la nuova tecnologia (secondo la logica del caso e quella delle cose), ma noi ne capiremmo meglio i motivi e le conseguenze. La mentale chiamata di D’Artagnan indusse Max Linder ad una più profonda e inquieta riflessione. Non mancava qualcosa al “King of Circus” appena concluso? Mancava l’effetto D’Artagnan: mancava un colpo a effetto, una trovata, un’innovazione. Quel film era arretrato rispetto a “Dart-In-Again” del ’22. E nello show biz si deve andare sempre avanti.
DART IN AGAIN Ma la freccia filmica di Max Linder andò a bersaglio, il D’Artagnan del cinema aveva colpito ancora: il suo Circo trionfava in Europa e negli Stati Uniti. Però l’Autore era tornato insoddisfatto da Vienna. Sulle colline, al limitare del bosco viennese, bevendo vino bianco per festeggiare la fine del film, circondato da gente euforica, che cercava di convincere il figlio del vignaiolo francese Leuvielle a non provar nostalgia per lo champagne, Max aveva incontrato un fascista italiano; tornato a Parigi, conobbe un altro italiano, un fuoriuscito antifascista. Le correnti emozionali del mondo erano ad alta tensione: che cosa volevano esprimere i totalitarismi? Riabbracciando Ninette, sua moglie, si sentì rassicurato. Prendendo in braccio Maud, sua figlia, dovette reprimere un brivido di spavento. Arrivarono altre buone notizie: Max Linder era stato nominato Presidente della Screenwriters’Association a Hollywood. Bisognava festeggiare. Ad una cena parigina, che avrebbe dovuto celebrare il culmine della carriera di Max, “L’Idiot que se croit Max” (titolo di un film del 1914, agli albori di quella luminosissima carriera) incontrò chi non avrebbe dovuto e non avrebbe più voluto incontrare.
CAPITOLO SETTIMO Potemkin è il nome della corazzata più famosa della storia del cinema: dalle glorie dei cineforum alla “boiata pazzesca” di Fantozzi/Villaggio, il film di Ejzenstein ha reso celebre il capolavoro muto del montaggio analogico. La corazzata prende il nome dall’Ammiraglio Potemkin, ufficiale e gentiluomo, amante ufficiale della Grande Caterina. Mi è particolarmente caro il suo nome, poiché lo diedi a Potemkin, il mio amatissimo cane, capostipite di una dinastia di lupi. Dall’Ammiraglio e da una sua trovata prendono il nome i Villaggi di Potemkin. Per amore della zarina, per rallegrare la vista dell’Imperatrice in visita nelle terre della sua Rus, i villaggi lungo l’augusto percorso venivano fatti decorare dal conte Sergei di facciate posticce e popolata di contadini-comparsa, ben vestiti e pasciuti, allegri e festanti sulle porte di casa. Una scenografia! Da smontare dopo il passaggio della Grande Caterina. Ma i costumi e uno spirito più sereno rimanevano in dotazione agli abitanti della realtà dietro la facciata. Perché il teatro è sempre meglio della vita. Venezia d’estate è tutta una scenografia per una gita scolastica. Il Doge professore non c’è più, se n’è andato, è stato dimissionato e a Venezia d’estate si diventa tutti studenti in libera uscita, studenti in vena di scherzi sciocchi e spensierati. E tutte le ragazze si sussurrano malizie. Poi, a notte fonda, giovani e meno giovani e vecchi e ancor più vecchi bagoloni s’infilano in fondo alle calli e spariscono chi in una casupola chi in un palazzo chi nel vomito della sua stessa sbronza. Allora, a Venezia, apre il Fondaco della Memoria. E una signora in mantella e cappuccio vermigli, come una maschera di Carnevale in estate, socchiude la porta della sua strana abitazione dalle finestre murate in Calle de Mezo e ti fa entrare. – Sono Madame Grigorovich: Nadja Grigorovich – .
LA CENA DELLE BEFFE I Linder: la Coppia Perfetta. Il neo Presidente dell’Associazione Americana degli Sceneggiatori e la giovane Bella Signora. Lui, uno degli ultimi esponenti della civiltà occidentale a saper indossare lo smoking (dopo di lui, solo Fred Astaire e chi altro?). Lei, Ninette, capace di restare una gamine coquette anche con un marito e una figlia piccolissima. A cena si parla del più e del meno. Max, in qualità di produttore e di autore,coinvolge nella gestazione del film ad alto budget “The Barkas Knight” (working title) René Clair: sarà un vero kolossal. La pre-produzione deve iniziare al più presto, si alzano i calici a salutare il varo del grande progetto, Ninette tocca il bicchiere del marito, tutta fiera di lui, Max vede qualcuno alle spalle della moglie e rimane basito. Ha visto Anja come non l’ha mai vista: è Anja, ma è una ragazzina. In un pulsare di dissolvenze incrociate, il volto della sconosciuta, quello di Anja e quello di Ninette si succedono al visetto di una bambina incontrata in una remota vendemmia riapparsa dall’infanzia, il paese d’origine della vita, nel bagagliaio del presente, da cui cade fuori, sulla carreggiata dell’esistenza in corso (in corsa): lo sai che non potrai tornare indietro a recuperare alcunché, ma tendi a frenare bruscamente la cabriolet del tuo destino, rischiando così la sbandata fatale. Te la presenteranno, Max. Si presenterà con il nome di Nadja Grigorovitch. Non avrai tempo e modo di scoprire che è la figlia di Anja. Ci sarà pochissimo tempo da passare con lei: ma troppo da sopportare.
NADJA, AMOUR FOU “Uccidimi domani, stanotte lasciami vivere” disse Desdemona.Nadja è il nome scelto da Andrè Breton, surrealista, per raccontare nel suo romanzo
l’amor folle. Folle d’amore, Max Linder… stavo per scrivere Max Ernst, a proposito di surrealismi e di lapsus surrealisti… Max Linder, fool for love, fool nel senso shakespeariano del Fool, folletto di se stesso, non è più in sé, si sdoppia, è l’Altro, l’Hyde del suo Jeckill (Kill Jeck!), l’attore allo specchio: è la sua gag più famosa e non la saprà più portare a compimento. Una cena formale è tutta una scena. René Clair ha tredici anni meno di Linder e non è ancora René Clair: ha scelto il suo nome d’arte, al posto del banale René-Lucien Chomette e la sua strada. Ha le idee chiare questo Clair. È venuto con il suo sceneggiatore, Francois Marie Martinez Picabia, nato nel 1879 a Parigi da padre spagnolo: proprio quest’anno, il 1924, Picabia, pittore, è tornato a vivere nelle vicinanze della sua città natale, a Tremblay-sur-Mauldre. C’è anche Man Ray: è venuto in compagnia di Kiki, la già leggendaria Kiki di Montparnasse, dalle terga celebrate nel capolavoro fotografico di Ray, her Man, “Le violon d’Ingres”, realizzato di recente. La modella, la fotomodella, la prima top model della Storia, affascina i presenti, anche Hemingway, entusiasta di fare un pasto abbondante quanto i suoi appetiti. Anche Marcel Duchamp, il pigro, disincantato, ironico sovvertitore dell’arte moderna. Anche il timido mondano Satie, il musicista perfetto per il cinema di Linder, fatto di analoga dose di divertimento, fatuità, stile e profondità. Max, invece, non ha occhi per Kiki, Max non ha occhi che per Nadja. Se ne accorge Ninette, la sua giovanissima Desdemona. – Uccidimi domani, stanotte lasciami vivere – . Otello Linder, moro impomatato, geloso di se stesso, geloso di Max, vorrebbe eliminarla subito. Così, si condanna e condanna sua moglie a morte. La sentenza è pronunciata, ma non è ancora nota.
ENTR’ACTE “Entr’Acte”, film di René Clair, dura 22’: non basterebbero 22 pagine per parlarne. A Picabia è sufficiente una frase: – La testa dell’uomo è tonda per permettergli di cambiare frequentemente idea – .Molti anni prima del “Posto delle Fragole”, molti anni prima di Bergman, René Clair e Picabia inventano la caduta di una bara dal carro funebre: la bara si apre, il cadavere (squisito) di un illusionista rotola fuori e fa scomparire tutti gli altri personaggi del film. Ah se René avesse fatto sparire così, come in un film, Nadja dal campo visivo di Max! “Entr’Acte” è un piccolo grandissimo film. Ah, se René Clair avesse fatto scomparire così, nell’illusione di un film, Max e Ninette! Il film di Linder con René Clair, “The Barkas Knight”, non si farà. La cena prosegue in forma di balletto: musiche di Erik Satie. L’ultimo successo di Max Linder, attore, regista, produttore e presidente degli sceneggiatori d’America, si chiama “Au secours”: aiuto! È stato realizzato nel 1923 e proiettato nello stesso anno al Cinema Linder, la sua sala cinematografica parigina. Max Linder è un protagonista e un uomo di cinema molto potente: naturale che sia al centro dell’attenzione. Ma l’attenzione di Max continua a posarsi con l’insistenza di una mosca cavallina sulle affascinanti acerbe fattezze di Nadja. René-Lucien Chomette, in arte René Clair, ha portato a cena la ragazza russa, pensando vagamente di farne la sua Kiki. Ora la presenta a Linder. – Nadja Grigorovich, Max – – Sono Max Linder, l’attore – – Lo so – . Nadja ha solo un anno meno di Ninette Linder. Eppure adesso Ninette sembra
invecchiata di una vita, di un’intera vita consumata accanto al marito. E la piccolissima Maud non conoscerà i suoi genitori. Hemingway, povero e felice, sazio di cibo, ma non di alcool e di sensazioni, si pasce della presenza e della vicinanza di Kiki di Montparnasse. Non se ne cura Man Ray, che fotografa mentalmente per uno dei suoi rayograph la passione prossima ventura: un’altra parigina, o un’altra espatriata. Giocherella con un pezzo di baguette Marcel Duchamp, pensando di realizzare con gli avanzi in tavola un’opera d’arte: anticipa così di un bel pezzo l’intuizione creativa di Daniel Spoerri. Quanto manca ad Halloween?
LA NOTTE DI HALLOWEEN Streghe e maschere son diventati gli invitati nel corso della cena. Stregato da Nadja, maschera giovanile di Anja, Max non riesce a far conversazione con lei. Stregata dall’uomo dai baffetti curatissimi, Nadja non riesce a parlargli di sé, a raccontargli le sue avventure di esule, a rivelargli alcunché di Anja, sua madre. Riesce solo a ridere con lui. “Quando ridiamo con Max Linder” – dirà Marcel Achard – “ridiamo in buona compagnia”. Streghe e maschere. Marcel Duchamp osserva la scena attraverso un personale Grande Vetro: la “Sposa messa a nudo dai suoi scapoli, anche” è Ninette o Nadja? Maschere nude. Un galoppino che somiglia al ruolo sostenuto da Bogart in “The Barefoot Contessa” (La Contessa Scalza) ha avvicinato Mr.Linder per conto di un tycoon di Hollywood. Perché non girare un adattamento di “The Porter From Maxim’s”? Rimasta sola, Nadja fu avvicinata da Hemingway. – Ti chiami Charlotte? Io ti ho chiamata così. In genere, non mi sbaglio – – Mi ricordo di te. Sei l’americano bello – – Ci siamo visti in un cafè, come lo chiamate voi – – Io non sono francese – – Neppure io – – Che ci fai a Parigi? – – Scrivo nei bar. Ti ho vista e ho scritto di te. E della tua amica – – Venusque? L’ebreo Venusque? – – Un uomo? Non sembrava – – Di più di un uomo – – Ho scritto un racconto su di te sul mio taccuino – – Raccontamelo adesso. Non mi hai detto il tuo nome – – Hemingway, Ernest Hemingway. – Ernest Hemingway cercò un po’ di ricordare e un po’ d’inventare la storia di Charlotte, una ragazza che lo aveva fissato in un petit cafè: lo aveva fissato intensamente, poi il narratore si era reso conto che era cieca. La short story faceva parte di quelle che sarebbero andate perdute. Un racconto del genere l’ha scritto Pirandello. Capita così tra scrittori: i soggetti girano, prima o poi qualcuno li mette sulla carta. La festa non è ancora finita. Ma i Linder se ne vanno. Quanto manca ad Halloween?
ALTRI GIORNI, ALTRE NOTTI Paris, 1925. Foto di famiglia in un interno: il Clown Chic, la Ragazzina Primo Amore, la Bambina Che è Un Amore. Max ha cominciato con il teatro. Ora recita a casa sua. Lo spettacolo va in scena fino
a sera. Maud passa dalle braccia della tata a quelle di Ninette: almeno una volta al giorno, anche il padre la prende in braccio. Max sa farla ridere. Quando la figlia ride, alla giovane madre viene da piangere. Allora Maud torna dalla nurse. “ Sei solo il buffone della morte, che con la tua fuga ti sforzi di evitare, mentre le corri sempre incontro “. Shakespeare, Misura per Misura, Atto III, scena prima. Una lezione di recitazione. Ritorno a Bordeaux. Ricordo di Anja. Cala la notte. Cala il sipario. Max non è più un attore famoso. È solo un marito disperato. Ama disperatamente Ninette: più precisamente, scendendo in profondità nella sua psiche, Max ama il suo amore per Ninette. Il comico da una comica alla settimana è diventato “Max, il buffone della Morte”. Non sa più fare altro. Ogni tanto, vede Nadja. Per lavoro, sostiene. Per un ruolo in “The Porter From Maxim’s”: il film che non farà mai. L’amore? Vorrebbe farlo ancora con Ninette, il suo solo, unico, grande amore esclusivo. Vorrebbe, ma non può più. Ninette doveva essere Anja… avrebbe dovuto essere Nadja. Ma questa sceneggiatura crudele non l’ha scritta Max Linder. Quando tutti lo guardano, un attore sa sempre cosa fare. Quando un attore è il suo stesso spettatore, non sa sostenerne lo sguardo. Deve trovare una via d’uscita.
CAPITOLO OTTAVO Si socchiude davanti a me la porta moresca del Palazzo Fantasma in fondo a Calle de Mezo e il fantasma che appare sulla soglia è un colibrì di cristallo. La sua voce cristallina suona uno xilofono di bicchieri vuoti, concerto per champagne bevuti e non goduti. Le sue fragili, delicate fattezze sono ammantate e incappucciate di velluto vermiglio. – Non ho mai fatto entrare nessuno e non ho voluto incontrare nessuno, neppure Maud. Ma tu…tu sei il figlio del Principe Pittore e della Princesse Juif. Entra e che tu sia il benvenuto, Sebastian. Ti conosco da prima che tu nascessi – . Madame Grigorovich, che ha pronunciato “Sevastian” alla russa, conobbe e frequentò i miei genitori, quando, coraggiosi, disinvolti conviventi spregiatori delle convenzioni, stavano, pionieri della Costa italiana, a Santa Margherita Ligure. Getulio Valentin, aristocratico di origine russa (russo-provenzale, per esser più precisi) pittore ritrattista, ufficiale coloniale in Libia, piantatore di tabacco e allevatore di cani da caccia in India, tornato via mare dall’Oriente, scampato fortunosamente ad un disastro aereo, conobbe mia madre a Milano. – La mia memoria è la mia maledizione – . Le stesse parole tante volte ripetute da maman. – La mia memoria è la mia maledizione – . Mia madre ricordava i dettagli più strani, curiosi, significativi. Dell’anziana, già allora, amica russa, fata madrina della sua fiaba d’amore con il Principe Valentin, mi aveva parlato spesso e a lungo. Eccola qui Madame Gigorovich: Nadja. La sua casa ha le finestre murate all’esterno e usate all’interno per incorniciare fotoritratti in bianco e nero o colorati a mano di un attore divertente e impeccabile: Max Linder. Nel riquadro delle finestre, Top Hat Max, il gentiluomo con il cilindro, in primopiano e a figura intera: tutte le finestre, tranne una. – La mia memoria è la mia maledizione. Solo di quella ho dovuto vivere. Ora sto per andarmene e mi piace lasciare a te quel che rimane del mio passato. Perdonami se parlo da attrice: avrei potuto esserlo. E invece non sono stata che un’ombra. Un’ombra tra le ombre, un’ombra tra i vivi – .
“Un’ombra si perde per troppa luce… o per troppa oscurità” sostiene Moni Ovadia. Prima abbagliata, poi investita e sommersa dal buio come da un’onda anomala: questo è quanto accadde a Nadja, troppo giovane per non perdersi ed essere perduta. Abbagliata dalla personalità mondana di Max Linder, abbagliato per controriflesso da lei al punto da incupirsi e da proiettare sulla ragazzina fatale il suo umore scuro: rayon vert de malheur… verde raggio di malasorte che spegne ciò che illumina. Al contrario del cinema. – Tu somigli in pari misura a tuo padre e a tua madre, prince Sebastian. E ti chiamo così, pensando tu sia succeduto a Valentin alla sua scomparsa – . È così, Madame: votre ami è mancato quindici anni fa. – Somigli a tuo padre e a tua madre in ugual misura: è banale che io lo rilevi e piuttosto raro che si verifichi in tanta esatta proporzione. Ti sto facendo un gran complimento, ma non sto civettando con te, caro. Erano talmente belli i tuoi genitori nel ’54! – .Beati Fifties, gli anni beati della giacca sulle spalle e delle scarpe da uomo bicolori, del cambio al volante, del gomito fuori dal finestrino e delle gomme bianche per auto, gli anni sereni dei primi pic nic con la valigia-tavolo, della prima televisione, ma soprattutto della Dolce Vita, scuola di cinema e di vita, prima di andare a scuola. Questa sera, basterà guardare in tv “Racconti d’estate” del ‘58 con un trascinante Alberto Sordi, capace di esprimere “tutto” anche con il semplice roteare degli occhi e con l’indimenticabile, ingenerosamente, scioccamente dimenticato Franco Fabrizi, eterno vitellone, per riassaporare l’estate felice dei miei genitori, splendidi all’american bar dell’Excelsior, verso Paraggi. Beati i miei Sixties, i miei anni beati sulla Costa, tra Rapallo e Paraggi, Santa Margherita e Portofino, a svezzarmi al Covo, quando suonava Marino Barreto jr. e ci s’inventava una rotonda sul mare e il nostro disco che suona, a educarmi con Churchill, a perfezionare la conversazione con Rex Harrison, Soraya, Richard Burton e Liz Taylor e Robert Taylor, Liz sposata con il primo e senza alcuna parentela col secondo, a nuotare con Pound ai Bagni Tigullio, a innamorarmi di Stefania V* e di Luisa C*, ad ascoltare lo zio architetto parlarmi dell'Ubermensh lungo il sentiero per il Castello di San Giorgio, i miei anni interessanti di ragazzino accompagnato da Simone de Beauvoir a vedere il film “La guerra dei bottoni”, di ragazzino in gita al maggio parigino e nella Parigi di Serge Gainsbourg e Jane Birkin e di Sartre e del Castoro al Deux Magots, che resterà la mia Parigi per sempre.– Prendiamo qualche tazza di tè, Sevastian? Da tanto tempo non scaldo più il samovar. Ho qualche segreto da rivelarti prima di partire – . Come una cerimonia degli addii.
LA CERIMONIA DEGLI ADDII Nella notte, sempre più in profondità. Parigi, 31 ottobre 1925. Esterno, giorno. Una mattina luminosa, naturalmente filtrata: perfetta per le riprese in esterni, se si facessero già shoooting open air. I pittori respirano colori a pieni polmoni. I pescatori del Lungosenna sono disposti a ributtare nel fiume i pesci pescati, chissà che uno di questi non sia il magico pesciolino d’oro. Gli americani che vivono a Parigi sono certi di non poter vivere altrove. Mancano ancora quattro anni alla Grande Depressione e al rientro forzato negli States. Max Linder si è alzato dal letto con l’America in testa. Oggi, è l’unico parigino che se ne vorrebbe andare. Parigi, 31 ottobre 1925. Esterno, giorno. Le tate spingono pigramente carrozzine dalle grandi ruote al Jardin de Luxmbourg. In una di queste carrozzine, la piccola
Maud Linder pigola. Parigi, ottobre. Interno, giorno. La signora Linder sta effettuando un acquisto in un negozio del Foubourg St. Honorè. Il marito le ha chiesto di comprare una vestaglia per sé e una veste da camera per lui. Ninette si sente spesso una moglie inadeguata. Negli ultimi tempi, teme che a Max non piaccia più far l'amore lei.Le due vestaglie scarlatte serviranno a riaccendere il fuoco del piacere? Parigi, 31 ottobre. Esterno, giorno. – Cos’è, cos’è questo limpidume? Che mi rende tutto troppo chiaro, chiaro e insostenibile, chiaro e insopportabile? Perché l’aria ottobrina mi brucia i polmoni come un gas nemico? Perché non sono rimasto là dove sono nato, a imbottigliare vino rosso? Perché non sono rimasto a Bordeaux e non sono diventato un anonimo contabile? Perché non sono restato in California, a pavoneggiarmi e a ubriacarmi dopo le 5 pm? Perché non ho sposato una donna che non avrei mai amato? E perché, perché non è scoppiata un’altra guerra che spazza i tavoli? Perché non è il dopoguerra, quando puoi ricominciare tutto da capo? – . Nadja ascolta. È troppo giovane per capire, ma non per ricordare. – Ti ho conosciuta che avevi la stessa età di Ninette e dovevi essere tu Ninette. Non so niente di te e, ormai, non serve a niente sapere o ignorare – . Nadja ascolta l’attore, che, recitando, le sta esprimendo la sua verità. È troppo giovane per deviare il corso degli eventi. Ma non per avere la sua strada segnata. È il suo momento di massima intimità con l’uomo: il primo e l’unico. L’ultimo. Max Linder ha deciso. Parigi, interno, giorno. La signora Linder è rincasata. Dov’è sua figlia Maud? È ancora in giro con la tata. Allora come mai la mamma si preoccupa tanto? Come mai vorrebbe vederla, prenderla subito in braccio? Come mai Max non c’è? Parigi, 31 ottobre 1925. Max ha mai baciato Nadja? Passeggiando da solo per la città, saluta con benevolenza composta che lo riconosce e gli esprime la sua composta simpatia. Passeggiando da solo, incontra casualmente sua figlia Maud in carrozzina. La bacia per l’ultima volta? Dà una manciata di franchi e un incarico alla tata. Continua la sua passeggiata solitaria. Parigi, sera. L’ultima notte dei Linder.
LA CENA DELLE CENERI Avesse già preso o meno la sua terribile, irrevocabile decisione, Max Linder rientrò a sera nel suo appartamento parigino e chiese di mettersi subito in libertà. La giovane moglie Ninette, nata Peters, lo accolse drappeggiata in una vestaglia vermiglia. Max indossò la sua, approvando l’acquisto. Si specchiò a lungo, accennò a simulare la sua celebre “gag dello specchio”, ma, dallo specchio, ricevette un’immagine leggermente e significativamente diversa dalla sua. La geniale satira autoreferenziale della riproduzione sottilmente autocritica della propria gestualità non funzionava più: l’attore dello specchio lavorava separato dall’ormai ex attore davanti allo specchio, che, esausto, non reggeva più il ritmo. Rispetto al suo doppio, Max era fuori sincrono. – Hai capito, vero, Ninette, perché ho voluto che indossassimo entrambi indumenti di questo colore? – .Prima di rientrare, Linder aveva visitato la sua sala cinematografica: nel cinema deserto, a schermo spento, aveva sentito il battito di 500 cuori rivelatori, come li avrebbe chiamati Poe; cinquecento, uno per ogni pellicola impressionata, uno per ogni film interpretato, uno per ogni film realizzato. Il ritmo, il tono cardiaco s’era affievolito fino al silenzio. Così il cinema aveva smesso di circolare nelle vene di Max Linder.
– Hai capito, Ninette? – Lei non capiva, non voleva capire. Provò a fraintendere. Cercò di sedurre il marito. Che ne fu commosso fino allo strazio. Dalla relazione dell’ anatomo patologo, non risulteranno tracce di cibo o di altre sostanze nei corpi di Max e Ninette Linder.
DUE VESTAGLIE VERMIGLIE Il colore per attenuare l’orrore: rossa, scarlatta, vermiglia è la stoffa che s’inzupperà di sangue. Due vestaglie come vele rosse sul mare bianco di un letto matrimoniale divenuto immenso per la distanza tra gli sposi. – Cerchiamo di morire con la dignità, con la serenità degli antichi romani, Ninette. – – Dobbiamo proprio morire, Max? – – Se mi ami, non c’è altro modo di conservare il nostro amore – . E aprì le vene alla giovane moglie. Ma non le aprì il suo cuore. – Non aver paura, Ninette, sentirai solo un po’ di freddo e nessun dolore – – Con te, Max, io non ho paura – – Ti seguirò, non temere: non ho altro luogo dove andare – – E la nostra Maud? – – Vivrà. Non le mancheremo. È piccola. Non ci riconosce ancora – . Come Max aveva previsto, l’effetto dell’emorragia fu attenuato dalla tinta della veste da camera che copriva il corpicino di Ninette, avvizzito dall’imminenza della fine. La sua mente già divagava nello stupore della perdita progressiva di energia vitale. E Max si aprì le vene, mescolando il suo sangue a quello della giovane moglie. Ma Ninette non se ne accorse. E non si rese conto della comparsa di una figura diafana: o la prese per un angelo.
L’ANGELO DELLA MORTE
“Non hai né gioventù, né vecchiaia, ma solo una siesta pomeridiana che sogna d’entrambe: invecchia la tua giovinezza e quando sei vecchia e ricca non hai più calore, passione, agilità o bellezza per render piacevole la tua ricchezza. Che merita dunque il nome di vita? In questa vita si nascondono più di mille morti…”
Shakespeare, Misura per Misura, atto terzo
Come ha fatto a trovare la casa dei Linder? Chi le ha dato l’indirizzo? Chi l’ha lasciata entrare? Ora è al cospetto dei moribondi. – Anja! – .Così, con un grido, Max riconosce in Nadja il suo primo amore. Nadja potrebbe salvarlo? Potrebbe salvarli entrambi? Sarà invece per loro l’Angelo della Morte.
CAPITOLO NONO A Venezia, tutto è attuale: tutto è, nello stesso tempo, antico e contemporaneo. Placidi elefanti marini, i traghetti per la Grecia che solcano il bacino di San Marco sfilando a rimorchio tra la Giudecca e la skyline della Prima Manhattan incrociano le galere della Serenissima che imbarcano per il conforto sessuale dei marinai un giovinetto, detto Fantolin de Culo. Tutto è già accaduto a Venezia. E continua ad accadere. Come un film che non smettiamo di guardare e rivedere. -Ho portato qui a Venezia la mia collezione di ricordi come la cara Peggy portò a Palazzo Venier dei Leoni la sua collezione di quadri. Lei i veneziani la chiamavano con un certo malanimo la Dogaressa. Io sono sempre stata semplicemente la Vecchia Pazza -. La casa di Nadja Grigorovich è un guscio vuoto. La sola finestra murata che non è occupata da un ritratto di Max Linder è tappezzata di strisce di pellicola. A strati, lì incollati ci sono i suoi film perduti, quasi tutti: quasi quattrocento film della stella collassata del cinema muto, un buco nero. -Sono stata io, la vecchia pazza, a fare questo stupido lavoro. Ogni metro di pellicola che guardavo in controluce e mi stampavo nella memoria l’ho poi incollato in questa nicchia -. Ora una carezza ad ala di farfalla di Madame Grigorovich sfiora la parete e il tabernacolo va in briciole e finisce in polvere. -Non ho mai avuto bisogno di denaro. Max me ne lasciò a sufficienza: un conto ben amministrato in una banca svizzera. Non ho mai avuto bisogno di una vita, ma solo di guardare film in controluce. Il mondo mi passava accanto e il tempo non passava mai, Sevastian. Portami fuori: portami all’Harry’s bar-. Venezia è il più grande ippodromo per il gran premio della bellezza femminile: sfilano al tondino di campi e campielli ragazzine dalle unghie dei piedi pittate con cura pittorica, sfilano lunghe gambe dall’abbronzatura vellutata, sfilano donne con le gonne più corte che sguardo maschile possa desiderare. La luce veneziana esalta la splendida leggerezza di chiome bionde, brune, rosse, tinte, ricce o a coda di cavallo al vento. La scenografia fa sgranare gli occhi, rendendoli più grandi e più profondi. E le veneziane crescono abituate a sfilare. Il culmine della gara gentile si raggiunge d’estate, in pieno sole. -Purtroppo, mentre Max moriva, mi sono innamorata di lui -. Intanto, percorrendo calle Vallaresso, avviene una straordinaria metamorfosi: la vecchissima Madame Grigorovich ridiventa la giovanissima Nadja. Per quanti scatti si potessero sprecare, non la si potrebbe mai fissare su carta fotografica o catturare in digitale. Lo stesso accade con Venezia. Invano la bersagliano, invano la mitragliano a migliaia i turisti con le loro macchinette, invano la bombardano con la videocamera: della città, resteranno loro solo confuse impressioni e l’equivoco dello stupore annunciato. -Quando mi sono chinata su di lui, per versargli all’orecchio il mio amore, Max moriva e Ninette, credo, era già morta. Monsieur Linder mosse le labbra e mormorò il suo volere, le sue ultime volontà, mi dette istruzioni e mi fece raccomandazioni, respirò l’estremo sospiro della sua leggenda poi spirò -. Varchiamo la soglia dell’Harry’s bar in calle Vallaresso e troviamo la solita compagnia di giro che dà senso a locali come questo, o come l’Oak room del Plaza a Central park, prima che chiudesse per trasformarsi in un tempio dei bei ricordi, gente stagionata che sa a memoria le battute e conosce le risposte senza formulare mai domande; ad un tavolo d’angolo siede un quartetto, composto da Ernest, Adriana, il
Colonnello e Renata. -Rimasi qualche minuto a vegliare quella coppia di fiori di sangue e me ne andai -. A Venezia, tutto è attuale e contemporaneo. Papa fa segno a Nadja di avvicinarsi.
AIUTO! “Aiuto!”. Sceneggiatura di Max Linder, con la collaborazione di Abel Gance, il regista del film. L’anno: il 1923. Il risultato: un capolavoro. Effetti speciali: lo schermo stesso si deforma, si allarga, si restringe, per una storia di trucchi e scommesse. La storia stessa del cinema. Protagonista: Max, nel ruolo di Max. Che, per un minuto, perde una scommessa già vinta: la scommessa stessa del cinema. La perde a causa della moglie: la perde in un minuto. Proprio mentre stava stravincendo. La storia stessa di Linder. Avrebbe dovuto resistere agli orrori di un castello di falsi orrori fino allo scoccare della mezzanotte. Raffinatissima finzione: il trucco spettacolare di un conte intraprendente per far quadrare i conti. Travestito da mostro, il conte stesso finge di insidiare la moglie del protagonista, lasciata sola in camera da letto da Max, che ha fatto un salto al club. Max riceve la sua richiesta di aiuto e, un minuto prima della mezzanotte, chiede a sua volta aiuto, premendo il fatidico pulsante di soccorso del castello al centro della scommessa. Quando accorre al capezzale della moglie, Max scopre il trucco e paga la posta. Con il ricavato, il conte paga la troupe che ha inscenato gli orrori. La storia stessa del cinema. Max Linder e la moglie sono morti di cinema.
I TRUCCHI E L’ANIMA Max Linder aveva un piccolo spazio tra i denti davanti, proprio in mezzo al sorriso. In “Aiuto!”, il film scritto e interpretato nel 1923, scopre spesso i denti. Al club, ha fatto una scommessa: resistere fino a mezzanotte in un castello dove appaiono scheletri giganti e scheletri nani, coccodrilli sul tappeto, serpenti nei cassetti. Un castello dove il butler, il maggiordomo, perde un braccio, poi la testa. E si mette la testa sotto il braccio superstite. Un castello dove, se ti accendi una sigaretta, spunta una pistola dalla parete e spara e la sigaretta ti rimane spenta tra le labbra. Stretta tra i denti, un po’ distanziati al centro. Un castello dove ci sono tigri dietro alla porta. Breton e Dalì, prima di Breton e di Dalì. Se suona il campanello e chiede aiuto prima della mezzanotte, Max perde la scommessa. La moglie lo aspetta a casa. È sola. Compare un mostro violentatore. La moglie chiama il marito: aiuto! Max risponde al telefono dal castello e si dispera. E, dal piccolo spazio tra i denti davanti, gli sfugge l’anima.
ARABIAN DEATH Nata il 29 luglio 1885 a Cincinnati, Ohio, Thedosia Burr Goodman diventa Theda Bara, la star: la dark lady di Hollywood. Il nome d’arte che le viene imposto non suona sinistro solo in italiano: è l’anagramma di Arabian Death, la Morte Araba. La fanno passare per principessa d’Arabia. Lei, confidenzialmente, preferisce farsi chiamare Theo. Debutta in teatro, a New York City, nel 1911, a ventisei anni, in uno spettacolo dal titolo significativo: “The Devil”. Passa al cinema. Diventa subito una diva nel ruolo del Vampiro: il film è “A Fool there Was”. Si ritira dalle scene e dallo schermo nel 1926, un anno dopo la morte di Max Linder, avvenuta a Parigi il 31 ottobre: il giorno di Halloween. Vive nascosta fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 1955, trent’anni dopo quella di Max. Perché si nasconde? E azzannando quali gole sopravvive la
Dracula di Hollywood? Il suo ultimo film s’intitolava “Madame Mystery”.
L’UOMO PIÙ BELLO D’EUROPA Feliks, marito di Irina Alexandrovna, nipote dello zar, definito l’Uomo Più Bello d’Europa, somigliava a mio padre, il principe Getulio Valentin. Nelle loro vene, scorreva infatti lo stesso sangue: sangue tataro. Feliks era il secondogenito della principessa Zinaide (Zinaide Nicolaivena , principessa Yussupov, con un dono naturale per la danza e la recitazione, talento apprezzato anche da Stanislavskij) e del conte Elston-Sumarokoff, discendente del celebre commediografo russo Sumarokoff. Per ukase imperiale, per decreto , cioè, dell’imperatore, sposando Zinaide, a sua volta bellissima, il conte Boris assunse anche il titolo di principe e il cognome degli Yussupov, derivante dal capostipite, il Khan Yussuf. Erede dell’Orda Nogalskaia, trattata da Ivan il Terribile, che chiamava Yussuf “amico mio, fratello mio”, come un reame. Tra guerre e alleanze con la non meno ammirata figlia di Yussuf, Soumbeca, regina del Kazan, di leggendaria bellezza, i rapporti con l’impero si normalizzarono con la conversione di Abdoul Mirza, che prese il nome di Dimitri, alla fede ortodossa e con l’attribuzione del titolo di principe Yussupov da parte dello zar Feodor. Il principe Gregory, figlio di Dimitri, fu consigliere di Pietro il Grande e il principe Nicholas Borissovich fu spesso ospite di Caterina di Russia al Palazzo d’Inverno. Nel 1756, l’imperatrice Elisabetta decretò l’apertura della prima sala teatrale pubblica a San Pietroburgo su suggerimento del principe Boris, che aveva una sua compagnia teatrale, trisnonno di Feliks. Nato il 24 marzo 1887, di fede ortodossa, Feliks, che porta il nome del nonno, Felix Nicolaievitch Elston, figlio, si dice, di Federico IV, re di Prussia, visitò l’Italia in compagnia del professore di belle arti Adrian Prakhov, da lui soprannominato Don Adriano. Da ragazzo, indossava talvolta abiti e gioielli della madre; gli accadde, così mascherato, di affascinare anche re Edoardo VII d’Inghilterra. S’innamorò di Irina, figlia unica di Ksenia e Alexander Romanov e la sposò. Feliks è noto per aver ucciso nel suo palazzo, la Moika, sull’omonimo canale di San Pietroburgo (la “Venezia del Nord”), il monaco Rasputin in un’allucinante notte di dicembre del 1916: attirato in una stanza sotterranea, Rasputin fu avvelenato dai congiurati, resistette al veleno, fu ripetutamente colpito a revolverate, sopravvisse, venne gettato in un altro canale ghiacciato e spirò. I veri motivi del complotto ai danni del discutibile “santone” mugiko rimangono avvolti nel mistero. Già studente ad Oxford e a Berlino, dopo la presa di potere dei bolscevichi, Feliks trascorse con la moglie il resto della vita a Parigi. Nel 1925, la polizia bolscevica scoprì a palazzo Yussupov, in una stanza segreta, lo scheletro di un uomo: forse, quello di un giovane rivoluzionario amato dalla bisnonna del principe Feliks. Nello stesso anno, a Parigi, Feliks incontrò Max Linder. Gli parlò della saga della sua stirpe e del caso Rasputin. Fu progettato un film: Linder avrebbe (molto credibilmente) interpretato la parte del principe Feliks Yussupov Elston-Sumarokoff, dando una significativa svolta alla sua carriera di attore comico-brillante. Successivamente, il principe vendette le sue memorie alla Metro Goldwyn Mayer, che ne trasse un film, “Rasputin e l’Imperatrice”. Questo gli permise di vivere decorosamente dopo la vendita dei suoi ultimi due Rembrandt.
MAX LINDER: ULTIMI SEGRETI Max Linder, vittima di un ricatto, uccise la moglie e si tolse la vita. Qualche giorno prima, nella sua sala cinematografica, gli era stato proiettato un breve film pornografico, dove Max e Theo figuravano alle prese con lo stupro e la soppressione di una minorenne. Max ricordava di aver interpretato quel cortometraggio a
Hollywood: Theo era Theda Bara, che aveva partecipato alla violenza, autentica come in uno snuff movie d’antan (si chiama snuff movie il filmato-verità di torture e morti violente) o (ed è la versione più attendibile) simulata, in travestimento maschile. Ricordava altrettanto bene di aver accuratamente occultato la pellicola nel suo archivio segreto domestico. Chi glielo aveva sottratto? Pare che Linder non abbia mai sospettato della responsabile del furto: la giovane Nadja. La figlia di Anja agiva per conto di emissari bolscevichi in Francia. Scopo del ricatto: assicurarsi che lo sceneggiatore-attore-regista-produttore non realizzasse mai il progettato film sulla fine di Rasputin, dove avrebbe narrato le vere ragioni di Feliks, connesse, pare, al fallito tentativo del suo gruppo di orientare a favore di una riforma menscevica, vale a dire socialdemocratica, della politica russa la lobby ebraica, alla quale, con l’approvazione dello zar, sarebbe stato destinato il governo di un vasto territorio dell’impero, combinazione di stato sionista e Nuova Terra Promessa. A tale programma si opponeva, appunto, Rasputin, introdotto a corte dalla granduchessa Militza e dalla granduchessa Anastasia Nicolaievna, rumene, soprannominate significativamente “il pericolo nero”, ma compromesso con i rivoluzionari del conte Uljanov: Lenin. Nel film mai realizzato, forse Feliks avrebbe rivelato anche la ragnatela di trame e ricatti che lo portarono all’irrevocabile decisione di eliminare il Monaco, di cui era stato, per un certo periodo, seguace. Sembra che il crollo di Max e la sua decisione di farla finita, traghettando nell’aldilà la sua vita al culmine del successo, più che al timore dello scandalo pubblico, furono dovuti alla ferma volontà di preservare intatta l’integrità emotiva della giovane moglie Ninette. Compiuta la sua missione, Nadja, da qualche tempo fattasi assumere come cameriera in casa Linder, avendo assistito, sconvolta, al doppio suicidio ed essendo entrata in crisi, approfittò della giovane età per sganciarsi dalla macchina spionistica sovietica e tornò in possesso dell’osceno filmato con Theda Bara. Quelle strisce di pellicola sono rimaste per anni incollate ad un vano della finestra della sua residenza veneziana. Pochi metri, sotto quelli dei film “perduti” di Linder, ereditati dalla Vecchia Pazza: pochi metri dell’unico film che sarebbe stato meglio perdere davvero e non si sarebbe più dovuto ritrovare. Nella sua autobiografia, venduta a Hollywood, Feliks Yussupov non fece alcun cenno alle dinamiche segrete della congiura per eliminare Rasputin e alle successive, impreviste, convulse conseguenze. L’amore per la sua terra d’origine indusse il principe ad inviare in Urss ingenti aiuti materiali, senza darne pubblicità, durante il drammatico assedio di Leningrado nella seconda guerra mondiale. Amore e Morte: si sa che tutto nasce da questa coppia cosmica. La piccola Nadja ha scontato con una vita in ombra la scommessa perduta per una manciata di minuti di un amore impossibile e la sconsiderata partecipazione ad una messa in scena di morte. La misteriosa “Theo”, principessa di morte, ha scontato con una vita celata nell’ombra gli eccessi di un’ingenua disinvoltura e la messa in scena sessuale con un regista-attore francese. Max si è tuffato nell’ombra, portando con sé Ninette, per non sporcare lo schermo della sua esistenza con fotogrammi di un esperimento erotico fatto per esplorare l’angolo più segreto della creazione cinematografica. Prima che a me, Madame Grigorovich aveva accennato al segreto di Max Linder ad Hemingway, lo scrittore incontrato a Parigi e rivisto a Venezia, rievocato in mia presenza all’Harry’s bar. Ma Hemingway, dopo essersi appassionato ai ricordi di Nadja, non li trascrisse, come avrebbe voluto, sui suoi taccuini: era a sua volta preso dal vortice di una passione insidiosa: quella per la giovane contessina Ivancich, Adriana, la veneziana ritratta come Renata nel discusso, coraggiosissimo, affascinante e danneggiato romanzo “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Morte portò a Ernest l’amore per Adriana, morte portò
ad Adriana l’amore di Ernest per lei: la contessa Ivancich finì suicida, dopo il matrimonio con un italiano e la sfortunata pubblicazione di un romanzo autobiografico. Con i suoi scheletri giganti e nani nell’armadio, anche Madame Grigorovich ha deciso di andarsene. Senza dirmi dove e come: lontano da Venezia, lontano da tutto e da tutti, in viaggio. La stagione moriva, per lei, assai dolcemente: da calle Vallaresso, accompagnai Madame Grigorovich alla stazione. Partì per non tornare. In gondola, mi feci traghettare lungo il Canal Grande fino a San Michele, l’isola delle sepolture veneziane, come se risalissi il fiume del tempo. Andai sulla tomba di Diaghilev, il grande impresario dei Ballet Russes, a cui, invece dei fiori, giovani danzatori continuano a portare le loro scarpette: andai da Diaghilev a raccomandargli di accogliere una connazionale giramondo, Madame Grigorovich, che, da qualche parte dell’universo, di lì a poco l’avrebbe raggiunto. A San Michele non è poi così difficile credere che esista una Venezia eterna, dove nulla si perde e tutti si ritrovano. “Falli incontrare” dissi ancora a Diaghilev: “Nadja, Anja, Max, Ninette, la ragazzina della vendemmia…”. Tornando a San Marco, scorsi il Lido all’orizzonte: si preparava un’altra edizione del festival di arte cinematografica. Sbarcato dalla gondola, in nome del cinema, in nome del suo campione, più fragile di Chaplin, passato indenne per non meno imbarazzanti esperienze con minorenni, andai ad alzare un calice di Valpolicella per Linder: un’“ombra” per Max, la cui ombra è degna di figurare a grandezza naturale accanto a quella di Charlot sul grande schermo della storia dello spettacolo. E la cui arte cinematografico è, oggi, per lo spettacolo che cambia, ancora più attuale. E altrettanto indispensabile. Credevo che la storia di Max finisse così: sbagliavo. Si sarebbe davvero conclusa solo un attimo dopo la fine.
CAPITOLO DECIMO A Venezia, rincasando, pensai alle parole di congedo che mi aveva rivolto alla stazione ferroviaria Madame Grigorovich, prima di partire per ignota destinazione: l’Ignoto, appunto. Alludevano alla morte e alla “viva voce”. E al suono e al colore di tale voce. Ebbi un’intuizione. Se si riferiva a Linder, suono e colore era quanto mancava al suo cinema, muto e in bianco e nero. Quanto mancava a decifrare il grande enigma della sua personalità. Tornai dunque a casa di Nadja. La porta era aperta. Mi parve un’ulteriore conferma: la mia straordinaria testimone non sarebbe tornata e m’invitava a rivedere quel si era lasciata definitivamente alle spalle. Fossi o meno suggestionato dal commiato, gli arredi mi parvero consapevoli che la vecchia abitante della palazzina non li avrebbe più sfiorati. In un primo momento, non notai alcunchè potesse avere la sia pur minima relazione con il “caso” Linder. Eppure non desistetti. Risentivo la voce flebile dell’amica dei miei genitori scomparsi mormorare “viva voce”, che pareva offrirmi uno spiraglio eccezionale sul passato. Quando m’imbattei nel pappagallo, capii che avevo trovato quel di cui non sapevo di essere in cerca. Il variopinto volatile se ne stava impettito, impagliato, sopra una mensola. Qualcuno ha detto che “la voce del pappagallo è la voce dell’inconscio”. Ma l’ancora vivacemente colorato pennuto non poteva più parlare, ammesso che l’avesse saputo fare da vivo. A meno che… Mi concentrai, osservando minuziosamente ogni angolo della stanza in penombra. Trovai così una scatola magica e la chiave definitiva dell’enigma di Max Linder. Geloso! Uno strumento tecnologico, un reperto di modernariato, una “stregoneria”, un frullatore di sogni e illusioni: come il cinema. Infilai la spina nella presa: il registratore a nastro di bachelite color crema, listato di rosso, funzionava. Il primo suono che ascoltai fu la voce di Nadja che parlava il francese melodioso dei russi ben educati, curiosamente inframmezzato di espressioni yiddish. Fu come presenziare alla lettura di un testamento: la verità era l’ultima volontà di Madame Grigorovich, chiunque fosse e comunque si chiamasse davvero. Dopo il suo racconto, una breve pausa. Quindi, la voce gracchiante di un pappagallo longevo recitò un paio di volte una formula: la decifrazione dell’enigma di Max Linder. Geloso!
MAX E NINETTE: L’ENIGMA SVELATO Alessandro Magno portò dei pappagalli dalle sue spedizioni in Oriente. L’imperatore Nerone ne ebbe una voliera, ma li fece sterminare perché ripetevano ossessivamente, secondo quanto riferisce Seneca, i versi meno riusciti dei suoi componimenti poetici. Nel sedicesimo e nel diciassettesimo secolo, l’importazione dei pappagalli dall’Australia e dal Sud America divenne abituale. Max Linder ricevette in dono una corella (un tipo di cacatua australiano) a Hollywood e lo chiamò Max. Max portò Max con sé in Europa. Max era presente quando Max disse a Ninette che l’avrebbe uccisa e che sarebbe morto con lei. I pappagalli sono longevi. Per molti anni, Max continuò a ripetere le parole di Max. Quando ho ascoltato la confessione di Max Linder, “doppiata” dal pappagallo a cui aveva dato il suo stesso nome, ho colto subito l’alta valenza simbolica della scoperta: il cinematografo stesso, muto e fotografico nel suo bianco e nero, parlava della pulsione autodistruttiva da sdoppiamento della personalità e del sogno di rinascita attraverso la pittoricità del colore. Il dualismo di Max è il dualismo del cinema. Linder ama Ninette e non può superare
quell’amore, il cinema è immagine e teme la parola, Max ama la moglie e teme l’impetuosità seduttiva che fa di lui un attore, il cinema espande la sua capacità di ripresa, visiva e fonica, implodendo tra effetti speciali mentre perde di specificità e di stupefacente spettacolarità (è la tv a monitorare la realtà, sono milioni e milioni le telecamere puntate sulla vita; quale action movie, derivante dalla locomotiva di Lumière, può competere con la diretta da Dallas, con lo sbarco sulla Luna, con il crollo delle Torri in diretta?). Sarà per nostalgia veterocinematografica, fondamentalismo paleofilmico, fanatismo melièsiano che qualcuno si ostina a sostenere che la missione Apollo è solo la più impegnativa e la più riuscita delle megaproduzioni di fantascienza? L’attore è un seduttore, ma non per questo ogni seduttore è attore: la carica seduttiva dell’attore è narcisistica. Max creò la gag dello specchio, apoteosi del lago di Narciso (l’Es) dove annega per gelosia di se stesso. Sono due i gradi di analisi che portano a tale conclusione.
L’IMMAGINE RIFLESSA, LA DONNA, L’ERMAFRODITO “Io guardo te, Ninette e vedo me stesso. Tu sono io, tu sei gelosa di me, tu mi uccidi, io sono geloso di me”. Feliks, principe (comunque) felice nei drammi della vita e nella tragedia della Storia, impersonando la propria parte femminile trovò in Irina l’alter ego del suo Narciso e, sopprimendo Rasputin, sublimò la sua conflittualità distruttiva. Impersonando Feliks, probabilmente Max Linder si sarebbe salvato con un transfert. Ma, aldilà dell’ipotesi ucronica, delle variazioni sul se (se avesse girato un film in più, se non fosse stato intossicato dai gas e dal successo, se non avesse incontrato Anja e Nadja) e sul sé, il gesto di morte di Max è un suicidio molto sofisticato: il ritorno del rimosso del cinema, bambino polimorfo, il rimorso dell’uomo che ha ceduto all’attore e dell’attore che ha ceduto all’amore. Linder, come lo abbiamo visto riflesso nello specchio d’argento della memoria di Madame Grigorovitch, compie con il doppio delitto, soppressione della moglie e di se stesso, un atto mancato. Linder, sciamanticamente evocato dalla registrazione della voce del suo pappagallo (la voce dell’inconscio, come si diceva), rivela il fraintendimento del sogno. Feliks, mesmerizzato , come testimoniò il principe stesso, da Rasputin, compie dall’ipnosi subita al complotto contro l’ipnotista, l’intero percorso terapeutico di rimozione dell’Incubo. Max si scontra con il Sogno: è un attore e pretende d’interpretarlo (di inscenarlo e di decifrarlo). “ Che ce ne facciamo di un sogno nella vita di tutti i giorni? Mi permettete di offrire qualche suggerimento pratico?”. Permettiamo e invochiamo suggerimenti dal grande James Hillman, l’esploratore dei segreti del profondo che viaggia lungo la rotta di Freud, Cristoforo Colombo dell’anima, non cercando le Indie e sapendo che troverà quel che non sapeva di cercare e che quel che troverà è l’America. “Prima di tutto, non cercate di sfuggirlo. Lasciate che vi stia attorno, che vi confonda, vi affligga, che infesti di immagini i vostri sentimenti. Viveteci con quel cane giallo, con quella serpe. Non perdete mai d’occhio l’erba”. L’adieu dei Linder è l’addio dello champagne, il taste dell’ultimo sorso, che, ormai lo sapete, è definito proprio così, l’adieu, dai viticultori (come il padre di Max). Ho colto un filo d’erba brinato L’autunno è morto, te l’ho ricordato
Non ci vedremo più sulla terra Odor dei tempi filo d’erba E tu ricordati che io ti aspetto.Preso in prestito da una poesia di Guillaume Apollinaire, questo è l’adieu di Ninette. A tale proposito, aggiunge Hillman: “resistete al bisogno di sapere; dominate il vostro impulso alla conoscenza, l’urgenza apollinea di leggere il sogno per trarne un chiarimento, una profezia”. E questo vale tanto per Ninette quanto per Max.
CANE GIALLO SERPE SULL’ERBA DELL’EDEN È giunto il momento di ascoltare la registrazione del pappagallo impagliato dal nastro del registratore marca Geloso rinvenuto in una vecchia casa di Venezia: “ Et ce serait bon d’avoir son enfant de nouveau, et ce serait doux, cette main dans le main de la femme qui dit o Max, mon cher mari, c’est donc vous! “. Ripetuto a pappagallo, l’addio di Max è la sua estrema, profonda confessione: “E sarebbe bello aversi bimbo di nuovo, e sarebbe dolce, mano nella mano della moglie che dice Max, caro marito, dunque sei tu “. In una proiezione d’innocenza, in uno sdoppiamento dolcemente regressivo, in un impulso di composizione tra il proprio Io adulto e l’estrema gioventù di Ninette, Max si specchia nella moglie-madre (e Maud, la figlia neonata, s’adombra come sogno di rinascita) ritrovandosi: dunque sei tu.
CHI È DI SCENA? “Come un autore, permettete ai personaggi del vostro teatro notturno di esprimersi” dice James Hillman. Ora che, oracolare, il pappagallo ha parlato e la misteriosa Nadja che lo tenne a lungo con sé è scomparsa e i segreti sono stati rivelati, senza per questo dover essere spiegati (“lasciatevi travolgere dal sogno; ecco la parola chiave, partecipazione anziché interpretazione”, ancora Hillman), permettiamo ai personaggi di questo teatro notturno di esprimersi. Sarà la drammaturgia a dare la parola a Max Linder, per il suo primo e unico “film parlato”, in scena tra vita e sogno (la vita è sogno è un’affermazione teatrale, non uno slogan telemarzulliano), insieme al suo Doppio Feliks, insieme ad Anja la cechoviana e Nadja la bretoniana, insieme a Theda la Tetra, insieme alle gag mute, insieme al Circo dei Mostri degli Spaventi. Max capovolse la sfortuna dello specchio infranto imitando se stesso allo specchio: imitando Linder, riattraversiamo lo specchio di Alice del cinema delle meraviglie illustrate (mute) alla ricerca delle sue parole perdute. Max Linder e tutti gli eroi del silent movie parlavano, infatti, mentre davano vita ai loro film, raccontandone una parte segreta, che integra le didascalie e le sonate di accompagnamento al pianoforte. Questa parte segreta è il loro segreto: la formula magica per passare dal cinema narcisisico al nuovo filmato multimediale emozionale (emozionante). Seguitemi dunque sul palcoscenico dove sta per andare in scena “Un Suicidio Molto Sofisticato”, vita e vicende immaginarie di Max Linder, il gagà della risata con il cilindro di seta, a partire dalla fine. Le istruzioni per l’uso contengono l’ultimo avvertimento di James Hillman: “Considerate che il sogno è un intero e che ogni sua parte va ricondotta al resto. Il vecchio albero, sradicato davanti alla casa di quando eravate bambini, la diva del cinema che vi dice qualcosa che al risveglio non riuscite a ricordare, la sensazione che vostra madre morta o una donna che le somiglia vi stesse accanto a bordo di una
piccola imbarcazione… tutti questi frammenti stanno insieme perché il sogno li ha uniti in un mosaico, un collage e, alla presenza di uno, si accompagna quello di tutti gli altri. Accoglietelo come un ospite, apritegli la porta di casa, dategli il benvenuto. Insegnate ai vostri figli ad essere felici di aver sognato, fatevi raccontare i loro sogni a colazione, lasciando che i fantasmi della notte dividano con voi la tazza di caffè, il buon succo d’arancia. E ricordate che c’è la mancanza d’immaginazione dietro ai peggiori crimini del nostro tempo”. Si apra il sipario.
DOPO I TITOLI DI CODA...
EFFETTO DOMINO Il cinema muta. La televisione muta. Ma la tv non è mai stata muta. La televisione nasce dalla radio: è sempre stata una scatola parlante. Deriva dal teatro. Il cinema, invece, è l’evoluzione della pittura e della fotografia. Comunque, il cinema muto ha sempre parlato: è tempo di ascoltarlo. Gli attori dei silent movies non erano mimi, eunuchi dello spettacolo, ma interpreti eloquenti che dialogavano con fitta iperespressività, lasciando al pubblico, volontariamente, spontaneamente interattivo, aiutato dalle didascalie, il compito di sentire e di ascoltare e di capire le loro parole. Dunque, l’attuale evoluzione/rivoluzione post cinematografica, o, se si preferisce, della generazione cineinternettiana della comunicazione portatile e dell’immaginazione diffusa in total blog, in global blob, è una riappropriazione multilinguistica, oltre che multimediale, dei vertici del muto: vedi Linder. Segnali in tal senso si colgono in prodotti per le sale di raffinato sperimentalismo e, insieme, destinati a largo target, come “Domino”, il film di Tony Scott, basato, nello stesso tempo, “on a true story” e sull’invenzione più sfrenata (più dell’ormai banale fantasy di maghetti e maddalene “zero in condotta”). Protagonista, Keira Knightley, attuale medaglia di bronzo del mio personale palmarès alle Olimpiadi del cinema, dietro alle medaglie d’argento ex aequo Nathalie Portman e Hilary Swank e alla medaglia d’oro Scarlett Johasson. Il personaggio Max, la poliedrica figura di Linder sono indispensabili per riscrivere la storia del cinema e preziosi per tracciarne il futuro. Il segreto di Max Linder viene svelato perché appartiene pienamente alla sua personalità di protagonista, nella vita, nella morte, nella finzione: un protagonista che attende di essere collocato al giusto posto nel Pantheon dell’Olimpo cinematografico. Il romanzo biografico è una missione archeologica: la vita e la fine di Max Linder sono il reperto di archelogia industriale che modifica il gusto attuale e suggerisce interventi di restauro e il riuso di materiali considerati desueti come il cinema muto. Il destino trionfale di Max è la sua resurrezione cinematografica: non un semplice biopic, ma un transfert, come i recenti film su Truman Capote (che rilanciano la narrativa mondiale a partire dal prototipo-genio) o la pellicola sulle esitazioni di Elisabetta d’Inghilterra al momento della tragica scomparsa-thrilling di Lady Diana. Il cinematografo nasce europeo per diventare internazionale negli Stati Uniti. Sarebbe opportuno che si rifondasse con il francese a Hollywoodland: Max Linder. Chaplin è riproducibile nel suo percorso esistenziale, ma è personaggio irripetibile. Linder, invece, può funzionare sia come personalità interessante e complessa sia come maschera riutilizzabile, serializzabile. Il suo segreto, romanzescamente scoperto e rivelato tra storia universale e storia familiare, s’interseca con momenti cruciali della storia mondiale del Novecento, dominata dall’epico scontro tra democrazia e tirannidi. Battaglia che continua nella contemporaneità, anche attraverso il serrato confronto tra ironia indipendente e
fondamentalisti schematici e fanatici. Ideale la figurina di Linder per interpretare quella pop star dell’aristocrazia di Feliks Yussupov, indolente e balzano tirannicida di un antesignano di Stalin: Rasputin.
C’è molto materiale da studiare, sceneggiare, recitare, filmare.
A suivre. Dans le bateux ivre de l’immagination au pouvoir. C’est le grand tralala, Max.
HOLLYWOODLAND/SCAPEs
Mille e Una Notte ai Giardini di Allah da “Appuntamento a Gomorra” di RIVA RADUNSKI Diari segreti tradotti, editati e commentati da FABRIZIO CALEFFI L’attore non dovrebbe recitare un ruolo. Come l’arpa eolia che veniva appesa agli alberi per essere suonata dal vento, l’attore dovrebbe essere uno strumento suonato dal personaggio da lui rappresentato ALLA NAZIMOVA
Riva Radunski, nata a Mariupol, in Russia, negli ultimi anni del diciannovesimo secolo, emigrata bambina negli States, visse a Los Angeles, California, dove cominciò a tenere un diario. Si trasferì poi a New York city e làdiresse la galleria d’arte “Reydon Art Gallery”. Morì a a Manhattan a 89 anni. A Hollywood, come possono testimoniare le sue Memorie inedite, sarebbe potuta diventare una gossip columnist più temuta di Louella Parsons ed Elsa Maxwell, le terribilissime pettegole del cinema, messe insieme. Ma, purtroppo per lei, aveva letto Proust in originale. Conoscendo perfettamente il francese, oltre ad altre cinque lingue, russo, yiddish, rumeno, inglese e portoghese, trovò impiego nel 1919 come segretaria-interprete di Max Linder, al cui fianco rimase fino al 1922, data del secondo e definitivo ritorno di Max in Europa. Nel mondo del cinema era entrata al fianco della madre, costumista: Sarah Radunski, con un altro nome, aveva ideato e cucito l’abito di Theda Bara per “Cleopatra” (1917). Riva, ragazzina, aveva disegnato i gioielli neo-egizi che Theodosia, in arte Theda, portava al collo nel film e aveva subito il fascino ambiguo di Miss Bara. La giovane di Mariupol sarebbe potuta diventare una grande lesbica alla Mercedes de Acosta; preferì osservare e rimase vergine per tutta la vita. Conobbi Riva Radunski a New York, negli anni ottanta. Holly K*, la mia ragazza di origine greca, lavorava alla Reydon Gallery al 1091 di Madison avenue cinque pomeriggi alla settimana, mentre la sera collaborava come tecnica del suono al BAM theatre, l’Accademia di Brooklyn, dove, recitando Pirandello, l’avevo incontrata. Riva, una baba dal berretto di lana, ci invitava talvolta a prendere il caffè con lei da Reggio, downtown. In una sola occasione ci condusse alla Russian Tea Room, di fianco a Carnegie Hall (è stata da poco riaperta:evviva!); fu allora che mi chiese di dare un’occhiata al voluminoso dattiloscritto dei suoi “appunti”, che, citando “Appuntamento a Samarra”, aveva
intitolato “Appuntamento a Gomorra”. Quando, di lì a poco, Riva morì, dopo l’ufficio funebre alla Campbell’s Funeral House, 1094 Madison avenue, mi ritrovai erede del diario di Grandma Radunski. A Holly la signora lasciò una deliziosa piccola tela di Maria Elena Vieira Da Silva, un olio dell’artista portoghese nata a Lisbona nel 1908, eroina della pittura del ‘900, anche se meno nota di Tamara de Lempicka, Frida Khalo, Sonia Delaunay o Natalja Goncarova. Glielo aveva promesso, un giorno, in galleria, dicendole: O sol brilha no céu de anill. De vagar se vai ao longe, cioè:“Il sole brilla nel cielo sereno. Pian piano, si va lontano”: era per Maria Elena che Riva aveva imparato il lusitano? La strana frase voleva suonare misteriosamente propiziatoria per la sua aiutante? Spero che con la vendita di questa opera Holly, con il destino nel nome e nel cognome, allusivo alla cinetica (e quindi al cinema), sia riuscita a migrare con la sua vecchia Volvo cabriolet, così poco adatta alla East cost, in California (go west, young girl) per diventare, come sognava, montatrice di grandi film. Io l’ho persa di vista, ma continuo ad augurarmi di ritrovarla nei titoli di testa o nelle nomination agli Oscar. Oppure ad un party a Santa Monica. Ma cominciamo ora a leggere insieme l’Album di Riva Radunski, Shahrazad di Hollywood, pubblicati qui in anteprima mondiale esclusiva.
Aprile, 17, 1919 Oggi Douglas Fairbanks, Mary Pickford, Charlie Chaplin e David W.Griffith hanno firmato l’atto di nascita della United Artists. Vogliono produrre, preservando la loro indipendenza creativa: un bel sogno. Griffith, il regista di “Nascita di una Nazione”, ha senz’altro la forza per essere il “padre” di questa impresa. È talmente americano D.W.! E non solo per il cappello da cow boy che gli piace portare in capo in ogni occasione. Con i suoi atteggiamenti da gentiluomo del Sud secessionista, Griffith forse intende anche la U.A. come una secessione dal sistema degli studi. Fa un certo effetto vederlo accanto al ricciuto ebreo Chaplin. Ma questa è l’America. Charlie e Mary (Pickford, NdT) si somigliano: lei è bella quanto può essere bella una donna, lui è bello quanto dev’essere un uomo. Max (Linder, NdT), appena arrivato dall’Europa, per esempio, è troppo bello. E, come quasi tutti i francesi, non diventerà mai un americano. Douglas Fairbanks è il miglior uomo della porta accanto che si possa trovare in questo momento al mondo. Ma la porta accanto è quella di un set, non della realtà. Mi hanno chiesto di fare l’interprete e la segretaria di Monsieur Linder: ho accettato. (Tom Cruise, a quanto si dice, sta ora per prendere le redini della United Artists, NdT)
Aprile, 24, 1919 Aprile, come sostiene T.S.Eliot, è davvero il mese più crudele? Di certo è un dono crudele saper leggere schegge di futuro negli sguardi della gente. Di Max Linder, per esempio. Da ieri, sono la sua personal assistent. Se Max fosse una ragazza, vestirebbe Chanel. Conobbi Coco a Parigi: me la fece incontrare mia madre. Era, credo, il 1906. Allora non era ancora scoppiata la guerra, quella
dove tutti hanno combattuto perché fosse l’ultima. E che non sarà di certo l’ultima. Le generazioni si susseguono, nascono, crescono, si avvicendano e non rinunceranno mai al loro gioco preferito: il jeu de massacre. Il gioco che li dispensa dalle responsabilità. I più fortunati muoiono prima di diventare adulti, gli altri, i reduci, si ritrovano vecchi e le battaglie combattute e le ferite subite li assolvono se non prendono più niente sul serio. Anche il signor Max, che il dio dell’hotel dove alloggia, il Giardino di Allah, lo protegga, ha combattuto e non vuole diventare adulto. Se è sopravvissuto alla guerra, non è detto che sopravviva alla pace. In questo consiste, mi pare, la sua sprezzante comicità francese.(Il giorno precedente, il 23 aprile, era uscito il “J’accuse” di Abel Gance: si scopron le tombe, si levano i morti…Film pacifista diretto da Gance con la collaborazione del poeta-viaggiatore Blaise (Cendras.NdT).
1919, Maggio In questo Olimpo californiano, gli attori sono le nuove divinità pagane. Muti come gli Dei, si esprimono agli umani attraverso le loro apparizioni sul grande schermo. Linder, mi sembra, non si comporta né da Apollo, anche se è di aspetto gradevole, né da Dioniso. E neppure da Marte, se è per questo. Non ne ha voglia, perciò non diventerà una vera star. Preferisce esercitare un fascino da illusionista che ha già incantato quasi tutti qui. Ripete spesso che lui viene dal teatro. Quel che è certo è che viene dall’Europa, dove si dà del tu agli dei. Strano che non sia ebreo.
Luglio, 4, 1919 È piena estate in questa terra dove è sempre estate. Si festeggia una festa americana. Gli Stati Uniti, risolta la guerra di secessione, sono veramente uniti, anche se gli americani sono molto divisi. Un po’ come capita a noi ebrei, ma per altre ragioni. Gli americani sono divisi tra quanti, eliminati i nativi, si considerano loro nativi e si ritengono depositari della tradizione, fatta di oscure limitazioni e gli americanizzati, ondate di pionieri che si sentono approdati nella Terra Promessa della Libertà. Gli Usa sono una grande nazione dove convivono le stirpi rivali dell’umanità, i nomadi e i contadini.
Luglio, 14, 1919 È la festa dei francesi, ma a Monsieur Linder non sembra importare molto della presa della Bastiglia. Gli preme maggiormente di far bella figura con Bessie Love, la bionda ventunenne Juanita Horton, che Griffith ha fatto debuttare a sedici anni, oltre a fornirla di un nome d’arte decisamente significativo. Max le racconta dei suoi inizi, della rivalità che lo opponeva in Francia ad Andrè Deed (Le Havre 1884-Parigi 1938, NdT), creatore del personaggio
di Boireau, che trasformò in Italia, dove si trasferì (per lavorare agli studi Itala di Torino con Pastrone, NdT) in Cretinetti. Poi si gonfia come un tacchino quando spiega a Bessie che nel 1912, con un compenso di un milione di franchi, è stato la star più pagata del mondo. Ho l’impressione che, senza chiedere il cambio in USD, Miss Love sia pronta a papparsi il tacchino francese con golosità festosa da Giorno del Ringraziamento.
Luglio, 19, 1919 Griffith s’informa con me sull’andamento della love story tra Bessie Love e Max Linder, come se volesse accertarsi che il “dono” è stato gradito. Mi sembra che lo sia stato. Juanita si dà da fare per due, Max è un po’ svagato. Si guarda intorno: forse, vuol stupire un’altra stellina con i suoi compensi-record del 1912. A proposito di lavoro, qui se la stanno prendendo comoda con Mr. Francia. Max non sembra farci caso.
Settembre, 20, 1919 Il caro Sam (Samuel Goldwyn, NdT) è tornato dall’Europa con una scoperta ungherese. La scoperta in questione ha 21 anni e un collo realizzato appositamente per reggere la sua deliziosa testa rapace. Si chiama Vilma, Sam le ha regalato un cognome: Banky. Così Konsics Vilma di Budapest è diventata Vilma Banky. Improvvisamente, Max sembra ansioso di dirigere e interpretare un film. Mi detta soggetti a raffica. Tutti con un ruolo chiave per Miss Konsics. E tutti i ruoli prevedono una scena alla Fille de Dieux: un film francese girato alla Giamaica nel 1916 dove la protagonista, Annette Kellerman, compare nuda. Non se ne farà niente. Ottobre, 31, 1919 Oggi: giorno (e soprattutto notte) delle streghe. Tutti mi hanno invitata dappertutto. Però Max ha insistito perché cenassi con lui e con il suo nuovo amico: Fatty. (Roscoe “Fatty” Arbuckle, nato nel 1887, comico grasso, da cui il nickname “Fatty”, Grassone, dall’umorismo sottile, morirà dimenticato nel ’33, NdT). Che i clown siano profondamente tristi è un luogo comune, che lo siano Roscoe e Max un dato di fatto.
Novembre, 18, 1919 Avete mai visto un ciccione inappetente? Arbuckle siede a tavola avido, come se ne andasse della sua stessa vita. Poi, lo snello Linder si esibisce in scorpacciate allegre, mentre “Fatty” si limita a bere. Io gli faccio compagnia, Max mi prende in giro per questo. Generosamente, Roscoe devia l’attenzione su di sé, esibendosi nel numero del goloso che non riesce ad inghiottire un solo boccone se non dopo averlo masticato il doppio delle volte prescritte
dall’antica scuola salernitana. Dalla fatica, il ciuffo gli si incolla di sudore in fronte. Ma Linder non si lascia distrarre. Sono io l’oggetto dei suoi lazzi. Vuole vedermi ubriaca. Loda il vino, descrive enfaticamente vendemmie in terra di Francia. Per accontentarlo, fingo di essere brilla. Ci facciamo cacciare tutti e tre dal locale. Quale? Non sono in grado di ricordarlo.
Dicembre, 24, 1919 Strana vigilia di Natale al Giardino di Allah: Max Linder mi obbliga a trascorrerla addobbando con lui un albero di Natale in questa regione senza inverni. Lui è drappeggiato in una vestaglia scarlatta. Mi ha preparato un regalo: una cassa di champagne francese. Mi ero dimenticata di avvertirlo che, nel frattempo, avevo deciso di diventare astemia. Allo scoccare della mezzanotte, brindiamo, noi due soli. Al terzo bicchiere, vado in bagno a vomitare. Torno per augurare Felice Natale a Max. Mi fa anche lui gli auguri, baciandomi poi sulle labbra. Mi accorgo che il sapore dei miei succhi gastrici lo fa star male. Merry Xmas, Max Linder!
Gennaio, 2, 1920 Ieri non sono stata in grado di scrivere una sola riga. Ho trascorso il Capodanno alla festa più esclusiva di Hollywood: a casa mia, in beata solitudine. Come si dice? Anno nuovo, vita nuova. Ma è solo un modo di dire, naturalmente. Max e “Fatty” sono stati ad un party con Vilma Banky. Pare che si siano presi a pugni a causa sua.
Gennaio, 12, 1920 Il signor Max non mi parla di Vilma e non accenna a “Fatty”. Vuole che sia io a parlargli. Delle mie origini e dei pogrom. Ne so ben poco dei pogrom io! I soliti racconti dei cosacchi scatenati. Io avevo un bambolotto vestito da cosacco. Della Russia gli dico soltanto che Ejzenstejn ripeteva: “mi appassiona Max Linder” e sosteneva di essere passato al cinema grazie a lui. (Sergei M. Ejzenstejn, regista di teatro e di cinema, autore del celeberrimo film “La corazzata Potemkin” e dell’imperdibile dittico “Ivan il Terribile” e “La congiura dei boiari” NdT)
Settembre, 11, 1920 Subbuglio e scandalo! Ieri a Parigi, all’hotel Crillon in place de la Concorde, hanno trovato Olive Thomas morta avvelenata. Giornata nera per Hollywood. Lutto e scandalo! La bella reginetta delle Ziegfeld Follies ha fatto una follia: si è tolta la vita con del bicloruro di mercurio. Myron è fuori di sé. Olive si è fatta fuori dopo una giornata di inutile ricerca di una dose di droga per il marito, Jack Pickford, fratello di Mary, una delle fondatrici della United. Queste sono le voci parigine. (Myron è Myron
Selzenick, tycoon della Selzenick Picture, per i cui studios era sotto contratto Miss Thomas; pare che il romanziere Gore Vidal si sia ispirato, in parte, a lui per il suo Myron/Myra Breckenridge, eroe/eroina della sua avventura narrativa più brillante, insieme a “Duluth”, NdT)
Settembre, 29, 1920 L’eco del caso Olive, giovane oliva avvelenata che ha fatto andare di traverso più di un Martini, non si è ancora spenta. Max mi è parso parecchio turbato dall’avvenimento. Per distrarlo un po’, gli racconto che le sorelle Gish, Lilian e Dorothy, magnifica coppia di attrici, sono proprio una coppia. Insomma, hanno un senso della famiglia talmente forte: fanno tutto, anche l’amore, in casa.
Novembre, 22, 1920 Max non ha più nessun bisogno di essere distratto dai miei pettegolezzi. Dall’Europa è appena arrivata l’adorabile Renèe Adorèe. È cresciuta nel circo e si vede. Voglio dire che mi è capitato di assistere ad un paio di suoi numeri acrobatici con Linder.
Novembre, 28, 1920 Adorabile Renèe. Adorèe adorata, un po’ cinicamente, da Max. Idolatrata, ma un po’ come se l’amore fosse una gag. La ragazzina sta al gioco. Sa camminare ad altezze vertiginose sul filo, mentre Linder un po’ la venera, un po’ fa il clown con lei. Max si è comprato una fantastica automobile italiana, un’ Isotta Fraschini color pervinca. Se la storia durerà fino a Natale, l’Isotta Fraschini sarà una slitta di Santa Klaus sensazionale per la coppia più bella di Hollywood.
Novembre, Chanukah, 1920 Festa delle Luci nella città più luminosa del mondo. Qui la luce è un culto: il sacro raggio che illumina i set e proietta la Grande Leggenda su ogni schermo. Sul cocchio dorato dall’Isotta Fraschini Renèe e la sottoscritta, in veste di chaperon, veniamo condotte a cena con un regista, tale Desmond Taylor, very British (ma non è affatto inglese, lo deduco da tracce di accento di Brooklyn), che mostra discreto entusiasmo per Miss Adorèe, senza che Max se ne dispiaccia. Mazel tov.
Dicembre, Xmas, 1920 Buon Natale, buon Natale! Un Natale spaventoso: Linder, brillo e brillante dopo il pranzo natalizio, ha sfidato con l’Isotta Fraschini ad una gara lungo Sunset boulevard la McFarland color cobalto di Wallace Reid, divo della Paramaount e noto morfinomane. Max mi ha voluta a bordo come palafreniera. Non c’è stato verso di declinare
il perentorio invito. La corsa: un’esperienza devastante. Renèe Adorèe: dimenticata.
Gennaio, 1, 1921 Emicrania da Capodanno. Elegantissimo party da Robo. Max si è trovato benissimo con Roubaix de l’Abrie Richey, il poeta e il pittore più ricco e brillante di Hollywood. Linder e Robo hanno fatto a gara ad esaltare, ironizzandola, la figura dell’aristocratico francese. Il premio in palio per la loro singolar tenzone pareva essere la moglie di Roubaix, un’italiana del nord. Si chiama Luigia Adelaide Assunta Modotti, tutti la chiamano Tina. Ho subito il suo fascino come un castigo. Castigo per me, ma anche per lei che lo emana, temo. Oppure dipende dal mio umore odierno da doposbronza. Sapore amaro in bocca, amarissimo in petto un peso opprimente.(Tina Modotti, nata a Udine nel 1896, morta in un taxi a Città del Messico nel 1942, bellissima attrice a Hollywood per un anno, dopo essere emigrata a San Francisco nel 1913, compagna di Robo, poi di Edward Weston, che la aiuta a diventare una fotografa straordinaria e la fotomodella di se stessa, bisessuale, rivoluzionaria, amica di Frida Khalo, attende la consacrazione cinematografica di una biografia perfetta per piccolo e grande schermo, NdT.
Marzo, 3, 1921 Tina Modotti è diventata una presenza costante nella vita hollywoodiana di Max Linder. Il loro gioco è il più consueto in città: lui le propone provini e ruoli, l’italiana critica, disprezza, polemizza, quasi che l’avesse inventato lei il cinema. Ma si mostra nature a Max: io sono stata costretta ad assistere ad una esibizione di nudo, Tina si atteggiava a modella e Max a pittore. Poi Modotti ha ricoperto di nuovo i suoi seni pieni (di seduzione), il suo corpo atletico, il suo cespuglio rigoglioso, si è rivestita e ha chiesto a Linder di spogliarsi. A quel punto, Max mi ha mandata via. Robo sembra nobilmente disinteressato ai rapporti tra sua moglie e il regista-produttore-attore-sceneggiatore europeo.
Marzo, 18, 1921 Anche Fatty è della partita: Max ha presentato Tina a Roscoe ed ora costituiscono un trio. Si sfidano a gare di bevute e Madame de l’Abrie Richey è quasi sempre l’ultima a crollare sotto il tavolo. Fin che sono in grado di parlare, se non di ragionare, discutono accanitamente di arte cinematografica. Fatty sbuffa quanto un ippopotamo affiorante da un fiume di alcool quando sente la parola “arte”.
Settembre, 5, lunedì, 1921: Labor Day Drammatico festino a San Francisco. Al San Francis hotel il Labor Day Party è finito male, molto male: una
brunetta di Chicago, Virginia Rappe, è finita all’ospedale. Ce l’ha mandata Fatty.
Settembre, 11, 1921 Ieri, dopo cinque giorni di ricovero per emorragia interna, Virginia Rappe, brunetta di Chicago, è deceduta a San Francisco. Pare che causa del decesso siano le conseguenze di una violenza carnale subita per introduzione di un corpo estraneo: una bottiglia di Coca-Cola, forse. Dello stupro della ragazzina è accusato Roscoe Arbuckle, il celebre attore comico. Tina (Modotti, NdT) è sconvolta e disgustata: sostiene di voler abbandonare il mondo del cinema. Max sembra spaventato.(Superficialmente accusato del crimine, Fatty Arbruckle si difese, ma rimase segnato dal marchio d’infamia e dovette da allora fino alla morte, avvenuta nel 1933, lavorare come regista sotto falso nome. Tina Modotti, lasciato il cinema, dove lasciò il segno del suo sguardo di tigre, per parafrasare il titolo di una pellicola da lei interpretata, conobbe il fotografo Edward Weston e s’innamorò di lui e della sua arte. Il marito Robo morì improvvisamente in Messico, dove Tina si stabilì con Weston nel 1923, diventando una grande fotografa e un’inquieta, spericolata militante del movimento comunista rivoluzionario. NdT)
Ottobre, data illeggibile, 1921 Lo spettro di Virginia Rappe abita a Beverly Hills e ne ossessiona gli abitanti. È come se la gente di cinema si aspettasse da un momento all’altro una sorta di cow boy pogrom contro di loro. Max Linder è particolarmente inquieto e i suoi scherzi hanno qualcosa di livido. Tina Modotti si produce in veri e propri comizi contro la corruzione e la prepotenza maschile. Al suo fianco, c’è quasi sempre una silenziosa, misteriosa cinesina, una cino-americana dall’aria di bambina perversa: credo che vada a letto con l’italiana. Max mi detta frenetici appunti di progetti cinematografici; ha anche inventato la gag della bottiglia di Coca-Cola, ma me l’ha fatta cancellare. Poi, però, l’ha descritta a Charlie (Chaplin, NdT) che ne è rimasto molto colpito.
Novembre, 10, 1921 C’è qualcosa di segreto, di irrisolto, di cabalistico, direi, in Charlot. È come se il suo genio attingesse ad una fonte segreta. Per qualche strana ragione, Max sembra temerlo. E non solo come “avversario temibile”: il rivale è Charlot, ma l’omino pericoloso è Chaplin, Charlie Chaplin.
Dicembre, 24, 1921 Max Linder ha ricevuto un dono curioso, un cadeux natalizio: un pappagallo. L’ha chiamato Max. Dice che gli insegnerà a parlare.
Febbraio, 12, 1922 Nuovo scandalo a Hollywoodland, la No Holy Men Land (gioco di parole dell’Autrice per assonanza tra Holly e Holy, “santo”, ad indicare una No Man Land, una Terra di Nessuno dei Non-Santi, NdT): il 1 febbraio, a Westlake, L.A., è stato trovato morto il regista Desmond Taylor. Ad uccidere il noto playboy pare sia stata Mary Miles Minter, verginella maliziosa. Aveva una storia con Desmond ed era la vergine più finta della California. Ma c’è di più. Si è scoperto che Desmond Taylor, un buon regista, a mio parere, non si chiamava né Desmond né, tanto meno, Taylor. E non era, come supponevo, affatto inglese. Il suo vero nome era William Deane Tanner e, nel 1908, aveva piantato moglie e figlia sulla East coast per venire qui a giocare le carte della sua vita nel cinema. O, se si preferisce, a giocare la sua vita a carte. Una partita vincente. Fino a quando non gli è uscita la carta della morte violenta. La città è in subbuglio. Max (Linder, NdT) pare sia rimasto molto colpito dalla vicenda.
Marzo, 28, 1922 Wallace Reid, il divo della Paramount, morfinomane, è andato completamente fuori di testa: si è bevuto il cervello, insomma. Con un trucco, è stato internato a viva forza in manicomio. Fine di una carriera. Linder passa molto tempo in compagnia del suo pappagallo Max.
Senza data, 1923 Mi è giunta notizia che il mio ex boss, Max Linder, che ha lasciato l’America per tornare in Europa, partendo con il suo pappagallo al seguito, dove, a quanto si dice, ha avuto divergenze insanabili con il co-autore Abel Gance per il montaggio del loro film “Au secours”, si è sposato in Francia con una ragazza di diciassette anni, una ragazza di nome Ninette. Felicitazioni, Max! Auguri, Ninette: tanta fortuna. Temo che ne avrai bisogno.
Novembre, 2, 1924 Tristi pensieri nel dia das muertos, nel giorno dei morti dei gentili (i non ebrei, NdT): il 31 ottobre scorso, Max Linder, a Parigi, ha ucciso Ninette e si è tolto la vita. Lasciano la piccola Maud, la loro sventurata figlioletta. Sono profondamente addolorata, ma non esattamente stupita. Max stava perdendo la sua carica: la sveglia di un nuovo giorno, invece di squillare, è esplosa. Questo è il Kaddish (lamento funebre, NdT) che mi viene in mente per il Grande Max. Non lo dimenticherò.
Data illeggibile, 1942 Quando ho saputo che Tina Modotti è stata trovata morta in un taxi a Città del Messico, mi è tornato in
mente, per associazione automatica, Max Linder. Da anni, non pensavo più a lui. Il cinema è cambiato e l’ha dimenticato: il cinema parla, ma non si parla più di lui. Anche la fine di Tina mi pare oscura e misteriosa quanto quella di Max, ecco perché li ho associati.
I Diari segreti di Riva Radunski continuano a coprire gli anni successivi della sua lunga e appassionante esistenza e sarà sicuramente opportuna la loro pubblicazione integrale. Ma la nota del 1942 è l’ultima in cui compare un accenno al protagonista di questo libro, Max Linder. In quanto a Tina Modotti, chi scrive si è occupato, nella sua commedia “Nel Sudamerica”, di svelare le ragioni della fine “oscura e misteriosa”, come dice Riva, della grande fotografa di origine friulana, un autentico “personaggio da film”. L’opera teatrale è il risultato di un viaggio dell’Autore in Messico, dove, nel 1989, a Oaxaca, ne ha iniziato la stesura, per completarla al castello di Sarturano nel 1991, rivedendola poi a Milano nel 1994, in occasione della prima messa in scena.
“Puro es tu dulce nombre, pura es tu fragil vida: de abeja, sombra, fuego, nieve, silencio, espuma de acero, linea, polense construyo tu ferrea, tu delgada estructura”: queste le parole del poeta Pablo Neruda incise sulla tomba di Tina.
Il brujo aveva minacciato Tina: non si può fotografare. Ma Tina aveva preso lo stesso le fotografie. Poi si era pentita e le aveva lasciate a me, perché le avevano fatto paura. Ma non c’è stato perdono per lei. Quando è salita sul mio taxi, a Mexico City, ho cercato di salvarla: ho visto che stava per morire di maledizione e le ho dato un boccone di carne degli dei. Gli amici di Tina hanno detto che l’ho avvelenata per ordine dei loro nemici e mi hanno spezzato le gambe. Ma Tina è morta per le fotografie che aveva preso nella regione di Oaxaca.
Questa la battuta, pronunciata in sottofinale, da Sergio (guidatore di un Apolo taxi, unidad 29, servicio mas de Apolo Comunicationes, taxi las 24 horas del dia, 541-9595, Mexico city) nella mia commedia. La fotografa Tina Modotti realizzò il suo ultimo servizio nella regione di Oaxaca e gli scatti scomparvero senza esser mai più ritrovati.
Dice Gianni M.De Ruta, protagonista di “Nel Sudamerica”: I funghi sono carne degli dei: solo i puri possono cibarsene. Devono guardarsi da ogni contatto con i cadaveri. Quattro giorni prima e quattro giorni dopo averli mangiati, bisogna rimanere casti, altrimenti si impazzisce.
Ma la frase finale dello spettacolo recita: Tina, tu e tutti i tuoi Eravate gli erranti. Erraste fino allo stremo E forse sì certo erraste invano. Ma nell’orrore l’errare Non è per forza sempre solo sbagliare.