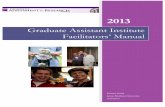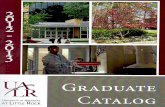graduate student
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of graduate student
IL LUOGO, IL TEMPO E IL SACRO
Note sulla poesia di Antonella Anedda
L’isola di luce, con briciole di scrittura a cuore, a mezzanotte, nel piccolo luccichio della chiave d’avviamento. P. Celan
LO SPAZIO- TEMPO: UNA NUOVA DIMENSIONE NELLA SCRITTURA DI ANTONELLA ANEDDA
I luoghi della scrittura di Antonella Anedda, a partire dalle “residenze invernali” che le hanno datol’imprimatur poetico, sono soprattutto interiori: piùche su una carta geografica dobbiamo allora cercarli in un non – luogo fisico, nei paesaggi degli autori da lei tradotti ed esplorati come in un viaggio compiuto e mai concluso. “Il pellegrino” scrive la poetessa nella raccolta di traduzioni/variazioni Nomi distanti, “non viaggia per scoprire, ma per esistere, viaggia per vedere il proprio viaggio riflesso nel corpo e nel pensiero che sosta e cammina”. 1Così la
1
Maddalena, l’ “isola nell’isola” cui è dedicata l’omonima sezione del Catalogo della gioia,2si dilata sottoi nostri occhi fino ad assumere i confini delle steppe russe, delle brughiere inglesi e del deserto mosaico: in questa vocazione all’universale essa rimane tuttavia se stessa, piccola custode dei “restidi sogni” dell’infanzia2:
“Questa piccola isola forata sott’acqua dai sommergibili americani, dove mio bisnonno piantò vitie agrumi, costruì stalle e portò dieci vacche dal continente (….)” 3
Nella scrittura di Antonella Anedda la Maddalena è dunque un’isola di secondo livello, metafora per eccellenza della segregazione; anche nella pause estive, come ala di scricciolo intempestivo, vi battela nostalgia del freddo che conserva tutte le cose. Alle basse temperature, dice Brodskij, la bellezza ritorna bellezza. Elena Petrassi in un saggio definisce le atmosfere dell’Anedda “un mondo invernale, simile a quello della Regina delle Nevi”, che “possiede un suo conforto, un suo agio, un forte aspetto protettivo”.4 Un’isola che, come tutti i posti del mondo, si sa in fondo una terra qualunque pur entro il proprio “principium individuationis” e 21Antonella Anedda, Nomi distanti, Empiria, Roma, 1998, p.72 Il Catalogo della gioia, Donzelli editore, Roma, 2003, p. 99-1093 Ibidem, p. 1054 Cfr Elena Petrassi, Le stagioni dell’anima: Antonella Anedda e il tempo come metafora dei mondi interiori, in La Mosca di Milano, n. 10, Milano, aprile 2004, pp. 54-56
in cui la presenza delle nostre radici non basta ad evitare di farci sentire stranieri:
In nessun luogo c’è bisogno di noitra un mese l’annoavrà una cifra baltica, biancamillenovecentonovantunodove il mille indietreggiafino a secoli – steppee l’uno, cavo,tintinna. 5
Luogo e tempo, dunque, sono indissolubilmente legati dalla legge della non permanenza, della dissoluzione:una ripetitività di gesti, tempi e memorie che ha come orizzonte inevitabile la morte e come testimoni le cose stesse :
Non parlavo che al cappotto distesoal cestino con ancora una melaai miti oggetti legatia un abbandono fuori di noieppure con noi, dentro la notteinascoltati. 6
Questo breve testo, che in apertura della prima raccolta suona già come una netta dichiarazione di
5 Antonella Anedda, Residenze invernali, Crocetti editore, Milano, 1992, p. 836 Ibidem p. 15
poetica, chiama gli oggetti interlocutori privilegiati grazie ad una loro ambivalenza particolare rispetto al mondo degli uomini – l’esseredentro e fuori, sganciati dall’esperienza umana e nello stesso tempo inerenti ad essa: ascoltatori inascoltati, la cui mitezza si traduce in un evangelico rifiuto di giudicare le vicende quotidiane, pur essendo in esse profondamente immersi. Potremmo parlare in Anedda di una sacralità degli oggetti, quella stessa sacralità che permea l’isola, le ricorrenze e le stanze – la cucina con ilbricco del latte appena versato, le corsie dell’ospedale intravisto di sfuggita sulla via del lavoro e confluito nell’omonima sezione di Residenze invernali; 7 l’albergo testimone di un “amore inapparente”, quello che ci ha concepito e che ci segue come un’ombra inseparabile di vita. 8In Anedda tutto è luogo e tempo insieme, perché tutto è umano.La cuccia dell’amatissimo cane Iskrà, il camino con la brace, persino le galline e le cipolle abbandonatesul lavabo dalla donna del sogno che sceglie di fuggire la vita, non sarebbero le stesse senza l’ora precisa in cui vengono fissate, senza la luce esatta che le colpisce e le rende dicibili.9 “Il dettaglio” leggiamo altrove “costruisce non solo l’orizzonte ma
7 Cfr. Residenze invernali, op. cit., pp. 27-438 Cfr. Il catalogo della gioia, op. cit., pp. 61-749 Il cane, la cucina e il camino sono immagini ricorrenti nella poesia di Anedda. La visione onirica della fuga da casa e del suicidio per annegamento è raccontata in Cosa sono gli anni, Fazi editore, Roma, 1997, pp. 122-127
l’autenticità dello spazio.”10 Sembra proprio che la poetessa voglia introdurci in una nuova dimensione poetica spazio - temporale, individuata da un amore estremo per la precisione del gesto, per una memoria che rifugge dal vago e dall’indeterminato. Forse un merito delle esperienze più significative del tardo Novecento è proprio quello di aver metabolizzato le poetiche precedenti, elaborando una nuova capacità percettiva che supera i confini tradizionali. Non piùuna scrittura soltanto di cose o soltanto di parole, non più uno sperimentare fine a se stesso o un’attenzione troppo mirata - erede della pur fondamentale esperienza della neoavanguardia – ai processi di decostruzione e dissoluzione dell’ io poetico. Piuttosto, come osserva Sandro Montalto parlando di Gabriela Fantato - una poetessa quasi coetanea rispetto ad Antonella Anedda – un possibile ritorno alla poesia “in chiave di ricerca dell’autentico”11. Il protagonista di ogni scrittura riuscita, infatti, non è mai semplicemente l’Io dell’autore, né il linguaggio preso a se stante; è invece la zona intermedia fra soggetto e mondo nella quale ha origine la parola stessa, non soltanto quella poetica. Ogni autore forgia la propria chiave,vorrei dire il proprio personale baricentro per immergersi nelle radici materiali della parola e faredi essa la vera protagonista della scrittura: non astratto codice forzatamente lontano dal senso
10 A. Anedda, Cosa sono gli anni, Fazi editore, Roma, 199711 Sandro Montalto, Compendio di eresia, ed. Joker, Novi Ligure, 2004,p. 99; cfr. anche La clessidra anno IX n. 1, maggio 2003, p. 92
comune, ma parola passata attraverso un’esperienza fatta di carne e di cuore, setacciata da un angolo visuale che si sa ben definito nella sua singolarità.Il verbo poetico non si fa propriamente carne, ma è già carne per la risonanza di realtà che porta con sé grazie all’esperienza vissuta, e proprio per questo viene scelto fra i molti possibili dall’occhio vigiledell’autore; è sperimentale, vorremmo aggiungere, non per un freddo programma filologico o per l’obbligo del neologismo a tutti costi, ma semplicemente in quanto sperimentato, cioè autentico.12
La firma di ciascun autore vero è - lo accennavo pocofa - il peculiare centro di gravità, la personale chiave di volta tale da consentirgli attraverso vie proprie ed originali l’affondo nel linguaggio, il recupero della parola come fonte di esperienza poetica. Forse il compito più importante di un lettore partecipe è proprio quello di scoprire e tradurre nel proprio orizzonte culturale questa cifra, questa filigrana segreta che traluce dalla scrittura degli autori da lui amati. Attraverso tale rete di codici e rinvii ciascun autore, che prima di tutto è lettore a sua volta, sceglie quasi inconsapevolmente i propri maestri; così la poesia genera altra poesia. Ancora una volta, non un’astratta “enciclopedia” filologicamente
12 Sulla poesia come ricerca della fisicità materica del linguaggio, riferita ad un’altra autrice contemporanea (Donatella Bisutti), cfr. Alessandra Paganardi, Alle radici materiali della parola, in Leggendaria, anno VIII n. 44, marzo-aprile 2004, pp. 12-15
quantificabile, ma una filiazione d’esperienza, un rivivere continuamente la parola. Nel caso di Antonella Anedda il lettore - anche grazie al rapporto intenso, all’amore particolarmente dichiarato che l’autrice intrattiene con i suoi auctores e con le loro tematiche - riceve una sorta di filo d’Arianna con cui può orientarsi meglio nei varivissuti poetici. La cifra, però, risulterà per contrappunto particolarmente complessa, la rete composta di molti nodi, difficilmente riassumibili inpoche formule. Abbiamo già detto che uno di questi nodi è l’azzeramento della distanza percettiva fra spazio e tempo, quasi la ricerca - e la prassi realizzata - di una dimensione percettiva potentemente sintetica. Possiamo ipotizzare che l’altra componente della cifra euristica di Anedda sia il rapporto che l’autrice riesce a stabilire col sacro. Un’ipotesi suffragata dalla stessa domanda chela poetessa si pone nel libro intitolato Cosa sono gli anni: una raccolta di saggi interpolati al racconto, alricordo e a spunti di riflessione:
“C’è uno spazio in cui il sostantivo (non l’aggettivo) sacro può scattare oltre l’ambiguità del suono, della retorica della memoria? Può questo termine tanto pericoloso stabilire fra sé e il linguaggio un patto che sottragga al nostro tempo la passività del contadino davanti alla Legge del racconto kafkiano?” Più avanti nel testo, l’autrice saluta nella propria scrittura e in quelle che verranno “un solco scavato non sopra, ma dentro il
sacro, che riesca a distinguere i volti, i nomi dellevittime e costruisca per loro un riparo contro ogni legge senza significanza. Solo in questo nuovo spazioil sacro può diventare ospitalità ed essere limpidamente sacro come le candele accese accanto al cibo per il nome del Signore, per la memoria dei morti” 13
La scrittura non è che un fragile solco lasciato dalla penna, ma capace di dare visibilità al tempo, proprio perché è “ la possibilità di un portare, di assumere il peso della propria e dell’ altrui morte, dell’ altrui sofferenza, dell’ altrui tremore.(…)La forza è (…) in questo crinale di morte che incontra la morte e tuttavia resta al suo posto fino alla fine” 14 La responsabilità della scrittura, dunque, rende il tempo tangibile e lo spazio sacro proprio in quanto lo inserisce nella storia L’avevano capito bene gli antichi Greci con l’intraducibile parola aiòn, il saeculum, l’eternità sottratta ad ogni successiva distinzione intellettuale fra mente e mondo, fra scorrere delle ore e spostamento fisico: procedere eterno e inseparabile di luogo e tempo che non può essere compreso attraverso il pensiero astratto ma soltanto consegnato al midollo, al seme, ai succhi biologici capaci di generare altra vita15. L’autrice
13 A. Anedda, Cosa sono gli anni, op. cit. , p. 71; p. 72.14 Ibidem. p. 72 - 7315 Sulla traduzione della parola greca aion (comunemente resa con“tempo”, “mondo”) come “essenza divina” e concretamente come
si pone una domanda che possiamo a buon diritto chiamare archetipica, ma che è fondamentale per la sua stessa poetica, per la possibilità di esistenza del metaxù crono – spaziale realizzato nei suoi versi.Rendere visibile il tempo significa salvarlo dalla dissoluzione ma non dalla storia, non
“midollo spinale” cfr. lo studio ormai classico di R.Onians The origin of European though about body, mind, soul, world, time and fate, Cambridge,1954. Sul rapporto fra midollo così inteso e liquido seminale nel pensiero arcaico cfr. anche A.Paganardi, L’ “eros synousias: un’eccentricità nello schema psicologico tripartito del Timeo, in Discorsi, anno X, 1990, p.305 – 319.
dall’avvicendamento delle stagioni e delle morti. L’amore che Antonella Anedda riserva alla scrittura come depositaria privilegiata del tempo visibile ci riporta al pensiero di una filosofa che ha fatto di queste tematiche il fulcro delle sue intuizioni folgoranti: sto pensando in particolare a Marìa Zambrano, alla sua rivisitazione del tempio classico come casa concreta del divino:
“Pur presentando la caratteristica così decisiva di essere dimora di un Dio, la presenza del tempio grecosuggerisce qualcosa di più (…): qualcosa che viene dalla divinità stessa, della quale è rifugio privilegiato, casa. Casa più che palazzo; focolare, benché il fuoco non ardesse di continuo; luogo con una doppia funzione, anzitutto: quella di essere una dimora conforme alla condizione del dio che ne determina l’ubicazione, per principio accessibile a tutti, dalla quale la divinità opera in modo continuo; poi la funzione di far vedere e di essere il centro dal quale si guarda. Il carattere monumentale che risplende ancora in alcuni templi non si impone eancor meno dovette imporsi nei tempi in cui il loro splendore era intatto;
perché se invitano a essere osservati, contemplati, invitano ancor più a entrare nel loro recinto, a contemplare dalla loro prospettiva, a guardare dai loro diversi siti. (…) Il principio della visibilità si fa sentire prima di essere riconosciuto dalla mente. (…) Ma si andava a cercare anche qualcosa di occulto, qualcosa di più del visibile, sebbene esperibile, specialmente, è inutile dirlo, nei templimisterici e oracolari. Una visione, una voce, parola,musica.”16 (il corsivo è mio)
Rendere visibile lo spazio sacro del tempo – la funzione del temenos secondo la filosofa Zambrano – è anche per Anedda un’operazione che non ha mai per fine la visibilità stessa, ma una nuova immersione nell’invisibile ormai contrassegnato, consacrato dalla parola. Per questo i suoi versi sono così umbratili, così privi di sonorità ricercate,: poesia “per ciò che si spegne”, che ripercorre senza rumore l’antica vocazione socratica della filosofia come preparazione alla morte. Senza rumore, nel dettaglio sottile ma non artefatto di una piastrella o di una ringhiera, di un’iniziale in cui sembra compendiarsie insieme azzerarsi il suono tronfio in cui ogni nomeminaccia di degradarsi se pronunciato a tutto tondo:
Nome. Non avere nome.Essere un’iniziale che non conosce vanità o faticacontrarsi in una sola lettera
16 Cfr. Marìa Zambrano, L’uomo e il divino, edizioni Lavoro, Roma, 2001, pp. 293 - 294
il cui splendore turba solo fugacementeperché perduto tra le schiere dei morti.Essere un graffio indifferentema in comunione con la gola segnatarosso di sangue trattenutodestinato a sparire senza cicatrice.
Tu né ferita né ustioneombra di ascia spettro di roveto.17
Una scrittura – tempio che sceglie di indicare il sacro riducendosi alle proprie fondamenta, rientrandonell’essenziale come se volesse tornare all’utero materno, all’origine. Le lettere, quel “vento di formiche” intravisto sul foglio dalla figlia di tre anni, sono le piccole bussole di questo ritorno, le briciole di pane che indicano a Pollicino la via verso casa.18In questa attesa della parola contano soprattutto virtù dimenticate come pazienza e tenacia, che limano l’intemperanza del desiderio e lotrasformano in un’ascesi persino troppo discreta per essere detta:
“Ho imparato che la perfezione ha la stessa iniziale della parola peccato, che non bisogna inseguirla e neppure attenderla perché a stento un suo bagliore raggiugerà l’anima vecchia nell’assedio. Per questo contro il consumarsi del corpo, contro la squisita
17 Il catalogo della gioia, cit., p. 1718 Il dialogo con la figlia è raccontato in Cosa sono gli anni, op. cit. p. 131
liturgia di autori lungamente amati come Cristina Campo scelgo l’attraversamento del tempo, con il tempo come un fardello piegato in quattro e infilato su un bastone. Non il rito e neppure il gioco che comporta i suoi riti, ma le cose come sono, appena schiarite da sguardo e e linguaggio, mille volte viste e fermate solo dopo una lunga fatica. Pellegrinaggio, parola che ha lo stesso peso di un gesto (…)”19
Il pellegrinaggio si fa avventura proprio in quanto non cerca il sensazionale, ma incontra il mistero. Come nei Racconti di un pellegrino russo, dove il viaggio lungo le steppe di un’estatica terra – le steppe tanto amate da Anedda attraverso il vento della piccolaisola Maddalena – viene consegnato con suprema umiltà ad un manoscritto anonimo, celando per sempre il nome del viandante. 20 Nessun protagonismo, eppurerimane nel lettore il senso di un’unicità dell’io narrante difficilmente riscontrabile in qualunque racconto a tutto tondo. Nessuna mappa o programma, mauna densità di eventi e di incontri che farebbe invidia ai nostri anemici tour operators di massa. E una Parola che genera il miracolo, guarisce gli ammalati,ricrea contatti dopo lunghe separazioni. Come la scrittura di Antonella Anedda, che pur nel silenzio di Dio ritrova la propria vocazione di tempio sicuro:come se Dio ancora ci parlasse dalla distanza, dall’immensità di quelle steppe in cui sembra forse 19 Ibidem, p. 11320 Cfr. Racconti di un pellegrino russo, Tascabili Bompiani, 2003
un po’ meno inquietante saperlo irreparabilmente lontano.
Forse l’anima non esiste ma esistono i suoi luoghila distanza: verste da percorrere a ritrosouna lingua capace di dire ciò che premesuono, frontalità, selvatiche radicirespiro di pianuresì respiro – per lo stretto di un’isolae al posto delle rimeil ritmo di un pernsieromai uditoinauditocome sempre è cercare concisione nell’altezza. 21
UNA PAROLA DISTANTEHo concluso le note di lettura precedenti citando un testo di Antonella Anedda che inizia con la distanza e si conclude con la verticalità – che è in fondo unaforma privilegiata di distanza. Vorrei continuare ricordando l’importanza che questo tema riveste in tutta l’opera dell’autrice, testimoniato anche dal titolo scelto per la raccolta di traduzioni/variazioni, Nomi distanti.22 Si tratta di mirabili Nachdihtungen, traduzioni – imitazioni, come Remo Faccani definisce le versioni poetiche di Celan
21 A. Anedda, Notti di pace occidentale, op. cit., p. 3422 A. Anedda, Nomi distanti, cit.
da Mandel’stam.23 O meglio è l’autrice stessa, nella prefazione, a spiegarci il senso di questa operazionedi poesia sulla poesia:
“Non esattamente versioni, non esercizi, non variazioni. Libere versioni? Non troppo libere, anzi legate alla promessa di una risposta. Risposta da lontano: al lontano testo originale, alla pura lingua della traduzione. Un sogno di esattezza nella precarietà. Come accade in mare quando ci si chiama da barche diverse, di notte, con lanterne nell’acqua buia, con volti e corpi nel buio. Chi risponde deve tener contodell’aria e del fragore, del freddo, del tremore dell’onda, del tremore del fiato: per capire il richiamo, per remare verso l’essenziale di ciò che sembra inesprimibile.”24
Come già nel libro di saggi – racconti Cosa sono gli anni,ritroviamo in quest’opera di Anedda una caratteristica comune anche alla sua poesia: la mescolanza di commento, narrazione, critica e autobiografia. Una mescolanza possibile in quanto nell’operazione poetica avviene il paradosso di un Ioche, per farsi interprete di istanze universali, devedistanziarsi da sé, scegliere un’ideale terza persona:
23 Osip Mandel’stam, Cinquanta poesie, Einaudi, Torino 1998, Introduzione, p. XVII24 Nomi distanti, cit., p.7
“Si dovrebbe avere la forza di pensare alla morte, diparlare della morte senza mai pronunciare la parola io. Chi scrive dovrebbe scostarsi del tutto, lasciarela morte sola, togliersi ogni voce”25
La poesia, votata per vocazione alla morte, è il paradosso di una parola che si autoazzera nella distanza estrema, nella separazione volontaria da ogni retorica dell’illusione. Antonella bambina sfoglia per gioco il libro di medicina legale del padre e, vedendovi la foto di un adolescente suicida,trasforma la forte impressione provata in quello sguardo distante da sé che diventerà più tardi poesia.26 Soltanto così si può raccontare, soltanto a prezzo di questa lacerazione primaria le parole possono “condividere il destino delle cose”27, narrarle nella lingua stessa della lontananza:
“Forse noi non esistiamo che per imparare l’alfabeto dei morti e per raggiungerli non appena saremo in grado di parlare la loro lingua. Forse chi è scomparso è solo assorto e basterebbe una parola non difficile, ma ancora sconosciuta, per farlo voltare verso di noi. Ecco, diremo davanti alla morte, era questo, qualcosa d’ infinitamente semplice come ora la mensola, quieta, bruna, sotto il lume verde. Questo, diremo, era il suono che in vita non
25 Cosa sono gli anni, cit. pag. 2926 L’episodio è raccontato in Cosa sono gli anni, p. 6527 Ibidem p.82
riuscivamo a decifrare, questa la terza cosa, che a scuola chiamavamo neutro”.28
La terza cosa, la terza persona, sono ancora e semprequel metaxù fra io e mondo che diventa raggiungibile soltanto con un duplice sforzo, di separazione dal proprio Sé biografico e di equilibrio tra un punto d’appoggio fragile come la scrittura e l’enorme fatica del mondo: l’autrice torna spesso su questo punto e a chi legge sembra di rivivere, in variazione, le bellissime pagine di Simone Weil sullabilancia e sulla leva.29 Se si accetta di pagare il prezzo di questa ascesi la poesia può veramente reggere il peso del mondo: un prezzo nascosto, mai gridato, come la fatica della vecchia che, in una sera di pioggia e in mezzo alla strada, si china a raccogliere la frutta caduta dalle pesanti buste di plastica. O come la pazienza gentile di Amelia Rosselli, che in una notte di black-out scende le scale per accompagnare l’ultimo ospite, una candela nella mano.30
28 Ibidem p. 1429 S. Weil, La pesanteur et la grace, tr. it. L’ombra e la grazia, ed. Bompiani Testi a fronte, Milano, 200230 Gli episodi sono raccontati in Cosa sono gli anni, p. 57 e p. 31
Fatica e distanza dicono all’unisono il mondo: sono la weiliana “pesantezza”, l’ombra che già al bambino appare inspiegabile e che non saranno certo le risposte degli adulti a fugare. Nella poesia di Anedda compaiono di rado scene direttamente legate all’infanzia, ma leggendo si capisce assai bene il forte legame fra le impressioni ricevute in età precoce e la futura vocazione poetica. Si può quasi dire che la sua poesia annulli i confini fra presentee memoria, rivisitandoli proprio nell’atto della scrittura. La poesia riesce in questo intento forse più della prosa; anche se va detto che nel lavoro di Anedda l’una nasce dall’altra, in una continua germinazione mediata dal verso lungo e da folgoranti prose poetiche.
“Davanti alla sponda dei letti sfilavano silenziose le rennecontro il legno degli armadi ardevano i fuochi dei Lapponifuori crepitavano rami e bottigliebruciavano alberi di Natalelegno e vetro segreto scintillio di carte.
E’ arrivato il Capodanno.Noi abbiamo vegliato senza fatica,semplicementela luna spezzava le travil’ombra di una calza velava il cortileogni lume era spento.”31
31 Residenze invernali, cit. pag. 31
Il lettore avverte che non è il bambino ingenuo a selezionare queste immagini, né l’adulto esperto: è una terza figura (quel neutro di cui si parlava prima?), il poeta. E’ come se l’attenzione di quel primo sguardo, così stranamente centrato sui particolari – il camino, la luce totalizzante della luna, l’assenza di ogni scissione gerarchica fra realtà e fantasia – catalizzasse gli embrioni di una percezione futura in grado di ripercorrere quelle sensazioni e di rinominarle.
“Chi scrive, chi stende il suo rapporto sul mondo, deve farlo su un foglio comune, con un inchiostro qualsiasi, dire ciò che è con esattezza. L’esattezza è l’erba toccata in sorte a ciascuno, la razione di
cibo e di sepoltura. E’ la cronaca di un poeta come Herbert che notifica come in un assedio i bambini sognino l’osso e il pane come i gatti e i cani. La storia arrotonda le cifre. La poesia tenta di dire centoeuno, fare dell’uno il nome, il profeta.”32
L’esattezza è quella dei dettagli: gli spiragli attraverso i quali Pasternak, Franco Loi, Anna Achmatova e gli altri poeti amati dall’autrice riescono a far trapelare il miracolo del mondo, l’universale. Oggetti “mischiati al linguaggio”,33 come li definisce la stessa Anedda, perché in fondo la separazione fra parole e cose è una finzione artificiale: reale è invece quello spazio intermedio,quel metaxù fra Io e mondo che è oggetto di esperienza, a partire dallo sguardo di un bambino durante la notte di Capodanno o davanti a un libro per lui ancora indecifrabile. Nel raccontare quella visione, nel ridirla con la precisione del tempo attuale, la poesia forse può essere definita il doppio dell’esperienza stessa, cioè della realtà – che è sempre esperienziale, mai rigidamente oggettiva. Si illuminano così le atmosfere di certi versi che non possono dirsi né di presente né di memoria, versi dove la sensazione stessa perde il proprio carattere di immediatezza per dilatarsi versoun’universalità temporale possibile soltanto in poesia. Spesso, non a caso, è la scrittura stessa la protagonista e quasi il vero narratore - osservatore,32 Cosa sono gli anni, p. 64 - 6533 Ibidem. , p. 95
dopo che il poeta ha abdicato al suo ruolo di Io grettamente autobiografico e si è fatto calamo solidale con le cose:
Scrivere una poesia: respirarel’aria tra la notte e il giornoe insieme a loro tra gli alberiquasi venisse sulla punta di ogni fogliaun tintinnio di brina un tepore di baval’inizio confuso di una fraseche strisciando mi scacciadepone oggetti, basse notetremando leggermentefa del mio guscio un cielo. 34
Esattezza, imprendibilità: un ossimoro non impossibile. L’universo è colto da un pertugio angusto perché angusta è la vita di ciascuno, delimitata entro ben precisi confini spazio – temporali: che si dilatano, tuttavia, non appena la parola “fa spazio alla distanza”, come scrive Franco Loi nella quarta di copertina del libro di traduzionipoetiche.35 La parola, ci avverte Anedda, è “dimessa einsieme precisa” (un altro ossimoro!) e “ha bisogno di poco” 36Ma se è la morte infine a decidere – perché ad essa è destinata e quasi dedicata tutta la poesia diAntonella Anedda – giova ricordare che sarà proprio
34 Il catalogo della gioia, cit., p. 1735 Nomi distanti, op. cit.36 Cosa sono gli anni, cit., p. 52 - 53
la morte ad azzerare ogni distanza, a ricomporre gli estremi dell’antitesi:
“Essere pronti alla morte: sarà possibile saperlo solo di fronte alla morte, ma avere coscienza di quanto poco comunque rimanga, di quanta poca differenza passi fra noi e il malato terminale o il condannato delinea l’orizzonte di un pensiero lontanodal trionfo e dal rancore” 37
Una volta annullata la distanza rispetto a sé, prima lungamente cercata come antidoto contro lo sterile autocompiacimento, si annichilirà anche un’altra separazione, quella fra parola e silenzio:
“E forse verrà un tempo prossimo al silenzio, eppure più lontano del silenzio, tempo di soli segni e voci di deserto nel deserto per un poema immenso, stellare. Allora capiremo le immagini e il senso dei luoghi, l’enigma di certe improvvise pene, le scheggedi realtà che ci ferivano. Allora tende, cornici, vasi e teli di plastica che adesso tremano nel vento saranno scagliati altrove. Resteranno i nomi, la raggiante corona delle frasi (…)”38
Ci sono passi poetici in cui il senso della poesia come morte, già profondamente assimilato attraverso la lettura di autrici molto amate come Simone Weil e Cristina Campo, supera ogni gabbia concettuale per 37 Ibidem. pag. 11238 Cosa sono gli anni, cit. p. 18
diventare puro suono d’attesa; come questo che vogliocitare, dove l’attesa stessa torna a rivestire la forma ad essa più congeniale, quella dell’interrogazione:
Forse se moriamo è per questo?Perché l’aria liquida dei giorniscuota di colpo il tempo e gli dia spazioperché l’invisibile, il fuoco delle attesesi spalanchi nell’ariae bruci quello che ci sembravail nostro solo raccolto? 39
Oppure questi versi, in cui anche il punto interrogativo sembra dissolversi a favore di una mimesi con le cose davvero completa, cioè attinta fino in fondo, ex – hausta:
Vento. Essere nel vento.Delle isoleessere nel maestrale. Soffia sulle Bocchefino a Bonifacio. E’ la mia bocca. Spalancatapiena di mare.40
Siamo di fronte all’esatta antitesi del Meriggio dannunziano: là l’io del poeta, tronfio e narcisista,si dilatava fino a inglobare il corpo del mondo, quisi azzera fino a sciogliersi in esso, in 39 Notti di pace occidentale, cit., p. 1740 Il catalogo della gioia, p. 44
un’anticipazione della morte che è attesa ma non invocata, non cercata. La morte stessa è chiamata colsuo nome, come tutti gli oggetti dell’universo poetico di Anedda, e per questo restituita ad un senso, al di là della disperazione e dell’afasia. Nonesiste nessun conforto, neppure quello – religioso o simbolico – di una resurrezione possibile; anzi la stessa resurrezione di Cristo, rovesciando suggestivamente la prospettiva kierkegaardiana, è definita “scandalo del cristianesimo”41. L’unica certezza rimane al dubbio, nel rispetto estremo per quell’atto di fede che la poetessa sceglie di lasciare nel vento come ogni altra affermazione dogmatica:
“Cristo è risorto? Non so se è risorto, non so se davvero era figlio di Dio, non so se un tremendo peccato si nasconde in questo sacrificio, non so se la croce annuncia una stella o i chiodi del mondo. Forse, semplicemente un uomo è passato sulla terra tradito dal suo tempo senza pace”.42
Nel risorgere, o nel non risorgere, Cristo ha esaurito l’estrema possibilità della storia: ha abbandonato il mondo, rivelando il paradosso e l’orrore di essere stato a sua volta abbandonato a sestesso dal proprio padre. Non ci sarà più un’ultima cena: forse soltanto un eterno sabato, l’ “abisso di
41 Cosa sono gli anni, p. 3442 Ibidem. p. 37
un silenzio incolmabile”.43 Nessuna consolazione: la gioia, per Antonella Anedda, è ben altro rispetto alla consolazione. E’ la difficile allegria, il riso lieve di Saba e Leopardi: quel riso che “libera e scardina il tempo in un’altezza che è oltre il pensiero, in un pensiero tanto forte da non offendere nessuno attraverso la pena”44. Un’altra distanza azzerata, un altro ossimoro ricomposto: quello fra dolore e gioia,come la poetessa ci racconta nell’intero Catalogo. La gioia, infatti, non è la semplice ilarità compressa nella propria iniziale – proprio la stessa che in apertura di libro compone l’acrostico isola:
“E’ la lettera dell’ilarità, del riso infantile ma anche del raglio degli asini che sembrano ridere e poi piangono o misteriosamente invocano. Le labbra sitendono, la lingua resta immobile. La testa impercettibilmente si inclina indietro in un inno incompiuto.”45
La gioia per Anedda è invece quella che sa com-prendere– in senso etimologico e quindi concreto, fisico – ildolore. E’ una gioia “dal cuore spezzato”, come chiarisce la citazione dal maestro chassid Nachman diBreslav, poi eletta ad esergo del Catalogo46. E’ la fragile felicità di Lara e Zivago nella casa di Varykino circondata dai lupi, mentre il mondo va in
43 Ibidem. p. 3444 Ibidem. p. 2345 Il catalogo della gioia p. 1346 Cosa sono gli anni p.23; Il catalogo della gioia p. 9
rovina e i protagonisti sanno di esserne parte, sannobenissimo nel loro cuore ciò che li aspetta. Una gioia che sorprende, la stessa della scrittura.
Mi spingo oltre il doloredove nessuno sospetta che si soffrain una zona di pelle mai colpitacupa come l’avambraccioo molata dall’osso come il gomito.Striscio piano con l’anima coperta da scaglie rosso – grigieper sostenere i rovi e lasciare a terrail sangue minimo. Un passo – sono paziente –e il corpo ha imparato a frusciare dentro l’erba.47
Una felicità di rari abbandoni, che ha ormai metabolizzato la lontananza stellare del divino. Non la chiama più neppure morte, ma semplicemente assenza. Non grida, non si dibatte, non aspetta più. La salvezza, forse, sarà un vento che finalmente si è fermato, perché ha riunito in un solo punto esatto tutti i venti dell’isola. E sarà una parola densa, aperta al mondo come la geometria di una lettera iniziale che ha percorso tutte le parole, radunato tutte le distanze.
47 Notti di pace occidentale cit. p. 40