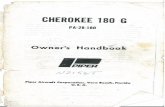G. Biancardi, A. Cadioli, D. Mantovani, G. Petrella, S. Resconi, L. Rivali, F. Saviotti, La...
Transcript of G. Biancardi, A. Cadioli, D. Mantovani, G. Petrella, S. Resconi, L. Rivali, F. Saviotti, La...
R���R��R�� BIBLIOGRAFICO RAGIONATO.LA MATERIALITÀ NELLA FILOLOGIA
(1985-2007)
A cura di
Giovanni Biancardi, Alberto Cadioli, Dario Mantovani, Giancarlo Petrella, Stefano Resconi, Luca Rivali, Federico Saviotti
����
A.
Antonelli Roberto, Interpretazione e critica del testo, in Letteratura italiana, iv, L’in-terpretazione, a cura di Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi, 1985, pp. 141-244.
Il contributo di Roberto Antonelli è l’occasione elettiva per *ssare, alla metà degli anni ’80, le coordinate e i limiti interpretativi della critica testuale. L’esigenza che muove Antonelli è anzitutto (com’è ovvio per un volume che, seppur nella straordinaria analiticità, può de*nir-si ‘di strumenti’) descrittiva, al *ne di o3rire una panoramica sulla disciplina il più possibile completa; senza tuttavia rinunciare, de*nizione dopo de*nizione, a un’attiva ridiscussione e attualizzazione di temi e concetti chiave : il testo, l’interpretazione e l’allegoria, la tradizione e la sua ‘gerarchia’ stemmatica (con questo descrivendo un percorso evolutivo del metodo lachmanniano), le aporie e la ‘crisi’ del lachmannismo, con le questioni poste da Bédier e poi discusse prima da dom Quentin, poi da Michele Barbi ; quindi la contaminazione, le due tipologie di tradizione ‘quiescente’ e ‘attiva’, la di3razione, l’archetipo. Una fondamentale distinzione, che è introdotta da Antonelli nel solco del dibattito sul bédierismo, è poi quella tra tradizione ‘alta’ e ‘popolare’ (pp. 201 e ssg.) : nella tradizione alta al testo è riconosciuto un bagaglio di valori, ed è – nota Antonelli – « sull’individuazione di un patrimonio di valori [che] si fonda l’idea stessa di tradizione, consegna di qualcosa di autorevole che valga la pena di essere tramandato. Il valore del testo rimanda al valore dell’Auctor, della sua auctoritas ». È il metodo lachmanniano, suggerisce Antonelli, che meglio si presta, con la sua selettività dei materiali per giungere all’espressione di una volontà autoriale, a fornire l’immagine di un testo di tradizione alta. Viceversa è nella tradizione bassa, dove non viene posto il nesso di autorialità, che si mostra più stringente la concordanza tra le istanze di Bédier e i ‘post-lachmannisti’, tanto che Barbi stesso – nota Antonelli – arriva a formulare esplicitamente alcuni principi che in Bédier apparivano solo embrionalmente accennati : come quello che si debbano pubblicare tutte le ‘versioni’ di uno stesso testo poiché tutte ugualmente dotate di ‘valore’, gettando così pure uno sguardo signi*cativo sull’articolazione storica e geogra*ca del testo, « fondamentale per la storia della [sua] ricezione » (p. 201). È in questo contesto e in questa prospettiva che Antonelli introduce – per la prima volta – la nozione (tecnica) di ‘*lologia materiale’ : una de*nizione ampia, eventualmente precisabile come ‘codicologica’ e che parte dalla necessità/opportunità di disporre di riproduzioni del manoscritto (quale che ne sia il supporto) il più possibile fedeli, attraverso edizioni facsimile o diplomatiche, nonché dall’esigenza di studiare il singolo testimone come documento di cultura ; questo tipo di approccio, che ha radici antiche e che nel secondo dopoguerra ha ottenuto nuova spinta sulla base di esigenze d’indagine « storico-sociali » (p. 207), deve per Antonelli legarsi all’operato *lologico secondo « prospettive nuove, complementari piuttosto che opposte a quelle di tipo lachmanniano e legate alla riappropriazione del Passato quale storia della fru-izione e (ri)produzione del Testo » (ibidem). Al momento in cui Antonelli scrive, questo tipo di indagini caratterizza speci*camente un settore degli studi *lologici, quello della *lologia medievale e umanistica ; ma ne è auspicata l’estensione tout court alla *lologia volgare, come « presupposto (e *ne) indispensabile di ogni indagine sulla tradizione » (p. 209). Evocando la combinazione pasqualiana di ‘storia della tradizione’ e ‘critica del testo’, l’autore suggerisce che lo studioso si trasformi in uno « speleologo o un archeologo del sapere » (p. 208), la cui indagine deve partire anzitutto dalla « materialità del testo » e dalla sua « storicità e3ettuale » (ibidem) ; il che signi*ca, secondo Antonelli, indagare il codice nella sua *sionomia (e dunque il supporto, la fascicolatura, l’inchiostro, gli elementi del testo decorativo – ovvero l’editing, in tutte le sue forme – e *gurativo, i suoi rapporti di copia con altri manoscritti) ma anche
repertorio bibliografico ragionato160
n�� �n ��� � ��� ��� �� ����� � ���� � ��� �� �� ����n���n � �n ��n�� ������ �� ����� : per ricostruire, come nota l’autore, una ‘tradizione materiale’ che si a"anchi all’indagine complessiva della tradizione culturale e letteraria e ne costituisca l’arricchimento.
[d. m.]
Avalle d’Arco Silvio, I canzonieri : de�nizione di genere e problemi di edizione, in La critica del testo. Problemi di metodo ed esperienze di lavoro, Atti del Convegno di Lecce, 22-26 ottobre 1984, Roma, Salerno Editrice, 1985, pp. 363-382.
La risposta alla domanda su come il lettore moderno debba a2rontare la lettura di testi medievali è ricercata da Avalle nel libro stesso, nella sua consistenza e nel suo signi4cato ideologico. Sono prese in esame due diverse tipologie che la raccolta di liriche può assu-mere : il Liederbuch d’autore e la raccolta antologica. La prima risulta di2usa a livello eu-ropeo : malgrado la ben nota tendenza medievale all’anonimato, molti poeti recuperano l’usanza classica di raccogliere sotto il proprio nome le loro opere. Diverse e notevoli le implicazioni culturali riscontrabili nell’‘antologia’. Essa, assemblata dalla ‘critica mili-tante’ più o meno coeva alle opere, costituisce un fondamentale « modello autointerpre-tativo » (la terminologia è di Lotman) e va quindi letta come prodotto di una selezione formalmente e ideologicamente motivata dall’esigenza di proporre l’immagine di una cultura omogenea, di fondare una norma. Dinanzi alla verità del manoscritto – altra rispetto a quella degli autori in esso rappresentati – due compiti saranno allora i compiti del ricercatore : da una parte l’analisi codicologica, in cui la materialità del testimone non solo fornirà informazioni utili per la ricostruzione stemmatica, ma impedirà pure quel fenomeno di ‘rimozione del codice’, frequente nelle edizioni critiche ; dall’altra l’indagine su contenuto e struttura della raccolta, in grado di consentire la corretta interpretazione della cultura in cui essa nacque. Segue un saggio di applicazione di tali prospettive di ricerca ai tre canzonieri italiani antichi.
[f. s.]
B.
Aquilecchia Giovanni, « Redazioni a stampa » originarie e seriori (Considerazioni di un editore di testi cinquecenteschi), in I canzonieri : de�nizione di genere e problemi di edizione, in La critica del testo. Problemi di metodo ed esperienze di lavoro, Atti del Convegno di Lecce, 22-26 ottobre 1984, Roma, Salerno Editrice, 1985, pp. 67-80.
Avvalendosi della « bibliogra4a testuale » (« come mi pare si possa ormai de4nirla anche da noi », p. 70), in quanto disciplina che studia il libro a stampa « sì come oggetto materiale nella sua struttura cartacea e nella sua componente tipogra4ca, ma ai 4ni della identi4cazione della stampa cui appartiene e della valutazione cronologica e attributoria degli errori e delle varianti » (p. 70), Aquilecchia, editore delle Sei giornate : Ragionamento della Nanna e della Antonia (1534) ; Dialogo nel quale la Nanna insegna a la Pippa (1536) di Pie-tro Aretino (Bari, Laterza, 1969, nella cui nota condannava già « il divorzio […] tra ricerca bibliogra4ca e critica letteraria », p. 369) traccia, sulla scorta del saggio di V. A. Dearing, The Case for Authorial Revision (« Studies in Bibliography », 1955), i tipi di revisione (revisione semplice, revisione regressiva, revisione continuata) condotte da uno scrittore, in particolare in sede tipogra4ca.
la materialità nella filologia (1985-2007) 161
����
B.
Crapulli Giovanni, Contributi della bibliogra!a materiale alla critica testuale, in Le edizioni dei testi !loso!ci e scienti!ci del ’500 e del ’600. Problemi di metodo e prospet-tive di ricerca, Atti del seminario di Studio di Gargnano, 1-3 aprile 1985, a cura di Guido Canziani, Gianni Paganini, Milano, FrancoAngeli, 1986, pp. 57-72.
Disponibile ora anche in Tamquam explorator. Percorsi, orizzonti e modelli per lo studio dei libri, a cura di M. C. Misiti, Manziana (Rm), Vecchiarelli, 2005, pp. 93-108, il saggio di Crapul-li, storico della 'loso'a, ma anche precoce frequentatore della bibliologia, a*ronta il proble-ma dell’edizione dei testi 'loso'ci e scienti'ci del Cinque e Seicento. Pur privilegiando le ricerche di natura lessicologica e lessicogra'ca, Crapulli si rende conto che non è possibile ignorare i problemi relativi alla trasmissione dei testi e in particolare la dimensione materiale del libro. Egli arriva così a concludere che « l’editore di un testo deve assolvere due funzioni, l’una critica e l’altra storiogra'ca, operando nell’ambito della bibliogra'a materiale. Con la prima cerca di risalire al testo nella sua forma redazionale originale che l’autore ricono-scerebbe come sua, con la seconda documenta le forme in cui il testo ci è e*ettivamente pervenuto » (p. 71).
Quando parla di bibliogra'a materiale, Crapulli compie un calco sul francese bibliographie matérielle, intendendo ciò che in inglese è espresso con analytical bibliography e in italiano ha assunto la forma di ‘bibliologia’. Crapulli, talvolta, assimila la bibliogra'a materiale alla bibliogra'a testuale (textual bibliography) di cui Conor Fahy ha fornito in italiano un’ottima introduzione (Introduzione alla « bibliogra!a testuale », « La Biblio'lia », lxxxii, 1980, pp. 151-182, poi anche in Sa%i di bibliogra!a testuale, Padova, Antenore, 1988, pp. 33-64).
Dopo una panoramica dei problemi relativi all’organizzazione del lavoro in tipogra'a e di come questi in6uiscano o possano in6uire sulla trasmissione dei testi, Crapulli passa, in ideale confronto con George Thomas Tanselle (The concept of « Ideal Copy », « Studies in Bi-bliography », xxxiii, 1980, pp. 18-53), a de'nire le varie fasi della ricostruzione dell’« esemplare ideale », ovvero di quell’esemplare, caratteristico della descrizione bibliogra'a analitica con intento 'lologico, che comprende tutti gli stati tipogra'ci. Il processo è di tipo 'lologico e comprende l’inventariazione degli esemplari, la loro collazione al 'ne di rilevare i di*erenti stati, la determinazione di interventi di revisione, la de'nizione della formula collazionale e la descrizione, in'ne la classi'cazione degli esemplari nelle varie famiglie.
[l. r.]
1987
A.
Huot Sylvia, From Song to Book. The Poetics of Writing in old French Lyric and Lyri-cal Narrative Poetry, Ithaca (ny)-London, Cornell University Press, 1987.
La letteratura medievale si presenta al tempo stesso come più orale e più visiva di quella contenuta nei libri d’oggi. Con tale paradosso si apre l’Introduction (pp. 1-8) ad uno studio che si pre'gge di fornire elementi utili per rispondere ad un quesito fondamentale : quale il ruolo del libro nel tardo medioevo ? Interrogativo tutt’altro che neutro, per le implicazioni
repertorio bibliografico ragionato162
d tipo sia materiale sia ideologico legate appunto ad un ruolo rilevante dell’oralità e ad una produzione manoscritta delle cui dinamiche si sa ancora troppo poco. L’analisi è condotta a tre livelli, quello codicologico, quello iconogra#co e quello poetico-letterario : quest’ultimo è sempre predominante, in quanto scopo dell’approccio alla singola opera è pur sempre quello di farne scaturire la corretta interpretazione nel dispiegarsi, in diacronia, della sua tradizione. Così la fusione dell’istanza lirica con quella narrativa in una tipologia nuova di testo è intesa come dinamica letteraria necessariamente parallela alla codi#cazione scritta di un genere, la poesia dei trovieri, cui l’oralità è consustanziale. La prima parte (On the Nature of the Book in the Thirteenth and Fourteenth Centuries) getta uno sguardo preliminare sull’orga-nizzazione delle raccolte miscellanee tra xiii e xiv secolo : nel primo capitolo (Scribal Practice and Poetic Process in Didactic and Narrative Anthologies, pp. 11-46) sono analizzate le antologie di opere didattiche e narrative, il secondo (Scribal Practice in Lyric Anthologies : Structure, For-mat, and Iconography of Trouvère Chansonniers, pp. 46-80) tratta invece delle sillogi liriche. La seconda parte (Lyricism and the Book in the Thirteenth Century) sviluppa lo studio di opere, in cui centrale è la dialettica tra lirismo e narratività : il Roman de la Rose (Singing, Reading, Wri-ting : Guillaume de Lorris, Jean de Meun, and the Manuscript Tradition of Le Roman de la Rose, pp. 83-106), il Guillaume de Dôle e il Roman du castelain de Couci (Text as Performance, Text as Ar-tifact : Contrasting Models for the Romance with Lyric Insertions, pp. 106-134), il Bestiaire d’amours (The Audiovisual Poetics of Lyrical Prose : Li Bestiaire d’amours and Its Reception, pp. 135-174), il Roman de la Poire e il Dit de la Panthère (Lyrical Writing and Compilation in Le Roman de la Poire and Le Dit de la Panthère d’amours, pp. 174-208). La terza parte (Lyricism and the Book in the Fourteenth Century) presenta alcuni esempi signi#cativi del compiersi nel xiv secolo di quel processo di progressiva organizzazione dei libri di poesia sulla base della personalità di un autore, segno di una nuova mentalità da parte di poeta e pubblico. Il settimo capitolo (The Vernacular Poet as Compiler : The Rise of the Single-Author Codex in the Fourteenth Century, pp. 211-242) immortala una fase ancora di transizione, segnata dall’a3ermarsi della forma dit, mentre ai casi ormai moderni di trionfo della scrittura come scelta di poetica in Machaut e Froissart sono consacrati gli ultimi capitoli (From Song to Book in an Early Redaction of the Oeuvre of Guillaume de Machaut : The Codex Bibl. Nat. fr. 1586, pp. 242-274 ; A Late Redaction of Machaut’s Œuvre : The Codex Bibl. Nat. fr. 1584, pp. 274- 302 ; The Poetic of Lyrical Writing in the Works of Jean Froissart, pp. 302-328). Il bilancio #nale (Conclusion, pp. 328-338) auspica l’am-pliamento della prospettiva di ricerca qui proposta ad altri generi e ad altre letterature, in uno studio comparato dell’emergenza della personalità autoriale e della dinamica de#nibile « from song to book » nell’Europa medievale.
[f. s.]
Zufferey François, Recherches linguistiques sur les chansonniers provençaux, Genève, Droz, 1987.
La tradizione manoscritta trobadorica si contraddistingue per un notevole polimor#smo linguistico e grafematico, dovuto tanto al divario cronologico che separa il periodo di pro-duzione della maggior parte dei testi e l’epoca di compilazione delle raccolte conservate, quanto alla pluralità dei luoghi in cui tali manoscritti sono stati copiati e alla natura com-posita connaturata a sillogi di questo tipo. Anche nel tentativo di agevolare il lavoro degli editori critici, la ricerca di François Zu3erey analizza alcuni canzonieri provenzali compilati nella Francia meridionale studiandone sistemi gra#ci e natura linguistica (con particolare attenzione per le forme abitualmente ritenute estranee alla occitanica), ma anche, qualora sia possibile un’analisi stratigra#ca dei diversi diasistemi sedimentatisi nel codice, tentando di individuare le fonti con<uite nel singolo manoscritto. Considerata l’inevitabile impossibilità di distinguere con certezza i tratti e3ettivamente risalenti all’autore, quelli in-seriti dall’ultimo copista del testo e quelli introdotti nelle fasi intermedie della trasmissione, risulta particolarmente funzionale il concetto di « scripta de la tradition à laquelle se rattache
la materialità nella filologia (1985-2007) 163
[!"# chansonnier » (p. 30) : più manoscritti derivanti da un medesimo antecedente presentano infatti tratti condivisi derivati dall’antigrafo comune, ma anche altri non attestati nei codici collaterali che si con"gurano quindi come innovazioni delle singole raccolte. François Zuf-ferey analizza nel primo capitolo quella che de"nisce « tradition auvergnate » (A A’ B D Da I K a e i frammenti di Udine e Parigi), a sua volta suddivisibile in « tradition uni"ée » (A A’ B), contraddistinta dalla tendenza propria dei compilatori in questione a uniformare anche gra-"camente i loro modelli durante la copiatura, e « tradition non uni"ée ». Per il primo dei due gruppi, l’analisi linguistica è condotta sottoponendo il corpus di poesie di Folchetto di Marsi-glia vergato in ognuno dei tre manoscritti a un medesimo questionnaire linguistique, permet-tendo così di individuare a*nità e di/erenze tra i codici ; i tratti così individuati permettono di collocare il luogo d’origine di questa tradizione nell’Haute-Auvergne. Uc de Saint Circ, attivo alla corte del Dal" d’Alvernha, avrebbe giocato un ruolo decisivo sia nella de"nizione di questa costellazione, sia nel suo trapianto in Italia con il « prolongement vénète ». La « tra-dition non uni"ée » è costituita dal canzoniere di Bernart Amoros, il cui studio linguistico permette di intravedere la presenza di una fonte principale linguadociana o provenzale a monte della raccolta. Segue l’analisi della « tradition languedocienne », suddivisibile in un ramo occidentale (C R, con il « prolongement lombard » di M G Q) e in uno orientale (b E J e, in parte, L N). Viene poi analizzato in quanto specimen della « tradition provençale » f, la cui compilazione è localizzabile ad Arles. La prima mano che verga il marciano V e il canzoniere Z, contraddistinto da una stratigra"a complessa che il copista particolarmente fedele al suo modello lascia trasparire, sono studiati in quanto rappresentanti dei manoscritti prodotti in Catalogna. Y, bipartito materialmente e anche linguisticamente, è invece particolare caso di silloge esclusivamente provenzale allestita in area oitanica. L’autore conclude il volume auspicando studi sulla natura grafematica e linguistica di singoli manoscritti, con particolare attenzione per la complessa stratigra"a di quelli compilati in Italia ; queste sarebbero a suo avviso imprescindibili operazioni preliminari all’analisi dell’idioletto di ogni trovatore. La ge-nerale uniformità linguistica che caratterizza i canzonieri trobadorici nel loro insieme risul-terebbe dunque spiegabile non solo alla luce della sostanziale conservatività della lingua d’oc e della predominanza del relativamente ristretto vocabolario cortese nell’ambito della pro-duzione letteraria che qui interessa, ma anche di un progressivo intervento normalizzatore operato dai copisti. Proprio poiché « les variantes graphiques n’ont d’intérêt que lorsqu’elles sont envisagées dans l’ensamble d’un manuscrit », l’autore suggerisce agli editori critici di abbandonare il metodo del manoscritto-base nella scelta della veste linguistica da conferire al testo, « en adoptant l’un des systèmes décantés que nous avons présentés » (p. 319). Questo saggio, dunque assai rilevante dal punto di vista metodologico, ha suscitato un ampio e produttivo dibattito : cfr., in particolare, Lino Leonardi, Problemi di stratigra!a occitanica. A proposito delle Recherches di François Zu#erey, « Romania », cviii, 1987, pp. 354-386.
[s. r.]
B.
Stoppelli Pasquale (a cura di), Filologia dei testi a stampa, Bologna, Il Mulino, 1987.
Il volume, prezioso e di fatto rimasto unico nel suo genere, ha il merito di raccogliere, in traduzione italiana, alcuni tra i migliori e fondamentali saggi su cui si fonda la textual biblio-graphy di matrice anglosassone. Le ampie indicazioni bibliogra"che, divise per argomenti, che chiudono l’antologia, contribuiscono a renderla un vero e proprio manuale che intro-duce « in quel particolare settore della ricerca bibliogra"ca […] che in italiano non fa alcuna di*coltà chiamare “bibliogra"a testuale”» (p. 9). Il "ne a cui mira questa disciplina, com’è noto, « è la valutazione degli e/etti prodotti da un processo di stampa sulla completezza e
repertorio bibliografico ragionato164
l$ correttezza del testo ». Partendo dalle sempre preziose considerazioni di un maestro della disciplina !lologica come Giorgio Pasquali (Storia della tradizione e critica del testo, Firenze, Le Monnier, 1934), l’Introduzione di Stoppelli mostra come sia naturale la maggiore attenzio-ne anglosassone ai problemi della tradizione testuale a stampa, rispetto al mondo italiano, dove invece l’attenzione si è concentrata sul manoscritto. Infatti, il maggiore autore di lingua inglese è William Shakespeare di cui non ci rimangono testimoni manoscritti, ma solo opere a stampa. In Italia, invece, anche se non mancano autori importanti !oriti in piena epoca tipogra!ca, la tradizione più antica e signi!cativa delle tre corone !orentine risulta, ovvia-mente, manoscritta, collocandosi ben prima dell’invenzione di Gutenberg.
Non è un caso, dunque, che anche la tradizione testuale a stampa di alcuni autori italiani, sia stata presa in considerazione da studiosi inglesi : si pensi, solo per fare qualche esempio, a Conor Fahy con l’Orlando Furioso (L’Orlando Furioso del 1532. Pro%lo di una edizione, Milano, Vita e Pensiero, 1988-1991, si veda qui la scheda di Giancarlo Petrella), a Neil Harris per l’In-namorato (Bibliogra%a dell’Orlando Innamorato, Modena, Panini, 1991, si veda qui la scheda di Giancarlo Petrella) e ancora a Fahy per I Promessi Sposi (Per la stampa dell’edizione de%nitiva dei Promessi sposi, « Aevum », 56, 1982, pp. 377-394, ora anche in Idem, Sa&i di bibliogra%a testuale, Padova, Antenore, 1988, pp. 213-244, si veda più oltre la scheda).
La bibliogra!a testuale, che, secondo Fredson Bowers, è un ramo della bibliogra!a ana-litica, « rappresenta un metodo per raccogliere dagli oggetti materiali che trasmettono il testo, cioè i libri a stampa, il massimo dell’informazione (sul testo) che essi sono in grado di o7rire » (p. 12). È importante tenere presente, tuttavia, che essa non rappresenta solo uno strumento, ma « rivelando la speci!cità delle trasmissioni a stampa, condiziona in modo sostanziale anche le procedure editoriali ». Una speci!ca competenza nel settore della bi-bliogra!a e, ancor di più, della bibliologia (la conoscenza cioè del sistema di fabbricazione e di7usione del libro antico a stampa), rappresenta un presupposto culturale fondamentale per l’editore di testi letterari che non hanno una tradizione manoscritta.
Ecco allora il senso di raccogliere per il pubblico italiano un’antologia di saggi fondamentali della tradizione bibliogra!ca anglosassone. Antologia che oggi, a oltre vent’anni dalla sua pub-blicazione, mantiene inalterati valore e utilità. Compaiono, infatti, tutti i nomi più importanti di questa disciplina, Walter Greg, considerato con Ronald B. McKerrow, il fondatore della mo-derna bibliogra!a, Philip Gaskell, Fredson Bowers, Thomas Tanselle e Conor Fahy.
Si inizia con Walter Wilson Greg (1875-1959), Il criterio del testo base (pp. 33-52), pubblica-to per la prima volta in « Studies in Bibliography », iii, 1950-1951, pp. 19-36 e poi nuovamente nei suoi Collected Papers (a cura di J. C. Maxwell, Oxford, Clarendon Press, 1966, pp. 374-392) usciti postumi. Questo saggio di Greg « costituisce per giudizio unanime il contributo me-todologico più importante della critica testuale inglese » del xx secolo. In ideale dialogo con McKerrow, Greg intende chiarire l’angusto concetto di testo-base (copy-text), introducendo anche problemi complessi come quello di lezione ‘sostanziale’ e lezione ‘accidentale’ applicati soprattutto alla gra!a dei testi antichi (inglesi in modo particolare). Vengono poi enunciati i criteri per l’edizione critica del teatro rinascimentale di cui Greg fu bibliografo (A bibliography of the English printed drama to the Restoration, London, Oxford University Press, 1939-1959).
A La trasmissione del testo (pp. 53-72) è dedicato il secondo saggio della raccolta, a !rma di Philip Gaskell (1926). Il testo, pubblicato in A New Introduction to Bibliography (Oxford, Clarendon Press, 1972, qui però è impiegata la terza edizione, 1978, pp. 343-358), assolve « il compito di illustrare i modi del passaggio del testo in tipogra!a » (p. 17). In questo saggio, concentrandosi soprattutto sui vari passaggi che caratterizzano la composizione tipogra!ca (il libro da cui è tratto è un ottimo manuale di bibliogra!a o, meglio, un’introduzione alla storia della tipogra!a e della fabbricazione della carta), Gaskell mostra una vasta gamma di errori che possono veri!carsi in questa fase seguendo le caratteristiche del lavoro del com-positore e del correttore.
George Thomas Tanselle, Il concetto di esemplare ideale (pp. 73-106), prende in considera-zione uno dei concetti (bibliogra!co e non !lologico) su cui si fonda la bibliogra!a analitica : l’ideal copy, proprio della tradizione a stampa e, evidentemente, non applicabile al mondo
la materialità nella filologia (1985-2007) 165
%&' manoscritto. All’interno dello stemma, occorre tener presente di tutte le varianti di stato riscontrabili in un’edizione. Se è ormai assodato (o dovrebbe esserlo) che nella stampa tipo-gra"ca di antico regime esistono innumerevoli varianti all’interno di ogni edizione, va da sé che nella bibliogra"a si deve considerare non l’edizione e tanto meno il singolo esemplare, ma quell’esemplare ideale, molto probabilmente mai esistito nella realtà, che comprende tutte le varianti di stato presenti in una determinata edizione. Purtroppo questo, eviden-temente, non è sempre possibile. Basti ricordare, come caso limite, tutte quelle edizioni sopravvissute in un unico esemplare. A livello di critica del testo, invece, qualora esista una tradizione diretta da un’edizione a un’altra, bisognerà inserire nello stemma non l’edizione e nemmeno l’esemplare ideale, ma capire di volta in volta quale esemplare (che potrebbe non essere sopravvissuto) testimonia l’antigrafo usato dal tipografo per stampare la nuova edizione. I casi possono essere molteplici e si rimanda all’Introduzione (pp. 7-32) di Stoppelli per una panoramica più precisa e dettagliata.
Il metodo per la descrizione bibliogra"ca dell’esemplare ideale è stato teorizzato da uno dei massimi bibliogra" del Novecento, Fredson Bowers, nei suoi Principles of Bibliographi-cal Description (Princeton, Princeton University Press, 1949) un vero e proprio caposaldo della bibliogra"a analitica. Nel volume di Stoppelli si trova il saggio di Bowers, L’autorità multipla. Nuovi problemi e concetti del testo-base (pp. 107-146), che dimostra « quanto sia importante nei testi moderni l’analisi bibliogra"ca, anche per de"nire l’ultima volontà dell’autore » (p. 30). Servendosi di numerosi esempi, Bowers dimostra come la teoria del testo-base di Greg non sia sempre applicabile, tenuto conto, soprattutto, delle numerose professionalità che contri-buiscono alla de"nizione ‘"nale’ del testo che esce dai torchi della tipogra"a.
Anche il secondo dei saggi di Tanselle presenti nell’antologia curata da Stoppelli, Il proble-ma editoriale dell’ultima volontà dell’autore (pp. 147-190), o1re una ri2essione sul delicato pro-blema, divenuto centrale nella moderna critica del testo, dell’ultima volontà dell’autore.
Chiude la carrellata di testi Conor Fahy, Sguardo da un altro pianeta. Bibliogra"a testuale ed edizione dei testi italiani del xvi secolo (pp. 191-216), saggio disponibile anche nella raccolta Sa#i di bibliogra"a testuale (pp. 1-32 cit.). Fahy, partendo dall’assunto che non sussiste, per i testi italiani del Cinquecento, la distinzione operata da Bowers della bibliogra"a testuale come branca della bibliogra"a analitica, cerca di rispondere a tre domande di fondo : « Fino a che punto le scoperte della bibliogra"a anglo-americana possono essere applicate alla stam-pa italiana del sedicesimo secolo […] ? Poi, vi sono delle speci"che di7coltà a cui in Italia va incontro chi fa ricerche di bibliogra"a testuale ? In"ne, le pratiche editoriali anglo-americane possono e dovrebbero essere adottate nell’edizione dei testi italiani del sedicesimo secolo ? » (pp. 193-194). In tal senso, il bel saggio di Conor Fahy, si pone come ideale ‘postfazione’ di questa raccolta, in quanto sembra trarre, indirettamente, alcune signi"cative conclusioni applicative.
[l. r.]
1988
A.
Cingolani Stefano Maria, Considerazioni sulla tradizione manoscritta delle vidas trobadoriche, in Actes du xviiie Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, Université de Trèves-Trier, 1986, vi, a cura di Dieter Kremer, Tübin-gen, Niemeyer, 1988, pp. 108-116.
L’autore intende mostrare come sulle generali dinamiche individuate già da Gröber che portarono alla formazione dei canzonieri di lirica provenzale intervengano anche alcuni
repertorio bibliografico ragionato166
m())*+,-m, *. (--( (-/0*+(, )1( /023*+2 4,5-/,6)*7,2+( ,+ 80(),-( 0(*9/: -/20,)2;)59/50*9, 2in progetti editoriali ben de!niti. Paradigmatica si rivela da questo punto di vista la tradi-zione delle vidas : si propone così una tipologizzazione delle sillogi occitaniche che tenga in conto non solo, gröberianamente, l’ordinamento delle poesie, ma anche « la presenza di testi non-lirici ; la disposizione delle vidas e, eventualmente, delle razos ; il modo di an-tologizzazione della lirica » (p. 112). Proprio la posizione di vidas e razos rispetto ai compo-nimenti commentati può o*rire i criteri per una ripartizione tassonomica dei canzonieri trobadorici in tre tipologie dotate di « ben preciso valore strutturale, e perciò intenzionale » (p. 113). L’autore nota poi come studi dedicati ai singoli manoscritti possano aiutare a in-dividuare a/nità anche di tipo materiale tra raccolte appartenenti ad aree linguistiche e culturali di*erenti.
[s. r.]
B.
Fahy Conor, Sa!i di bibliogra"a testuale, Padova, Antenore, 1988.
Il volume è uno dei capisaldi per quanti si occupano a vario titolo di bibliogra!a o, meglio, di bibliologia (all’italiana) o bibliogra!a analitica (secondo la terminologia anglosassone). Il libro si divide piuttosto nettamente in due parti : nella prima, intitolata Contributi metodolo-gici, si trovano sei saggi di carattere generale, che servono a inquadrare la disciplina, i suoi ambiti e alcuni concetti fondamentali ; nella seconda parte, sotto il titolo di Studi bibliogra"ci, si passa dalla teoria alla pratica, con l’autore che mostra sette brillanti applicazioni concrete delle metodologie della bibliogra!a testuale.
La raccolta si apre con il saggio che chiude un’altra importante antologia di testi sulla bibliogra!a testuale, cioè il volume Filologia dei testi a stampa, a cura di Pasquale Stoppelli, Bologna, Il Mulino, 1987 (si veda qui la relativa scheda). Si tratta di Sguardo da un altro pianeta. Bibliogra"a testuale ed edizione dei testi italiani del xvi secolo (pp. 1-32), un contributo in cui Fahy, analizzando la situazione bibliogra!co-bibliotecaria italiana, cerca di veri!care l’applicabilità della bibliogra!a testuale anglosassone nella Penisola.
I successivi due saggi sono, per i bibliogra!, dei veri e propri capisaldi. Nel primo, Introduzione alla bibliogra"a testuale (pp. 33-64), l’autore fornisce un’ampia e articolata de!-nizione della disciplina e degli ambiti che le sono propri, grazie anche ad alcuni esempi ; ne traccia inoltre una schematica storia identi!cando i personaggi più signi!cativi. Nel secondo, Edizione, impressione, emissione, stato, saggio che compare qui per la prima volta, Fahy chiarisce i quattro concetti cardine della bibliogra!a analitica. È chiaro, o dovrebbe esserlo, che nella tipogra!a antica i volumi che componevano una edizione non erano tutti uguali. È stato necessario, pertanto, costruire un sistema che de!nisse le famiglie a cui poi ricondurre i vari testimoni delle edizioni giunte !no a noi. La prima enunciazione di questi quattro concetti è di Fredson Bowers (Principles of Bibliographical Description, New York, Russell & Russell, 1962, pp. 37-114 e 379-426, la princeps però è Princeton, Princeton University Press, 1949), ma qui Fahy li riprende e li illustra con chiarezza anche al pubblico italiano.
Con Il concetto di ‘esemplare ideale’ (pp. 89-112), ci si sposta su un altro dei concetti enun-ciati per la prima volta da F. Bowers (Criteria for Classifying Hand-Printed Books as Issues and States, « Papers of the Bibliographical Society of America », xli, 1947, pp. 271-292), quello di ideal copy. Ricostruire questa (anche se mai !sicamente esistita) dovrebbe essere l’obiettivo della descrizione bibliogra!ca analitica, con il risultato di descrivere un esemplare così come l’avrebbe voluto l’editore. Le osservazioni di Fahy riguardano anche il saggio di George Thomas Tanselle, The Concept of ‘Ideal Copy’ (disponibile in italiano in Filologia dei testi a stampa, a cura di P. Stoppelli, pp. 73-106), che precisa in modo de!nitivo e più avanzato
la materialità nella filologia (1985-2007) 167
<= posizioni di Bowers a proposito della descrizione dell’esemplare ideale (per Tanselle la « descrizione standard di un libro »). Per Tanselle, la descrizione dovrebbe essere una vera e propria ricostruzione storica dell’intera impressione o emissione, che ne abbraccia tutti gli stati storicamente documentati.
Nell’ultimo saggio della prima sezione, Nota non-fantascienti�ca (pp. 113-122), anch’esso inedito, Fahy ‘smitizza’ in qualche modo il lavoro del bibliografo e lo mette in relazione con i nuovi strumenti che la tecnologia o"re, arrivando a concludere, giusto vent’anni fa, che il computer sarebbe diventato l’ancella della bibliogra#a, consentendo la realizzazione di schede e di percorsi di interrogazione impensabili tempo addietro.
Nella seconda sezione – quella forse più interessante per il #lologo puro – Conor Fahy con sette saggi tutti già pubblicati, ma con aggiunte inedite, o"re al lettore alcuni esempi di ‘bibliogra#a testuale applicata’ alla realtà italiana. I testi riguardano quasi tutti edizioni italiane del Cinquecento ma, con Per la stampa dell’edizione de�nitiva dei « Promessi Sposi » (pp. 213-244) ci si a"accia #no alla metà dell’Ottocento.
Variegato risulta il panorama degli autori considerati, mentre dal punto di vista geogra#-co è Venezia ad avere il ruolo più importante. Si va da Le due edizioni ‘napoletane’ delle « Forcia-ne questiones » di Ortensio Lando (pp. 123-140), in cui Fahy attribuisce a Lione e a Venezia le due edizioni (1535 e 1536) che recano invece la falsa data di Napoli, alla breve postilla Di un’edizione cinquecentesca dell’« Aminta » di Tasso (pp. 141-144), in cui l’autore fornisce alcune precisazioni a un omonimo contributo di Bortolo Sozzi (« Studi tassiani », xviii, 1968, pp. 37-43).
Alla princeps degli Asolani di Bembo è dedicata la Nota sulla stampa dell’edizione aldina del 1505 degli « Asolani » di Pietro Bembo (pp. 145-154), dove Fahy presenta qualche precisazione riguardo a un articolo di Cecil Clough (Pietro Bembo’s ‘Gli Asolani’ of 1505, « Modern Lan-guage Notes », lxxxiv, 1969, pp. 16-45), che dimostrava come la presenza in alcuni esemplari e l’assenza in altri della lettera dedicatoria a Lucrezia Borgia, rappresenti, contro l’opinione di Renouard, una semplice variante di stato e non di emissione.
Su un tema problematico come quello delle correzioni al torchio si so"erma Fahy nel saggio Correzioni ed errori avvenuti durante la tiratura secondo uno stampatore del Cinquecento : contributo alla storia della tecnica tipogra�ca in Italia (pp. 155-168), riportando la testimonianza contenuta in Girolamo Ruscelli, Del modo di comporre, Venezia, G. B. e M. Sessa, 1559.
Più lunghi e complessi gli ultimi tre saggi della raccolta. Nel primo Fahy ricostruisce le questioni e vicende editoriali relative a Le edizioni veneziane dei « Paradossi » di Ortensio Lando (pp. 169-212). Si passa poi a uno dei contributi più noti dell’autore, Per la stampa dell’edizione de�nitiva dei «Promessi Sposi» (pp. 213-244), che fornisce importanti precisazioni bibliogra#che riguardanti le tecniche di stampa, da sovrapporsi al ricco materiale docu-mentario utile alla ricostruzione del romanzo. L’ultimo contributo, L. Ariosto, « Orlando Furioso », Ferrara, Francesco Rosso, 1532. Pro�lo di una edizione (pp. 245-270), è una sintetica anticipazione dell’impresa più importante di Conor Fahy, L’«Orlando furioso» del 1532. Pro�lo di una edizione (Milano, Vita e Pensiero, 1989, si veda qui la scheda), su cui non occorrerà insistere oltre.
Il volume, in conclusione, se certo risulta più utile al bibliografo che non al #lologo, presenta, in ogni caso, le solide fondamenta teoriche della bibliogra#a analitica e testuale e una miniera di esempi metodologici a cui attingere : essi dimostrano come l’indagine bibliogra#ca possa essere un valido (a volte un necessario) elemento di integrazione alla critica testuale.
[l. r.]
repertorio bibliografico ragionato168
>?@?
A.
Careri Maria, Interpunzione, manoscritti e testo. Esempi da canzonieri provenzali, in Miscellanea di studi in onore di Aurelio Roncaglia, « Cultura Neolatina », xlvi, 1-4, 1986, pp. 23-41, poi in Miscellanea di studi in onore di Aurelio Roncaglia a cin-quant’anni dalla sua Laurea, i, Modena, Mucchi, 1989, pp. 351-370.
L’attenzione riservata dai copisti delle antologie trobadoriche alla scansione metrica delle poesie si rivela attraverso l’ampio utilizzo di espedienti gra/ci utili alla sua messa in rilievo ; alcuni trascrittori, nell’intento di rendere conto anche della struttura sintattica delle poesie, fe-cero ricorso a ulteriori segni utili allo scopo, il cui studio potrebbe rivelarsi produttivo anche ai /ni della ricostruzione critica dei testi. La studiosa propone una distinzione tra « interpunzione del manoscritto », propria del singolo manufatto e del trascrittore relativo, e « interpunzione del testo », presente in tutti i testimoni di un determinato componimento e dunque parte in-tegrante della sua tradizione. Si esempli/ca la prima tipologia con l’analisi dei segni utilizzati in H e L : tale genere di punteggiatura può risultare utile anche agli occhi dell’editore critico, che vi può intravedere sia uno strumento funzionale a un caso di esegesi antica del testo (arrivando talvolta a spiegare eventuali lectiones singulares), sia una proposta possibile di prassi interpuntiva. Caso emblematico di « interpunzione del testo » è invece quello delle coblas tenso-nadas ; l’autrice analizza l’intera tradizione manoscritta della sesta cobla della canzone di Peire Rogier Ges del tems com era gais riscontrandovi una punteggiatura forse risalente addirittura all’archetipo, i cui ‘errori di trascrizione’ ripartiscono i testimoni nei medesimi gruppi indi-viduabili a livello stemmatico. Su queste basi si propongono dunque due correzioni all’in-terpunzione adottata nel testo critico. Altri studi che si concentrano sull’importanza della punteggiatura vergata nei manoscritti, anche ai /ni della ricostruzione critica dei testi, sono Maria Careri, L’interpunzione nella tradizione manoscritta delle biogra!e trobadoriche, in Storia e teoria dell’interpunzione, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Firenze, 19-21 maggio 1988, a cura di E. Cresti, N. Maraschio, L. Toschi, Roma, Bulzoni, 1992, pp. 23-38 ; Anatole Pierre Fuksas, La scrittura prosodica dei canzonieri trobadorici : i vers ai companho di Gugliel-mo d’Aquitania, in Ritmologia, Atti del Convegno Il ritmo del lingua"io. Poesia e traduzione, Dipartimento di Linguistica e Letterature comparate dell’Università degli Studi di Cassino, 22-24 marzo 2001, a cura di F. Bu8oni, Milano, Marcos y Marcos, 2002, pp. 167-183.
[s. r.]
Meneghetti Maria Luisa, Il #orilegio trobadorico di Ferrarino da Ferrara, in Mi-scellanea di studi in onore di Aurelio Roncaglia a cinquant’anni dalla sua Laurea, iii, Modena, Mucchi, 1989, pp. 853-872.
La studiosa rintraccia in questo saggio alcune fonti caratteristiche dell’antologia appron-tata da Ferrarino da Ferrara (Dc, copiata intorno al quarto decennio del Trecento sulle carte 243-260v del manoscritto estense), ri<ettendo poi più in generale sull’origine e sulle implicazioni di ordine ricezionale della forma-<orilegio. Vari elementi portano a supporre che Ferrarino, dotato di scrupoli /lologici in particolare in ambito attributivo, non abbia operato una cernita e riduzione da una silloge di testi completi : egli trascelse gli items accolti nella propria crestomazia da un corpus di selezioni già allestito in precedenza, integrandolo poi con ulteriori materiali. Per alcuni dei loro contenuti sia F sia Dc dovettero comunque aver fatto ricorso indipendentemente al medesimo collettore di testi già scorciati ; tale ipo-tesi risulta confortata anche dal fatto che entrambi i <orilegi condividono numerose pièces
la materialità nella filologia (1985-2007) 169
aABCD con le collezioni di coblas esparsas trascritte in vari canzonieri trobadorici. La presenza di tale Sentenzensammlung già a monte del lavoro di selezione testimoniato dalle sillogi di esparsas e operato intorno alla "ne del Duecento da Dc e F attesta da una parte l’esistenza di una consolidata prassi antologizzatrice già a questa altezza cronologica, mentre dall’altra sottolinea una sostanziale identità di struttura e funzione svolta da #orilegi e raccolte di coblas. Operazioni di questo tipo rispondono in e$etti all’esigenza di prontuari di savoir-vivre cortese per nuovi pubblici, ancora a$ascinati dal messaggio trobadorico, ma ormai irrime-diabilmente distanti da quella dimensione culturale di cui i trovatori erano stati una delle espressioni più signi"cative.
[s. r.]
Meneghetti Maria Luisa, Il manoscritto fr. 146 della Bibliothèque Nationale di Parigi, Tommaso di Saluzzo e gli a%reschi della Manta, « Romania », cx, 1989, pp. 511-536.
B.
Fahy Conor, L’« Orlando furioso » del 1532. Pro*lo di un’edizione, Milano, Vita e Pen-siero, 1989.
Lo studio di Conor Fahy, originariamente nato come « breve intervento a un seminario sulla trasmissione dei testi a stampa nel periodo moderno », rappresenta un ‘classico’ della "lologia applicata ai testi a stampa nel quale l’autore ricostruisce, attraverso l’identi"cazione e la registrazione delle molteplici varianti interne, l’intervento costante di Ludovico Ariosto durante la fase di stampa dell’edizione del 1532. Partendo dagli studi degli anni venti del se-colo scorso di Santorre Debenedetti e Michele Catalano dedicati alla storia della stampa del Furioso del 1532, Conor Fahy applica i nuovi metodi e mezzi di ricerca bibliogra"ca al "ne di un’indagine più accurata delle caratteristiche di tutti gli esemplari superstiti dell’edizione del 1532. La collazione degli esemplari ricostruisce « la storia interna della stampa dell’edizione de"nitiva del Furioso », delineando quella che può essere de"nita, in termini bibliogra"ci, la descrizione dell’esemplare ideale del Furioso del 1532. Lo studio si sviluppa in due parti. La prima, Descrizione (pp. 15-92), fornisce una dettagliata recensio e descrizione delle copie note del Furioso del 1532, cui segue l’elenco delle varianti introdotte durante la stampa disposte secondo le singole forme tipogra"che. La seconda parte, Commento (pp. 95-176), sviluppa i dati emersi dalla collazione di tutti gli esemplari in un saggio articolato che ricostruisce le vicende editoriali delle tre edizioni del Furioso, per poi so$ermarsi sull’edizione de"nitiva del 1532 e sulle numerose varianti autoriali interne. Rispetto allo studio di Debenedetti, nel quale le varianti sono presentate in un contesto unicamente linguistico-stilistico, Conor Fahy le analizza invece per la prima volta dal punto di vista bibliogra"co. L’individuazione dello stato corretto e scorretto della forma tipogra"ca costituisce per il "lologo il discrimi-ne « nella scelta della variante seriore, oltre ogni considerazione di ordine contenutistico o linguistico-stilistico ». Il contesto bibliogra"co soccorre infatti il giudizio soggettivo del "lologo, fornendogli « una prova fattuale che renda più sicuro il suo lavoro ». Il volume è corredato di tre appendici : gli annali di Francesco Rosso, il tipografo del Furioso del 1532 ; una scheda sull’edizione del Furioso stampata a Roma dal Blado nel 1533 che rappresenta una copia dell’edizione de"nitiva e perciò priva di valore ai "ni della costituzione del testo de"nitivo del Furioso ; le varianti della copia autografa dell’episodio di Olimpia andata in tipogra"a. Su questo volume è poi intervenuto Neil Harris, Filologia e bibliologia a confronto nell’Orlando Furioso del 1532, in Libri tipogra* biblioteche : ricerche storiche dedicate a Luigi Bal-samo, a cura dell’Istituto di Biblioteconomia e Paleogra"a, Parma-Firenze, Università degli Studi di Parma-Olschki, 1997, pp. 105-122.
[g. p.]
repertorio bibliografico ragionato170
EFFG
A.
Brunetti Giuseppina, Sul canzoniere provenzale T (Parigi, Bibl. Nat. F. fr. 15211), « Cultura Neolatina », l, 1, 1990, pp. 45-73.
L’autrice si concentra inizialmente sullo studio degli elementi propriamente materiali di questo codice particolarmente composito (fascicolazione, qualità della pergamena e così via), traendone importanti conclusioni utili alla precisazione delle modalità e degli ambienti di produzione e ricezione della raccolta. Il manoscritto è palinsesto in molte delle sue carte 0nali, ove è stata riutilizzata pergamena originariamente adibita alla redazione di documenti notarili o registri : pare dunque delinearsi il pro0lo di un manufatto allestito da un privato per uso personale, assimilabile alla tipologia del « libro-registro » (secondo la de0nizione di A. Petrucci), alla quale sono da ricondursi anche altri testimoni della lirica romanza medie-vale pressoché coevi a T, quali il canzoniere Vaticano latino 3793. Risulta inoltre che alcune sezioni sono vergate completando quaternioni già precedentemente scritti ; è poi possibile individuare un vero e proprio Liederbuch isolabile anche materialmente. Segue un’analisi interna della sezione di liriche del manoscritto, 0nalizzata in particolare all’individuazione delle sue fonti : la studiosa, utilizzando, oltre alle edizioni critiche dei singoli componimenti, anche una tavola sinottica in grado di rendere conto della posizione di ogni testo di questa parte del codice nel resto della tradizione manoscritta trobadorica, identi0ca la presenza di due apporti principali a monte dell’antologia lirica, che si mescidano rispondendo a vari intenti degli allestitori, tra i quali spicca però in maniera netta il tentativo di costruire una raccolta il più completa e ampia possibile. L’analisi degli unica di T permette poi di circoscri-vere alcuni gruppi di testi accomunati dal fatto di essere stati composti in ambiti geogra0ci e cronologici a4ni : in questi casi il manoscritto parigino è dunque latore di componimenti altrimenti sconosciuti, la cui omogeneità di fondo risulta ulteriormente accentuata dalla natura della loro tradizione manoscritta. Segue un’appendice dedicata ad alcuni apparenti problemi di ordine attributivo, talvolta sintomatici di interventi riordinativi operati coscien-temente dai compilatori.
[s. r.]
Careri Maria, Il canzoniere provenzale H (Vat. Lat. 3207). Struttura, contenuto e fonti, Modena, Mucchi, 1990.
La Presentazione di Aurelio Roncaglia sottolinea la natura pionieristica di questo lavoro, ricordando l’ineludibile necessità di ricerche dedicate al singolo manoscritto, condotte sulla scia della gröberiana ‘stemmatica dei canzonieri’ e nella consapevolezza dell’intreccio che rende inevitabilmente interdipendenti analisi codicologica, grafematica e stemmatica. Lo studio si apre con un capitolo dedicato alla descrizione esterna del manufatto, funzionale all’individuazione non solo di caratteristiche relative alle sue modalità di allestimento, ma anche di elementi utili alla de0nizione del suo lettore implicito : il canzoniere, frutto di in-terventi operati a più riprese da tre mani e confezionato in uno scriptorium privato per uso personale, è tra l’altro palinsesto, vergato su pergamena che doveva precedentemente ripor-tare un testo universitario. Grazie all’analisi di questi dati di natura materiale, l’autrice riesce a razionalizzare l’apparente disordine della raccolta, individuando una primitiva ripartizione tradizionale per generi poi in gran parte snaturata dal progressivo apporto di nuovi materiali successivamente reperiti dai compilatori. Il confronto tra i contenuti di questo ‘canzonie-re originario’ di H e quelli degli a4ni ADI(K) porta a ritenere che il suo allestitore abbia
la materialità nella filologia (1985-2007) 171
pHIJKJLMNOPQO operato una cosciente selezione sulle sue fonti, optando per la trascrizione di testi in gran parte marginali ; interventi consapevoli del compilatore non sono in e!etti per nulla escludibili, considerate le sue competenze trobadoriche attestate da varie glosse apposte ai testi. Si procede poi all’individuazione delle fonti di ogni partizione del manoscrit-to : « più esattamente si è tentato di de$nire in modo analitico il rapporto tra la tradizione manoscritta e i dati codicologici » (p. 119), per poi proporre una più precisa collocazione di H nella tradizione stessa. Tale ricerca è stata svolta basandosi inevitabilmente sullo spoglio dell’edizione critica di ogni singolo testo trascritto nel canzoniere ; l’utile schedatura che segue in coda al volume raccoglie per ogni componimento della silloge anche questo tipo di dati. Confermando nella sostanza le conclusioni di massima di Gröber, la studiosa veri$ca che i primi testi trascritti dipendono per la maggior parte dalla costellazione (notevole la vicinanza con D, anche nell’ordine di trascrizione), sui cui materiali si innestano apporti allotri di diversa natura ; fonti più variegate caratterizzano invece le successive aggiunte a cui fu sottoposto il canzoniere. Segue l’analisi grafematica, condotta, per ogni mano, su una campionatura di testi e organizzata in due tabelle, una elaborata in modo da permettere di ricondurre le gra$e presenti nel manoscritto alle loro rispettive basi etimologiche, l’altra per poter compiere l’operazione inversa. L’autrice dichiara il valore necessariamente documen-tario di tale ricerca e segnala che « l’indagine propriamente linguistica non è parsa praticabile sulla base della documentazione disponibile, dal momento che un’esatta equivalenza grafe-ma/fonema può essere stabilita in un contesto linguistico propriamente occitanico […]. Tale risultato non è conseguibile con sicurezza nel caso di un canzoniere copiato in Italia, dietro alle gra$e del quale non possiamo che postulare un con*itto fra sistemi gra$ci e fonologici diversi » (pp. 220-221). Si editano poi le glosse apposte alle poesie, assai signi$cative sia per lo studio della ricezione antica dei testi, sia per individuare importanti indizi utili alla loca-lizzazione del manufatto (una zona del Veneto occidentale compresa tra Venezia, Padova e Treviso). Completano il volume l’edizione e lo studio della cosiddetta Summa dictaminis, l’edizione diplomatica delle carte di più complessa lettura e numerose riproduzioni fotogra-$che di luoghi signi$cativi del canzoniere.
[s. r.]
Martin Henri-Jean, Vezin Jean (a cura di), Mise en page et mise en texte du livre manuscrit, Paris, Éditions du Cercle de la Librairie-Promodis, 1990.
La Préface (pp. 9-14) curata da Jacques Monfrin chiarisce gli scopi dell’opera : tracciare, at-traverso un’ampia serie di esempi signi$cativi (ben 445 fotogra$e di ottima qualità), la storia del libro manoscritto nella civiltà occidentale, inteso tanto come $ssazione materiale di un discorso orale, quanto come oggetto centrale nello sviluppo della cultura, dall’antichità al medioevo. In particolare, Geneviève Hasenohr è responsabile del capitolo intitolato Tra-duction et littérature en langue vulgaire (pp. 229-352). Il semplice elenco dei titoli degli undici paragra$ o!rirà un’idea degli ambiti approfonditi dalla studiosa, con l’attenzione sempre rivolta al lay-out della pagina e alla strutturazione del testo al suo interno : Les origines monas-tiques, pp. 231-234 ; Le rythme et la versi"cation, pp. 235-238 ; Les chansons de geste, pp. 239-244 ; Les romans en vers, pp. 245-264 ; La prose, pp. 265-272 ; Les systèmes de repérage textuel, pp. 273-287 ; Discours vernaculaire et autorités latines, pp. 289-315 ; Bibles et psautiers, pp. 317-327 ; Les recueils lyriques, pp. 329-334 ; Les manuscrit théâtraux, pp. 335-340 ; Vers une nouvelle esthétique, pp. 349-352. È sottolineata la tendenza al progressivo a!rancamento del manoscritto in volgare dai modelli mediolatini, parallela alla crescente emancipazione della letteratura romanza dalla sua matrice latina. Tale dinamica si con$gura come una ricerca di resa espressiva funzionale alla tipologia del testo, la cui lettura è notevolmente orientata dalla sua stessa collocazione nella pagina e dal dispiego degli elementi gra$ci e iconogra$ci.
[f. s.]
repertorio bibliografico ragionato172
STTS
A.
Tyssens Madeleine (a cura di), Lyrique romane médiévale : la tradition des chanson-niers, Actes du Colloque de Liège, 1989, Liège, Bibliothèque de la Faculté de philosophie et lettres de l’Université de Liège, 1991. [Recensioni di Dominique Billy, « Revue de linguistique romane », lvii, 1993, pp. 171-181 ; Walter Meliga, « Medioevo Romanzo », xviii, 1993, pp. 115-123].
Il volume contiene il resoconto del Convegno tenutosi a Liège dal 14 al 16 dicembre 1989. La rilevanza tanto dell’oggetto – i canzonieri lirici romanzi, esaminati mediante contributi di taglio sia teorico sia sperimentale – quanto dei relatori, giusti7ca la scelta di presentare al lettore non solo il testo delle comunicazioni ma pure la registrazione delle discussioni da queste suscitate. Madeleine Tyssens introduce nell’Avant-propos (pp. 7-8) l’idea, coltivata soprattutto tra i 7lologi italiani e in particolare dalla ‘scuola romana’, che nello studio della lirica la critica testuale non possa prescindere dall’esame sistematico, materiale prima di tutto, delle sillogi che la tramandano. Tale presupposto è, per quanto concerne i canzo-nieri provenzali, ben inquadrato in un’ottica di sviluppo storico e argomentato in termini pragmatici dall’intervento di Aurelio Roncaglia (Retrospectives et perspectives dans l’étude des chansonniers d’oc, pp. 19-38). Il ripercorrere l’evoluzione dell’interesse nei confronti delle antologie medievali, dal xvi secolo ad oggi, prelude all’indicazione di pro7cue linee di svi-luppo attuali per la disciplina. Rispetto ai manoscritti, è a8ermata la necessità di muoversi in due direzioni principali : la riproduzione fotogra7ca e il loro esame ad ogni livello, donde la critica testuale e la ricerca storico-culturale potranno parimenti trarre giovamento. Maria Luisa Meneghetti (Les "orilèges dans la tradition lyrique des troubadours, pp. 43-60) si propone di de7nire la tradizione dei >orilegi presenti all’interno dei canzonieri provenzali. L’analisi, che prende le mosse da un preliminare studio della raccolta di Ferrarino da Ferrara (Eadem, Il "orilegio trobadorico di Ferrarino da Ferrara, in Miscellanea di studi in onore di Aurelio Roncaglia a cinquant’anni dalla sua Laurea, iii, Modena, Mucchi, 1989, pp. 853-872), individua due fonti originarie riprodotte liberamente dai singoli compilatori, a seconda del gusto o dell’impo-stazione ideologica della silloge, e identi7ca nei >orilegi una modalità antologica tipicamen-te italiana. La relazione di Agostino Ziino (Carattere e signi$cato della tradizione musicale trobadorica, pp. 85-170 ; alle pp. 170-212, tavola e note) verte sui canzonieri occitani dotati di notazione musicale. Il corpus dei testi accompagnati dalla melodia è studiato con particolare attenzione all’esigua consistenza e alla collocazione marginale nella tradizione : tra le poche conclusioni certe proposte, quella che testi e musiche abbiano avuto circolazione separata e di8erente fortuna. L’intervento di François Zufferey (A propos du chansonnier provençal M (Paris, Bibl. Nat., fr. 12474), pp. 221-242) puntualizza alcune questioni relative alla silloge – interpretazione della struttura globale, edizione di un unicum, analisi delle strati7cazioni della scripta – a integrazione degli studi della chartiste Anne-Claude Lamur (le cui con-clusioni sono parzialmente divulgate nell’articolo Aux origines du chansonnier de troubadours M (Paris, Bibl. Nat., fr. 12474), « Romania », cix, 1988, pp. 183-198) e propone l’abbozzo di una storia ‘interna’ del canzoniere. Valeria Bertolucci Pizzorusso (Osservazioni e proposte per la ricerca sui canzonieri individuali, pp. 273-302) si concentra sulle raccolte di componimenti monoautoriali, sostenendo l’importanza per indagini simili del ricorso alla 7lologia mate-riale. Sono esaminati i Liederbücher trobadorici, sia quelli la cui esistenza è ormai acclarata, sia quelli ancora da individuare, che andranno ricercati più facilmente tra i trovatori tardi (una nuova proposta riguarda Cerverí de Girona). Ampio spazio è poi dedicato al compatto nucleo di ‘versi e prose’ relativi a Bertran de Born, ricondotto alla corte dei Da Romano, cui
la materialità nella filologia (1985-2007) 173
UVWe conforme per gusto e ideologia. Maria Careri (Alla ricerca del libro perduto : un doppio e il suo modello ritrovato, pp. 329-376) divulga una propria recente e notevolissima trouvaille : un breve canzoniere provenzale conservato alla Real Academia de la Historia di Madrid (Mh2). L’esame di codice e contenuti rivela, in almeno una sua parte, una copia fedele del Libre per-duto di Miquel de la Tor, per la cui ricostruzione esso costituirà dunque una testimonianza fondamentale. Madeleine Tyssens (Les copistes du chansonnier français U, pp. 379-396) ana-lizza la materialità del canzoniere di Saint-Germain, 2n qui poco considerato dalla critica, malgrado la sua antichità. Lo studio di fascicolazione, gra2e, scripta e pièces tradite permette di comprendere le complesse fasi compositive della silloge, confermandone l’a3nità con l’altro canzoniere lorenese C. Roberto Crespo (Il ra#ruppamento dei « jeux-partis » nei canzo-nieri A, a e b, pp. 399-426) opera una disamina della consistenza e dell’ordinamento dei jeux-partis nei canzonieri artesiani. Sono due i nuclei di testi individuati, distinti per contenuto e orientamento culturale : l’uno, più antico, gravitante attorno a Guillaume le Vinier, l’altro risalente a qualche decennio più tardi, connotato decisamente in senso municipale, con la consacrazione di Jehan Bretel e della sua cerchia. Due pagine di storia letteraria, dunque, immortalate in due scatti generazionali successivi. Elsa Gonçalves (Sur la lyrique galego-portugaise. Phénoménologie de la constitution des chansonniers ordonnés par genres, pp. 447-464) in-daga la composizione delle tre sillogi che tramandano la lirica dei trovadores. Lo studio delle frequenti infrazioni al progetto originario di ordinamento delle raccolte per generi porta la 2lologa a farle in genere risalire al momento della fusione dei Liederblätter all’interno dei canzonieri. Il Rapport &nal di Jacques Monfrin (pp. 501-510) ripercorre gli argomenti trat-tati dai relatori, esprimendo soddisfazione per il generale e continuo a3namento da parte dei 2lologi delle competenze codicologiche. Il bilancio è assai positivo per la produzione provenzale e galego-portoghese, mentre in ambito oitanico, italiano e castigliano si attende ancora un progresso massiccio degli studi.
[f. s.]
Meneghetti Maria Luisa, Uc de Saint Circ tra &lologia e divulgazione (su data, formazione e &ni del Liber Alberici), in Il Medioevo nella Marca. Trovatori, giullari, letterati a Treviso nei secoli xiii e xiv, Atti del Convegno, Treviso, 28-29 settembre 1990, a cura di Maria Luisa Meneghetti, Francesco Zambon, Treviso, Premio Comisso, 1991, pp. 115-128.
Le carte 153-211 del codice provenzale D sono latrici di quello che il manoscritto stesso de2nisce Liber Domini Alberici, ovvero l’antologia personale di Alberico da Romano, proba-bilmente allestita da Uc de Saint Circ ; di essa il compilatore ha però trascritto solamente i componimenti che non aveva già copiato nelle prime 150 carte, vergate ricorrendo a una fonte diversa. La studiosa nota che i fogli 185v-211 sono contraddistinti dalla presenza di acquisizioni più frammentarie, variegate nella natura dei testi copiati e prossime alla data di allestimento del codice. Considerata la mancanza di materiali di questo tipo nella prima parte della raccolta, M. L. M. ipotizza che queste carte costituiscano la trascrizione inte-grale della seconda parte del Liber Alberici, dunque priva di riduzioni operate dal copista. La notevole assenza di Sordello dal canone dei poeti rappresentati nella raccolta mostra chiaramente la precisa rispondenza della selezione dei testi a criteri anche di natura politica, mentre la trascrizione nella silloge di un sirventese di Uc de Saint Circ contraddistinto da una datazione più bassa (1240) rispetto a quella dei componimenti del resto dell’antologia permetterebbe di datare l’allestimento del Liber Alberici intorno a questa data. L’importanza della risistemazione della tradizione trobadorica operata dal poeta caorsino alla corte dei da Romano è sottolineata ulteriormente dalla sua attività di autore di vidas e razos : tali testi rispondono all’esigenza di rendere perspicua a nuovi pubblici (nuovi tanto dal punto di vista geogra2co, quanto sociale) un’esperienza poetica che trovava la propria ragion d’essere solo nel contesto politico e culturale delle corti della nobiltà feudale occitanica. Tale operazione,
repertorio bibliografico ragionato174
XYZmettendo il Fortleben della lirica trobadorica in ambiti storici e socioculturali diversi da quelli originari, ne ha certamente orientato la successiva ricezione italiana.
[s. r.]
B.
Fahy Conor, voce Bibliogra!a testuale, in Enciclopedia Italiana (1979-1992). Appendi-ce (A-D), Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991, pp. 356-357.
Nella voce scritta per l’aggiornamento dell’Enciclopedia Italiana, Conor Fahy precisa che, per de+nire la bibliogra+a testuale, non bisognerebbe riproporre la consolidata espressione di Philip Gaskell (« la critica testuale applicata ai problemi […] dell’edizione di testi stampa-ti », in A New Introduction to Bibliography, Oxford, Clarendon Press, 1972), quanto conside-rarla « come riferentesi all’interfaccia fra due discipline diverse, lo studio analitico del libro stampato […] e la critica testuale » (p. 356). Dopo avere ricordato l’importanza dell’analisi materiale, e avere richiamato la lunga tradizione degli studi italiani sulla stampa antica (che tuttavia non hanno portato a un’analisi bibliogra+ca in sede di +lologia), Fahy indica alcune speci+cità della +lologia dei testi a stampa, riproponendone sinteticamente le caratteristiche, da lui già approfonditamente delineate nei suoi scritti più ampi.
Harris Neil, Bibliogra!a dell’« Orlando innamorato », i-ii, Modena, Panini, 1988-1991.
L’amplissimo lavoro di Neil Harris ricostruisce l’intricata vicenda editoriale dell’Orlando innamorato dall’edizione princeps del 1482-1483, attraverso le continuazioni e i rifacimenti, +no all’edizione del testo originale ad opera di Antonio Panizzi impressa a Londra nel 1830-1831. La storia editoriale e bibliogra+ca dell’Innamorato include tutte le edizioni del testo, anche se parziali, non invece le traduzioni. La bibliogra+a risulta divisa da Harris in sette capitoli che corrispondono alle « sette tappe maggiori nella fortuna e sfortuna dell’Innamorato » : le edizioni del testo originale anteriori al 1500 ; le edizioni del testo originale e le sue continua-zioni scritte da altri autori nel Cinquecento ; il Rifacimento di Francesco Berni ; la versione in sei libri curata dal poligrafo Lodovico Domenichi in edizioni dal 1545 al 1784 ; la stessa in una versione diversa, allestita dall’editore Bonelli, in edizioni tra il 1576 e il 1676 ; il Rifaci-mento del Berni dal Settecento ; in+ne l’edizione panizziana del 1830-1831. Il primo volume a5ronta la questione dal punto di vista strettamente bibliogra+co : Harris propone per ogni edizione dell’Innamorato una scheda allestita secondo la migliore tradizione dell’analytical bibliography anglosassone, nella quale fornisce, nell’ordine, una trascrizione semifacsimilare del frontespizio e del colophon, moltissimi dati bibliologici, una descrizione del contenuto, una descrizione dell’apparato iconogra+co presente nell’edizione, i riferimenti bibliogra+ci e in+ne l’elenco degli esemplari noti in collezioni pubbliche. Il secondo volume, oltre a un generoso apparato di indici e illustrazioni che completano le descrizioni fornite nelle schede del primo volume, raccoglie una serie di contributi che ricostruiscono l’ambiente storico e letterario nel quale nacque il poema, le vicende testuali e tipogra+che delle editiones principes oggi perdute, i rapporti di quest’ultime con le stampe veneziane e con l’unico manoscritto superstite del poema. L’indagine sulla tradizione a stampa cinquecentesca del poema è il pretesto a importanti digressioni su tipogra+ ed editori e sulla produzione cavalleresca del Cinquecento. I capitoli successivi indagano ancora dal punto di vista tipogra+co e testuale le giunte e i rifacimenti del Berni e del Domenichi, +no alla riscoperta ottocentesca da parte di Antonio Panizzi del quale viene messo in luce il metodo di lavoro critico e +lologico.
[g. p.]
la materialità nella filologia (1985-2007) 175
\]^_`bb` ce \fgh]_i Textual Criticism and Literary Sociology, « Studies in Bibliog-raphy », xliv, 1991, pp. 83-144.
Il lungo saggio di uno dei più illustri e autorevoli esponenti della bibliogra*a analitica anglo-americana mira, almeno parzialmente, a rispondere alle critiche di Donald McKen-zie alla teoria bibliogra*ca tradizionale fondata in gran parte sul magistero di Fredson Bo-wers, formulate in modo particolare in Printers of the mind, « Studies in Bibliography », xxii, 1969, pp. 1-75 (disponibile in italiano in Stampatori della mente e altri sa!i, Milano, Sylvestre Bonnard, 2003, per cui si veda la relativa scheda). Qui si fa largamente riferimento anche a Bibliography and the Sociology of Texts, London, The British Library, 1986 (disponibile in ita-liano in Bibliogra"a e sociologia dei testi, Milano, Sylvestre Bonnard, 1999, per cui si veda qui la relativa scheda).
Tanselle esordisce con l’osservazione che « if one considers systematic textual criticism to have begun with the Alexandrian librarians of the third century b.c., then one can say that for twenty-two and a half centuries the ultimate goal of textual criticism was – almost with-out exception – the establishment of texts as intended by their authors » (p. 83). Questi sono, è noto, i presupposti della *lologia e della critica testuale, messi in qualche modo in crisi da critiche sopraggiunte da alcuni ambienti degli studi letterari. Sono proprio tali posizioni (soprattutto quelle sociologiche di McKenzie e di Jerome McGann) che Tanselle ripercorre nel corso del saggio, tentando di fornire alcune risposte e riportando l’attenzione sulla tradi-zionale bibliogra*a testuale che così signi*cativi risultati ha ottenuto in area anglosassone.
Tanselle accusa McKenzie di aver costruito una disciplina politicizzata che non si sorregge da sola grazie alle proprie funzionalità, ma deve sempre essere in qualche modo ‘costruita’. L’autore, invece, propone di ritornare alla pratica bibliogra*ca tradizionale e alla sua utilità per la critica testuale, a7ermando che molte considerazioni del neozelandese erano già presupposte, per esempio, in Walter Greg, che però le ha applicate agli ambiti propri della textual bibliography.
Dopo una serie di esempi di applicazioni riuscite di critica testuale mediante principi della bibliogra*a analitica, Tanselle conclude che « textual and literary theorists can, and will, continue to debate the nature of texts, but editors have to face the practical question of how their procedures are a7ected by the theoretical positions they hold ».
[l. r.]
Trovato Paolo, Con ogni diligenza corretto. La stampa e le revisioni editoriali dei testi letterari italiani (1470-1570), Bologna, Il Mulino, 1991.
Muovendo dalla considerazione che gli studi sulla « rivoluzione inavvertita » della stampa hanno dedicato le maggiori attenzioni a stampatori e pubblico, trascurando « tutti gli “in-tellettuali” che *n dall’inizio hanno collaborato con i tipogra*, suggerendo titoli da pubbli-care, allestendo indici, correggendo le bozze di stampa, e soprattutto eliminando dai testi “errori” della più varia natura, veri (cioè sostanziali) o presunti o meramente linguistici » (p. 7), Trovato pone al centro del suo libro il lavoro di revisione dei testi condotto in tipogra*a. Protagonisti delle sue pagine diventano quindi i « correttori », e in particolare i loro interventi sulla lingua. Prendendo in esame un secolo decisivo per il consolidamento e la di7usione della stampa e per le scelte linguistiche che vengono a stabilizzarsi (l’arco cronologico è dal 1470 al 1570), Trovato presenta, con un’esempli*cazione molto ricca, lo sviluppo del lavoro tipogra*co nel suo rapporto con l’edizione dei testi, soprattutto di quelli provenienti dalla tradizione manoscritta. Le domande, formulate dallo stesso studioso nelle pagine prelimi-nari, sono di questo tipo : « Cosa signi*cava, nel Quattrocento e nei primi sette decenni del Cinquecento, curare la pubblicazione a stampa di un testo letterario in volgare ? Quali erano, se e quando c’erano, i metodi e le teorie messe in opera dai “correttori” ? Quali le loro con-
repertorio bibliografico ragionato176
vjkoqrkq j stuwq wj uxyjzzuzqvj {jw yt||wq}r ? E ancora, quali le conseguenze testuali e lingui-stiche dell’interferenza di questi antenati dei moderni !lologi con i nostri classici ? Quali le innovazioni metodologiche in un arco di tempo che va dall’età laurenziana all’apprendistato del Tasso ? » (p. 13). Le risposte a queste domande (via via portate nei vari capitoli), permet-tono di approfondire un quadro culturale che tocca i temi della storia della lingua (quelli più cari a Trovato, storico della lingua italiana), della nuova funzione degli intellettuali (maestri di scuola, ecclesiastici, docenti universitari di basso rango, per riprendere la tipologia esposta nella prima pagina dei Preliminari), della nascita di una !lologia ancora lontana da quella mo-derna, ma consapevole dei problemi testuali. Gli strumenti metodologici sono espressamen-te ricondotti alla !lologia dei testi a stampa, con l’intenzione di contribuire « ad annettere alla nostra tradizione di studi !lologici […] il territorio scon!nato e imprescindibile del libro a stampa, monopolio della “nuova bibliogra!a” angloamericana » (p. 14).
In particolare, nel capitolo terzo, Notizie sui «correttori», vengono indicate le « fonti a noi accessibili per valutare in concreto l’operato dei “correttori” » : « Le varianti a penna apporta-te agli esemplari di tipogra!a », « Gli Errata corrige », « Le cosiddette varianti di stato (o varian-ti interne a un’edizione) », « Le varianti che emergono dalla collazione di edizioni diverse » (pp. 82-83). Sulla base di queste osservazioni metodologiche, Trovato dà il via a uno studio di edizioni di autori classici e italiani in volgare che, secondo una suddivisione in capitoli che segue la scansione cronologica, mostra il complesso lavoro richiesto al passaggio dal mano-scritto alla stampa (che spesso era il risultato della collazione di vari codici), e gli interventi che, nel corso di revisione, composizione, correzione, sono stati eseguiti sui testi. Varrà la pena di ricordare qui, in modo speci!co, il capitolo quinto, intitolato Le vulgate quattrocente-sche delle Tre Corone (1470-1500), che presenta le prime edizioni a stampa di Dante, Petrarca, Boccaccio, e gli errori, o le « correzioni » sulla lingua, che, dalle prime edizioni, sono stati poi trasmessi a quelle successive. Prestata attenzione alle edizioni di Manuzio – nel capitolo sesto Le novità aldine (1501-1515) –, alla di+usione di scritti di « regole grammaticali » per la lin-gua volgare, presto fatte proprie da correttori e stampatori (capitolo settimo Prime correzioni secondo le «regole» (1516-1530)), all’« Espansione del !orentino trecentesco (1531-1540) » (come suona il titolo del capitolo ottavo), i correttori diventano i protagonisti delle pagine di Trova-to. Al nome di Lodovico Dolce è dedicato il capitolo nono – L’ascesa del Dolce (1541-1552) –, che tratta anche dell’evoluzione delle scelte dei Manuzio e della crescita dell’azienda dei Giolito : per questi Dolce cura « la prima edizione di una interminabile serie di Furiosi » (p. 221), nei quali, rispondendo a una crescente domanda del mercato, incrementerà di volta in volta le appendici, mentre lo stampatore si preoccuperà di far sembrare diverso ogni volume con « accorte variazioni dei criteri editoriali e dei frontespizi » (p. 222). A Girolamo Ruscelli, che « alla !ne degli anni ’50 […] era una !gura centrale dell’industria libraria », sono dedicati il capitolo decimo (Un correttore «libraro» : Ruscelli e compagni (1553-1555)) e undicesimo (Filologia e linguistica del Ruscelli (1552-1566)) : contro una tradizione che considerava Ruscelli un poligrafo di scarso valore, Trovato, pur sottolineandone la bravura nell’attività « promozionale » delle sue edizioni, mette in risalto anche la maggiore consapevolezza grammaticale, rispetto agli altri correttori, (così che « la sua !lologia fu prevalentemente riduzione degli “autori buoni” alle regole, “secondo i modi della lingua volgare” » : p. 275), e l’attenzione per le correzioni ortogra!che che « vanno, nel complesso, nella direzione poi rilanciata dal Salviati e dalla Crusca e hanno contribuito, in molti casi, a !ssare usi ancor oggi invalsi » (p. 287).
L’ultimo capitolo del volume (Verso l’autore (1561 e oltre). Con qualche proposta di «/lologia delle correzioni»), indica nell’anno 1561 l’avvio di « un decennio di svolta : l’Indice di Paolo IV e le ultime sessioni del Concilio di Trento sono i sintomi più evidenti del cambiamento, che investe in pieno il mondo dell’editoria » (p. 299), quando i cambiamenti non riguarderanno più solo la lingua e lo stile, ma anche il contenuto, « e la storia della !lologia costeggia da vicino quella, non meno a+ascinante, della censura ». Nelle pagine conclusive del capitolo, Trovato invita a non con!dare troppo nelle possibili « varianti d’autore » da trovare il sede di stampa, che possono far correre il rischio di trascurare la « complessità dei problemi posti dalla mediazione delle tipogra!e » (p. 320).
la materialità nella filologia (1985-2007) 177
~���
A.
Antonelli Roberto, Canzoniere Vaticano latino 3793, in Letteratura italiana. Le Opere, i, Dalle Origini al Cinquecento, a cura di Alberto Asor Rosa, Torino, Einau-di, 1992, pp. 27-44.
Tavera Antoine, La table du chansonnier d’Urfé, « Cultura Neolatina », lii, 1-2, 1992, pp. 23-138.
Il canzoniere provenzale R, il più monumentale tra quelli appartenenti alla macrocate-goria gröberiana dei zusammengesetzen Handschriften, si con'gura come uno dei testimoni più complessi della lirica trobadorica. Il saggio, oltre a concentrarsi su alcuni fondamentali aspetti di natura materiale precedentemente ignorati, mostra come l’analisi della tavola an-tica del manoscritto contribuisca in maniera decisiva non solo all’individuazione dei diversi apporti di fonti che hanno concorso al suo allestimento, ma anche alla precisazione delle modalità operative adottate da chi lo ha compilato. Dopo aver individuato due notevoli cesure interne alla raccolta, Antoine Tavera fa notare come un’ulteriore tavola, trascritta su una carta non numerata (proprio per questo da lui denominata feuillet ‘zéro’), preceda quella de'nitiva del manoscritto ; secondo lo studioso, la prima delle due attesterebbe una iniziale organizzazione dei materiali antecedente rispetto all’arrivo nello scriptorium di nuovi e notevoli apporti testuali. In seguito a tale massiccio arrivo di componimenti, il progetto editoriale complessivo sarebbe mutato rispecchiandosi nella redazione della nuova e de'ni-tiva tavola, rispondente a criteri più ristretti rispetto a quella precedente. Venendo alle fonti di R, Antoine Tavera delimita quattro macrosezioni che fungono da ipotesi di lavoro per la loro individuazione ; l’ultima delle quattro è contraddistinta dall’estrema varietà delle tipo-logie testuali rappresentate (vi 'gurano per'no testi non lirici, alcuni dei quali giunti nello scriptorium dopo la compilazione della tavola). In tale luogo del manoscritto sarebbe dunque particolarmente evidente il processo di fusione di precedenti rotuli ; tra questi Liederblätter emergono chiaramente anche due interessanti Liederbücher, quello che raccoglie le pièces di Bertran Carbonel e quello, d’autore e celeberrimo, di Guiraut Riquier. Conclude il saggio l’edizione diplomatica della tavola, preceduta da alcuni schemi riassuntivi della complessa struttura del canzoniere.
[s. r.]
B.
Casadei Alberto, Recenti studi di (lologia dei testi a stampa, « Lettere italiane », xliv, 1992, pp. 93-108.
Si tratta di una prima ampia e commentata rassegna degli studi dedicati alla 'lologia dei testi a stampa usciti in Italia negli anni ottanta del secolo scorso.
repertorio bibliografico ragionato178
����
A.
Avalle d’Arco Silvio, I manoscritti della letteratura in lingua d’oc, a cura di Lino Leonardi, Torino, Einaudi, 1993.
Nuova edizione del fondamentale studio avalliano (1961), con aggiornamento bibliogra*-co e riconsiderazione di alcuni nodi fondamentali (ad es. la posizione dell’editio variorum , i +orilegi, i rapporti tra testo e apparato decorativo, tra testo e musica) alla luce delle nuove esperienze di studio.
[d. m.]
Busby Keith, Nixon Terry, Stones Alison, Walters Lori (a cura di), Les ma-nuscrits de Chrétien de Troyes : The Manuscripts of Chrétien de Troyes, Amster-dam-Atlanta, Rodopi, 1993. [Recensione di Gioia Paradisi, « Critica del testo », i, 3, 1998, pp. 1063-1070].
Lo studio approfondito dei 45 testimoni che costituiscono la tradizione dei romanzi di Chrétien de Troyes, in quanto punto di partenza imprescindibile per la conoscenza delle opere stesse : tale lo scopo dichiarato nell’Avant-propos ai due volumi (pp. vii-ix), l’uno dedi-cato ai contributi critici o8erti da studiosi americani, britannici, francesi, tedeschi e olandesi, l’altro all’impressionante mole degli apparati (appendici, note, cataloghi dei manoscritti, una sterminata bibliogra*a e quasi 500 illustrazioni, di cui una trentina a colori). Il progetto, che investe ogni aspetto materiale dei testimoni (codicologia, studio della decorazione e dell’iconogra*a, analisi dell’ordinamento delle raccolte e del loro signi*cato, ricerca su tali basi dei rapporti stemmatici tra i mss.), concretizza cinque anni di ricerche in un lavoro ambizioso, che ha il merito di o8rire una ricca messe di informazioni e di spunti per ulte-riori approfondimenti. La General introduction (pp. 1-8) a9data ad Alison Stones dichiara la novità dell’opera rispetto agli studi precedenti, ivi compreso il fondamentale La tradition manuscrite des romans de Chrétien de Troyes (Paris, 1939) di Alexandre Micha : l’approccio scelto consente al lettore di avere precisa cognizione dei codici grazie anche ad un ampio corredo di illustrazioni (la parte preponderante della raccolta è in e8etti quella dei saggi relativi all’iconogra*a). Apre la serie dei contributi Terry Nixon (Romance Collections and the Manuscripts of Chrétien de Troyes, pp. 18-26), che a8ronta la questione generale della tipologia dei codici che tramandano i romanzi di Chrétien : particolare attenzione è riservata ai mss. duecenteschi che tramandano le prime raccolte complete dei cinque romanzi. Keith Busby (The Scribe of MSS T and V of Chrétien’s Perceval and its Continuations, pp. 49-66) veri*ca mediante lo studio codicologico e delle gra*e l’e8ettiva ‘gemellarità’ di due manoscritti già da tempo assimilati dalla critica, suggerendo l’utilità dell’analisi variantistica di testimoni simili per comprendere l’usus di un copista medievale. Un approccio assai approfondito alla materialità dei testimoni, di cui sono indagati mise en page e mise en texte, si ritrova nel contributo di Françoise Gasparri, Geneviève Hasenohr, Christine Ruby (De l’écriture à la lecture : ré#exion sur les manuscrits d’Erec et Enide, pp. 97-148). L’analisi dei sette testi-moni, prodotti da un’artigianato librario quali*cato e sovente destinati ad una collettività professionale, fornisce lo spunto per alcune considerazioni di validità generale in merito agli elementi (abbreviazioni, punteggiatura, segmentazione del testo, posizione delle lettri-nes) usati dai copisti per orientare la lettura. Lori Walters (The Use of Multi-Compartment Opening Miniatures in the Illustrated Manuscripts of Chrétien de Troyes, pp. 331-350) si interroga sulla funzione delle illustrazioni suddivise in più riquadri poste in testa ai romanzi in due
la materialità nella filologia (1985-2007) 179
���. Ancora a Keith Busby si devono due contributi di tematica percevaliana : un articolo del 1988 (The Illustrated Manuscripts of Chrétien’s Perceval, pp. 351-364) che tratta il rapporto testo-illustrazione-rubrica nei 5 testimoni miniati del Conte du Graal, e un altro (Text, Minia-ture, and Rubric in the Continuations of Chrétien’s Perceval, pp. 365-376) che applica la stessa prospettiva di ricerca ai testimoni delle Continuazioni. Angelica Rieger (Le programme ico-nographique du Perceval montpelliérain, BI, Sect. Méd. H 249 (M), avec la description détaillée du manuscrit, pp. 377-436) esamina l’eccezionale testimonianza del codice di Montpellier, in cui il testo è accompagnato da un corredo di 55 illustrazioni che costituiscono un vero e proprio racconto per vignette parallelo al testo. Il profondo esame materiale rivela che il programma iconogra1co mira a conferire all’immagine un valore autonomo rispetto al testo, indicando un’opportunità di lettura del romanzo alternativa a quella testuale.
[f. s.]
Huot Sylvia, The Romance of the Rose and its medieval readers : interpretation, re-ception, manuscript transmission, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
Nell’ambito di un’indagine della ricezione del Roman de la Rose, è notevole l’attenzione riservata dall’autrice nei confronti del libro manoscritto e delle sue componenti materiali. Basti, in tal senso, menzionare la ricchezza della documentazione codicologica fornita dal capitolo 8 (Sacred and Erotic Love : The Visual Gloss of ms. Bibl. Nat. fr. 25526, pp. 273-322), il cui corredo di tavole o4re al lettore tanto le immagini delle miniature più signi1cative quanto lo schema della struttura di alcuni fascicoli.
[f. s.]
La &lologia romanza e i codici, Atti del Convegno di Messina, Facoltà di Lettere e Fi-loso1a dell’Università degli Studi, 19-22 dicembre 1991, a cura di Saverio Guida, Fortunata Latella, Messina, Sicania, 1993.
Il Convegno di Messina costituisce una panoramica ricca di spunti di ri6essione sullo stato attuale della 1lologia romanza in Italia, nel confronto necessario con le testimonianze ma-noscritte medievali. Evidente è la continuità di approccio metodologico rispetto al Colloque di Liège di due anni prima. Si segnalano qui soltanto i contributi signi1cativi nell’ottica della 1lologia materiale. Aurelio Roncaglia (L’immagine paleogra&co-visiva dell’antecedente perduto e l’immagine intellettuale della struttura originaria, strumenti di critica del testo, pp. 15-28) o4re un magistrale esempio di come uno studio paleogra1co condotto con prudenza ed intuito, oltre che sorretto dalle imprescindibili competenze storico-linguistiche, possa pro-durre risultati insperati in sede di restauro testuale. Luciana Borghi Cedrini (Il trattamento dei codici repertoriali, pp. 49-56) propone la de1nizione di « codici repertoriali » per un’ampia tipologia di raccolte miscellanee (canzonieri, laudari, ‘manoscritti-biblioteca’ di testi giulla-reschi) : ‘repertorio’ pare infatti il termine più adatto a designare un accumulo di materiali non casuale ma organizzato e con precise funzioni modellizzanti. Di tali codici è propu-gnato, secondo l’insegnamento di Avalle, uno studio unitario, materiale in primis, come di antologie ‘monumentali’ e ‘documentarie’ al tempo stesso. La comunicazione di Walter Meliga (I canzonieri trobadorici I e K, pp. 57-70), che si so4erma sui ‘gemelli’ I e K, è la premes-sa ad uno studio complessivo dei due codici. Allo scopo di sviscerare il signi1cato della loro identità, egli mira a porne in luce le di4erenze, sulla base di consistenza materiale e studio grafematico, sostenendo l’opportunità di una comparazione stemmatica dei due testimoni a livello ‘micro1lologico’. Roberto Antonelli espone (Manoscritti latini e romanzi del xiii secolo, pp. 71-88), a nome del gruppo di studio che coordina (composto dai giovani studiosi della ‘scuola romana’), le prime risultanze di un progetto di catalogazione dei codici duecen-teschi conservati alla Biblioteca Vaticana, che si pre1gge lo scopo di ricostruire in termini storico-geogra1ci la produzione libraria dell’epoca, restituendo in tal senso al manoscritto la
repertorio bibliografico ragionato180
��� centralità. Maria Luisa Meneghetti (Stemmatica e problemi di attribuzione fra provenzali e siciliani, pp. 91-106) a'ronta la questione delle divergenze attributive, ricorrente nella lirica romanza. La studiosa mette in causa la possibilità di sciogliere lachmannianamente il nodo : lo sconsigliano in e'etti tanto il carattere ‘aperto’ della tradizione, quanto la frequente incoerenza stemmatica tra testo e rubriche. La strategia suggerita è quella di un approccio ‘multiprospettico’, con il dato codicologico a supportare le risultanze di un’analisi basata su criteri stilistici. Luciano Formisano (Prospettive di ricerca sui canzonieri d’autore nella lirica d’oïl, pp. 131-152) prova a dirimere alcune questioni relative alla consistenza dei Liederbücher nella tradizione della poesia dei trovieri sulla base dell’ordinamento dei componimenti nei canzonieri, e riesamina contestualmente le scelte di organizzazione dei materiali da parte degli editori moderni del Castellano di Couci, Guillaume le Vinier e Conon de Béthune. Lucilla Spetia (Il ms. MR 92 della Biblioteca Metropolitana di Zagabria visto da vicino, pp. 235-272) descrive approfonditamente il codice che tramanda il canzoniere Za, so'ermandosi sulla composizione materiale della raccolta, sul suo contenuto e sulle circostanze storiche della sua compilazione e successiva circolazione. Per il canzoniere è avanzata una solida proposta di collocazione nello stemma di Schwan. Maria Carla Battelli (Il codice Parigi, Bibl. Nat. F. fr. 844 : un canzoniere disordinato ?, pp. 273-308) propone uno studio codicologico e stemma-tico del Chansonnier du roi, a partire dalle vistose e già note discrepanze tra l’ordinamento dei contenuti fornito dalla tavola e la struttura e'ettiva della raccolta. La studiosa individua il principio compositivo di questa e fa emergere, anche dall’esame delle fonti, il signi6cato delle infrazioni al progetto originario. Monica Longobardi (Frammenti di codici dall’Emilia-Romagna : secondo bilancio, pp. 405-418) torna a fare il punto (il Primo bilancio è apparso in « Cultura Neolatina » del 1988) sul valore 6lologico e il signi6cato storico-culturale dei fram-menti da lei rinvenuti all’Archivio di Bologna : 57 unità provenienti da codici francesi, italiani e provenzali, riutilizzate in un periodo circoscritto (in particolare 1610-1625) per la rilegatura di libri notarili. Lino Leonardi (Guittone nel Laurenziano. Struttura del canzoniere e tradizione testuale, pp. 443-480) si cimenta con le questioni guittoniane suscitate dallo studio del canzo-niere L, in cui la posizione dell’aretino è, com’è noto, di grande rilievo. L’ipotesi che il Lau-renziano possa costituire la copia di una raccolta d’autore è rigettata sulla base dei riscontri operati sulla struttura del codice, da cui emergono, tuttavia, tracce di un ordinamento originario da attribuire al poeta stesso. Giosuè Lachin (La composizione materiale del codice provenzale N (New York, Pierpont Morgan Library, M 819), pp. 589-608) conduce in parallelo un esame codicologico e dei contenuti del manoscritto, le cui innumerevoli singolarità non avevano 6n qui ricevuto le dovute attenzioni. Lo studioso postula il disegno originario di una raccolta strutturata per sezioni d’autore e connotata in senso religioso-didattico. Degna di nota la premessa di Lucia Lazzerini al proprio intervento – Varianti d’autore o infortuni di copista ? Recensio e interpretatio nel caso di Marcabru, iv (Al prim comens de l’ivernaill), pp. 629-648 –. Ella richiama ad un’intelligente rigore 6lologico, per evitare gli abusi commessi nei confronti del testo dalle derive bédieristiche : tra queste ultime è annoverato il ‘feticismo del manoscritto’, in cui rischiano di incorrere gli studiosi di 6lologia materiale. Una tavola rotonda (pp. 755-782) conclude il Convegno, riproponendone presupposti teorici ed esiti. D’Arco Silvio Avalle si rallegra dell’interesse che sempre più suscita il manoscritto presso i 6lologi romanzi. Lo studio di esso è fondamentale non soltanto per la ricostruzione stem-matica (qui peraltro trascurata) ma soprattutto per il progresso della conoscenza linguistica e storico-culturale, e si rende tanto più necessario in quanto sempre più lontana pare farsi l’astrazione rappresentata dall’‘originale d’autore’. Madeleine Tyssens invita alla prudenza nello studio dei testimoni, per evitare errori che possono derivare da una 6ducia eccessiva nel manoscritto : esso non andrà dunque mai ipostatizzato, bensì ritenuto come punto di partenza imprescindibile per ogni esperienza del testo, 6ne, questo sì, del compito del 6lo-logo. Aurelio Roncaglia riprende il caveat pronunciato da Lazzerini in merito al rischio che il dovuto interesse per il codice medievale possa degenerare in un culto smodato, ricordando che « scopo della 6lologia è l’intelligenza piena del testo ». Cesare Segre ripropone, contro
la materialità nella filologia (1985-2007) 181
��������� di Avalle per l’edizione diplomatica di singoli codici, la necessità di risalire verso « qualche cosa » che se non vuole chiamarsi « archetipo » né tantomeno « originale », costituirà lo stadio più vicino ad essi che sia possibile raggiungere.
[f. s.]
Meliga Walter, Osservazioni sulle gra�e della tradizione trobadorica, in Atti del Se-condo Congresso Internazionale della Association Internationale d’Études Occitanes, Torino, 31 agosto-5 settembre 1987, Torino, Dipartimento di Scienze letterarie e &lologiche dell’Università di Torino, 1993, pp. 763-798.
L’autore propone un metodo di analisi del polimor&smo della scripta trobadorica che coniughi un approccio di tipo ‘orizzontale’, ovvero una ricerca incentrata sul singolo canzo-niere, con indagini di tipo ‘verticale’, orientate cioè alla descrizione di gruppi omogenei di materiali poi con0uiti in raccolte più vaste (a partire dalle singole sezioni d’autore). Si segna-la inoltre la necessità di distinguere i fenomeni gra&co-linguistici e1ettivamente signi&cativi ai &ni di studi di questo tipo da quelli che fattori estranei alle convenzioni gra&che hanno reso sostanzialmente neutri. L’analisi del trattamento di ŏ latina nelle posizioni previste per il dittongamento condizionato nell’ambito dell’intera tradizione funge da esempli&cazione del metodo proposto. Tali principi sono ulteriormente precisati, anche facendo ricorso a più puntuali riscontri con i lavori metodologicamente rilevanti di François Zufferey (Recher-ches linguistiques sur les chansonniers provençaux) e Maurizio Perugi (ed. critica delle poesie di Arnaut Daniel), in Walter Meliga, Les graphies et la tradition manuscrite troubadouresque. Problèmes et observations, Actes du iv Congrès International de l’Association Internationale d’Études Occitanes, Vitoria-Gasteiz, 22-28 août 1993, i, a cura di Ricardo Cierbide, Vitoria, 1994, pp. 205-212 ; Idem, Les études graphématiques et la tradition des troubadours, « Revue des langues romanes », xcviii, 1, 1994, pp. 31-47.
[s. r.]
Pulsoni Carlo, Un Ur-buch di tenzoni ?, in xxe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes, Université de Zürich, 6-11 avril 1992, a cura di Gerold Hilty, Tübingen-Basel, Francke, 1993, v, pp. 125-140.
Analizzando alcune delle caratteristiche materiali che le a>ni sezioni di tenzoni raccol-te in A D riproducono dal loro antigrafo (con particolare attenzione per gli spazi bianchi lasciati alla &ne delle poesie), l’autore identi&ca la natura del loro comune antecedente : esso doveva presentarsi come « un collettore o libro di tenzoni » (p. 136). Per la postulazione dell’esistenza di un altro Ur-buch, in questo caso di vidas in prosimetro, cfr. Giuseppe Noto, Le « biogra�e » trobadoriche contenute nel canzoniere P : perché un’edizione documentaria, in Scène, évolution, sort de la langue et de la littérature d’oc, Actes du Septième Congrès International de l’Association Internationale d’Études Occitanes, Reggio Calabria-Messina, 7-13 juillet 2002, i, a cura di Rossana Castano, Saverio Guida, Fortunata Latella, Roma, Viella, 2003, pp. 579-592.
[s. r.]
Storey H. Wayne, Transcription and Visual Poetics in the Early Italian Lyric, New York-London, Garland, 1993.
I saggi raccolti da Storey nel volume sono guidati da un unico intento di veri&ca : ovvero se la trascrizione dei testi della lirica italiana – dalle origini a Dante e Petrarca – sia confor-me, nella ‘facies’, all’intento di rappresentazione voluto dall’autore stesso ; e di conseguenza, se nelle vicende editoriali successive tale dettame autoriale risulti osservato. Storey parte dal presupposto che i poeti in questione abbiano composto i loro testi ideando anche la
repertorio bibliografico ragionato182
����� ����� ����� ��������� ������� �¡ � �� ¢��� ���� ���� �£� �� ����� ��¤���� ¥� ��¦�� ���‘volontà visuale’ dell’autore, che il più delle volte la trascrizione manoscritta non assicu-ra ; come egli stesso sottolinea, « we cannot accurately assess the poetics, nor the poetic message […] without considering the visual dimension of […] poetic strategies devised in early manuscripts » (p. xxv) ; ritenendo che la ‘forma-canzoniere’ (quale risulta nella sua cristallizzazione petrarchesca) sia uno strumento per preservare la poetica autoriale dagli accidenti o (peggio) dalle manipolazioni della tradizione (p. xxiv), Storey sottolinea come i predecessori di Petrarca abbiano sviluppato in proposito particolari strategie : una di queste è legare la di&coltà del testo a rari layout di trascrizione ; quindi la tenzone, vista come vin-colo metrico-tematico e che per Storey è l’antecedente più diretto della raccolta, del poetry book ; in*ne l’author’s book, che nell’antica lirica spesso nasce come variazione su una stessa forma metrica (il sonetto, che circola in ‘corone’) o su uno stesso tema.
Da queste premesse, il volume si sviluppa in modo binario : una prima parte comprende quattro saggi focalizzati anzitutto sul percorso del testo letterario dai margini della pagina del codice *no al centro del campo scrittorio (pp. 5-48) e sul valore semantico che ha la disposizione del testo nella pagina (pp. 71-100) ; quindi sulla ri-de*nizione dello spazio mar-ginale della pagina in situazioni esemplari (i Memoriali bolognesi, il manoscritto Chigiano L.viii.305), per arrivare al caso di Guittone, e alle sue scelte di rappresentazione del testo del Trattato d’amore. La seconda parte è tutta incentrata su Petrarca e sulle sue strategie di riforma delle tecniche dei predecessori, il cui fallimento avrebbe orientato, secondo Storey, i percorsi compositivi dell’Aretino : l’attenzione è anzitutto alla determinazione del concetto petrarchesco di testo (cap. v), e alla sua rappresentazione nei Rerum vulgarium fragmenta (vi), per focalizzare in*ne (cap. vii) l’indagine su esordi e chiuse.
Per quanto concerne, in*ne, le implicazioni ecdotiche della sua inchiesta Storey, in un’ot-tica eminentemente pragmatica, pur sottolineando che l’indagine si focalizza sull’« evento della trascrizione testuale » (p. xxvii), rivendica la validità del metodo lachmanniano, anzi-tutto distinguendo tra trascrizione in quanto registrazione di un atto performativo, che si distingue da altri analoghi sulla base del comportamento e delle motivazioni dello scriba, e trascrizione come una delle performances scritte o incarnazioni del testo, che risulta dal con-tributo parziale di ciascuna di esse ; e dichiarando quindi che la rigida aderenza a una sola di queste istanze si contrappone ad un approccio veramente critico al testo, la cui ricostruzione dipende invece da un’accorta combinazione delle due.
[d. m.]
1994
A.
Careri Maria, Ressemblances matérielles et critique du texte : exemples de chansonniers provençaux, « Revue des langues romanes », xcviii, 1, 1994, pp. 79-114.
La studiosa analizza alcuni casi in cui, all’interno di canzonieri provenzali, si registrano de-viazioni rispetto alle caratteristiche della mise en page abitualmente adottata nei manoscritti trobadorici : tali aspetti di tipo materiale possono infatti rivelarsi elementi utili alla precisa-zione di dinamiche compilative seguite dai copisti, nonché dati preziosi per la ricostruzione di diverse fasi nella formazione delle raccolte, individuando ad esempio cambiamenti di fonte, oppure l’origine da un modello comune. Maria Careri conclude rivendicando l’impor-tanza della « collation des manuscrits » che, rispetto alla « collation des textes », risulterebbe « un élément beaucoup plus objectif et solide » in quanto « résultat assuré d’un passage écrit » : « les éditeurs en tiennent compte de façon non-systématique, alors que cela ma paraît un
la materialità nella filologia (1985-2007) 183
§¨§©ª«¬ certain, sur lequel fonder le stemma codicum » (p. 93). Tale approccio metodologico viene duramente criticato da Carlo Pulsoni, Considerazioni a margine di un recente contributo dedicato alla !lologia materiale, in La sestina, « Anticomoderno », ii, 1996, pp. 327-335.
[s. r.]
Leonardi Lino (a cura di), Guittone d’Arezzo, Canzoniere. I sonetti d’amore del codice Laurenziano, Torino, Einaudi, 1994.
L’edizione del Canzoniere di Guittone a cura di Lino Leonardi nasce dall’esigenza di ve-ri+ca di « un’ipotesi storiogra+ca, formulata su Guittone iuxta sua principia » (p. xi) : che cioè la corona di 86 sonetti d’argomento amoroso tràdita da L (il laurenziano Redi 9) rispecchi un intento compositivo unitario, organizzato secondo una consecuzione narrativa ; ovvero non un Liederbuch ordinato secondo intento autoriale a posteriori, come si potrebbe anche pensare per l’intero corpus guittoniano conservato nel codice laurenziano (ipotesi, ad esem-pio, sostenuta poco dopo questa pubblicazione da Michelangelo Picone (cfr. Guittone e i due tempi del « Canzoniere », in Guittone d’Arezzo nel settimo centenario della morte), ma un vero e proprio ‘canzoniere’, concepito « a parte subiecti » (p. xxv), come provocatoriamente il titolo (secondo Leonardi) suggerisce.
È più che probabile, nota l’editore, che ancorché la silloge contenuta in L sia frutto di una sistemazione non autoriale, tra le fonti del codice vi sia però una sorta di volume di ‘opera omnia’ strutturato dallo stesso Guittone e che dovette avere anche circolazione autonoma (ne restano le tracce, ad esempio, nella testimonianza di Benvenuto da Imola). Tuttavia, per Leonardi, perché la serie guittoniana sia de+nibile in quanto ‘canzoniere’ dovrà rispondere a criteri di unitarietà, di consapevolezza costruttiva e di perspicuità narrativa : proprio i criteri che inducono a proporre « l’etichetta nel suo senso più forte, petrarchesco » (p. xxv) ; è già nell’accostamento a serie autoriali ordinate in senso cronologico, come il libre di Guiraut Riquier, attraversando episodi non esclusivamente lirici come le Càntigas de Santa Marìa di Alfonso X e i Miracles Nostre Dame di Gautier de Coinci, per arrivare in+ne alla Vita Nova, che la corona guittoniana può trovare qualche spazio. Negli esempi di Guiraut Riquier e di Dante, tuttavia, l’ordinamento sequenziale dei componimenti è a8dato a un elemento di connessione esterno, nel caso di Guiraut il sistema delle rubriche datate, nel caso di Dante una ben più elaborata cornice prosastica, esperienze entrambe riconducibili al modus delle sillogi trobadoriche strutturate con vidas e razos. Analoghi all’esperimento guittoniano sono invece i Rerum vulgarium fragmenta, dove i legami che formano l’insieme sono completa-mente immanenti al testo : la ricerca dunque, nella corona di 86 sonetti, di una trama di connettori formali che consente di passare dall’unità al macrotesto, riconoscendo i segni di quella che Leonardi de+nisce « operazione strutturatrice […] di primo grado » (ovvero, non è attuata a posteriori ma in una linea di sviluppo per la quale ogni episodio condiziona la scrittura del successivo, p. xxviii), consente di parlare della serie guittoniana come del più notevole antefatto delle ‘collane’ di componimenti due-trecentesche, da quella dell’Amico di Dante, a Niccolò de’ Rossi, per giungere +no al Fiore. Gli elementi connettivi, dunque : su tutti il metro, con l’iterazione dei sonetti con schema a rima alternata, e poi il collegamento basato sull’omofonia tra sonetti contigui, che risale alla tipicità delle coblas unissonans e doblas occitaniche e che coinvolge 64 sonetti su 86 ; in aggiunta al contenitore metrico, un terzo forte elemento di connessione è rappresentato da richiami lessicali e sintattici, nonché dal ripetersi cadenzato di temi : su tutto, il !l rouge rappresentato da un’ironia « feroce e divertita » (p. xi), che nella progettualità di questa raccolta è strumento di delegittimazione del codice amoroso tradizionale, realizzata non attraverso il rigore morale (che sarà piuttosto tipico di Frate Guittone), ma dall’interno, con una costante allusività verso gli antecedenti siciliani e d’Oltralpe, occitanici e oitanici.
[d. m.]
repertorio bibliografico ragionato184
®¯®°±®²²³ ´µ³´ ¶·³¸´, Problemi attributivi in ambito trobadorico, in L’attribu-zione : teoria e pratica, Atti del Seminario di Ascona, 30 settembre-5 ottobre 1991, a cura di Ottavio Besomi, Carlo Caruso, Basel-Boston-Berlin, Birkhäuser, 1994, pp. 161-182.
Vàrvaro Alberto, Il libro i delle Chroniques di Jean Froissart. Per una !lologia inte-grata dei testi e delle immagini, « Medioevo Romanzo », xix, 1994, pp. 3-36.
Lo studio di stile, modalità di esecuzione e contenuti delle miniature presenti in alcuni dei molti testimoni del libro i delle Chroniques di Froissart porta a individuare un progetto illustrativo unitario, cui non può essere considerato estraneo lo stesso scrittore. Sulla base di questo esempio, Vàrvaro sostiene, dove possibile, l’applicazione di una ‘4lologia delle immagini’ a supporto di quella testuale : se, infatti, è dato ricostruire la volontà anche ico-nogra4ca dell’autore, lo studio dei rapporti tra le miniature può risultare, insieme a quello delle varianti, di grande aiuto nella ricostruzione della genealogia dei testimoni, soprattutto in tradizioni vaste e complesse.
[f. s.]
B.
Fahy Conor, Bibliologia e !lologia, in La !lologia testuale e le scienze umane, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1994, pp. 137-146.
Come dichiara esplicitamente in apertura di questo breve saggio, Fahy si propone di de-lineare « nelle sue linee generali, il contributo che può dare l’analisi bibliologica al lavoro 4lologico ». In nove lunghi e densi paragra4, lo studioso ripropone alcuni fondamentali assunti teorici e metodologici del rapporto tra bibliogra4a e 4lologia, con particolare riferimento agli strumenti necessari al bibliografo e al 4lologo (ad es. i cataloghi delle edi-zioni uscite in uno speci4co periodo, quale può essere un secolo). Viene anche a<ermata apertamente la convinzione che « non importa con quale teoria del testo letterario e della critica testuale un 4lologo si accosti al suo lavoro, egli avrà sempre bisogno di controllare rigorosamente le testimonianze che hanno trasmesso l’opera » (p. 143) : da qui la necessità di conoscere i modi con i quali si e<ettua la trasmissione a stampa. Interessante anche la considerazione che la teoria del copy text, per quanto discutibile, ammonisce « a non trascurare la prima edizione di un’opera, anche quando esistono edizioni posteriori con varianti d’autore » (p. 144).
1995
A.
Asperti Stefano, Carlo I d’Angiò e i trovatori. Componenti « provenzali » e angioine nella tradizione manoscritta della lirica trobadorica, Ravenna, Longo, 1995.
Attraverso lo studio di apparenti singolarità proprie di ambiti circoscritti della tradi-zione manoscritta trobadorica, l’Autore si propone di individuare tracce di eventuali in-=ussi operati sulla poesia romanza e la sua trasmissione da parte dell’ambiente politico e culturale angioino. Decisamente degne di nota sono le proposizioni di metodo che orien-
la materialità nella filologia (1985-2007) 185
¹º»¼ ½º ¾¿ÀÁ¾Àº : intendendo la trasmissione dei testi non solo come strumento decisivo per la ricostruzione critica degli stessi, ma anche come « processo storico che si ri!ette nei te-stimoni superstiti » (p. 14), Stefano Asperti isola all’interno di alcuni manoscritti seriazioni di componimenti che, così dislocati a causa di fattori storici esterni, si rivelano omogenei tra loro per motivi di varia natura. Nella ricerca di tali gruppi di poesie è opportuno concentrarsi in particolare su quei testi che risultano estranei al corpo principale della raccolta per via della loro cronologia, della loro tradizione o per il fatto di essere opera di poeti attivi nel medesimo luogo nel medesimo periodo ; signi%cativi sono anche i compo-nimenti trascritti in apertura o chiusura di canzoniere, oppure in spazi precedentemente lasciati bianchi. Il volume riserva sette capitoli ad altrettanti manoscritti provenzali, ana-lizzati nella peculiare prospettiva sopraenunciata ; tra questi si segnala in particolar modo il quarto, dedicato a un’inserzione sordelliana in H, in quanto applicazione paradigmatica dell’approccio metodologico seguito. I primi due capitoli tentano un’interpretazione complessiva degli unici due canzonieri per motivi diversi riconducibili direttamente ad ambienti angioini : f e M. In entrambi sembrano però mancare chiari in!ussi culturali risalenti alla corte di Carlo : f ignora proprio i poeti direttamente legati al potere angio-ino, mentre M, napoletano, trascrive materiali in gran parte già preconfezionati, senza tentare di fornire un nuovo assetto organico all’insieme. Nei casi di E e W è la struttura codicologica a individuare gruppi interessanti di testi, accomunati da a+nità anche di tipo formale. Il canzoniere E è completato da un fascicolo di tre carte che raggruppa una serie di dansas e due canzoni in cui si nominano Carlo d’Angiò e, tramite senhal, sua moglie Beatrice. In alcuni spazi bianchi lasciati dal copista di W (francese M) si registrano invece integrazioni con testi provenzali e oitanici appartenenti a generi simili a quelli che con-cludono E (dansas, rondeaux e così via), legate ad ambienti napoletani : la %gura di Carlo I appare dunque al centro di processi di innesto nella tradizione trobadorica di forme tipiche della poesia dei trovieri, nonché di innovazione della lirica oitanica dal punto di vista della composizione e dell’esecuzione musicale. Si analizzano in%ne i casi dei due manoscritti centro-italiani F e P, nei quali sono con!uite diverse tradizioni che gli allesti-tori hanno però saputo riorganizzare nel tentativo di fornire alle raccolte una sostanziale organicità d’insieme : l’analisi di tale operazione risulta assai produttiva nell’ambito di ricerche sulla ricezione antica della lirica trobadorica in queste aree. Nella sua sezione ini-ziale il !orilegio F dedica ampio spazio a Sordello, poeta legato alla corte di Carlo I e sorta di exemplum del perfetto cavaliere cortese agli occhi anche del pubblico italiano ; sono però individuabili nell’antologia chiare tracce di una preponderante tradizione di origine estense ravvisabile anche in P. Nel caso di quest’ultimo codice, dopo aver sottolineato la signi%cativa atipicità dell’apertura di canzoniere lasciata a testi erroneamente attribuiti a Blacasset, l’autore si concentra sulla sezione di coblas esparsas, ove individua alcuni apporti di tipo angioino nell’ambito di una raccolta che si rivela particolarmente coerente a livello interdiscorsivo con alcune fasi della poetica dantesca e, più in generale, connaturata alla situazione di fecondo fermento della poesia toscana coeva.
[s. r.]
Beltrán Vicenç, Tipología y génesis de los cancioneros. Las grandes compilaciones y los sistemas de clasi#cación, « Cultura Neolatina », lv, 1995, pp. 233-265.
La carenza di studi dedicati agli aspetti materiali dei canzonieri della lirica spagnola costi-tuisce per Beltrán lo spunto per una ricerca di ampio respiro, che, iniziata nel 1992 (El caso de Jorge Manrique, in Historias y #cciones. Colloquio sobre la literatura del siglo xv, Valencia, Uni-versitat de Valencia, 1992, pp. 167-188), vede in questo contributo una tappa fondamentale. L’autore, la cui a+liazione all’impostazione metodologica dominante nella romanistica ita-liana è immediatamente dichiarata, si propone di dimostrare, attraverso l’analisi comparata di sillogi poetiche iberiche da una parte, provenzali, francesi e italiane dall’altra, come le
repertorio bibliografico ragionato186
ÂÃÄÅÆÇÈÉÊe dell’indagine sulle une e sulle altre, lontane per epoca e ideologia di composizio-ne, possano corroborarsi a vicenda.
[f. s.]
Lachin Giosuè, Partizioni e struttura di alcuni libri medievali di poesia provenzale, in Strategie del testo. Preliminari Partizioni Pause, Atti del xvi e xvii Convegno interuniversitario, Bressanone, 1988 e 1989, a cura di Gianfelice Peron, Padova, Esedra, 1995, pp. 267-304.
L’autore cerca di isolare partizioni materiali interne ai singoli canzonieri utili a precisarne natura e lettore implicito ; la ricerca è condotta analizzando induttivamente i manoscritti pro-venzali A B D I K. Si segnala in primis l’utilità dell’individuazione di suddivisioni interne alle singole raccolte, nonché della loro organizzazione e gerarchia (sulla cui de6nizione interviene spesso anche l’aspetto gra6co) : il singolo fascicolo, che costituisce di fatto l’unità minima di composizione materiale del codice, o l’unione di più di essi contraddistinti dall’omogeneità dei contenuti trascritti, individua talvolta precise sezioni coerenti all’interno dei manufatti, facendo verosimilmente intravedere a monte di tali suddivisioni non solo booklets di testi del medesimo poeta, ma anche « raccolte di genere », « raccolte d’occasione » e « raccolte per a9ni-tà tra autori » (p. 287). Si nota poi che i copisti tendono a ordinare i corpora di singoli poeti da trascrivere seguendo principalmente criteri di ordine quantitativo ; eventuali presenze e/o as-senze evidenti, nonché dislocazioni inusuali, sono spesso indice di precise opzioni editoriali. Si consideri in6ne il fatto che i primi trovatori trascritti tendono a conferire particolari connotati alla raccolta nel suo insieme. Il saggio presenta una ricchissima esempli6cazione.
[s. r.]
Picone Michelangelo, Guittone e i due tempi del « Canzoniere », in Guittone d’Arezzo nel settimo centenario della morte, Atti del Convegno internazionale di Arezzo, 22-24 aprile 1994, a cura di Michelangelo Picone, Firenze, Cesati, 1995, pp. 73-88.
B.
Sorella Antonio, ed. critica di: Benedetto Varchi, L’Hercolano, con una presen-tazione di Paolo Trovato, Pescara, Libreria dell’Università, 1995.
L’edizione critica (in due tomi) viene condotta da Sorella con gli strumenti della 6lologia dei testi a stampa, in particolare collazionando (con il metodo delle fotocopie trasparenti) tutti gli esemplari superstiti. Le pagine del curatore, in particolare, approfondiscono la re-lazione che intercorre tra le due edizioni postume del 1570, entrambe uscite dai torchi dei fratelli Giunti, ma una a Firenze e una a Venezia.
1996
A.
Gorni Guglielmo (a cura di), Dante Alighieri, Vita nova, Torino, Einaudi, 1996.
L’edizione del prosimetro dantesco procurata da Gorni mostra un’evidente discontinuità rispetto all’edizione che Michele Barbi aveva pubblicato nel 1932 : prima di tutto nel titolo,
la materialità nella filologia (1985-2007) 187
ËÌÍ l’editore propone alla latina, non dittongato, coerentemente al dettato dei due codici che sono considerati più vicini all’intentio dantesca – il Martelli 12 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze e il Toledano 104.6 (trascritto da Boccaccio) – nonché sulla scorta del Convivio, che nei riferimenti all’opera giovanile attesta senza eccezioni il titolo Vita nova. La novità più signi#cativa di questa edizione non è tuttavia nel titolo ma in un’inedita proposta di partizione del testo : una divisione che l’editore vuole in 31 ‘paragra# ’ (termine che Dante medesimo impiega all’inizio dell’opera, cfr. vn, ii, 10) anziché i 42 capitoli in cui erano ripartite le precedenti edizioni, compresa quella Barbi : la proposta sarebbe suggerita, secondo Gorni, dalla presenza in codici che appartengono a rami di-erenti della tradizione di un’organizzazione del testo, appunto, in 31 paragra# che egli sostiene non possa essersi veri#cata in modo casuale, ma senza dubbio debba risalire a un’ultima volontà autoriale da cui la tradizione manoscritta si sarebbe invece, poco per volta, emancipata. L’ipotesi di Gorni, nei fatti, sembra inseguire una seducente proporzione tra il numero dei capitoli e il numero dei componimenti poetici, anche se in realtà la perfetta simmetria non si realizza, in quanto alcuni paragra# contengono più di un componimento, mentre altri nessuno ; così, pure per l’individuazione all’interno del testo di ‘serie’ di paragra#, che corrisponderebbero ad altrettante, note sequenze narrative. Mancando un’evidenza certa, rimane il dubbio che tali suddivisioni del testo siano, più che autoriali, innovazioni introdotte dalla tradizione per evidenziare all’interno della Vita nova le seriazioni della narrazione : la nuova divisione del testo è stata pertanto accolta con qualche scetticismo e non senza polemiche, cui Gorni ha più volte replicato (ad es. nel recente Filologia materiale, !lologia congetturale, !lologia senza ag-gettivi, « Modern Language Notes », 119, 1, 2004, pp. 108-119) sottolineando la bontà dei propri argomenti, che proprio dalla materialità traggono forza.
Pulsoni Carlo, Considerazioni a margine d’un recente contributo dedicato alla !lologia materiale, in La sestina, « Anticomoderno », ii, Roma, Viella, 1996, pp. 327-335.
Il contributo di Pulsoni esordisce con la dichiarazione statistica dell’ormai ampio successo ottenuto dalla #lologia materiale, de#nita come ‘disciplina’ in corrispondenza a una for-mulazione più volte espressa da Roberto Antonelli (qui citata dalla prefazione al volume Il discorso bifronte di Guzman de Alfarache di Norbert von Prellwitz). L’analisi di Pulsoni si appunta, in chiave polemica, verso il saggio di Maria Careri intitolato Ressemblances ma-térielles et critique du texte : exemples de chansonniers provençaux, comparso nel 1994 sulla « Revue des langues romanes » e incentrato sulla possibilità d’instaurare relazioni ecdotiche sulla base di elementi materiali. La critica è indirizzata puntualmente agli esempi che la Careri adduce a sostegno della propria tesi, e quasi per ciascuna esempli#cazione si precisano considerazio-ni generali di metodo : nel caso di O, in cui l’oscillazione della mise en page tra colonna doppia e singola riHetterebbe un’alternanza di ‘antigra# ’ a disposizione del copista, e in particolare l’esistenza di un’ulteriore fonte di O per i -. 35-73, l’ipotesi formulata dalla Careri (che origina da un’idea di Gröber, poi però respinta dallo studioso tedesco), è smentita secondo Pulsoni dall’estrema variabilità della mise en page, che costringerebbe quasi a supporre l’uso di un antigrafo di-erente per ogni pièce ; idea sottesa è quella che il criterio materiale realmente utile all’indagine sul testo sia quello – ugualmente ‘esterno’ e di ascendenza gröberiana – del reperimento all’interno dei canzonieri di seriazioni omogenee di componimenti, e della concordanza tra testes in caso di divergenza attributiva, i soli dati questi non soggetti all’incostanza operativa di un copista. Nel caso dei Horilegi Cm, Dc e F, dove alla parentela stemmatica corrisponderebbero, secondo Careri, importanti aKnità del testo decorativo, e dove la presenza in Cm, più antico, di lettrines istoriate assenti in Dc F indicherebbe una maggiore fedeltà al modello, sempli#cato invece dagli altri due testes, Pulsoni evoca il pa-squaliano recentior non deterior, sottolineando che la maggiore vicinanza di un manoscritto a un antigrafo è data non dalla cronologia ma dal numero degli interpositi, e in ogni caso invita a considerare che il dato testuale dipende dal copista, che nella maggior parte dei casi non coincide con il miniatore/decoratore. In#ne il caso dei manoscritti A e D, apparentati
repertorio bibliografico ragionato188
ÎÏÐÐÏ comune discendenza dall’editio variorum avalliana, che la Careri intenderebbe sic et sim-pliciter, considerando un oggetto ‘compiuto’, mentre Pulsoni (concordando con l’ipotesi di Zu!erey di un manoscritto ‘in divenire’) propende invece per un esemplare che muta la propria forma gradualmente, quanto più viene a contatto con le fonti che lo compongono : solo intendendo come modello in progress, in cui con#uiscono sezioni già costituite, e del tutto omogenee, insieme a materiali meno compattamente preordinati, si comprende la fortissima a%nità di A e D nella sezione delle tenzoni (27 componimenti seriati, con egual numero di coblas e tornadas e rubriche simili) ; e soprattutto, si coglie il valore ecdotico degli spazi lasciati in bianco alla +ne di componimenti privi di tornada, che la Careri considera genericamente come una caratteristica materiale che accomuna A e D, ma che in realtà in certi casi può soccorrere nel ricostruire l’entità originaria di un componimento, come nel caso della canzone di Raimbaut de Vaqueiras Ara∙m requier sa costum’e son us, in cui lo spazio bianco doppio lasciato in calce dal copista di A corrisponde alla presenza di una doppia tor-nada nella tradizione : segno che il dato materiale, lungi dal costituire una verità assoluta in chiave ecdotica, può felicemente integrare le conclusioni che il +lologo trae dall’esame della varia lectio e delle macrostrutture.
[d. m.]
B.
Harris Neil, Una pagina capovolta nel Filocolo veneziano del 1472, « La Biblio+lia », xcviii, 1996, pp. 1-21.
Il contributo si rivela una magistrale lezione di bibliologia applicata all’edizione veneziana del Filocolo di Boccaccio stampato nel 1472 da Gabriele di Pietro assieme al socio Filippo. Har-ris risolve quello che da decenni costituiva un vero e proprio enigma, ossia la presenza, in tutti gli esemplari superstiti, al verso dell’ultima carta (c. B8v), che sarebbe dovuto rimanere bianco, di alcuni brani del Filocolo provenienti da un punto precedente del testo e perdipiù impressi capovolti. L’autore smentisce l’ipotesi +nora maggiormente accreditata (sostenuta da Curt F. Bühler, A Misprint in the Venetian Filocolo of 1472, « Papers of the Bibliographical Society of America », li, 1957, pp. 319-322) secondo la quale l’impressione al rovescio sarebbe dovuta a un errore dei torcolieri che inchiostrano sbadatamente una pagina inserita nella forma tipogra+ca, come spesso accadeva, per supporto all’altra metà del foglio da imprime-re. La collazione fra i testi ribaltati stampati nella carta +nale e gli stessi brani stampati alle carte precedenti (cc. k2v, s3r e s4v-s5r) rivela invece come si tratti originariamente di bozze di stampa rimaste accidentalmente senza correzioni manoscritte, +nite nella pila dei fogli scartati e riutilizzate allorché i due tipogra+, giunti al termine dell’impressione, si resero conto di essere a corto di fogli da imprimere. I fogli precedentemente scartati vennero allo-ra recuperati e il capovolgimento della pagina indicava al lettore la necessità di annullare il messaggio testuale ivi contenuto.
[g. p.]
Garavelli Enrico, Appunti sull’“impronta” : catene di edizioni, riproduzioni facsimi-lari, apogra&, « Aevum », lxx, 1996, pp. 185-196.
L’impronta – uno degli elementi materiali che concorrono all’identi+cazione di un libro a stampa : « stringa alfanumerica formata da 16 caratteri (formata dal prelievo di lettere e segni gra+ci da alcuni punti prestabiliti del libro) » (così la de+nisce Edoardo Barbieri in Guida al libro antico. Conoscere e descrivere il libro tipogra&co, Firenze, Le Monnier, 2006, p. 175) – è al centro delle pagine di Garavelli, che, dopo avere esaminato tre edizioni cinque-centesche delle Rime di Annibal Caro, si è interrogato sulla sua possibile e%cacia in ambito
la materialità nella filologia (1985-2007) 189
ÑÒÓÒÓgico. Pur essendo rivolto ai !lologi, ponendo un interessante problema dal punto di vista dell’analisi dei dati materiali di un libro, il saggio, proprio perché mette in discussione la possibilità di identi!care con l’impronta tutte le copie della stessa edizione, ha suscitato le reazioni (a volte negative) di bibliogra! e bibliotecari, sulle quali Garavelli interviene, con puntuali osservazioni, in un’ampia Premessa all’edizione elettronica del saggio, pubblicata in « Cinquecento plurale » (immissione in rete 1° aprile 2007, www.nuovorinascimento.org/cinquecento/).
Tanselle G. Thomas, Textual Instability and Editorial Idealism, « Studies in Biblio-graphy », xlix, 1996, pp. 1-60.
Il saggio di Tanselle prende in considerazione, con la consueta intelligenza che si deve riconoscere a uno dei più importanti esponenti dell’analytical bibliography anglosassone, due concetti particolarmente interessanti, ma anche estremamente complessi.
Nelle sessanta pagine che compongono il contributo, Tanselle ripercorre criticamente gli scritti pubblicati in inglese e il dibattito sul tema che ha caratterizzato la prima metà degli anni novanta. La mole di pubblicazioni, nel periodo preso in considerazione, risulta parti-colarmente ampia a seguito dell’interesse di1uso per i rapporti tra studi e teorie letterarie e critica testuale.
Dopo un breve accenno a un maestro delle discipline bibliogra!che come Fredson Bowers, Tanselle comincia la rassegna con i due testi ‘classici’ di Jack Stillinger e Jerome McGann, che servono a inquadrare i problemi, soprattutto quelli relativi alla de!nizione di autore o, meglio, di responsabilità autoriale. L’instabilità del testo, infatti, è una caratteristica delle opere pubblicate in antico regime con la stampa manuale, dovuta ai molteplici passag-gi che un testo subisce e ai numerosi attori che su di esso, a vario titolo, intervengono.
Qui però la questione si pone in maniera di1erente (e forse più radicale) perché Stillinger e McGann, sulla scorta anche delle posizioni di Donald F. McKenzie, propongono, nella fattispecie, lo smantellamento della !gura dell’autore, asserendo che le sue intenzioni di partenza non trovano quasi mai applicazione nella proposta !nale di un testo. Questo vale per tutte le categorie di testi, non solo quelli antichi.
A questa posizione Tanselle si contrappone con decisione rimettendo in campo tutte le tradizionali armi della bibliogra!a analitica e riproponendone la validità dei metodi. Il tutto prendendo in considerazione alcune (solo quelle che contengono enunciazioni metodologi-che che possono inserirsi in questo dibattito) delle numerose antologie di testi uscite negli anni 1990-1995, valutandone di volta in volta le posizioni e gli approcci metodologici.
La rassegna risulta utile per un inquadramento generale del complesso e partecipato dibattito in lingua inglese sulle questioni relative alla critica testuale dopo McKenzie. Per gli esiti successivi del dibattito si veda, sempre di Tanselle, Textual Criticism at the Millennium, « Studies in Bibliography », liv, 2001, pp. 1-80 (con, in questa sede, la relativa scheda).
[l. r.]
1997
A.
Spetia Lucilla (a cura di), intavulare. Tables de chansonniers romans, ii, Chan-sonniers français, 2, H (Modena, Biblioteca Estense)-Za (Bibliothèque Métropolitaine de Zagreb), Liège, Université de Liège, 1997.
Primo (ancorché indicato come secondo) a vedere la luce tra i volumi della serie dedicata ai canzonieri oitanici. La scelta di una trattazione congiunta è suggerita più che dall’esiguità
repertorio bibliografico ragionato190
Ôei testimoni (63 e 25 pièces), dalla circostanza di avere a che fare con i due soli canzonieri francesi copiati in Italia. In tal senso, il loro ra%ronto si rivela assai interessante, da una parte per la ricostruzione del pur limitato ramo italiano della tradizione, dall’altra per l’indagine, ancora da svolgere, sulla di%usione della lirica dei trovieri in Veneto nel tardo Duecento.
[f. s.]
B.
Libri tipogra! biblioteche : ricerche storiche dedicate a Luigi Balsamo, a cura dell’Istitu-to di Biblioteconomia e Paleogra*a, Parma-Firenze, Università degli Studi di Parma-Olschki, 1997.
Nei due ampi volumi pubblicati in onore di uno dei maggiori studiosi italiani di bibliogra-*a, Luigi Balsamo, i numerosi saggi coprono tutti i settori dello studio del libro : la tipogra*a e il commercio librario, la legatura e le biblioteche, la biblioteconomia e la bibliogra*a; la sezione « Bibliologia e *lologia », in particolare, raccoglie scritti che si rifanno alle problema-tiche e ai metodi della *lologia dei testi a stampa: Edoardo Barbieri, La Frotola nova già attribuita ai torchi di Aldo Manuzio (pp. 75-104); Neil Harris, Filologia e bibliologia a confronto nell’Orlando Furioso del 1532 (pp. 105-122); Roberto L. Bruni, Tre edizioni cinquecentesche delle Rime contro l’Aretino e la Priapea di Nicolò Franco (pp. 123-144); Diego Zancani, Un recupero quattrocentesco : La vita di Pietro Avogadro bresciano di Antonio Cornazzano e il lavoro di un editore del Cinquecento (Remigio Nannini) (pp. 145-168); Leonardo Quaquarelli, Lodi di Bo-logna in tipogra!a (pp. 363-384).
1998
A.
Bertolucci Pizzorusso Valeria, Filologia del codice e !lologia del testo, in Atti del xxi Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Centro di Studi *lologici e linguistici siciliani dell’Università di Palermo, 18-24 settembre 1995, vi, a cura di Giovanni Ru8no, Tübingen, Niemeyer, 1998, pp. 797-801.
L’intervento della studiosa all’interno della tavola rotonda conclusiva ripercorre attra-verso una bibliogra*a ragionata la recente storia della *lologia materiale, apparato metodo-logico fondamentale per la ricostruzione del testo e della cultura che esso rappresenta.
[f. s.]
Borriero Giovanni, Nuovi accertamenti sulla struttura fascicolare del canzoniere Vaticano Chigiano, « Critica del testo », i, 2, 1998, pp. 723-750.
Filologia classica e romanza : esperienze ecdotiche a confronto, Atti del Convegno di Roma, 25-27 maggio 1995, a cura di A. Ferrari, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1998.
Un’intera sessione del convegno è dedicata alla *lologia materiale, come a uno degli ambiti più signi*cativi in cui misurare a8nità e di%erenze di atteggiamento tra classicisti e romanisti. Le due relazioni a8date a questi ultimi, Elsa Gonçalves (Appunti di !lologia ma-teriale per un’edizione critica della poesia profana di Alfonso X, pp. 411-428) e François Zufferey
la materialità nella filologia (1985-2007) 191
ÕPhilologie matérielle et codicologie : l’enseignement des chansonniers provençaux, pp. 429-442), si pongono nel solco tracciato dai Congressi di Liège (1989) e Messina (1991).
[f. s.]
Ferrari Anna (coordinato da), intavulare. Tavole di canzonieri romanzi, 1998.
Riprendendo e sottoponendo a opportuni aggiornamenti una prospettiva di ricerca già a suo tempo indicata da Gröber, quella delle ‘tavole di studio’, i volumi di questa serie si propongono di fornire un resoconto in forma tabulare della struttura di ognuno dei singoli canzonieri latori della lirica romanza delle origini. Si intende così procurare agli studiosi degli strumenti esaustivi, ma nel contempo agili, utili all’individuazione dell’organizzazione interna e delle peculiarità di ogni raccolta ; tale operazione si inserisce dunque a pieno titolo in quel 1lone di studi che, « guardando ai canzonieri non come a semplici e passivi relatori di testi, ma come a individui storici, culturalmente intenzionati, intende ria2ermarne l’assolu-ta primaria centralità, nella convinzione – ra2orzata dai risultati concreti – che hanno ancora molto da dire » (p. x dell’Introduzione al primo tomo). La serie è ripartita in quattro settori, corrispondenti alle altrettante aree linguistiche che hanno dato origine alle più importanti tradizioni liriche romanze : i. Canzonieri provenzali, ii. Canzonieri francesi, iii. Canzonieri ita-liani e iv. Canzonieri galego-portoghesi. La descrizione in forma tabulare di ogni manoscritto è strutturata in cinque indici, che, organizzati secondo criteri di2erenti, permettono diversi tipi di approccio ai contenuti della singola raccolta. Per i canzonieri dotati di tavola antica, si fornisce un’edizione diplomatico-interpretativa di quest’ultima, segnalando le eventuali divergenze con quanto e2ettivamente trascritto nel codice. L’uniformità nell’organizzazio-ne degli indici agevola un confronto immediato tra i contenuti e la struttura interna delle singole raccolte, permettendo così di individuarne a5nità e divergenze già a una prima analisi contrastiva super1ciale. Tutti i volumi sono dotati di introduzioni che, anche se non « ambiscono all’esaustività e sono 1nalizzate innanzitutto a facilitare la consultazione degli Indici » (ivi, p. xi), risultano in alcuni casi di grande valore ; esse fungono comunque da utile punto di partenza per un primo orientamento nella bibliogra1a pregressa dedicata al singolo manoscritto analizzato.
[s. r.]
Lombardi Antonella (a cura di), intavulare. Tavole di canzonieri romanzi, i, Canzonieri provenzali, 1, Biblioteca Apostolica Vaticana. A (Vat. lat. 5232), F (Chig. L. iv. 106), L (Vat. lat. 3206) e O (Vat. lat. 3208), Città del Vaticano, Biblioteca Aposto-lica Vaticana, 1998. Careri Maria (a cura di), intavulare. Tavole di canzonieri romanzi, i, Canzonieri provenzali, 1, Biblioteca Apostolica Vaticana. H (Vat. lat. 3207), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1998. Tyssens Madeleine (a cura di), intavulare. Tables de chansonniers romans, ii, Chansonniers français, 1, a (B. A. V., Reg. lat. 1490), b (B. A. V., Reg. lat. 1522), A (Arras, Bibliothèque Municipale 657), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1998.
Il volume, destinato in origine ad aprire la serie dei canzonieri oitanici, è dedicato in primis alla silloge vaticana a e, solo subordinatamente, ad A e b : la trattazione parallela dei tre codici artesiani è giusti1cata dall’estrema a5nità dei corpora traditi dagli ultimi due rispetto a quello di a, il quale rappresenta in maniera più completa il contenuto della fonte comune.
[f. s.]
repertorio bibliografico ragionato192
Ö×
Fahy Conor, Roberto Ridol�, Italian bibliographical Scholar, « Studies in Bibliogra-phy », li, 1998, pp. 26-47.
A una delle (gure che hanno caratterizzato gli studi bibliogra(ci italiani del Novecento è dedicato questo saggio di Conor Fahy. Roberto Ridol( (1899-1991), Direttore della più im-portante rivista italiana di bibliogra(a, « La Biblio(lia » (dal 1945 al 1982), pioniere degli studi sulla carta e la (ligrana negli incunaboli (Le �ligrane dei paleotipi. Sa!io metodologico, Firenze, Tipogra(a Giuntina, 1957) e studioso delle cosiddette contrastampe (Incunabuli contrastam-pati : nuovi sussidi per l’attribuzione e la datazione dei paleotipi, « La Biblio(lia », li, 1949, pp. 131-144), viene de(nito da Fahy « l’unico grande bibliografo analitico italiano del xx secolo ».
Nobile di origini, Ridol( mostrò ben presto, contro il parere del padre che lo avrebbe voluto chimico, le sue attitudini per gli studi umanistici : i suoi primi contributi furono dedi-cati alla (gura del cardinale « Niccolò Ridol( (1501-1550), diplomat, bibliophile and patron of letters » (p. 27). Si dedicò anche allo studio e all’inventariazione di numerosi archivi privati (orentini, senza trascurare (gure di spicco del rinascimento italiano (Savonarola, Guicciar-dini, Machiavelli). Questi studi gli valsero anche la Laurea honoris causa all’Università di Oxford (1961).
Fondamentalmente autodidatta, Ridol( a7nò le sue conoscenze mediante la lettura assidua del catalogo degli incunaboli della British Library (bmc) e dell’Handbuch der incu-nabelkunde di Konrad Haebler (sul quale si vedano ora anche Edoardo Barbieri, Haebler contro Haebler. Appunti per una storia dell’incunabolistica novecentesca, Milano, isu-Università Cattolica, 2008, e la traduzione del manuale in Konrad Haebler e l’incunabolistica come discipli-na storica, a cura di A. Ledda, Milano, cusl, 2008).
È tra la (ne degli anni quaranta e gli anni cinquanta che si concentrano i contributi più importanti di Ridol( nelle discipline bibliogra(che con, oltre alle opere già ricordate, il vo-lume La stampa in Firenze nel secolo xv (Firenze, Olschki, 1958) e le aggiunte al Gesamtkatalog der Wiegendrucke (gw).
Il saggio di Fahy si chiude con un’utile bibliogra(a di testi ridol(ani scelti. Sul contributo di Ridol( agli studi bibliologici sulla carta si veda anche, dello steso Fahy, Roberto Ridol� e lo studio bibliologico della carta, « La Biblio(lia », xcvii, 1995, pp. 35-57.
[l. r.]
Sorella Antonio (a cura di), Dalla textual bibliography alla �lologia dei testi ita-liani a stampa, Pescara, Libreria dell’Università, 1998.
Una testimonianza di come la textual bibliography di stampo anglosassone stia penetrando gradatamente nel mondo degli studi (lologici italiani. È stato Conor Fahy, maestro a livel-lo internazionale di questo settore di studi, il primo ad appellarsi agli studiosi e, in modo particolare, ai bibliogra( e ai (lologi italiani, a7nché applicassero i già rodati metodi della bibliogra(a testuale nell’approccio con la tradizione a stampa dei testi italiani.
Il libro curato da Antonio Sorella mostra come questo appello non sia caduto nel vuoto e presenta un’antologia di saggi a scopo didattico, tutti già pubblicati (ma qui talvolta aggior-nati) dedicati a libri italiani del Quattro e Cinquecento con una parentesi anche sul secolo dei Lumi. Da tale lavoro emergono « i risultati di un decennio di studi condotti sulla stampa italiana antica con gli strumenti della bibliogra(a testuale » (p. 23).
Il volume si divide in tre sezioni composte da due saggi ciascuna. La prima, riprendendo un giustamente apprezzato e fortunato saggio di Conor Fahy (Sguardo da un altro pianeta : bibliogra�a testuale ed edizione dei testi italiani del xvi secolo, per il quale si vedano in questa sede le schede Filologia dei testi a stampa, a cura di Pasquale Stoppelli, 1987 e Sa!i di biblio-
la materialità nella filologia (1985-2007) 193
ØÙÚÛÚ ÜÝÞÜßÚàÝ, dello stesso Fahy, 1988), è intitolata Sguardi da un altro pianeta e presenta due contributi di studiosi inglesi. Si inizia proprio con lo stesso Conor Fahy, Forme tipogra�che e varianti interne : appunti bibliogra�ci e �lologici (pp. 37-66) che dopo aver presentato le fonti, interne ed esterne, che servono al bibliografo per ricostruire la storia di un’edizione, si sof-ferma, anche con l’ausilio di un’ampia appendice (con esempli%cazioni tratte dall’Orlando Furioso, Ferrara, Francesco Rosso, 1532), sul problema delle variazioni interne e, in modo par-ticolare, sulle varianti testuali, considerate, per questo compito, « più eloquenti di ogni altro indizio » (p. 40). Il saggio risulta particolarmente utile dal punto di vista metodologico.
Neil Harris, Una pagina capovolta nel « Filocolo » veneziano del 1472 (pp. 67-96), uscito per la prima volta su « La Biblio%lia », xcviii, 1996, pp. 1-21 (si veda in questa sede la relativa scheda di Giancarlo Petrella) « è ripresentato qui con correzioni e integrazioni dell’autore » (p. 24). Harris, mettendo in campo tutti i mezzi della bibliogra%a analitica, risolve in modo bril-lante la complessa questione di una pagina capovolta presente (anche se il testo contenuto non è sempre lo stesso) nella carta [B]8v di tutti i dieci esemplari superstiti dell’edizione Venezia, Gabriele di Pietro, 1472, del Filocolo di Giovanni Boccaccio, che contiene anche la princeps della Vita del Boccaccio di Girolamo Squarza%co.
Nella seconda sezione si passa a Descrizioni e assa%i �lologici nostrali. Il primo contributo è di Paolo Trovato, Revisioni testuali e revisioni linguistiche nelle vulgate di Dante e Petrarca (1475-1500) (pp. 99-134). L’autore, de%nito da Sorella « dopo Ridol%, tra i primi che hanno sapu-to giovarsi delle conoscenze acquisite sugli aspetti materiali della stampa antica nel campo %lologico-linguistico » (p. 97), presenta qui i « risultati di un sondaggio condotto sulle vulgate tardoquattrocentesche della Commedia e dei Rerum vulgarium fragmenta, vale a dire sulle 7 edizioni di Dante con il commento landiniano e sulle 14 di Petrarca che recano il commento del Filelfo o il commento Filelfo-Squarza%co al Canzoniere, stampate e di regola vendute dagli editori assieme al commento dell’Ilicino ai Triumphi » (p. 100).
Gustavo Bertoli, Le prime due edizioni della seconda “Rassettatura” del « Decameron » (pp. 135-156), indaga i rapporti tra le due edizioni del Decameron %rmate da Filippo e Jacopo Giun-ti, la prima a Venezia (agosto 1582) e la seconda a Firenze (ottobre 1582), e curate dal ‘ras-settatore’ Leonardo Salviati. L’edizione veneziana, cronologicamente precedente, dipende invece sostanzialmente dalla %orentina di cui riprende, anche se con signi%cative varianti, la composizione riga per riga.
L’ultima sezione è dedicata a Nuove edizioni di testi italiani. Giovanni Biancardi, in Le prime stampe del « Mattino » pariniano ed il testo della dedica « Alla Moda » (pp. 159-206), sviluppa qui le ricerche pubblicate in Per il testo della prima redazione del « Mattino » : appunti sulle stampe milanesi del 1763, « Studi e problemi di critica testuale », lv, 1997, pp. 51-76. Vengono prese in considerazione, dopo l’edizione critica curata da Dante Isella (Milano-Napoli, Ricciardi, 1969, e poi, Milano, Fondazione Pietro Bembo/Ugo Guanda Editore, 1996), le prime reda-zioni dell’opera di Parini, uscite nel 1763 dai torchi del tipografo milanese Antonio Agnelli. Il saggio si chiude con l’edizione della dedica « Alla Moda » e con un’appendice che presenta la descrizione analitica delle prime tre emissioni del Mattino.
Antonio Sorella, in%ne, con L’edizione dell’« Hercolano » e la bibliogra�a testuale (pp. 207-236), ripresenta qui alcune pagine introduttive all’edizione critica dell’Hercolano di Benedetto Varchi da lui curata nel 1995 (supra).
Utile per un sintetico inquadramento generale sulla realtà della tipogra%a antica e le que-stioni legate alla bibliogra%a testuale il Glossario ragionato (pp. 25-34) che segue, in apertura del volume, l’introduzione di Sorella La �lologia dei testi a stampa in Italia (pp. 5-22).
[l. r.]
Trovato Paolo, L’ordine dei tipogra�. Lettori, stampatori, correttori tra Quattro e Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1998.
Si tratta di una raccolta di saggi già pubblicati, che, nonostante i diversi punti di partenza, approfondiscono tutti le trasformazioni portate dalla stampa nel sistema di trasmissione e
repertorio bibliografico ragionato194
áâ di!usione del testo. I saggi sono distribuiti in quattro sezioni : « Dalla parte dei lettori » (dedicata in particolare agli Studi sull’alfabetizzazione e sull’istruzione e a Latino e volgare tra scuola e tipogra!a come suonano i titoli dei due scritti) ; « Sondaggi sulla circolazione del libro (Il libro in Toscana nell’età di Lorenzo e Manoscritti e stampe nei conventi abruzzesi) ; « La stampa e la "ssazione dell’italiano » (Stampa e norma linguistica, Prefazioni cinquecentesche e «questione della lingua», Un consuntivo : la stampa l’italiano letterario) ; « L’ordine dei tipogra" » (Manoscritti volgari in tipogra!a e Caratteri, formato e sistemi di interpunzione). Se, come si legge nella Pre-messa, « da varie angolazioni, il presente libro cerca di studiare appunto l’ordine dei tipogra", le sue peculiarità e le sue conseguenze » (p. 11), i saggi delle ultime due sezioni, in particolare, si confrontano con i dibattiti e le sollecitazioni della ‘"lologia dei testi a stampa’, richiamate nella Premessa dallo stesso Trovato, che da un lato si interroga sul ruolo della stampa nella « "ssazione dell’italiano letterario » e nella « di!usione dei segni di interpunzione e dei dia-critici » (insistendo sull’importanza del ruolo dei curatori e dei revisori : in La stampa e la !ssazione dell’italiano, pp. 131-141) e dall’altro sottolinea l’importanza di esaminare le copie di tipogra"a, in Manoscritti volgari in tipogra!a (pp. 175-196). In quest’ultimo saggio (che ripren-de l’intervento alle giornata di studio Il libro di poesia dallo scriptorium alla tipogra!a, i cui atti sono pubblicati in Il libro di poesia dal copista al tipografo, a cura di M. Santagata, A. Quondam, Modena, Panini, 1989 : qui è alle pp. 43-56), Trovato descrive « la varia “fenomenologia” » ri-scontrata in numerosi manoscritti, prendendo le mosse dall’indicazione di W. G. Hellinga (Copy and Print in the Netherlands. An Atlas of Historical Bibliography, Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1962), secondo il quale « il segno più sicuro dell’utilizzazione di un ms. in tipogra"a è la presenza di segnature […], vale a dire numeri […] o combinazioni di numeri e lettere del tipo A p°, A 2, A 3, ecc., a indicare l’inizio (reale o presunto) delle pagine e la loro successione nei fascicoli del libro a stampa » (pp. 177-178). Dopo avere mo-strato molti esempi in questa direzione, Trovato si so!erma sui « segni dell’intervento di un “correttore”, che “prepara” il testo per la stampa » : anche per questo approfondimento sono molti gli esempi riportati (con particolare riferimento alla gra"a e alla fonomorfologia), e le voci bibliogra"che riferite alle varie edizioni. L’ampia rassegna commentata dei manoscritti di tipogra"a conosciuti all’altezza cronologica del saggio (presentati anche attraverso un ricco corredo di illustrazioni) permette di sottolineare l’importanza, anche per l’ecdotica dei testi a stampa, dello studio della copia utilizzata per la composizione.
1999
A.
Antonelli Roberto, La tradizione manoscritta e la formazione del canone, in Dai Siciliani ai Siculo-toscani. Lingua, metro e stile per la de!nizione del canone, Atti del Convegno, Lecce, 21-23 aprile 1998, a cura di Rosario Cosuccia, Riccardo Gual-do, Galatina, Congedo, 1999, pp. 7-28.
Sviluppando il problema del con"ne, molto sottile, che divide rimatori siciliani tout court dai cosiddetti ‘siculo-toscani’, Antonelli rivendica l’autorità della tradizione manoscritta, che è rappresentata nei fatti soprattutto dalla testimonianza di V (Vat. latino 3793), per la sua vicinanza al codice (o ai codici) che Dante mostra, nel De vulgari eloquentia, di aver letto. In particolare, si indagano la posizione e i con"ni dei fascicoli che la silloge vaticana dedica alla poesia dei Siciliani : un patrimonio ingente di testi – rispetto alle altre due grandi antologie liriche L (il Redi 9 della Laurenziana di Firenze) e P (il Banco Rari 217 della Nazionale di Firenze) – in cui l’indubbia preminenza data alla poesia della corte di Federico è però "ltrata in un prodotto redatto successivamente alla caduta della casa di Svevia, che manifesta il suo
la materialità nella filologia (1985-2007) 195
ãäågiore interesse per l’Italia comunale, toscana e !orentina dell’epoca appena precedente allo Stilnovo.
[d. m.]
Battelli Maria Carla, Le antologie poetiche in antico francese, « Critica del testo », ii, 1, 1999, pp. 141-180.
L’autrice continua ad occuparsi (cfr. Eadem, Les manuscrits et le texte : typologie des recueils lyriques en ancien français, « Revue des langues romanes », c, 1996, pp. 111-129), della tradizione dei canzonieri oitanici, con la medesima impostazione teorica – la necessità di muovere dalla materialità del codice per comprenderne ‘modalità di confezione’ e ‘criteri ispiratori’ – ma con uno sviluppo più approfondito e conclusioni più solide. Si dimostra che l’ordinamento per autori caratterizza una fase piuttosto precoce, e ideologicamente motivata, della tra-dizione, rivelandosi struttura soggiacente anche alle antologie composte secondo criteri diversi (genere, ordine alfabetico), come conferma anche l’esame del Liederbuch di Adam de la Halle.
[f. s.]
Borriero Giovanni, Considerazioni sulla tradizione manoscritta della Tenzone di Dante con Forese, in I numeri, « Anticomoderno », iv, Roma, Viella, 1999, pp. 385-405.
Meneghetti Maria Luisa, La forma canzoniere fra tradizione mediolatina e tradizio-ni volgari, « Critica del testo », ii, 1, 1999, pp. 119-140.
Moreno Paola (a cura di), intavulare. Tables de chansonniers romans, ii, Chanson-niers français, 3, C (Bern, Burgerbibliothek 389), Liège, Université de Liège, 1999.
Terzo volume della serie, dedicato all’importante canzoniere lorenese. Particolarmente approfondito è lo studio della storia interna della raccolta, letta nella strati!cazione delle fonti diverse che lo compongono.
[f. s.]
Nocita Teresa, Per una nuova paragrafatura del testo del Decameron, « Critica del testo », ii, 3, 1999, pp. 925-934.
Lo studio indaga la speci!ca funzionalità del sistema di maiuscole elaborato da Boccaccio nel manoscritto Hamilton 90, autografo del Decameron, cui egli delega l’evidenza di alcune suddivisioni interne alla narrazione ; in appendice, l’edizione diplomatico-interpretativa della novella i, 5 segnala la tipologia di ciascuna iniziale.
[d. m.]
Squillacioti Paolo, Le poesie di Folchetto di Marsiglia, Ospedaletto (Pi), Pacini, 1999.
Questa edizione critica risulta particolarmente signi!cativa nella prospettiva che qui interessa poiché, nello studio introduttivo (in particolare alle pp. 3-16), Paolo Squillacioti individua un Liederbuch folchettiano coniugando i dati forniti dall’analisi della varianti con quelli emersi dalla critica esterna (ordine di trascrizione dei componimenti nei diversi testi-moni). Tale gruppo di testi è isolabile considerando la sequenza di componimenti che apre il gröberiano P2, ovvero la seconda parte in cui il codice provenzale P risulta suddivisibile
repertorio bibliografico ragionato196
æç rapporto alle fonti in esso con!uite ; tale Liederbuch ricorre in maniera molto simile nella porzione iniziale del corpus folchettiano accolto in gran parte dei canzonieri che tramandano i testi del poeta marsigliese. La sua analisi in relazione al resto della tradizione del trovatore permette inoltre di individuare tre « canali di alimentazione dei canzonieri » (p. 11) che co-prono la quasi totalità della produzione di Folchetto e tendono a disporsi nella medesima sequenza nei diversi testimoni ; proprio questo è l’ordine di successione dei testi adottato da Paolo Squillacioti nella sua edizione.
[s. r.]
B.
Harris Neil (a cura di), Bibliogra!a testuale o !lologia dei testi a stampa ? De!nizioni metodologiche e prospettive future, Convegno di Studi in onore di Conor Fahy, Udine, 24-25-26 febbraio 1997, Udine, Forum, 1999.
Il volume raccoglie gli atti del Convegno svoltosi a Udine in occasione del conferimento della Laurea ad honorem in Conservazione dei Beni Culturali a Conor Fahy, docente emerito di Lingua e Letteratura italiana dell’Università di Londra. In tale occasione, diversi studiosi hanno o/erto contributi a quello che può essere considerato il maestro degli studi di bi-bliogra1a testuale (calco sull’inglese textual bibliography) in Italia. Si ricordino almeno, a tal proposito, i suoi Sa"i di bibliogra!a testuale, Padova, Antenore, 1988 (si veda qui la relativa scheda a 1rma mia) e il pro1lo bibliogra1co dell’edizione 1532 dell’Orlando furioso (Milano, Vita e Pensiero, 1989, per cui si veda qui la scheda di Giancarlo Petrella).
Dopo la Prolusione (pp. 13-22) di Attilio Mauro Caproni, Conor Fahy, nella sua bella lectio, traccia proprio un bilancio del contributo della 1lologia testuale agli studi italiani pur riconoscendo che alcuni studiosi italiani come Santorre Debenedetti e Michele Barbi, negli anni trenta erano arrivati autonomamente a brillanti risultati nello studio della tradizione a stampa rispettivamente del Furioso e dei Promessi Sposi (problemi con cui Fahy ha avuto modo di confrontarsi brillantemente). Non è un caso che Fahy ricordi come un gigante nella preistoria della bibliogra1a testuale inglese l’italiano Antonio Panizzi (1797-1879), biblioteca-rio del British Museum.
Capita spesso di riscontrare negli studenti universitari di Lettere, qualunque sia la loro specializzazione, la pressoché completa mancanza di competenze tecniche nei confronti del libro a stampa. Questo deriva dal fatto che in molti casi per la tradizione 1lologica italiana sembra una perdita di tempo la raccolta di più o meno estesi dettagli tecnici che, appa-rentemente, poco o nulla hanno a che fare con la costituzione e la tradizione del testo. Al 1lologo tradizionale, in 1n dei conti, non interessano tutti quei dati che ritiene più utili per « ricostruire la storia della stampa, che costituisce parte integrale di quella storia del libro che ora vediamo sempre più chiaramente come parte determinante della storia della cultura » (p. 31). La lectio di Fahy, ma in fondo anche il suo magistero e quello dei bibliogra1 anglosassoni (nel testo brevemente ripercorso), intende invece proporre, con garbo, un cambio di visuale a7nché, con i debiti adattamenti alla realtà italiana, anche nella Penisola possano essere impiegati con sempre maggior pro1tto i metodi della textual bibliography, che già in diverse occasioni hanno dato risultati signi1cativi.
Un pro1lo (con la bibliogra1a delle opere 1no al 1999, pp. 311-344) del bibliografo Conor Fahy, quasi a ideale completamento della lectio dello stesso, è tracciato da un maestro di questo settore di studi in Italia, Neil Harris, curatore del volume.
Il primo saggio è di Edoardo Barbieri, Tra !lologia dei testi a stampa e storia del libro : Ri-dol!, Cicerchia e le ‘contrastampe’, (pp. 35-58), ottimo esempio dei risultati a cui lo studio delle contrastampe, avviato da Roberto Ridol1 (1899-1991), può portare. Le contrastampe sono i segni lasciati da un foglio appena stampato (quindi con l’inchiostro fresco) su un altro foglio
la materialità nella filologia (1985-2007) 197
èéêëgra!co. Il loro interesse è particolare, negli studi bibliogra!ci, quando su un foglio di un’edizione compare la contrastampa con il testo di un’altra edizione, il che, dimostrando la contemporanea presenza in tipogra!a delle due composizioni tipogra!che, può quindi servire a datare un’edizione sine notis qualora l’altra sia datata o altrimenti databile. Barbieri, in questo caso, identi!ca in un esemplare parigino della Passione del Cicerchia, l’edizione, Firenze, Morgiani e Petri, 1492, ipotizzata da Ridol! sulla base di una contrastampa che appariva su un esemplare del savonaroliano Trattato o vero sermone dell’orazione, Firenze, Bartolomeo de’ Libri, 1495 ca.
Segue il contributo di Andrea Cuna, Esempi e problemi di stampa del greco nel xv secolo (pp. 59-86), dedicato a uno dei settori in cui la tipogra!a italiana del rinascimento ha dato i suoi risultati più preziosi (si pensi, ad es., alle celeberrime edizioni di !ne Quattrocento di Aldo Manuzio). Qui però viene presentato un primo bilancio di un’analisi concentrata sull’origine gra!ca dei primi tipi greci e su alcuni episodi di stampa del greco prima di Manuzio. L’ap-proccio è eminentemente bibliologico : vengono identi!cati i possibili antigra! manoscritti delle varie edizioni a stampa con tutti i problemi tipici della realizzazione tipogra!ca di questa lingua e le conseguenti oscillazioni tra modelli epigra!ci e minuscoli corsivi.
Con l’intervento di Marco Villoresi La biblioteca del canterino. I libri di Michelangelo di Cristofano da Volterra (pp. 87-124) si ritorna, linguisticamente parlando, al mondo italiano. La ricerca intende far luce su « un ricco e vasto universo letterario : quello dell’artigianato poetico e prosastico dei secoli xiv e xv, riproposto con successo grazie ai riadattamenti e alle manipolazioni dei mestieranti al soldo delle tipogra!e, dei quali il volterrano sembra essere un tipico rappresentante » (p. 107).
In L’edizione 1521 delle Opera Iocunda di Giovan Giorgio Alione (pp. 125-138), Enzo Bottasso, attento studioso di libri, ma anche di biblioteche e biblioteconomia, analizza con la consueta acribia i problemi della resa gra!ca e, in genere, della produzione a stampa in volgare nel Piemonte del Cinquecento. Viene segnalato qui l’uso corrente in Francia, ma anche in Italia, di pubblicare singole farse in fascicoli dal formato oblungo. Si tratta del formato caratteri-stico, già in epoca manoscritta, per i testi poetici (si pensi al celebre dipinto con la Dama col petrarchino di Andrea Del Sarto, conservata alla Galleria degli U6zi di Firenze) e per i testi teatrali.
Le pagine di Neil Harris, Per una $lologia del titolo corrente : il caso dell’Orlando Furioso del 1532 (pp. 139-204), tornano, muovendosi sui passi del maestro Fahy, sulla celeberrima princeps di Ariosto, attraverso la prospettiva dello studio del titolo corrente. Harris considera il modus operandi dello stampatore ferrarese Francesco Rosso, inserendo lo studio del titolo corrente nella complessiva analisi della fabbricazione di un libro, di cui l’autore traccia anche uno schematico ma preciso panorama. Tale operazione mostra come la composizione del titolo corrente – aspetto che si potrebbe considerare marginale – concorra invece a determinare l’organizzazione del lavoro di composizione tramite l’identi!cazione delle gabbie tipogra-!che.
Carlo Maria Simonetti, La Compagnia dell’Aquila che si rinnova : appunti sui consorzi editoriali a Venezia nel Cinquecento (pp. 219-268), propone un primo bilancio dei dati oggi conosciuti su una delle più importanti (e tra le più grandi d’Europa) società editoriali della Venezia tardocinquecentesca, nata dall’unione di alcuni degli editori più in vista e la cui at-tività si protrasse per alcuni decenni, anche se con continue riformulazioni societarie. Note tipogra!che, marche e dati ricavabili dalle varie stipule societarie, che attestano l’estrema dinamicità e l’adeguamento continuo delle iniziative editoriali alle necessità a7aristiche con-corrono a tracciare un articolato pro!lo della Compagnia.
L’intervento di Giuseppina Zappella, che verte su Un rebus tipogra$co : fascicolo appa-rente e fascicolo strutturale in un’edizione napoletana del Seicento (pp. 269-294), mostra come conoscendo in modo preciso e dettagliato le tecniche di composizione è possibile arrivare a risultati sicuri ed estrarre dall’esemplare una serie consistente di dati utili sia sul piano storico sia su quello critico.
repertorio bibliografico ragionato198
ìí ambito più bibliotecario è la relazione di Rosaria Campioni, Osservatore da un altro pianeta : Conor Fahy e il censimento delle edizioni italiane del xvi secolo (pp. 205-212) che, parafra-sando un noto contributo di Fahy (Sguardo da un altro pianeta : bibliogra!a testuale ed edizione dei testi italiani del xvi secolo, per il quale si vedano in questa sede le schede di Filologia dei testi a stampa, 1987, e di Sa"i di bibliogra!a testuale, 1988), presenta il progetto « edit16 » su cui interviene anche Diego Maltese, Bibliogra!a nazionale retrospettiva : a proposito del censimento delle edizioni italiane del xvi secolo (pp. 213-218).
Giovanna Gronda chiude la miscellanea con le pagine di solido impianto metodologico, Taglia e incolla : sulla tradizione testuale dei libretti d’opera (pp. 295-310), dedicate alle varianti di stampa delle edizioni teatrali.
[l. r.]
McKenzie Donald Francis, Bibliogra!a e sociologia dei testi, Milano, Sylvestre Bonnard, 1999.
Il neozelandese Donald McKenzie (1931-1999) tenne la serie inaugurale delle Panizzi Lectures alla British Library nel 1985 (pubblicate a London, The British Library, 1986), che qui vengono proposte in versione italiana. McKenzie è il fautore dell’approccio sociale all’ecdotica : egli cioè dà risalto al libro come ‘forma espressiva’, mettendo in relazione la presentazione 6sica del testo e l’ambiente sociale da cui proviene e su cui agisce. Compiendo questa operazione l’autore, pur inserendosi nel solco tracciato dalla bibliogra6a analitica anglosassone, ne critica i presupposti fondamentali, cioè la raccolta di dati oggettivi ricavati dall’osservazione dei manufatti superstiti, e spregia anche, in qualche modo, l’interesse per l’intenzione dell’autore.
È comunque innegabile il signi6cativo contributo apportato dallo studioso neozelandese alla teoria bibliogra6ca e, forse più indirettamente, a quella della 6lologia. Il maggiore lavo-ro di McKenzie è infatti la monumentale e dettagliatissima ricostruzione dell’attività della Cambridge University Press tra Sei e Settecento (The Cambridge University Press, 1696-1712. A Bibliographical Study, Cambridge, Cambridge University Press, 1966).
La fortuna di McKenzie è probabilmente maggiormente legata al mondo francese, che ha un approccio al libro di tipo forse più sociologico (lettura e impatto dei testi sul pubblico dei lettori) che analitico e 6lologico. Si vedano, a conferma di questa tesi, gli importanti studi di Robert Darnton e Roger Chartier, tra i più illustri rappresentanti di quella storia sociale del libro e delle idee che, dalla Francia, va progressivamente a8ermandosi. Riconoscendo il debito verso il neozelandese, lo stesso Darnton lo de6nisce « il più grande bibliografo del nostro tempo ». E sono proprio le argomentazioni di McKenzie ad aver costituito il presup-posto per il passaggio dai metodi quantitativi della tradizionale storia del libro francese alla nuova histoire du livre, a8ermatasi dagli anni ottanta e incentrata sui lettori, la materialità e i signi6cati.
Centrale risulta, qui come altrove nel pensiero di McKenzie, la « nozione di testualità »; infatti, « inscritto nella materialità delle sue forme, alieno da qualsiasi deriva idealistica, è […] il testo (verbale e scritto, iconico, gra6co, 6lmico, fotogra6co, musicale) a costituire il principio generale uni6cante della bibliologia e delle discipline ad essa variamente connesse » (p. 90). Si potrebbe dire che la materialità, tanto cara alla tradizione anglosassone, passa in secondo piano o, meglio, viene subordinata alla componente testuale. « ‘Testo’ nel senso semantico-strutturale del termine, quale insieme ordinato e coordinato di simboli e di segni, retto da una sintassi che può talora presentarsi in forma non verbale, volto all’espressione ed alla creazione di signi6cati, intesi quale attività primaria della mente umana » (p. 90). Si vede come, parlando di testo, McKenzie non si riferisca necessariamente ai libri, ma a tutti quei sistemi di simboli proposti a un’interpretazione. Ci sono testi che non presuppongono nemmeno il linguaggio verbale (immagini, carte geogra6che, partizioni musicali, addirittu-ra il territorio).
la materialità nella filologia (1985-2007) 199
îï secondo luogo McKenzie sottolinea gli e!etti, in termini di senso, dovuti alle forme. Ogni testo, infatti, è necessariamente inscritto in una qualche materialità e ogni forma è or-ganizzata secondo strutture proprie che svolgono un ruolo essenziale nel processo interpre-tativo e possono mirare a orientare la ricezione, a controllare l’interpretazione, a quali$care il testo. Si pensi, solo per fare un esempio, alle copertine dei libri che cercano di accattivare il potenziale lettore sugli sca!ali delle librerie. Questa concezione non può che rimettere in discussione la tradizionale visione della bibliogra$a e delle sue competenze disciplinari. « De-$nita come lo “studio della sociologia dei testi”, la disciplina è sollecitata a estendere il suo orizzonte di studi in due diverse direzioni : da un lato, stabilendo protocolli di descrizione e forme di controllo bibliogra$co capaci di prendere in considerazione tutti i testi che non siano dei libri ; dall’altro, considerando che il suo oggetto di studio è costituito dall’insieme dei processi di produzione, di trasmissione e di ricezione dei testi, in tutte le loro forme » (p. 100). La bibliogra$a, dunque, perso il carattere ‘ancillare’ diviene disciplina « fondamentale per la ricostruzione delle modalità attraverso le quali una comunità dà forma e senso alle sue esperienze fondamentali » (p. 101).
Il volume si divide in tre parti corrispondenti alle tre lectures. Nella prima, Il libro come forma espressiva (pp. 15-36), McKenzie insiste sulla centralità del manufatto per la disciplina bibliogra$ca. La seconda parte reca il titolo, ripreso da un’espressione di Milton, La !ala infranta : i testi non-libri (pp. 37-58). È proprio questa la sezione centrale del volume, in cui la teoria dell’immaterialità del testo, cara all’autore, si esprime con grande forza e chiarezza. Questo concetto non può che dare ulteriore forza alle posizioni di chi, come Thomas Tan-selle, sostiene la necessità della conservazione dei supporti originali.
L’ultima parte è dedicata a La dialettica della bibliogra!a o"i (pp. 59-82) e propone, appun-to, ulteriori sviluppi della disciplina.
Il volume presenta, a mo’ di appendice, due saggi A proposito di Donald McKenzie. Il primo è Ciò che è passato è il prologo, di Renato Pasta (pp. 85-98), che riprende un altro celebre sag-gio di McKenzie (ora disponibile in italiano in Il passato è il prologo. Due sa"i di sociologia dei testi, Milano, Sylvestre Bonnard, 2002, per cui si veda la mia scheda). Il secondo è di Roger Chartier, Testi, forme, interpretazioni (pp. 98-108) e altro non è se non la traduzione della prefazione all’edizione francese.
La critica strutturalista ha portato alle estreme conseguenze le proposte di McKenzie, a!ermando l’assolutezza del testo, separato da ogni forma $sica particolare e ridotto alla sola struttura verbale ; la scomparsa dell’autore ; il ri$uto di riconoscere alle modalità di trasmissione, ricezione e interpretazione di un’opera una qualsiasi importanza nella costitu-zione del suo signi$cato. La proposta di McKenzie, invece, mira a ricostruire il processo di costruzione di senso proprio a partire dalla sua storicità.
[l. r.]
2000
A.
Brunetti Giuseppina, Il frammento inedito « Resplendiente stella de albur » di Giaco-mino Pugliese e la poesia italiana delle origini, Tübingen, Niemeyer, 2000.
La ricerca descritta nel volume di Giuseppina Brunetti prende l’avvio dalla scoperta di un frammento poetico inedito di lirica in volgare italiano intitolato Resplendiente stella de albur, versione antiquior (in un volgare de$nito « veneto orientale », che pure mantiene tratti di un sistema secondario), della lirica di Giacomino Pugliese tràdita dal Vaticano latino 3793 (V) con il titolo Ispendiente stella d’albóre. Il fortunato ritrovamento costituisce una testimonianza
repertorio bibliografico ragionato200
ðñò più parti eccezionale (p. 1) : il frammento è infatti, prima di tutto, il più antico lacerto tra-scritto della lirica siciliana, contemporaneo per giunta all’elaborazione stessa della Scuola ; è poi una « registrazione avventizia […] quasi un relitto a$orato dal naufragio della Scuola di Federico II » ; si tratta quindi di un documento a carattere testimoniale, sul quale la lirica di Giacomino appare in uno stadio sicuramente più vicino all’originale e non alterato dalla toscanizzazione linguistica ; in%ne, esso è prova della di&usione precocissima della poesia siciliana fuori dai con%ni del regno meridionale e fuori, anche, « dai canoni dell’irradiazione toscana ». Lo studio della Brunetti è diviso in due parti : la prima riguarda il frammento vero e proprio, di cui si descrive l’aspetto materiale a partire dalla collocazione nel codice, il C88 della Zentralbibliothek di Zurigo, latore principalmente delle Institutiones Grammaticae di Prisciano (metà xii secolo) ; sui fogli non occupati dalla trascrizione dell’opera principale compaiono frammenti vari di argomento grammaticale e tre testi trascritti dalla stessa mano : dei brani liturgici, un Landfriede promulgato nel 1234 da Enrico VII di Svevia, %glio di Federico II, e il frammento di Giacomino. Il pro%lo che la Brunetti delinea per lo scriba di questi testi è quello di un clericus con una « sciolta competenza scrittoria e forse una certa scaltrezza linguistica » (p. 22), capace com’è di scrivere senza commettere errori vistosi in latino, in medio alto-tedesco e in volgare italiano ; si tratterebbe, secondo Brunetti, di un « personaggio coltivato e curioso, dimorante in una zona di con%ne ove tradizioni e lingue di&erenti potevano allora […] trovare contatti e composizione » (ibidem) ; il testo di Giacomi-no è anzitutto copia di un testo scritto (ne fa fede la trascrizione %nale di un segno interpun-tivo) e con ogni probabilità (come si dice a p. 23) copia di un antigrafo su cui comparivano già il Landfriede e il testo in volgare ; l’ipotesi che si formula per spiegare la presenza del testo di Giacomino è quella di una ‘nota dorsale’ : non si può infatti pensare che i suoi versi fossero sul documento come riempitivo alla maniera di quanto si vede nei Memoriali bolognesi, ché ben diverso è l’ambito documentario – si tratta di una legge regia, rigidamente costruita dal punto di vista formale – e di$cilmente la trascrizione è fatta per evitare una contra&azione. L’indagine materiale prosegue con l’edizione dei testi (il Landfriede e i versi di Giacomino, editi in forma sinottica con la versione del Vaticano, e con un corredo di note) e con un’ex-pertise prima gra%ca (unità di scrittura, sistema delle abbreviazioni, grafemi, che indica complessivamente una padronanza non elevatissima del testo scritto da parte dello scriba, che agisce dunque in modo semimeccanico) e quindi linguistica, che conduce al pro%lo cui si accennava poc’anzi (p. 100) : un volgare italiano settentrionale, del Veneto orientale, di cui alcuni tratti riconducibili (seppure dubitativamente) a una varietà « estremamente » orientale (il friulano) ; una patina linguistica sotto la quale tuttavia si possono riconoscere tracce di un sistema secondario, vicino a quello autoriale, che la Brunetti chiama « lingua di Giacomino ».
La seconda parte dello studio è costituita da una serie di approfondimenti che la trouvaille e lo studio materiale connesso rendono imprescindibili : una geogra%a dei rapporti letterari tra Italia meridionale e Germania, con uno sguardo sui centri di di&usione della cultura e sui mediatori culturali (di origine tedesca) più strettamente in rapporto con la corte sveva, per meglio comprendere il milieu culturale che tenne come riferimento l’ignoto amanuense che copiò i versi di Giacomino ; quindi un’indagine – materiale anch’essa – sull’ampiezza e costituzione di un’ipotetica biblioteca federiciana, composta di una raccolta ‘immobile’ e di una ‘mobile’, commisurata alle esigenze di un monarca in continuo spostamento lungo la Penisola : per tentare di ricostruire quale fosse l’orizzonte ‘bibliogra%co’ di cui lo scriba poteva disporre ; in%ne, un sistematico catalogo di tutte le antiche attestazioni della poesia italiana in volgare, per confrontare il frammento ritrovato con alcuni analoghi e de%nirne il carattere extra-vagante (p. 182). Nel capitolo conclusivo l’autrice propone poi alcune ipotesi relative a Giacomino e al suo supposto liber, per il quale l’ipotesi che si suggerisce (posta in termini comunque probabilistici) è quella di un rotulus o Liederblatt, uno dei ‘fogli volanti’ su cui sarebbe circolato il breve canzoniere del poeta (otto liriche in tutto), e da una cui elaborazione, secondo Brunetti, abbastanza primitiva deriverebbe il modello del frammento
la materialità nella filologia (1985-2007) 201
óôõö÷øùúù (che consta di sole quattro strofe rispetto alle otto del canzoniere V) ; tale ipotesi implicherebbe un’iniziale fruizione « anorganica » del corpus di Giacomino (pp. 194-195).
Chiude il volume un’appendice in cui con%uiscono studi di varia natura, tra i quali risultano emblematici della produttività di un’indagine anzitutto materiale quelli relativi alla struttura del Vaticano latino 3793, che ne chiariscono l’ordinamento interno, le moda-lità dell’errore, l’immagine dell’antecedente (danneggiato) quale si evince dall’esame della fascicolazione, il valore ecdotico degli spazi bianchi e, in/ne, l’analisi della tradizione di V attraverso l’esame del frammento Magliabechiano.
[d. m.]
Cepraga Dan Octavian, Sistema dei generi lirici e dinamiche compilative : la posi-zione della pastorella nei canzonieri occitanici, « Critica del testo », iii, 3, 2000, pp. 827-870.
In questo studio l’autore propone un’attenta analisi delle diverse modalità che caratteriz-zano la trascrizione delle pastorelle occitaniche nei canzonieri trobadorici. Tale approccio risulta particolarmente produttivo per tentare una più precisa de/nizione degli elementi di-stintivi del genere, nonché per tracciare un pro/lo storico che evidenzi le peculiarità proprie della creazione e ricezione di questi testi in periodi e contesti ideologici assai diversi tra loro. Da questa ricerca emerge come primo dato utile il fatto che, tanto nella tradizione veneta , quanto in quella linguadociana y, le pastorelle dei trovatori più antichi /gurano disciolte
nelle sezioni che nei canzonieri raggruppano le canzoni. Per quanto riguarda le più antiche generazioni trobadoriche, dunque, tali dati evidenziano la mancanza della percezione della pastorella intesa come genere a sé stante ; nel contempo risulta particolarmente accentuato il rapporto intrinseco di questi testi con le tematiche della canso cortese e con il dibattito ideologico che in quei decenni si occupava della precisazione della natura della !n’amor. Un notevole cambiamento si registra considerando gli autori attivi tra xii e xiii secolo. Nella tra-dizione manoscritta di questi poeti è infatti possibile intravedere episodi che mostrano una mutata percezione dei testi che qui interessano : ciò è indice di una iniziale presa di coscienza delle peculiarità del genere pastorella, ma nel contempo del suo progressivo allontanamento dalla canso nel contesto di una nuova organizzazione interna della tradizione trobadorica imperniata sull’opposizione tra stile elevato e stile basso. I Liederbücher degli autori dell’au-tunno della stagione trobadorica attestano una ormai precisa cognizione della pastorella intesa come genere poetico ben de/nito, ma certamente minore, anche in conseguenza del progressivo svuotamento della tensione ideologica che caratterizzava tale tipologia testuale alle sue origini.
[s. r.]
Poe Elizabeth W., Compilatio. Lyric Texts and Prose Commentaries in Troubadour Manuscript H (Vat. Lat. 3207), Lexington, French Forum, 2000.
Basandosi sull’analisi della struttura del canzoniere provenzale H e dichiarando l’inten-zione di voler fornire un completamento di tipo letterario allo studio condotto sul medesi-mo manoscritto da Maria Careri nel 1990, l’autrice analizza alcune sezioni del codice indivi-duandovi in particolare tracce di stretti rapporti con l’attività poetica e divulgativa di Uc de Saint Circ. Dopo aver fornito una descrizione del manufatto, Elizabeth W. Poe si concentra sulla serie di coblas esparsas e tensonadas che caratterizza la sezione H3 del canzoniere ; tale raccolta si rivela dotata di particolare organicità, conferitale dalla /tta rete di richiami reci-proci che legano strettamente tra di loro i componimenti trascritti, tanto sul piano contenu-tistico quanto su quello metrico. Spicca in questa silloge di testi la /gura di Uc de Saint Circ, autore di ben diciotto degli items vergati in H3
; questi ultimi sono più analiticamente presi in considerazione nel secondo capitolo del volume, ove si precisa che questa serie di poesie
repertorio bibliografico ragionato202
ûüýþverebbe da una medesima fonte, contraddistinta da scarsa circolazione e dalla solidarietà di tematica e datazione delle coblas in essa comprese. L’autrice studia poi i componimenti di trobairitz trascritti in H3, la cui peculiare natura è messa in rilievo anche a livello materiale dalla presenza di miniature : secondo Elizabeth W. Poe, l’allestitore di H avrebbe avuto ac-cesso a una raccolta di testi forse originariamente concepita per un pubblico femminile, e, durante la trascrizione, ne avrebbe snaturato il carattere originario inframezzando alcune coblas misogine ai componimenti a voce femminile. L’analisi delle glosse apposte alla sezione H1 spinge poi la studiosa a ipotizzare che la maggior parte di esse sia stata copiata dai modelli a disposizione dell’allestitore e dunque non sia frutto di un lavoro di tipo anche esegetico operato delle diverse mani che hanno contribuito alla compilazione del codice. Lo studio procede concentrandosi sulle vidas e razos raccolte in H2 e H3, tutte ascritte a Uc de Saint Circ : integrando le conclusioni di Gröber, l’autrice individua a monte di H2 tre di&erenti fonti. Le prose di H3 deriverebbero invece, oltre che dalla collezione di poesie di trobairitz, da una raccolta di coblas tensonadas approntata dal poeta caorsino prima del suo arrivo in Italia. Il sesto capitolo o&re un’edizione della cosiddetta Summa dictaminis dei fogli 47-49 ; bisogna segnalare che in questo caso l’autrice « [has] reintegrated the coblas into the context of the prose statements about them » (p. 192). Tale sezione di H è poi analizzata nel settimo capitolo, ove si individuano i diversi apporti di fonti qui con0uiti e si tenta una collocazione storico-letteraria della peculiare raccolta : emergono in particolar modo le a1nità che la av-vicinano alla tipologia del 0orilegio inteso come progressiva riduzione delle raccolte di poe-sia lirica ad agili prontuari di savoire-vivre cortese. L’analisi condotta dalla studiosa americana mette dunque in luce l’importanza ricoperta dalla 2gura di Uc de Saint Circ nell’economia complessiva dei materiali con0uiti in H, un codice che si rivela particolarmente a1ne agli interessi di lettori che intendano avvicinarsi alla lirica trobadorica con un approccio di tipo scolastico, piuttosto che 2nalizzato all’imitazione del modello poetico occitanico.
[s. r.]
B.
Cannata Nadia, Il canzoniere a stampa (1470-1530). Tradizione e fortuna di un genere fra storia del libro e letteratura, Roma, Bagatto Libri, 2000.
L’autrice propone un’indagine che mira a ricostruire produzione e circolazione del gene-re lirico in Italia fra 1470 e 1530. I due estremi cronologici corrispondono a due edizioni cru-ciali nella storia del libro di rime : la princeps del Canzoniere di Petrarca (Venezia, Vindelino da Spira, 1470) e la pubblicazione delle Rime del Bembo (Venezia, Giovanni Antonio e fratelli Nicolini da Sabbio, 1530). Della sterminata produzione di libri di rime dà conto il Catalogo generale delle edizioni (pp. 211-256) e il successivo Catalogo descrittivo (pp. 257-423), col quale l’autrice ha inteso allestire una bibliogra2a delle edizioni di libri di rime impresse tra il 1470 e il 1530. L’indice cronologico delle edizioni e quello per stampatori e luoghi di stampa co-stituiscono gli strumenti di corredo necessari per muoversi con agio all’interno di tale vasta produzione. L’indagine bibliogra2ca consente in primo luogo di raccogliere i dati necessari per approfondire il discorso sul genere lirico, altrimenti ogni ri0essione in tal senso risul-terebbe pressoché infondata. Dai dati raccolti risulta infatti che in Italia nell’arco di tempo indicato furono stampati oltre 500 libri di rime, ossia, in termini di copie, presumibilmente circa 450.000 copie in un sessantennio, con inevitabili oscillazioni a seconda dei periodi. La ricerca condotta da Nadia Cannata, oltre a delineare il successo di un genere, individua l’evoluzione materiale del libro di rime, mutuando metodologia e interessi dell’analytical bibliography anglosassone. L’ampia introduzione (pp. 49-206) traccia l’evoluzione della forma libro tra Quattro e Cinquecento, so&ermandosi sulle caratteristiche che assume il libro in rapporto al testo che veicola. Si delinea il passaggio dai libretti in quarto stampati su due
la materialità nella filologia (1985-2007) 203
ÿc�c��� e destinati ad un pubblico popolare, al modello del Canzoniere di Petrarca stampato nel formato in folio come testo di un autore canonico, !no alla svolta inaugurata nel 1501 dall’edizione aldina di Petrarca che impone un nuovo modello di libro di rime nel formato in ottavo privo di commento. Alla luce della svolta del primo Cinquecento si illustra la for-mazione di un nuovo mercato per il libro di rime e l’adozione, talvolta forzata, della forma canzoniere anche a testi che « canzonieri non erano mai stati prima ». Lo studio indaga in modo approfondito le diverse tipologie adottate per i tre best seller del periodo : Sera!no Aquilano, Tebaldeo, Petrarca.
[g. p.]
Rico Francisco, Crítica textual y transmisión impresa (para la edición de « La Cele-stina »), in Imprenta y crítica textual en el Siglo de oro, a cura di Francisco Rico, Valladolid, Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, 2000, pp. 223-242.
Il saggio si apre con una dichiarazione di intenti : la necessità (o meglio l’« urgenza ») che la critica testuale presti un’« attenzione sistematica » alle speci!cità della trasmissione dei testi a stampa. La scelta di prendere come oggetto di studio la Tragicomedia de Calisto y Melibea, all’origine della letteratura moderna e dell’età della stampa, viene giusti!cata con l’esem-plarità delle sue vicende editoriali. Analizzando i testi di numerose edizioni della Celestina, e sottolineando, come in altri suoi scritti (in particolare nel successivo Francisco Rico, En torno al error. Copistas, tipógrafos, #lologías, Madrid, Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, 2004) l’inadeguatezza del metodo lachmanniano per i testi stampati, Rico mostra l’importanza di introdurre criteri di indagine speci!ci : scrive per esempio che « importa familiarizarse con las adiciones y omisiones motivadas por la ratio typographica, porque con frecuencia son capitales para el establecimiento del texto » (p. 233).
Santoro Marco, L’apporto della bibliogra#a testuale all’indagine #lologica, « Espe-rienze Letterarie », xxv, 1, 2000, pp. 3-32.
L’autore, muovendo da una serie di considerazioni sulla « bibliogra!a » pone una serie di interrogativi, sulla base delle pagine dei maggiori esponenti della textual bibliography, che riguardano i problemi relativi all’intreccio tra analisi materiale del libro e critica testuale, e all’autonomia delle discipline.
Tanselle G. Thomas, The Concept of Format, « Studies in Bibliography », liii, 2000, pp. 67-113.
« A few bibliographical terms are widely used by the general public, though usually with somewhat di6erent meanings from those understood by bibliographers » (p. 67). Comincia con questa forse banale, ma opportuna, considerazione il saggio di uno dei maggiori espo-nenti della bibliogra!a analitica anglo-americana, George Thomas Tanselle.
Uno di questi termini, che il senso comune utilizza in modo diverso rispetto a quello tecnico del bibliografo, è appunto ‘formato’. « People speak of the format of a television show or a ceremony, where the term refers to the nature and order of the contents » (p. 67 ; il gioco non rende perfettamente in italiano perché anche da noi è passato l’uso di ‘format’ e non si è tradotto in ‘formato’).
Il formato o, forse meglio, il formato bibliologico, invece, è un concetto importantissimo, che appartiene alla sfera della bibliogra!a. Esso è l’unico elemento a9dabile che permette al bibliografo di conoscere, in qualche modo, le dimensioni originali di un’edizione antica. Se per il libro industriale moderno è su9ciente fornire il formato bibliometrico (le misure in cm o mm del volume) – quello che si trova anche, normalmente, nelle schede di catalogo delle biblioteche – per il libro antico questo non ha quasi nessun senso, se non a livello di descrizione di un particolare esemplare. Infatti, era pratica frequente, in antico regime, quella
repertorio bibliografico ragionato204
d� ������� ����� � � � ����� �� d� ���������� �� ��� ����������� ������� ���� ������di legatura. Inevitabilmente, dunque, in molti casi il libro va progressivamente ‘rimpicciolen-dosi’. Quello che invece interessa, nella bibliogra!a analitica, è il foglio tipogra!co originale su cui è stato stampato il testo. E proprio il numero di piegature che il foglio tipogra!co ha subito, identi!cabile attraverso l’andamento di !loni e vergelle sulla carta e la posizione della !ligrana, fornisce il formato bibliologico, che è parte essenziale della formula collazionale (una stringa alfanumerica che descrive sinteticamente, ma analiticamente, un’edizione).
In questo saggio Tanselle ripercorre alcune problematiche relative al formato : la nascita e lo sviluppo del concetto, il suo impiego e la sua utilità nella bibliogra!a analitica, la sua identi!cazione pratica.
[l. r.]
2001
A.
Meliga Walter (a cura di), intavulare. Tavole di canzonieri romanzi, i, Canzonie-ri provenzali, 2, Bibliothèque nationale de France. I (fr. 854), K (fr. 12473), Modena, Mucchi, 2001.
Careri Maria, Fery-Hue Françoise, Gasparri Françoise, Hasenohr Gene-viève, Labory Gillette, Lefèvre Sylvie, Leurquin Anne-Françoise, Ruby Christine, Album de manuscrits français du xiiie siècle. Mise en page et mise en texte, Roma, Viella, 2001.
Esplicitamente debitore rispetto agli studi francesi precedenti (cfr. Mise en page et mise en texte du livre manuscrit, Paris, 1990), l’Album incarna in e6etti un progetto ben più ambizioso, di cui l’Introduction (pp. xi-xxxix), delinea i connotati. Scopo dell’opera è quello di muovere da un approccio materiale al manoscritto il più approfondito e capillare possibile per giun-gere alla determinazione di parametri ricorrenti nella presentazione dei testi, da utilizzare come criteri per lo studio degli stessi. Sono analizzati 52 manoscritti letterari confezionati in Francia tra il secondo decennio e la !ne del xiii secolo e conservati nelle biblioteche parigi-ne. Estremamente varie sono le forme e le tipologie testuali proposte. Ogni scheda (notice) è dedicata ad una pagina, scelta all’interno di un manoscritto. L’esame dettagliato di essa è completato da un’utile rappresentazione della sua struttura (righe, colonne, spazi riservati all’inserimento di elementi diversi) e dalla duplice edizione, diplomatica e interpretativa in sinossi, del testo. Numerose sono le considerazioni che gli esiti di tale studio permettono alle autrici di esprimere (Les manuscrits français du xiiie siècle : ré+exion d’après les témoins retenus, pp. xvi-xxxvii). Prima di tutto, è constatato il legame, necessario e in evoluzione diacronica, tra tipologia di testo, formato e qualità del codice, mise en page ; non si trovano, tuttavia, corrispondenze univoche e regolari tra questi elementi, né risulta sempre agevole estrapolare il signi!cato del loro rapporto reciproco. L’acquisizione paleogra!ca più impor-tante è costituita dall’individuazione di un repertorio di gra!e peculiari alla produzione in volgare (tavola alle pp. xxviii-xxix). Grande attenzione è rivolta, inoltre, alla mise en texte – abbreviazioni, punteggiatura e segmentazione dell’enunciato – di cui si descrive l’evoluzione a partire dall’uso mediolatino. Corredano il volume un glossario bilingue (francese e italia-no) di termini codicologici, la bibliogra!a, distinta in generale e speci!ca per ogni singolo manoscritto, e 16 tavole a colori.
[f. s.]
la materialità nella filologia (1985-2007) 205
Careri Maria, Codici facsimilati e tradizione attiva nella Geste des Loherains, « Ro-mania », cxix, 2001, pp. 323-356.
Nella tradizione lorenese della Geste des Loherains esiste un notevole numero di codici identici per costituzione e mise en page, che presentano però lezioni spesso divergenti e poco razionalizzabili. Careri, che riconosce in essi dei ‘facsimili’, nel senso proposto da Orlandi per alcuni manoscritti mediolatini, li analizza codicologicamente e ne confronta le varianti. Gli esiti della ricerca attestano un atteggiamento contraddittorio dei copisti, che da una parte riproducono fedelmente la struttura del modello, dall’altra intervengono sul testo. La studiosa individua, sulla base della tipologia variantistica, una massiccia dinamica contami-natoria che spiegherebbe la maggior parte delle discrepanze testuali. L’interesse &lologico di una simile ricerca è notevole, in quanto permette di ricostruire da un punto d’osservazione privilegiato alcuni meccanismi della copia in tradizioni ‘attive’.
[f. s.]
Leonardi Lino (a cura di), I canzonieri della lirica italiana delle origini, Tavarnuzze (Fi), sismel-Edizioni del Galluzzo, 2001.
La monumentale opera di edizione facsimile commentata dei tre manoscritti latori della lirica italiana delle origini &ssa un fondamentale turning point, consegnando agli studiosi uno strumento assolutamente versatile per l’indagine dei primordi della scuola poetica italiana : rappresentata appunto, sul versante delle testimonianze manoscritte, da una tradizione che, almeno &no allo spartiacque « generazionale e culturale » (Leonardi, nella Prefazione, p. vii) di Dante e Cavalcanti, si costituisce attorno e a partire dalle tre grandi sillogi in esame, esem-plate in Toscana sullo scorcio del Duecento : il manoscritto Vaticano latino 3793 (V), il Redi 9 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze (L) e il Banco Rari 217 (già Palatino 418) della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (P). Il progetto di edizione e studio comples-sivo rappresenta, nelle parole del curatore, il traguardo di una ricerca che, con il retroterra dei pionieristici approcci degli studiosi ottocenteschi, nonché dell’intervento della maggior parte degli editori di rime duecentesche, si costituisce nell’opera di d’Arco Silvio Avalle, attraverso la sua edizione interpretativa dei tre canzonieri allestita in vista delle Concordanze della lingua poetica italiana delle Origini (1992). In preparazione alle Concordanze – precisa Le-onardi – « si provvide ad un aggiornamento dei rilevamenti paleogra&ci e linguistici sui tre codici, ma l’attenzione dell’immenso lavoro fu necessariamente centrata altrove, in primo luogo sui problemi ecdotici e lessicali determinanti per l’allestimento del testo e delle fu-ture concordanze » (p. vii). La nuova edizione fotogra&ca diviene pertanto l’occasione per sistematizzare l’esame critico dei canzonieri, proponendo per ciascuno di essi un’indagine anzitutto materiale : strutturale e paleogra&ca, e dell’apparato iconogra&co, oltreché ov-viamente della loro posizione linguistica. Per quanto riguarda l’esame delle caratteristiche linguistiche, esso è condotto attraverso illuminanti contributi di Pär Larson (V), Giovanna Frosini (L) e Valentina Pollidori (P), confermando ipotesi geolinguistiche già precedente-mente formulate o in attesa di veri&ca : nel caso di V una scripta compattamente &orentina, di ascendenza borghese-mercantile, che si caratterizza per l’assenza di ogni latinismo ; per L una patina complessivamente pisana, che rinvia al luogo di provenienza della raccolta ma che tuttavia lascia trasparire, in sezioni fortemente omogenee come quella guittoniana o quella di Monte Andrea, tracce chiare della lingua delle fonti ; nel caso di P, l’origine pistoiese della mano che esempla il manoscritto (postulata da Avalle nel 1981 e quindi veri&cata dalla sua allieva Rossana Giorgi in una tesi dell’a.a. 1982-1983, poi con5uita nelle clpio), è ipotesi che il corredo delle miniature pareva smentire in favore di Firenze ; la pistoiesità della scripta è invece certi&cata attraverso la griglia di fenomeni che è &ssata attraverso le ricerche di Arrigo Castellani (il cui punto di arrivo è la Grammatica storica della lingua italiana, del 1990) e quindi precisata (per mezzo dell’analisi dei documenti coevi) da Paola Manni.
repertorio bibliografico ragionato206
M� è soprattutto l’esame della materialità dei codici che permette di trarre considerazioni decisive : la prima, fondamentale osservazione del curatore è quella che « in una tradizione pur così rarefatta, e per gran parte dipendente dalle medesime fonti, non si potrebbero pensare strutture compositive più diverse tra loro, e tutte singolarmente originali anche rispetto al retroterra occitanico » (p. vii) ; in particolare, riguardo a V, la presentazione curata da Antonelli (che aggiorna e precisa quanto già espresso in un contributo del 1992 dedicato al Canzoniere Vaticano latino 3793, per la Letteratura italiana di Einaudi) conferma la sua « orga-nizzazione tendenzialmente cronologica » in cui il materiale è ordinato in una « prospettiva +orentinocentrica » (pp. vii-viii), che partendo dai poeti della Magna Curia risale la Penisola e giunge, per il tramite di Bonagiunta, Guittone e Guinizzelli, all’esperienza dei +orentini Chiaro Davanzati e Monte Andrea. Un libro-antologia programmaticamente laico (p. 19), nel quale non ha pressoché spazio la poesia religiosa, e in cui l’assemblatore segue una rigorosa prospettiva storica (di cui si è appena detto) e ‘critica’, nella partizione tra canzoni (genere ‘alto’) e sonetti (genere ‘basso’), che connette V all’esperienza delle grandi antologie trobadoriche : facendo del codice – per utilizzare le parole di Antonelli – « un vero monu-mento letterario e critico alla poesia prestilnovista » (p. 9). Inoltre, se si accantona momenta-neamente una prospettiva lachmannianamente ricostruttiva e si considera il Vaticano latino 3793 nella sua materialità di « veicolo » della tradizione, si osserverà che è con ogni probabilità uno dei suoi derivati il manoscritto cui Dante ricorre, nel progetto del De vulgari eloquentia, per i poeti della Scuola siciliana e per il pre-stilnovismo (p. 6).
Quanto a L, l’analisi complessiva del canzoniere chiude, avvalendosi delle rinnovate peri-zie linguistica e paleogra+ca, la serie di interventi a più riprese dedicati, da Leonardi e non solo, alla questione dell’autorialità del canzoniere ‘di Guittone’ (in particolare, Leonardi Lino, Guittone nel Laurenziano. Struttura del canzoniere e tradizione testuale, in La !lologia ro-manza e i codici ; quindi Guittone d’Arezzo, Canzoniere. I sonetti d’amore del codice Laurenzia-no, a cura di Lino Leonardi ; e in+ne Picone Michelangelo, Guittone e i due tempi del « Can-zoniere », in Guittone d’Arezzo nel settimo centenario della morte) : la de+nizione cui si giunge è quella di « canzoniere aperto » (p. ix), che complessivamente sminuisce la proposta di Picone di considerare L in toto canzoniere d’autore, Liederbuch (il che comporterebbe anche, nota Leonardi, « una diversa valutazione della sua ‘autorevolezza’ anche sul piano testuale » : cfr. p. 159) ; la luce che la rinnovata indagine della materialità del codice (la mise en page, le rubriche, l’ordinamento dei testi, il comportamento di copisti e revisori) getta sulla struttura comples-siva del Rediano 9 spinge a postulare che alla base della silloge vi siano certo fonti riviste e ordinate da Guittone, che testimoniano la sua « ultima volontà testuale », ma che esse siano probabilmente state assemblate da « uno o più fedeli seguaci di Guittone » (p. ix).
In+ne P, la più antica delle tre raccolte (risale infatti all’ultimo quarto del ’200) e quella che complessivamente ospita il minor numero di componimenti (180, contro i 432 del Redi e il migliaio di V) ; l’indagine sul Palatino rivela una composizione più articolata rispetto a V e L, in dipendenza da un numero maggiore di fonti che apparentemente si giustappongono in modo non omogeneo, ma che in realtà si corrispondono in un progetto di raccolta amorosa organico e integralmente descritto da un testo decorativo e +gurativo ricco e imponente. È infatti proprio il corredo iconogra+co, descritto da Maria Luisa Meneghetti nel quadro delle più importanti raccolte miniate coeve (il codice Manesse, i manoscritti occitanici A, I, K, N, R, il Cancionero de Ajuda), che mostra uno strettissimo rapporto con il contenuto del manoscritto e che dichiara il proprio debito – tematico e ideologico – con il De Amore di Andrea Capellano nelle due grandi ‘illustrazioni’ (non più miniature) del folio iniziale (un triumphus amoris in cui lo stesso Andrea è ritratto, in nero, nel quadrante in alto a destra) e del folio 52v.
[d. m.]
Longobardi Monica, Censimento dei codici frammentari scritti in antico francese e provenzale ora conservati nell’archivio di Stato di Bologna. Bilancio de!nitivo, in La
la materialità nella filologia (1985-2007) 207
������� dell’Italia padana e la presenza francese nei secoli xiii-xv, Atti del Convegno di Pavia, 11-14 settembre 1994, a cura di Luigina Morini, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2001, pp. 17-38.
Seguito e completamento (gli anni trascorsi tra il convegno e la pubblicazione degli Atti o&rono all’autrice la possibilità di aggiornare ulteriormente la bibliogra+a) del bilancio presentato a Messina nel 1991 (Frammenti di codici dall’Emilia-Romagna : secondo bilancio, in La !lologia romanza e i codici, Atti del Convegno di Messina, Facoltà di Lettere e Filoso+a dell’Università degli Studi, 19-22 dicembre 1991, Messina, Sicania, 1993, pp. 405-418) : ciò che viene proposto al pubblico, insieme al censimento completo dei frammenti rinvenuti in un decennio, sono considerazioni di indubbio interesse in merito alla circolazione di testi e manoscritti romanzi nell’« Italia padana » tra xvi e xvii secolo, oltre ad alcune proposizioni di metodo in vista di ricerche ulteriori, auspicate da Longobardi a partire dall’esempio della propria pro+cua esperienza.
[f. s.]
Pulsoni Carlo, Repertorio delle attribuzioni discordanti nella lirica trobadorica, Mo-dena, Mucchi, 2001.
Il volume di Pulsoni nasce dall’intento di a&rontare una delle questioni centrali e tuttora aperte della lirica d’oc : i casi di attribuzione dubbia nel corpus dei trovatori rappresentano infatti il 15% del corpus complessivo. L’indagine risulta dalla constatazione che il primo sistematico censimento dei componimenti trobadorici compiuto da Bartsch nel 1872 abbia trasformato i manoscritti in semplici sigle, svincolandoli dalla loro materialità storica, che rappresenta uno strumento tra i più preziosi per dirimere eventuali dubbi di attribuzione ; prima « vittima », nota Pulsoni, di questo sistema di classi+cazione è Gröber, che nelle sue Liedersammlungen der Troubadours si basa spesso, per istituire relazioni tra codici, su attri-buzioni erronee proposte da Bartsch. Né dal siglario di Bartsch si discostarono in seguito, nel 1933, Pillet e Carstens nella loro Bibliographie der Troubadours, pur richiamando più volte l’attenzione sulle di6coltà attributive di alcuni testi : osservando che « il valore iconico della sigla numerica […] produce in taluni casi una certa inerzia rispetto alle questioni attributive » (p. 3), il volume nasce dall’esigenza di schedare in modo imparziale i componimenti attribuiti a più di un trovatore, poiché le classi+cazioni esistenti o&rono solo soluzioni in positivo.
Da un esame statistico, nella maggior parte dei casi (il 68%) l’incertezza attributiva riguar-da solo due autori, una tipologia cui si allineano in de+nitiva anche le situazioni di discor-danza in altre tradizioni liriche (oitanica, italiana, galego-portoghese e medio alto-tedesca, queste ultime due soprattutto per la scarsa consistenza della tradizione manoscritta) ; il più delle volte gli autori coinvolti hanno la stessa iniziale, o hanno nome identico (spesso il nome, come avviene ad es. in codici come C e R, è abbreviato), o è scritto il solo nome privo della cittadinanza ; oppure si tratta di trovatori coevi, che non di rado hanno gravitato nelle stesse corti o hanno scambiato tenzoni o coblas. Tali considerazioni integrano l’osservazione preliminare di Avalle (ne I manoscritti della letteratura in lingua d’oc, 1993, p. 68) secondo cui la maggior parte degli errori e degli scambi di attribuzione dipenderebbero dall’allestimento delle Gelegenheitssammlungen, quelle raccolte contenenti testi di diversi autori, non ordinati e trascritti talvolta da fogli volanti, dove spesso i componimenti apparivano privi di rubrica.
La novità strutturale introdotta da Pulsoni è quella di registrare le situazioni di attribu-zione discordante, diversamente da quanto avviene nella Bibliographie der Troubadours, attra-verso i codici, registrando per ciascun caso il dato del manoscritto e quelli dei manoscritti che con esso concordano e discordano, o&rendo così al lettore la possibilità di giudicare in modo neutro, attraverso il confronto dei materiali a disposizione ; da suggestioni ricavate da due contributi di Maria Luisa Meneghetti (Problemi attributivi in ambito trobadorico, negli Atti del Seminario L’attribuzione : teoria e pratica, 1994 ; e Stemmatica e problemi d’attribuzione
repertorio bibliografico ragionato208
f�� provenzali e siciliani, negli Atti del Convegno La !lologia romanza e i codici, 1993), Pulsoni tenta di tipologizzare le situazioni distinguendo per casi di discordanza ragioni codicologi-che e contenutistiche : tra le prime la molteplicità di fonti, la possibilità di cambiamento delle stesse, e soprattutto i casi di « %ne sezione », per i quali l’autore conia la tipologia di « errore seriativo » (p. 18), che può essere ‘progressivo’ o ‘regressivo’, a seconda che i primi compo-nimenti di una sezione siano attribuiti al trovatore della sezione precedente, ovvero che gli ultimi componimenti di una sezione siano attribuiti al trovatore della sezione successiva ; vi sono poi casi di contiguità tra trovatori maggiori e minori, dove l’attribuzione anomala può essere dovuta al ruolo che il ‘minore’ svolge nella performance del ‘maggiore’. Tra le ragioni contenutistiche, si menzionano l’analogia del tema e quella della cifra stilistica, nonché il riutilizzo di schemi metrici e/o musicali.
[d. m.]
B.
Fiaschi Silvia, Una copia di tipogra!a !nora sconosciuta : il Laurenziano Plut. 89 sup. 113 e ‘l’editio princeps’ del “De re aedi!catoria”, « Rinascimento », xli, 2001, pp. 267-284.
L’autrice individua nel codice Laurenziano Pluteo 89 sup. 113 la copia di tipogra%a del De re edi!catoria di Leon Battista Alberti che è stata utilizzata per comporre la princeps (Firenze, 1485).
Tanselle G. Thomas, Textual Criticism at the Millennium, « Studies in Bibliogra-phy », liv, 2001, pp. 1-80.
In risposta a Jerome McGann, il maggiore esponente dell’approccio ‘sociologico’ nell’ec-dotica (le forme dei testi così come originariamente di>usi), e ad alcuni suoi ‘seguaci’, dopo il saggio Textual Criticism and Literary Sociology, « Studies in Bibliography », xliv, 1991, pp. 84-144 (per cui si veda qui la relativa scheda), Thomas Tanselle propone questa ampia e articolata rassegna sulla questione. All’inizio di un nuovo secolo e di un nuovo millennio, Tanselle, uno dei maggiori esponenti della textual bibliography anglo-americana, ritorna su uno dei temi che più gli sono cari : la relazione tra lo studio dei libri come manufatti e la critica testuale.
« Textual criticism is one of the few scholarly %elds that can be talked about in terms of millennia, for it has been practiced in an organized fashion for at least twenty-three hundred years » (p. 1). Tanselle, tuttavia, ricorda come le critiche giunte alla disciplina negli ultimi anni del xx secolo, in seguito ai nuovi approcci di stampo ‘sociologico’ ai testi, abbiano minato o abbiano cercato di minare in qualche modo i presupposti su cui la critica testuale è nata, si è sviluppata e ha ricevuto importanti supporti dal mondo della textual bibliography. È proprio dal cuore della bibliogra%a analitica anglosassone che sono giunte le critiche più signi%cative alla visione tradizionale che ha in Fredson Bowers il suo esponente di maggior rilievo e proprio in Tanselle uno dei maggiori continuatori e ‘apologisti’.
Il saggio è l’occasione per il bibliografo Tanselle di ripercorrere le ultime evoluzioni della bibliogra%a e della critica testuale, soprattutto in area anglosassone, e per prospettare le s%de che si presentano allo studioso, anche in seguito all’introduzione di nuove tecnologie che postulano nuove forme testuali (in primo luogo gli ipertesti, particolarmente utili, secondo Tanselle, per le edizioni critiche e per le descrizioni bibliogra%che analitiche), ma anche nuovi canali di trasmissione dei testi. Gli interventi presi in considerazione qui da Tanselle riguardano gli ultimi cinque anni in ideale continuazione con il saggio Textual Instability
la materialità nella filologia (1985-2007) 209
a ! Editorial Idealism (« Studies in Bibliography », xlix, 1996, pp. 1-60 ; si veda qui la relativa scheda).
[l. r.]
2002
A.
Alvar Carlos, Lucía Megías, José Manuel, Diccionario #lológico de la literatura medieval española. Textos y transmisión, Madrid, Editorial Castalia, 2002.
Strumento di consultazione utilissimo ed esaustivo. Le schede, dedicate ai singoli autori, sono disposte in ordine alfabetico e riportano, dopo una nota bio-bibliogra+ca, il repertorio della tradizione delle singole opere, accompagnato da una sintetica ma precisa descrizione dei testimoni che le tramandano.
[f. s.]
Busby Keith, Codex and Context. Reading Old French Verse Narrative in Manuscript, Amsterdam-New York, Rodopi, 2002. [Recensione di Massimiliano Gaggero, « Critica del testo », vi, 3, 2003, pp. 1147-1158].
La breve Introduction (pp. 1-6) espone le motivazioni di questo enorme saggio (60 pp. soltanto per la bibliogra+a di riferimento) sui manoscritti della narrativa oitanica in versi. Busby ritiene necessario a4ermare la centralità della componente materiale per lo studio di una produzione letteraria che vede in quella la condizione necessaria della propria esistenza e comunicabilità : il recupero dei codici, strumento altresì fondamentale di indagine storico-culturale, è sostenuto in contrapposizione con certa critica statunitense che, attenta solo agli aspetti testuali, ritiene di poter prescindere da tutto ciò che è ‘contesto’, e in continuità con il « codicological imperative » (p. 2) a suo tempo enunciato da Sylvia Huot (From Song to Book. The Poetics of Writing in old French Lyric and Lyrical Narrative Poetry, Ithaca, ny-London, 1987), le cui ricerche sono più volte richiamate. Una rapida panoramica sugli argomenti trattati fornirà un’idea della ricchezza degli spunti che il libro o4re. Il capitolo 1 (Manufacture and Sale, pp. 7-58) tratta dell’evoluzione, tra xii e xiii secolo, della produzione di manoscritti, di cui, pur evitando generalizzazioni abusive, sono individuate alcune linee di tendenza. Il capitolo 2 (Varietes of Scribal Behaviour, pp. 59-126), vede l’indagine sui manoscritti preceduta dalla polemica con i sostenitori della New Philology, cui l’autore oppone un concetto euri-sticamente pro+cuo di variance, quale è valutabile concretamente nell’attitudine del copista verso il modello, per come appare dalla testimonianza fornitane dal manoscritto. Tre casi, in particolare, sono esaminati : quello di una duplice copia da parte dello stessa mano (mirror copying), quello di un copista interventista (wilful scribe), quello, in+ne, di uno scriba carat-terizzato da atteggiamento ricostruttivo (corrector/editor). Nel capitolo 3 (Mise en texte, mise en page, and Reader Manipulation, pp. 127-224) sono indagate, con ampia esempli+cazione, le forme di orientamento del lettore da parte del contesto (mise en texte e mise en page). Il quarto capitolo (Text, Miniature, and Rubric, pp. 225-366) è dedicato allo studio del corredo miniato e delle rubriche di quattro lunghe compilazioni – il Roman de Renart, il ciclo epico della crociata, il Roman d’Alexandre, il Perceval di Chrétien de Troyes e le sue Continuazioni – in rapporto al testo. Il capitolo 5 si misura con la lettura ‘contestuale’ delle opere tradite in antologie. L’autore prende in esame tre diversi generi : la chanson de geste, con il suo ad-densarsi in cicli ; il romanzo arturiano epigonico, che tende a coagularsi in base alla materia
repertorio bibliografico ragionato210
e "# $%&'"(&)#*'#+ #),)e # fabliaux. Il capitolo 6 descrive la geogra!a della produzione dei codici, o#rendo un panorama storicamente circostanziato di quella che è de!nita medieval Francophonia, suddivisa in cinque partizioni geolinguistiche : la Normandia con l’Inghilterra e l’Angiò, il Nord-Est piccardo-vallone, l’Est lorenese e borgognone, il Centro parigino e la Champagne, in!ne l’Italia (grande centro di ricezione di letteratura e libri francesi). Il set-timo capitolo, in!ne, ripercorre, grazie alla testimonianza di cataloghi e postille sugli stessi manoscritti, la storia dei loro possessori, suddivisi per appartenenza sociale. Un paragrafo a parte è riservato, ancora una volta, all’Italia e alle sue grandi famiglie signorili, appassionate di letteratura transalpina.
[f. s.]
Careri Maria, Per una tipologia dei manoscritti epici, in L’épopée romane, Actes du xve Congrès international Rencesvals, Poitiers, 21-27 août 2000, a cura di Gabriel Bianciotto, Claudio Galderisi, Poitiers, Université de Poitiers-Centre d’études supérieures de civilisation médiévale, 2002, pp. 759-762.
L’autrice presenta i primi risultati di un progetto di ricerca che mira all’esame e alla sche-datura dell’intero corpus dei codici di epica francese copiati entro la metà del Trecento. Due sono gli aspetti considerati : la mise en page e il rapporto tra formato e qualità del volume.
[f. s.]
Meneghetti Maria Luisa, La cultura visiva (a"reschi, rilievi, miniature), in Lo spa-zio letterario del Medioevo, 2, Il Medioevo volgare, ii, a cura di Piero Boitani, Mario Mancini, Alberto Vàrvaro, Roma, Salerno Editrice, 2002, pp. 463-488.
Muovendo dalla constatazione della millenaria coesistenza e interazione delle culture visiva e letteraria, parzialmente tradita nei secoli che vanno dalla !ne dell’età antica !no almeno al xii secolo, il contributo !ssa per il medioevo alcune situazioni e momenti topi-ci : anzitutto il fatto che « la prima e più pro!cua convergenza […] tra arte e letteratura si manifesta, nel corso del medioevo, proprio nella chiave di una fruizione didattica », secon-do i precetti che a più riprese e a più altezze cronologiche sono enunciati da personalità emblematiche della cultura dell’epoca : « pictura quasi scriptura », si legge nelle Epistulae di Gregorio Magno, o « pictura […] est laicorum litteratura », nell’Elucidarium di Onorio d’Au-tun ; e non è un caso, nota Meneghetti, che sia proprio il Medioevo l’epoca in cui l’apparato decorativo si a>anca alla scrittura per interagirvi in una proporzione sempre più paritaria, e il codice miniato, per così dire « si fa […] parete, […] o#rendosi a una fruizione pubblica e collettiva » ; così come è la parete dipinta che « si fa manoscritto », ospitando un ‘testo’ sempre più caratterizzato da una valenza narrativa (p. 470).
Di seguito, l’autrice si misura con uno dei nodi del rapporto tra arte e letteratura in epoca medievale, e cioè la « presenza di temi letterari nel complesso delle realizzazioni arti-stiche » (p. 479) ; già episodicamente sviluppato in relazione al ciclo di a#reschi del Castello della Manta (Il manoscritto fr. 146 della Bibliothèque Nationale di Parigi, Tommaso di Saluzzo e gli a"reschi della Manta, apparso nel 1989 su « Romania »), il tema ha trovato il suo compiuto sviluppo in un recente Convegno tenutosi a Certaldo nel 2007 (titolo del contributo è Temi cavallereschi e temi cortesi nell’immaginario *gurativo dell’Italia medievale, in La letteratura caval-leresca dalle « Chansons de geste » alla « Gerusalemme liberata ») ; qui come nel Convegno certal-dese, si individuano come fonti privilegiate dei soggetti !gurativi l’epos rolandiano, attestato soprattutto in contesti monumentali a carattere religioso, e il romanzo arturiano, presente in contesti di fruizione più privata, quali possono essere le camerae Lanzaloti a#rescate in residenze e castelli nobiliari.
[d. m.]
la materialità nella filologia (1985-2007) 211
B-
Bertolo Fabio Massimo, Studi di bibliogra�a testuale, « La Cultura. Rivista di #lo-so#a letteratura e storia », xl, 1, 2002, pp. 153-162.
L’autore o+re una panoramica dei più recenti studi di bibliogra#a testuale, e, mettendo in guardia da esercitazioni erudite prive di ampio respiro, sollecita « nuove edizioni critiche e ricerche bibliologiche che – almeno per il versante della #lologia italiana – contribuiscano a dare senso e dignità al metodo » (p. 158).
Bionda Simone, La copia di tipogra�a del ‘Trattato dei Governi’ di Bernardo Segni : breve incursione nel laboratorio del volgarizzatore di Aristotele, « Rinascimento », xlii, 2002, pp. 409-442.
L’autore presenta (servendosi anche di immagini) la copia di tipogra#a per l’editio princeps (1549), presso Lorenzo Torrentino, del volgarizzamento della Politica di Aristotele compiuto da Bernardo Segni.
McKenzie Donald Francis, Il passato è il prologo. Due sa"i di sociologia dei testi, a cura di Michael F. Suarez, Milano, Sylvestre Bonnard, 2002.
Nel 1992, in occasione del centenario della fondazione della Bibliographical Society bri-tannica, il neozelandese McKenzie tenne una conferenza dal titolo What’s Past is Prologue (poi pubblicata privatamente : London, Bibliographical Society, 1993) : in essa, partendo proprio dalla storia della « Bibliographical Society » e della analytical bibliography di stampo anglosassone, guardava verso il futuro della disciplina, in modo particolare considerando i problemi e le opportunità legati all’avvento dell’informatica. È da qui che nasce questo agile volumetto che raccoglie solo due testi di McKenzie introdotti da Michael Suarez e basati sul primato del manufatto. « Scopo di questo libro è di rendere per la prima volta facilmente ac-cessibili in italiano due fra i più importanti scritti di McKenzie » (p. 7). Uno dei punti centrali del pensiero del bibliografo neozelandese è di mettere in relazione, nel migliore dei modi possibili, la storia della produzione libraria e gli studi letterari. In questo volumetto, che mo-stra come la concezione della bibliogra#a proposta dall’autore sia distante dalle tradizionali posizioni dell’analytical bibliography anglo-americana, se ne ha una prova convincente.
Il primo contributo, Il passato è il prologo. La Bibliographical Society e la storia del libro (pp. 19-42), che dà il nome alla breve raccolta, è proprio dedicato all’istituzione inglese e alla sua ormai più che centenaria attività, della quale McKenzie fu anche presidente. Proprio grazie a questa sua autorevolezza egli « si servì di questa occasione non solo per dare un giudizio sulle imprese accademiche della Società negli ultimi cento anni, ma anche per sollevare domande provocatorie sul futuro » (p. 13). Partendo dal presupposto che ogni elemento del libro materiale è portatore di signi#cato, McKenzie asserisce che tutto concorre alla com-prensione e all’interpretazione di un’opera.
McKenzie non manca poi di passare in rassegna il contributo alla disciplina portato dai bibliogra# britannici, asserendo però che manca loro « la “struttura concettuale” necessaria a trasformare la bibliogra#a analitica in una più completa “storia del libro” » (p. 14).
Nel secondo saggio, La sociologia di un testo. Oralità, alfabetismo e stampa all’inizio del xix secolo in Nuova Zelanda (pp. 43-92), pronunciato come discorso presidenziale alla Bibliogra-phical Society di Londra e pubblicato per la prima volta su « The Library » (s. vi, 6, 1984, pp. 333-365), McKenzie fornisce una prova concreta della sua teoria della ‘sociologia dei testi’, a;data in particolare alle « Panizzi lectures » raccolte in Bibliography and the Sociology of Texts (London, The British Library, 1986 : il lettore italiano può leggerle in Bibliogra�a e sociologia dei testi, Milano, Sylvestre Bonnard, 1999 ; si veda in questa sede la relativa scheda).
repertorio bibliografico ragionato212
I. questo contributo, quasi con spirito patriottico, McKenzie ricostruisce la controversa storia del Trattato di Waitangi del 1840. Questo accordo, fatto $rmare dai rappresentati della Corona imperiale britannica a quaranta capi Maori, stabiliva la cessione di autorità all’Impero inglese. I problemi nascono a causa del diverso paradigma culturale che separa i $rmatari : da un lato gli inglesi, con una millenaria tradizione scritta di stampo europeo, dall’altro i Maori per cui il testo scritto non aveva alcun valore o, almeno, non superava come autorevolezza gli accordi verbali. La bibliogra$a dunque, tutt’altro che limitata agli studi letterari o $lologici, può e anzi deve ampliare il suo raggio d’azione anche alla storia, politica e sociale. Questo auspicato allargamento si ritroverà poi anche in Bibliography and the Sociology of Texts, con un’enunciazione più precisa e articolata.
[l. r.]
2003
A.
Beltrán Vicenç, Copisti e canzonieri : i canzonieri di corte, « Cultura Neolatina », lxiii, 2003, pp. 115-163.
Ancora una tappa dell’ormai più che decennale ricerca di Beltrán sui canzonieri iberici. Lo studioso si domanda se sia possibile rinvenire, tra le raccolte conservate, la testimo-nianza di quella fase intermedia di aggregazione dei materiali nella tradizione che Gröber identi$cava nelle Gelegenheitsammlungen. Sono prese in esame dapprima le circostanze storico-culturali in cui tali sillogi furono assemblate : il collegamento privilegiato con l’ambiente signorile determina la de$nizione di esse come ‘canzonieri di corte’. L’analisi materiale del canzoniere catalano J porta ad individuare in esso proprio un esemplare di questa tipologia.
[f. s.]
Costantini Fabrizio, Le unità di scrittura del Vaticano Latino 3793, « Critica del testo », vi, 3, 2003, pp. 969-1008.
Zamuner Ilaria (a cura di), intavulare. Tavole di canzonieri romanzi, i, Canzo-nieri provenzali, 3, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana. V (Str. App. 11 = 278), Modena, Mucchi, 2003.
Noto Giuseppe (a cura di), intavulare. Tavole di canzonieri romanzi, i, Canzonieri provenzali, 4, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana. P (plut. 41. 42), Modena, Mucchi, 2003.
B.
McKenzie Donald Francis, Stampatori della mente e altri sa/i, a cura di Michael F. Suarez, Milano, Sylvestre Bonnard, 2003.
Questa collezione di saggi corrisponde solo in parte all’edizione originale di Making mea-ning. “Printers of the mind” and other essays, a cura di Peter D. McDonald, Michael F. Suarez, Amherst-Boston, University of Massachusetts Press, 2002, che comprende ben undici saggi,
la materialità nella filologia (1985-2007) 213
/01230 questa italiana che ne propone solo tre, due dei quali non fanno parte della raccolta originale.
È nel lungo saggio Stampatori della mente. Osservazioni sulle teorie bibliogra�che e sull’atti-vità delle tipogra�e (pp. 29-122), che dà il nome alla raccolta e che è uscito per la prima volta su « Studies in Bibliography », xxii, 1969, pp. 1-75, che McKenzie a&onda la sua critica alla tradizionale bibliogra'a analitica anglosassone e, in modo particolare, a Fredson Bowers e Charlton Hinman – rispettivamente maestro e allievo – due dei capisaldi della visione anglo-americana della bibliogra'a. Quest’ultima, secondo McKenzie, non va rinchiusa nell’ambito della 'lologia e della critica testuale, ma va riportata sul piano storico e puramente testuale (nel senso del valore del testo in relazione a un pubblico). Il bibliografo neozelandese fa una critica di metodo che mina (o dovrebbe minare) alla radice l’applicazione della bibliogra'a analitica. Egli propone, infatti, di sostituire il metodo induttivo, secondo cui dalle attesta-zioni concrete degli esemplari superstiti si formula poi una regola generale, con quello deduttivo, secondo cui un’ipotesi di carattere generale viene sottoposta a veri'ca mediante l’applicazione ai singoli casi. Anche se il tema ritorna spesso negli scritti di McKenzie, si tratta di uno dei saggi più importanti dello studioso e di uno dei più celebri.
Partendo da alcune considerazioni sull’organizzazione del lavoro all’interno di una tipogra-'a di antico regime (e McKenzie conosceva bene tale realtà grazie all’assidua frequentazione degli archivi storici della Cambridge University Press da cui nasceranno i due volumi di The Cambridge University Press, 1696-1712. A Bibliographical Study, Cambridge, Cambridge University Press, 1966), l’autore mostra come le deduzioni dei bibliogra' analitici non siano sempre pre-cise se messe in relazione alla documentazione diretta dell’attività impressoria. Il rendimento degli operai (uomini, donne, in Spagna anche schiavi), la produzione simultanea con la fase di composizione che deve armonizzarsi perfettamente con quella di impressione, sono tutti dati che emergono sì dagli oggetti materiali che si studiano, ma anche dai documenti d’archivio (quando si ha la fortuna che questi siano sopravvissuti !). Queste variabili però spesso danno luogo a situazioni completamente imprevedibili (com’è insito in ogni attività umana) che dif-'cilmente poi emergono dallo studio ‘nudo e crudo’ dei manufatti. I ‘tipogra' della mente’ (forse meglio ‘di fantasia’) diventano così delle mere supposizioni che mal si conciliano con i veri operatori del mondo della stampa. Purtroppo non sempre è possibile disporre di un patrimonio documentario (o, come lui le de'nisce, « prove collaterali ») come quello indagato da McKenzie, che rappresenta una rara eccezione piuttosto che una regola.
Il secondo saggio è dedicato invece a La storia del libro (pp. 123-138) e originariamente è nato come contributo alle celebrazioni per il centenario della Bibliographical Society ingle-se (1992). D’altra parte, « la storia dei libri, se non la “storia del libro”, è una delle attività cui la Bibliographical Society si dedica 'n dalla sua nascita » (p. 123). Il contributo cerca di descrivere che cos’è, secondo McKenzie, la storia del libro in relazione sia alle attività della Bibliographical Society sia alla analytical bibliography.
Il terzo e ultimo saggio della raccolta presenta Le economie della stampa, 1550-1750. Scale di produzione e condizioni di vincolo (pp. 139-172). Qui McKenzie, con tono seminariale e didattico, descrive alcuni aspetti della gestione economica e commerciale delle ‘industrie’ tipogra'co-editoriali di antico regime. Il panorama che emerge fa rimpiangere di non aver a disposizione anche gli altri testi della raccolta originale in lingua inglese, in gran parte dedicati alla circolazione e al commercio del libro in Inghilterra nel Sei e Settecento. L’auto-re, infatti, si è occupato a più riprese di questo tema che rappresenta uno dei settori meno esplorati delle discipline del libro.
Il volume presenta anche una Testimonianza allargata di Michael F. Suarez su D. F. McKenzie e le forme di conoscenza bibliogra�ca (pp. 7-28), che traccia un bel pro'lo intellettuale di McKenzie e mostra gli svariati interessi (soprattutto bibliogra'ci, ma anche letterari), tutti coltivati con serietà e metodo, che hanno caratterizzato la vita dello studioso. Da qui emergono anche i presupposti del saggio più importante di questa miscellanea, che attinge a piene mani dal pensiero 'loso'co di Karl Popper.
repertorio bibliografico ragionato214
456enzie, insomma, ricorda quanto sia indispensabile mantenere unita l’analisi speci!ca e minuziosa dei singoli aspetti degli esemplari con la ricerca storica e quindi, soprattutto, con la ricerca documentaria in archivio. Questo è l’unico metodo, secondo l’autore, a consentire di comprendere con una panoramica ampia e minuziosa la realtà complessiva dell’oggetto che il bibliografo ha davanti a sé.
[l. r.]
2004
A.
Storia, geogra!a, tradizioni manoscritte, « Critica del testo », vii, 1, 2004.
Il numero monogra!co della rivista contiene gli Atti del Convegno tenutosi a Roma nel maggio del 2001 : l’ottica proposta dagli organizzatori (Presentazione, pp. vii-ix) mira ad unire i tre aspetti sintetizzati nel titolo in un pro!cuo approccio al testo. Lo studio materiale del codice viene così inserito, secondo l’insegnamento di Avalle, in un coordinamento sistematico delle competenze ai !ni della ricostruzione storica e !lologica. Alcuni contributi sono di parti-colare interesse per la !lologia materiale. Maria Careri e Paolo Rinoldi (Copisti e varianti : codici gemelli nella tradizione manoscritta della Geste de Guillaume d’Orange e della Geste des Loherains, pp. 41-104) si interrogano sulla possibilità di ricostruire l’e0ettiva fenomenologia dell’azione dei copisti nella trascrizione e nella compilazione. In vista di tale scopo, sono presi in considerazione i casi particolari dei ‘codici gemelli’. Roberto Benedetti (Frammen-ti arturiani. Percorsi e nuove individuazioni : l’Estoire del saint Graal, pp. 257-294) a0ronta la questione dello studio dei frammenti di romanzi medievali, tanto in una prospettiva storico-culturale, quanto per l’importanza che essi possono rivestire in sede di constitutio textus. Va-leria Beldon (Osservazioni sulla tradizione manoscritta della lirica d’oc e d’oïl in area lorenese, pp. 425-446) individua, mediante l’analisi della struttura e delle fonti dei tre canzonieri U, C ed I, una linea lorenese di tradizione di testi e melodie oitanici e occitanici.
[f. s.]
Battelli Maria Carla, Due canzonieri, un solo manoscritto ? A proposito di Paris, BnF fr. 765 (canzoniere L) e Bern, Burgerbibliothek 231 (canzoniere B), « Critica del testo », vii, 3, 2004, pp. 981-1044.
La studiosa a0ronta la questione, già accennata da Schwan sulla base dell’estrema somi-glianza di alcuni elementi, dell’ipotetica appartenenza delle due sillogi, !n qui piuttosto trascurate dalla critica, ad un medesimo manoscritto. L’esame della composizione materiale di esse, accompagnato dall’analisi gra!ca, linguistica e dei corpora traditi, porta a confermare che il progetto originario doveva prevedere un unico codice composito.
[f. s.]
Carapezza Francesco, Il canzoniere occitano G (Ambrosiano R 71 sup.), Napoli, Liguori, 2004.
G, compilato in area veneta nell’ultimo trentennio del Duecento, è uno dei rari can-zonieri musicali trobadorici conservati e l’unico di tale genere prodotto in Italia : questo costituisce il principale motivo d’interesse del codice, al quale F. C. dedica un’analisi « essen-zialmente descrittiva » (p. 5). L’indagine è impostata sulla falsariga dello studio che Maria Ca-
la materialità nella filologia (1985-2007) 215
r7r8 9798:; < = >7? @AADE F< G7>H< :8F7>J<rG8 >7??K GJL98K 97??7 NK>J8 97? :KO8GJ< Or8>:8O<?7Eparticolarmente problematico nel caso del manoscritto ambrosiano. L’analisi degli aspetti materiali del manufatto permette di e"ettuare alcune osservazioni riguardo al rapporto esistente tra testo poetico e testo musicale : la copiatura dei componimenti verso per verso (che il compilatore ricava probabilmente dal suo antigrafo, sprovvisto però di notazione) pare infatti essere in contrasto con le abitudini degli altri canzonieri trobadorici dotati di melodie e sembra con�gurarsi come un tentativo di coniugare l’interesse precipuamente musicale dell’allestitore con un’attitudine �lologico-letteraria tipica della ricezione italiana della lirica provenzale. Indizi di varia natura rendono inoltre assai probabile che la gra�a del notatore e quella del correttore che intervenne sul manoscritto in tempi molto prossimi alla sua compilazione appartengano alla medesima persona. Quanto alle melodie di G, la loro fonte, unica, andrà probabilmente identi�cata con un collettore di canzoni dotate di nota-zione musicale a�erente a circuiti della tradizione manoscritta trobadorica diversi da quelli a cui sono da ricondurre i componimenti trascritti nella raccolta. La descrizione interna del canzoniere permette invece alcune osservazioni sulle scelte editoriali dell’allestitore. Si nota in primis l’assenza dell’usuale tripartizione per generi : la mancanza della sezione dedicata ai sirventesi, caratteristica condivisa da G e Q, potrebbe far pensare a una comune derivazione da una tradizione autoctona, dunque non italiana. La tavola dei contenuti del manoscritto evidenzia una netta preponderanza di autori operanti in Occitania, ma anche la presenza di poeti italiani o attivi in Italia settentrionale non oltre il quarto decennio del xiii secolo. Il canone dei trovatori e dei testi trascritti si motiva sulla base del numero di melodie che l’allestitore prevedeva di reperire, così come avviene anche nel caso degli altri canzonieri musicali trobadorici. Per quanto riguarda l’ordinamento interno, il compilatore ha adottato un criterio di tipo quantitativo, nonostante siano rilevabili tracce residue di una distribu-zione alfabetica probabilmente praticata in piani più alti della tradizione e, in alcuni punti, forse anche di un’organizzazione fondata su a%nità metriche. Segue un’analisi grafematica condotta su un campione rappresentativo di testi ; i suoi risultati sono presentati in forma tabulare per gra�e e per basi etimologiche, così come già aveva fatto Maria Careri nella sua monogra�a su H. Proprio il confronto con il già ben studiato H facilita un tentativo di classi�cazione degli italianismi presenti nel codice ambrosiano. Il volume, corredato anche da numerose tavole, è completato dall’edizione critica degli unica e da quella diplomatica dell’intero canzoniere. Dall’analisi complessiva del manoscritto risulta chiaro « come i suoi caratteri materiali e strutturali, ovvero le circostanze della sua produzione, vadano collegati alla sua funzione primaria di repertorio di testi da cantare. Ad una fruizione di tipo diretta-mente performativo rimandano in e�etti alcuni elementi dell’apparato musicale » (p. 206). Cfr. anche intavulare. Tavole di canzonieri romanzi, i, Canzonieri provenzali, 6, Milano, Biblio-teca Ambrosiana. G (R 71 sup.), a cura di F. Carapezza, Modena, Mucchi, 2004.
[s. r.]
Borghi Cedrini Luciana (a cura di), intavulare. Tavole di canzonieri romanzi, i, Canzonieri provenzali, 5, Oxford, Bodleian Library. S (Douce 269), Modena, Mucchi, 2004.
Zimei Enrico, Sulla divisione della catena gra&ca in antico occitano. Scritture docu-mentarie, « Critica del testo », vii, 2, 2004, pp. 877-905.
B.
« Ecdotica », i, 2004.
Con la direzione di Gian Mario Anselmi, Emilio Pasquini (entrambi dell’Università degli Studi di Bologna) e di Francisco Rico, dell’Universidad Autónoma de Barcelona e direttore
repertorio bibliografico ragionato216
PQR Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, il primo numero di « Ecdotica » (pubbli-cata da Carocci editore in collaborazione con il Dipartimento di Italianistica dell’Università degli Studi di Bologna e il Centro para la Edición de los Clásicos Españoles) si apre con una Presentazione %rmata dai direttori che, citando un intervento di Aurelio Roncaglia del 1975, sottolinea l’estensione della nozione di ecdotica, più ampia di quella di critica testuale, « includendo in sé tutti gli aspetti della tecnica editoriale : anche quelli meno essenziali, concernenti, di là dell’assetto interno del testo, anche l’assetto esterno dell’edizione (modi di messa in pagina, disposizione, titolazione, uso di0erenziato dei caratteri gra%ci, corredo d’illustrazioni e d’indici, ecc.) » ; di fatto « tutti gli elementi che segnano l’intero cammino di un testo dall’autore ai lettori (o fruitori), sempre che tali elementi vengano contemplati nella prospettiva di un’edizione, antica o moderna, destinata allo studio o alla lettura, tipogra%ca, informatica o sotto l’aspetto di un qualsiasi tertium quid ».
Proprio perché « il campo dell’ecdotica è immenso », e comprende temi, metodi, criteri di0erenti, la nuova rivista si propone di o0rine « una panoramica stimolante », privilegiando soprattutto « le questioni di più ampia portata », « le implicazioni generali delle concrete espe-rienze di lavoro », le ri3essioni sui problemi legati alle edizioni di un testo ma anche le questioni introdotte dalle nuove teorie critiche che investono lo statuto stesso del testo. La conclusione propone come comportamento critico l’assunzione di un « atte!iamento ecdotico che ci invita ad accostarci alla letteratura come luogo di incontro di autori, testi e lettori » (p. 6).
Sulla base di queste premesse il primo numero si apre con la sezione « Saggi e proposte », che presenta un ampio studio di Roger Chartier, Editer Shakespeare (1623-2004), cui seguono saggi di ri3essione sulla pratica dell’edizione critica (Francesco Benozzo, Filologia al bivio : ecdotica celtica e romanza a confronto, Lucia Castaldi, Paolo Chiesa, Guglielmo Gorni, Teoria e storia del lachmannismo, Neil Harris, Ri*ettendo su letteratura e manufatti : pro+lo di George Thomas Tanselle, Cristina Urchueguia, « Kritisches Edieren ». L’edizione critica in Ger-mania o!i).
La successiva sezione, « Foro », è dedicata al Seminario tenutosi al Dipartimento di Italia-nistica dell’Università di Bologna, il 19 maggio del 2003, in occasione dell’edizione curata da Amedeo Quondam del Cortigiano di Baldassarre Castiglione (Milano, Mondadori, 2002), con interventi di Paolo Trovato, Antonio Sorella, Emilio Pasquini, Francisco Rico e dello stesso Quondam, cui si è aggiunto l’intervento scritto di Alfredo Stussi. Nella sezione « Testi », vengono riportati, con una Introduzione di Antonio Sorella, due scritti di Augusto Cam-pana, letti come « incunaboli della tipo%lologia in Italia » (si tratta della Nota bibliogra+ca alle « Epistolae Aemilianae » di Giambattista Morgagni, e di Una edizione poco nota degli « Opuscula miscellanea » del Morgagni). Le ultime due sezioni, « Rassegne » e « Cronaca », sono dedicate rispettivamente ad o0rire ampie recensioni, la prima, notizie su convegni e seminari da poco conclusi, la seconda.
Sorella Antonio, L’autore sotto il torchio. Sa!i di tipo+lologia, Pescara, Libreria dell’Università, 2004.
Antonio Sorella, docente di Storia della lingua italiana all’Università « G. D’Annunzio » di Chieti-Pescara e da anni impegnato nella ri3essione sulla %lologia dei testi a stampa, rac-coglie qui vari saggi (per lo più relazioni o interventi a convegni e seminari, ma manca una avvertenza che precisi la singola origine) che propongono in particolare alcune indagini su edizioni del Cinquecento e ri3essioni nate dall’esame di edizioni moderne di autori rina-scimentali (ad es. l’edizione di Amedeo Quondam del Cortegiano). In particolare gli scritti riguardano l’attribuzione all’Aretino della commedia I tre tiranni (1533), la seconda edizione delle Prose della volgar lingua di Bembo, presso Marcolini, gli interventi di Benedetto Varchi nell’edizione delle Prose della volgar lingua uscita per Lorenzo Torrentino, le polemiche che hanno coinvolto i revisori tipogra%ci cinquecenteschi (Lodovico Dolce, Girolamo Ruscelli, Anton Francesco Doni, Lodovico Domenichi). Viene anche raccolto il saggio, di natura teo-rica, che delinea il territorio della « tipo%lologia » e giusti%ca il « nome nuovo » : « perché se ne
la materialità nella filologia (1985-2007) 217
STUVWendesse immediatamente la sua speci!cità nell’ambito degli studi !lologico-linguistici ed inoltre perché una simile etichetta fosse facilmente traducibile in tutte le lingue europee e si prestasse a derivazioni come tipo !lologico, tipo !lologicamente, ecc. » (p. 62). In!ne vanno ricordati i tre scritti, ad apertura di volume, dedicati ad Augusto Campana e alla sua opera (considerata uno degli « incunaboli della tipo !lologia in Italia »).
Tanselle G. Thomas, Letteratura e manufatti, a cura di Luigi Crocetti, Neil Har-ris, Firenze, Le Lettere, 2004.
« Il libro è un oggetto materiale testimone di un processo fabbricativo che ha in/uito sia sul testo in esso veicolato sia sulla ricezione di quel testo » (p. xxxv). Su questo assunto, nato nell’ambito della !lologia e della critica testuale anglosassone e ricordato nel bel saggio introduttivo di Neil Harris (La bibliogra!a e il palinsesto della storia, pp. ix-lxviii), si fonda questo volume, divenuto in breve tempo uno dei classici della bibliogra!a analitica di matrice anglosassone. Lo stesso Tanselle precisa : « Le opere verbali possono anche essere immateriali, ma generalmente giungono a noi legate a oggetti ; e perciò lo studio di queste opere non si può distinguere dallo studio dei manufatti. Scopo di questo libro è di esami-nare la teoria che sta a fondamento di quest’osservazione e le conseguenze pratiche che ne derivano » (p. lxxv).
Il volume raccoglie quindici saggi, già pubblicati dall’autore in diverse sedi tra il 1977 e il 1996, più un’appendice con una Dichiarazione sulla funzione di libri e manoscritti nell’età elet-tronica, pronunciata l’11 settembre 1992 al simposio per il cinquantesimo anniversario della Houghton Library, e una Dichiarazione sul signi!cato dei documenti primari, adottata dall’Exe-cutive Council of the Modern Language Association of America il 19 maggio 1995.
Un’avvertenza pare necessaria : il titolo della raccolta, infatti, potrebbe in qualche modo sembrare fuorviante, invece « la parola “letteratura” […] si riferisce non solo alle “belle let-tere”, ma a tutte le opere verbali ; è usata nello stesso senso che si trova in espressioni come “la letteratura economica”, “la letteratura medica” e così via » (p. lxxii).
In apertura si trova il saggio introduttivo di Neil Harris, uno dei maggiori specialisti di bibliologia in ambito internazionale, La bibliogra!a e il palinsesto della storia. Con la consueta intelligenza e in modo brillante Harris non solo presenta dettagliatamente i testi che costi-tuiscono il volume di Tanselle, ma traccia un’articolata panoramica storica sulla bibliogra!a analitica anglo-americana, costruendo un immaginario sca3ale con tutti i ‘classici’ della disciplina. I grandi repertori di incunaboli e cinquecentine che oggi tutti gli studiosi adope-rano più o meno pro!cuamente sono !gli in gran parte di questo approccio analitico alla descrizione bibliogra!ca. Si pensi, solo per fare un esempio, al bmc, cioè al catalogo degli in-cunaboli della British Library (sulla storia dell’incunabolistica si vedano ora anche Edoardo Barbieri, Haebler contro Haebler. Appunti per una storia dell’incunabolistica novecentesca, Milano, isu-Università Cattolica, 2008 e Konrad Haebler e l’incunabolistica come disciplina storica, a cura di A. Ledda, Milano, cusl, 2008).
Ma Harris ripercorre anche le tappe più signi!cative dei contributi alla critica testuale o3erti dagli studi bibliogra!ci. Qui non si può non fare il nome almeno di Charlton Hin-man, allievo di Bowers, che ha dato l’esempio migliore dell’applicazione delle teorie della bibliogra!a testuale nel suo The printing and proof-reading of the First Folio of Shakespeare, Oxford, Clarendon Press, 1963.
I saggi che si trovano in Letteratura e manufatti sono suddivisi in cinque gruppi di tre ciascuno. Nel primo gruppo si trovano tre saggi che aiutano in qualche modo a inquadrare il problema o, almeno, mostrano il pensiero di Tanselle a proposito del libro come veicolo materiale di un testo immateriale e, come tale bisognoso di conservazione. A questo fanno riferimento anche i due testi in appendice. Non è su9ciente conservare il testo continuando a farlo ‘migrare’ da un supporto all’altro. È proprio il supporto, invece, a essere portatore di signi!cato quasi quanto il testo, in quanto espressione di un’attività umana che diventa co-municativa. La biblioteca non conserva l’opera di Mozart, ma solo la sua rappresentazione
repertorio bibliografico ragionato218
iX spartiti e note scritti su carta. L’autore sostiene che la biblioteca deve essere paragonata al museo, che non si sognerebbe mai di eliminare determinati supporti con il pretesto della di!coltà della conservazione. Come la fotogra#a non sostituisce un dipinto, nemmeno può sostituire un libro, manoscritto o a stampa. In seconda battuta si trova descritto il complesso rapporto tra bibliogra# e biblioteca e un’articolata de#nizione di cosa sia la storia del libro intesa come disciplina con un ampio riferimento, ovviamente, al mondo anglosassone.
Nella seconda sezione Tanselle precisa ulteriormente il suo pensiero a proposito della conservazione dei ‘documenti primari’ : se lo studioso si a!da solo a riproduzioni, corre il rischio di perdere una grossa fetta di informazioni. Le biblioteche che eliminano materiale antico in quanto già micro#lmato al #ne di ottenere nuovi e maggiori spazi, compiono un vero, rinnovato, rogo di libri.
Con il terzo gruppo di saggi, si entra maggiormente nel campo dei problemi #lologici e di critica testuale. Tanselle sottolinea l’importanza della descrizione bibliogra#ca analitica non solo come presupposto (recensio) del lavoro ecdotico, ma come parte fondamentale di esso. Una bibliogra#a spogliata da tutti gli aspetti analitici e descrittivi, sia per il libro antico sia per quello moderno, è utile solo ai collezionisti e agli amatori. Il professionista deve invece pretendere bibliogra#e analitiche, che descrivano le edizioni in modo preciso, anno-tando le varianti al #ne di facilitare il processo di ricostruzione dello stemma. A tal proposito vengono presentati i rapporti tra La descrizione dei libri americani e la tradizione bibliogra!ca britannica (pp. 187-220) e tra Bibliogra!a enumerativa e libro !sico (pp. 221-236).
La quarta sezione è la più pertinente ai problemi #lologici ed ecdotici. Nel primo saggio Tanselle prende in considerazione le posizioni decostruzioniste riguardo alla critica del testo, partendo dal manifesto della corrente, ovvero Deconstruction and criticism, New York, Seabury Press, 1979. L’occasione è propizia per tornare sul problema dell’uso del vocabolo ‘testo’ per ‘opera’, dimenticando che « per la #lologia la distinzione fra i testi dei documenti (manoscritti o a stampa, privati o pubblicati) e il testo delle opere è fondamentale » (p. 239), il che postula necessariamente che « i testi nei documenti non possano essere identi#cati auto-maticamente coi testi delle opere che quei documenti pretendono di trasmettere » (p. 240).
Nel secondo saggio, Fare a meno del testo base (pp. 279-306), Tanselle intavola una ideale discussione con Walter Greg e Ronald B. McKerrow a proposito del concetto di ‘testo-base’. Egli propone di superare « questo concetto, spesso utile e tuttavia intrinsecamente restritti-vo » (p. 281). Greg e McKerrow, infatti, avevano fondato il loro pensiero su questo principio per cercare di rendere oggettivo il processo di emendazione dei testi, passaggio che, di fatto, non si è realizzato.
Di fronte al proliferare di strumenti informatici e, in modo particolare, ipertestuali, Tan-selle, dopo aver tracciato una breve storia del dibattito metodologico sulla ricostruzione critica dei testi, presenta l’ipertesto come una risorsa importante per gli editori critici, che hanno la possibilità di superare i tradizionali limiti del libro a stampa, presentando un’edi-zione che include tutte le varianti in un unico prodotto.
L’ultima sezione del libro di Tanselle interessa forse più il bibliografo che non il #lologo (anche se da quanto detto emerge la sottile linea che separa, secondo l’autore, i due profes-sionisti). Tanselle critica l’approccio sociologico del neozelandese Donald McKenzie (per cui si vedano qui le schede relative alle edizioni italiane dei suoi testi). Una bella e utile pano-ramica storica non solo dei rapporti tra le due discipline, ma anche dell’evoluzione storica dell’analitical bibliography anglosassone si trova in Bibliogra!a analitica e storia della stampa (pp. 343-362). Chiude la raccolta il saggio Storia della stampa e altra storia (pp. 363-388), in cui Tanselle enuncia che cosa signi#chi fare storia del libro, in che relazione sta la disciplina con la storia istituzionale e quali sono i vari approcci, anche di carattere nazionale, alla storia del libro. Il tutto sempre all’insegna, come si diceva in apertura, della materialità del libro e di come ogni approccio storico, #lologico, sociologico, economico … a questo oggetto non possa prescindere da tale sua caratteristica.
[l. r.]
la materialità nella filologia (1985-2007) 219
�YY5
A.
Radaelli Anna (a cura di), intavulare. Tavole di canzonieri romanzi, i, Canzonieri provenzali, 7, Paris, Bibliothèque nationale de France. C (fr. 856), Modena, Mucchi, 2005.
B.
Barbieri Edoardo, Una prassi correttoria della tipogra$a manuale : il cartiglio incol-lato, « La Biblio%lia », cvii, 2, 2005, pp. 115-142.
Il saggio presenta una consuetudine in uso nelle tipogra%e cinquecentesche : il ricorso a un cartiglio con la lezione corretta applicato sulla pagina con l’errore. Di grande importanza per lo studio delle pratiche della stamperia, le pagine qui proposte sono di indubbio interesse anche per le conseguenze della prassi del cartiglio sul piano %lologico.
« Ecdotica », ii, 2005.
Il secondo numero della rivista diretta da Gian Mario Anselmi, Emilio Pasquini e Francisco Rico si apre con la sezione « Saggi », che propone scritti di Luciano Formisano (Gaston Paris e i «nouveaux philologues». Ri%essioni su un libro recente), Francisco Rico («Lectio fertilior» tra la critica testuale e l’ecdotica ; vedi scheda qui sotto), Pasquale Stoppelli (Dentro la liz, ovve-ro l’edizione di mille testi), Peter Shillingsburg (Verso una teoria degli atti di scrittura), Paul Eggert (These post-philological days…). Anche in questo caso la sezione « Foro » propone i materiali di un seminario : al centro dell’interesse lo stato delle collane di classici, in Italia e all’estero, sulle quali si sono confrontati critici e %lologi e responsabili editoriali : Hugues Pradier (La «Bibliothèque de la Pléiade»), Joseph Thomas («Library of America»), Guglielmo Gorni (Perché avete chiuso gli «Scrittori d’Italia» ?), Mariarosa Bricchi (Classici bur (1949-2004) e altri tascabili), Mauro Bersani (L’Einaudi e i classici), Ezio Raimondi (Le vie del testo).
La sezione « Testi » è dedicata alla Compagnia di Gesù : Amedeo Quondam, infatti, in uno scritto intitolato Gesuiti a Venezia : il sogno di una ricca «libraria» « senza spesa », introduce il testo, curato da Camilla Giunti, Informatione d’un modo facile d’arrichir senza spesa D’ogni sorte di libri tutte le librarie della Compagnia, Proposto al Molto Rever. P. N. Mutio Vitelleschi Preposito Generale Dalla Congregatione Provinciale di Venetia, fatta in Bologna nel principio di Ma0io l’anno 1619.
Prima delle sezioni di recensioni (« Rassegne ») e di notizie (« Cronaca »), una parte intito-lata « Questioni » presenta un intervento di Michele Feo (Filologia e storia. Augusto Campana e l’edizione delle « Epistolae Aemilianae » di Giambattista Morgagni) nel quale si puntualizzano alcune osservazioni proposte da Antonio Sorella nella presentazione dei testi di Augusto Campana del numero i di « Ecdotica » (2004, vedi scheda sopra).
Filologia dei testi a stampa (area iberica), a cura di Patrizia Botta, con la collaborazio-ne di Aviva Garribba, Elisabetta Vaccaro, Modena, Mucchi, 2005 (« Studi, testi e manuali »).
Il volume prende le mosse dal Simposio internazionale Filologia dei Testi a stampa (area iberi-ca), che si è tenuto a Pescara dal 20 al 22 novembre 2003 e ne raccoglie quasi tutti gli interven-ti, che coprono, da un punto di vista cronologico, il periodo che va dall’introduzione della stampa all’odierna produzione informatica, e, dal punto di vista dei libri e dei generi, libri
repertorio bibliografico ragionato220
Z[ grande formato e fogli volanti, testi di prosa e di poesia, con un prevalenza di esempi e di temi della letteratura spagnola. I quaranta scritti proposti sono divisi in sezioni tematiche (Teatro, Celestina, Prosa, Poesia, Questioni teoriche, Lingua, Varia et brevia), e l’ultima di queste (con saggi di Gian Mario Anselmi, Lorenzo Baldacchini, Paolo Cherchi, Neil Harris, Antonio Sorella, Alfredo Stussi) è dedicata a « Questioni di italianistica ».
Gonelli Lidia Maria, Esercizi di bibliogra�a testuale sulla princeps dell’Amorosa Visione (1521), « Filologia Italiana », ii, 2005, pp. 147-160.
Analizzando 42 esemplari della prima edizione a stampa dell’Amorosa Visione, e rilevan-do rifacimenti e nuove composizioni di alcuni mezzi fogli, Lidia Maria Gonelli dimostra l’intervento di Girolamo Claricio in correzioni a lungo attribuite allo stesso Boccaccio.
Rico Francisco, « Lectio fertilior » : tra la critica testuale e l’ecdotica, « Ecdotica », ii, 2005, pp. 23-41.
Lo scritto prende spunto da un passo del Don Quijote de la Mancha (cap. xxxii della prima parte, dove l’editio princeps legge : « Luego ¿quiete vuestra merced quemar más libros ? », mentre altre stampe, comunque autorevoli, recano la variante mis), per svolgere interessanti ri5essioni sul ruolo dell’editore innanzi a con5itti, apparentemente insanabili, tra varianti tramandate esclusivamente da fonti tipogra6che. Una volta presentata la situazione testuale del locus chisciottesco, e ribadita l’impossibilità di stabilire con certezza quale sia, per esso, la lezione genuina, Rico pone il problema di quale atteggiamento assumere, in concreto, di fronte a casi tanto complessi, giacché terminata l’analisi, all’editore spetta comunque il com-pito di optare per una variante, da porre a testo. Di qui la sua proposta di adottare – o per usare le sue stesse parole di « scommettere » – sulla lectio fertilior, ovvero sulla variante che maggiormente stimoli un dialogo fra il testo e il suo apparato e più inviti il lettore a ri5ettere su questo insieme indissociabile in un’edizione che, proprio perché critica, si propone quale strumento provvisorio per eccellenza.
[g. b.]
2006
A.
Spetia Lucilla (a cura di), intavulare. Tables de chansonniers romans, ii, Chan-sonniers français, 4, Z (Siena, Biblioteca Comunale H. X. 36), Liège, Université de Liège, 2006.
Appare, dopo sette anni di attesa, un nuovo volume della serie. L’autrice si propone di riprendere e integrare il fondamentale e pionieristico lavoro di Marcello Spaziani su Z (Il canzo-niere francese di Siena (Biblioteca Comunale, H. X. 36). Introduzione, testo critico e traduzione, Firenze, 1957) : va in questa direzione l’indagine approfondita sulla storia e sulle fonti della silloge.
[f. s.]
Borriero Giovanni (a cura di), intavulare. Tables de chansonniers romans, iii, Canzonieri italiani, 1, Biblioteca Apostolica Vaticana Ch (Chig. L. viii. 305), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2006.
Il primo volume della serie dedicata alle sillogi liriche italiane si con6gura come il risul-
la materialità nella filologia (1985-2007) 221
t\t], impressionante per mole e rigorosa tensione all’esaustività, delle ricerche condotte da Borriero sul Chigiano "n dalla propria tesi di dottorato (tra le tappe intermedie i due fondamentali contributi Nuovi accertamenti sulla struttura fascicolare del canzoniere Vaticano Chigiano L. viii. 305, « Critica del testo », i, 2, 1998, pp. 723-750, e Considerazioni sulla tradizione manoscritta della Tenzone di Dante con Forese, in I numeri, « Anticomoderno », iv, 1999, pp. 385-405, il primo dei quali qui rifuso). Egli o&re una descrizione minuziosa del codice e della sua storia (pp. 131-168), accompagnata da un attento esame della fascicolazione (pp. 169-190), volto alla ricostruzione di quella originaria scompaginata, nonché dall’analisi capillare degli elementi della mise en page, in funzione soprattutto della più corretta interpretazione metrica dei componimenti (pp. 191-246) : tutti aspetti che determinano l’evidente eccezionalità del volume nei confronti degli altri della collana (come peraltro segnalato da Anna Ferrari nella Presentazione, pp. v-vi). La novità più signi"cativa risiede, però, nell’introduzione di nuovi criteri proprio per la ‘tabulazione’, che costituisce la struttura fondante del progetto di intavulare : il sistema degli indici è infatti reinterpretato e arricchito per incontrare le esigenze descrittive di una produzione lirica che non può avvalersi della strumentazione esistente per quelle provenzale e francese. In tal senso, di notevole interesse risulta la tavola vi (pp. 431-500), contenente l’Indice critico-bibliogra$co, repertorio che, pur limitato agli autori traditi dal Chigiano, si richiama al modello globale rappresentato dalla Bibliographie der Trou-badours. Le minuziose Istruzioni per l’uso delle tavole (pp. 1-58, da integrare con le Istruzioni particolari, pp. 253-274) e una nutrita serie di Appendici (pp. 501-585), contenenti, tra l’altro, l’edizione interpretativa dei sonetti adespoti, corredano un lavoro la cui completezza è pari alla precisione delle informazioni o&erte.
[f. s.]
Zimei Enrico (a cura di), intavulare. Tavole di canzonieri romanzi, i, Canzonieri provenzali, 8, Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale. J (Conventi soppressi F 4 776), Modena, Mucchi, 2006.
Romualdi Stefania (a cura di), intavulare. Tavole di canzonieri romanzi, i, Can-zonieri provenzali, 9, Paris, Bibliothèque nationale de France. B (fr. 1592), Modena, Mucchi, 2006.
« Liber », « fragmenta », « libellus » prima e dopo Petrarca. In ricordo di d’Arco Silvio Avalle, Seminario internazionale di Studi, Bergamo, 23-25 ottobre 2003, a cura di Fran-cesco Lo Monaco, Luca Carlo Rossi, Niccolò Sca&ai, Firenze, sismel-Edizioni del Galluzzo, 2006.
Il contributo di Lino Leonardi (Creazione e fortuna di un genere : la $lologia dei canzonieri dopo Avalle, pp. 3-22) ripercorre la storia e i risultati degli studi incentrati sui singoli canzo-nieri proponendo anche alcune nuove possibili linee di ricerca da approfondire nell’ambito di questo "lone di studi particolarmente incoraggiato da d’Arco Silvio Avalle : si sottolinea in particolare l’utilità che gli strumenti informatici potrebbero rivestire per indagini che coniughino un approccio di tipo sincronico (incentrato sul singolo canzoniere) a uno di tipo diacronico (focalizzato sull’insieme della tradizione), oltre che per l’edizione sinottica delle diverse raccolte. Luciana Borghi Cedrini (I « libri » della poesia trobadorica, pp. 69-80) o&re un’agile visione d’insieme delle diverse tipologie di canzoniere provenzale incrociando dati esterni, quali datazione e localizzazione, e interni (criteri di ordinamento, natura degli spazi lasciati bianchi). Walter Meliga (Le raccolte d’autore nella tradizione trobadorica, pp. 81-92) suggerisce alcuni criteri utili alla sicura individuazione di raccolte d’autore nei manoscritti occitanici, fondandosi sull’analisi di disposizione e concordanze dei testi che farebbero parte della supposta silloge. Carlo Pulsoni (Per un approccio bédieriano alle « vidas ». I codici I K e le loro fonti, pp. 115-134) propone di analizzare le vidas in relazione ai progetti editoriali che
repertorio bibliografico ragionato222
s^_`bghjgk^g^ lmml n^opbmlqb^gj kjb n^kbnb gjb uvlmb s^g^ h`lsn`bhhj ; questo metodo, esem-pli!cato con lo studio delle prose biogra!che copiate nei ‘gemelli’ veneti I K, permette di veri!care !no a che punto gli allestitori siano intervenuti sui materiali provenienti dalle loro fonti. Silvia Buzzetti Gallarati (La produzione e la tradizione manoscritta dei poeti « comici » e « realistici » delle origini, o�i : caso, selezione, volontà ordinatrice ?, pp. 135-168) analizza la tradi-zione dei poeti comici, traendone utili indicazioni per gli editori moderni. H. Wayne Storey e Roberta Capelli (Modalità di ordinamento materiale tra Guittone e Petrarca, pp. 169-186) si so2ermano sull’importanza che il fascicolo ricopre anche nell’ambito dei canzonieri italiani delle origini in quanto unità autonoma non solo dal punto di vista materiale, confrontando poi questa situazione con quella degli autogra! petrarcheschi.
[s. r.]
B.
« Ecdotica », iii, 2006.
Il terzo numero di « Ecdotica » propone, nella sezione « Saggi », studi di edizioni (Neil Harris, Pro!lo di un incunabolo : le « Epistolae in cardinalatu editae » di Enea Silvio Piccolomini (Roma 1475), Federico Della Corte, ‘Usus scribendi’, ‘ratio typographica’ e altri preliminari a un’edizione di Aretino, Cristina Urchueguía, Tra poetica e !sica. Nota preliminare a Mar-tens e Reuß), e ri9essioni teorico-metodologiche (Gunter Martens, Sul compito critico dei !lologi editoriali. Tesi per un concetto allargato della critica testuale, Roland Reuss, Vicende del manoscritto, vicende della stampa. Appunti sulla ‘genesi del testo’, David C. Greetham, Philology Redux ?). Il « Foro » questa volta è dedicato all’« autore in tipogra!a », con interventi di Neil Harris (Come riconoscere un ‘cancellans’ e viver felici), di Sonia Garza Merino (El ‘original’ de imprenta. El diseño del libro impreso antiguo según su autor), di Paola Italia (Le ‘penultime volontà dell’autore’. Considerazioni sulle edizioni d’autore del Novecento). In particolare i saggi di Neil Harris (che precisa le ragioni che portano a nuovi atti composizione e quindi alla sostituzione di un foglio con un altro, approfondendo la sua ri9essione con vari esempi, tra i quali la prima edizione dei Promessi Sposi) e di Sonia Garza Merino (che pone al centro del suo scritto lo studio delle copie di tipogra!a per cogliere il contributo dell’autore alla forma !nale del libro) toccano punti di rilievo per il tema della materialità nella !lologia dei testi a stampa, mentre quello di Paola Italia è di sicura importanza per lo studio dei rapporti tra la letteratura novecentesca e gli interventi redazionali (che, di fatto, possono rappresentare l’« ultima volontà » del redattore, non quella dell’autore, che appunto resta « penultima »).
Nella sezione « Testi », Jeremy Lawrance parla di Stoppard, Housman and the mission of tex-tual criticism, mentre in quella chiamata « Questioni », Francesco Bausi commenta alcune edizioni petrarchesche (Mito e realtà dell’edizione critica. In margine al Petrarca del Centenario). Seguono le sezioni di recensioni (« Rassegne ») e di notizie (« Cronaca »), queste ultime dedi-cate all’« Institut für Textkritik » (che raccoglie in una cooperativa alcuni editori indipendenti, che si stanno ponendo « l’obbiettivo di collegare ricerca !lologica pura e metodi avanzati di presentazione del testo », p. 291), e alle edizioni Sylvestre Bonnard, di Milano.
Garavelli Enrico, Per l’edizione critica della Talanta di Pietro Aretino, in Per Carlo Dionisotti, Roma, Salerno Editrice, 2006.
Sorella Antonio, La vulgata nella tipo!lologia : due casi esemplari, « Filologia Italia-na », iii, 2006, pp. 155-172.
Nel fascicolo di « Filologia Italiana » interamente dedicato alla ‘vulgata’, Sorella esamina le revisioni editoriali del Cortegiano di Baldassarre Castiglione e dei Dialogi di Sperone Speroni.
la materialità nella filologia (1985-2007) 223
wxxy
A.
Costantini Fabrizio, Le unità di scrittura nei canzonieri della lirica italiana delle Origini, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2007.
Il volume di Fabrizio Costantini si colloca all’interno di un produttivo $lone di studi della recente $lologia materiale : ovvero, l’analisi delle cosiddette ‘unità di scrittura’ individuabili all’interno della scripta dei manoscritti e le eventuali $nalità ecdotiche di tale studio : le unità di scrittura sono considerate in quanto agglutinazioni e segmentazioni della catena gra$ca che non corrispondono all’usus moderno : a partire dalle indagini sui canzonieri francesi (i contributi di Andrieux-Reix e Monsonego del 1997, per « Romania » e del 1998, per « Langue française » ; quello di Baddeley e Biedermann-Pasques per la « Revue de linguistique roma-ne », e quello di Zimei per « Critica del testo », entrambi del 2004), nota anzitutto Costantini (pp. 18-19) che non è possibile tentare una comparazione sincronica dei dati sui canzonieri francesi con i dati dei manoscritti italiani, a causa del « di4erente contesto storico-culturale di provenienza dei campioni inventariati », nonché del ritardo che connota la tradizione italiana, anche sul versante della produzione dei manoscritti, rispetto alla coeva esperienza d’Oltralpe : tant’è vero che i codici francesi della $ne del xiii secolo presentano un sistema che già corrisponde, nella sostanza, alla divisione moderna della catena gra$ca ; mentre per i codici italiani si rileva uno stadio ancora primitivo determinato, oltre che dalle ragioni poc’anzi evidenziate, anche dal ritardo con cui in Italia fu introdotta nella scrittura latina la prassi di scansione dei testi.
Territorio d’indagine individuato da Costantini è quello dei tre canzonieri della lirica ita-liana delle origini, al cui interno è selezionato un campione di 45 componimenti per ognuna delle tre sillogi, per un totale di 135 testi trascritti : nei fatti, il complesso dei componimenti che godono di triplice attestazione. Premesse doverose sono quelle che spingono Costantini a notare che i tre codici (pp. 24-25) « rappresentano un bacino d’indagine per alcuni tratti vario, per altri omogeneo » ; in primo luogo, per P e V, la ricerca riguarda un contesto in cui una sola mano ha trascritto il codice, mentre diverso è il caso di L, dove intervengono più mani ; quindi, la tipologia della silloge : P e L sono de$nibili come « libro cortese di lettura » e sono trascritti in littera textualis da copisti di professione, mentre V rivela una $sionomia di « libro-registro di lusso » (la de$nizione è adottata da Petrucci), vergato in una semicorsiva che è denominata da Petrucci stesso come ‘protomercantesca’ ; viceversa, sono abbastanza omogenei i tempi e i luoghi di produzione delle scritture in esame : l’area nord-occidentale della Toscana, tra la $ne del xiii secolo e l’inizio del xiv : una forbice ristretta, laddove le indagini sui canzonieri francesi sono caratterizzate da uno scarto geogra$co e cronologico ben più ampio. L’analisi delle unità gra$che parte dalla trascrizione della pagina del codice e si esprime quindi in una trascrizione interpretativa, in cui l’‘obbligo di fedeltà’ richiesto si estende alla segmentazione gra$ca e4ettivamente realizzata dai copisti e in cui Costantini introduce la distinzione terminologica tra ‘spazio’ (l’intervallo normalmente posto tra due lettere della stessa unità) e ‘spaziatura’ (l’intervallo più ampio che si ha tra unità di4erenti ; cfr. p. 39, con il rinvio alla precedente formulazione terminologica di Costantini stesso – cfr. F. Costantini, Le unità di scrittura del Vat. lat. 3793, « Critica del testo », vi, 3, 2003, pp. 969-1008 –). Il parametro di riferimento, nei casi di dubbio interpretativo, è quello delle clpio, in un’ottica tuttavia non passiva, ma proponendo talvolta soluzioni migliorative.
L’analisi delle circa 36000 unità gra$che costituenti il corpus o4re risultati senza dub-bio molto interessanti, soprattutto in relazione alla funzione grammaticale delle unità di scrittura (capitolo 5) : ad esempio per quanto riguarda l’articolo, che è forse il principale
repertorio bibliografico ragionato224
z{z|z}~� di aggregazione gra!ca, e il cui comportamento consente di individuare una ten-denza comune di V e L contro P, la cui mano, maggiormente avvezza alla copiatura di testi latini, mostra una maggior propensione alla segmentazione analitica del testo (pp. 61-62). Interessante è poi notare che già nell’evoluzione della scriptio continua dal latino classico a quello volgare si realizzò una diversa disposizione degli elementi del periodo in relazione al mutamento strutturale della lingua ; così parimenti nel passaggio successivo alle lingue romanze, osserva Costantini (p. 64), si realizza un fenomeno di « segmentazione del testo in unità di scrittura complesse » e la possibilità di riunire il testo in sintagmi si traduce ‘sulla carta’ in una disposizione agglutinata degli elementi gra!ci. I tre capitoli successivi (6-8) sono incentrati anzitutto sulla valutazione del cosiddetto ‘corpo fonico’, ovvero sull’entità sillabica di ciascuna componente dell’unità di scrittura, preferendo un’unità ‘molecolare’ (la sillaba) all’atomo-lettera, che per elementi a/ni (come ad esempio le preposizioni per e a) mostra risultati quantitativamente fuori proporzione (un rapporto di grandezza, come in questo caso, di 3 a 1) ; quindi dall’analisi del corpo fonico si passa a quella di comportamenti particolari (gra!ci e non solo) connessi a tale indagine : è il caso della fonosintassi, e dei suoi caratteri visibili sulla pagina del manoscritto, e delle cosiddette ‘segmentazioni abnormi’.
Una valutazione complessiva dell’indagine (cap. 9), soprattutto in relazione alla possibilità di ricavarne linee di tendenza generali, consente un bilancio in positivo, purché l’analisi sia e3ettuata – nota l’autore – su corpora di provata omogeneità (stessa tipologia di testi, stesso ambito di lingua, stesse coordinate cronologiche), così che essa possa mettere bene in luce la prassi dello scrivente, distinguendo tra ciò che è abitudine gra!ca e ciò che costituisce anomalia : solo infatti circoscrivendo i caratteri anomali della tracciatura testuale si possono ricavare dati che risultino signi!cativi in chiave ecdotica ; ed è su questa via che l’indagine sulle unità di scrittura mostra tutta la sua utilità per discipline come la paleogra!a, la storia della lingua e, soprattutto, la !lologia.
[d. m.]
Tyssens Madeleine (a cura di), intavulare. Tables de chansonniers romans, ii, Chansonniers français, 5, U (Paris, bnf fr. 20050), Liège, Université de Liège, 2007.
Il quinto volume della serie è dedicato al canzoniere di Saint-Germain-des-Prés, oggetto da un ventennio delle attenzioni della studiosa : i capitoli introduttivi alle tavole costituiscono in e3etti la ripresa e lo sviluppo del contributo o3erto al Convegno di Liège (Les copistes du chansonnier français U, in Lyrique romane médiévale : la tradition des chansonniers, Actes du Col-loque de Liège, 1989, Liège, 1991, pp. 379-396).
[f. s.]
B.
Barbieri Edoardo, L’editio princeps di Jacopone da Todi (Firenze, Bonaccorsi, 1490) : note bibliologiche, « La Biblio!lia », 109, 2007, pp. 105-142.
Il contributo prende in esame la prima edizione delle Laudi di Jacopone da Todi, uscita a Firenze dai torchi di Francesco Bonaccorsi il 28 settembre 1490. La pubblicazione presenta diversi interventi di un anonimo curatore – che Barbieri dimostra essere persona diversa dal tipografo – il quale a più riprese comunica al lettore gli interventi !lologici eseguiti sul testo (da una rudimentale recensio, !no alla scelta dei testi e delle lezioni da proporre), le correzioni avvenute in corso di stampa, le motivazioni della pubblicazione. Analizzando più esemplari da un punto di vista bibliologico e !lologico, con un excursus !nale di tipo icono-gra!co sulla silogra!a ra/gurante Jacopone inginocchiato davanti alla Madonna, l’autore dimostra come l’intento della pubblicazione sia assieme devozionale e letterario. Sullo sfon-
la materialità nella filologia (1985-2007) 225
�� la serie di edizioni novecentesche, che hanno dapprima considerato in maniera esclusiva e poi misconosciuto la princeps !orentina.
[l. r.]
Giancarlo Petrella, Uomini, torchi e libri nel Rinascimento, presentazione di Luigi Balsamo, Udine, Forum, 2007.
I saggi raccolti in questo volume approfondiscono lo studio di alcuni aspetti dello storia del libro del Quattro-Cinquecento, « con volontarie incursioni nell’attigua riserva dei !lologi » (p. 11). In quest’ultima direzione va soprattutto l’esame di varie edizioni cinquecentesche, e in particolare della princeps della Descrittione d’Italia di Leandro Alberti.
Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 13 del 21.07.1999Direttore responsabile: Fabrizio Serra
*
Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, ancheparziale o per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo
e�ettuati, compresi la copia fotostatica, il micro�lm, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta della
Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma,un marchio della Accademia editoriale®, Pisa · Roma.
Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
*
Proprietà riservata · All rights reserved© Copyright 2009 by
Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma,un marchio della Accademia editoriale®, Pisa · Roma
Stampato in Italia · Printed in Italy
*
La Accademia editoriale®, Pisa · Roma, pubblica con il marchio Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma, sia le proprie riviste precedentemente edite con
il marchio Istituti editoriali e poligra!ci internazionali®, Pisa · Roma, che i volumi delle proprie collane precedentemente edite con i marchi Edizioni dell’Ateneo®, Roma,
Giardini editori e stampatori in Pisa®, Gruppo editoriale internazionale®, Pisa · Roma, e Istituti editoriali e poligra!ci internazionali®, Pisa · Roma.
*
Si invitano gli autori ad attenersi, nel predisporre i materiali da consegnare alla redazione e alla casa editrice, alle norme speci�cate nel volume Fabrizio Serra,
Regole editoriali, tipogra!che & redazionali, Pisa · Roma, Serra, 20092 (ordini a: [email protected]).Il capitolo Norme redazionali, estratto dalle Regole, cit., è consultabile Online alla
pagina «Pubblicare con noi» di www.libraweb.net
*
issn 1128-6326issn elettronico 1724-0530
isbn 978-88-6227-163-9
��������
Questo fascicolo 9
teoria
Roberto Antonelli, Filologia materiale e interpretazione 13
Alberto Cadioli, La materialità nello studio dei testi a stampa 21
critica
Federico Saviotti, Il via"io del poeta e il via"io del testo : per un approccio geogra#co a Raimbaut de Vaqueiras e alla sua tradizione manoscritta 43
Massimiliano Gaggero, Mise en texte e riscrittura nelle Continuazioni del Conte du Graal di Chrétien de Troyes 61
Fabrizio Costantini, L’analisi della segmentazione gra#ca come metodo d’in-dagine #lologico-materiale : il caso del canzoniere V e del frammento M 83
Enrico Garavelli, Dall’Istoria alla stampa. Giambattista Adriani tra auto-censura di famiglia e ‘politicamente corretto’ 97
Elisabetta Crema, Pubblicare testi musicali : il Tempio Armonico di Giove-nale Ancina 117
Giovanni Biancardi, Per una nuova edizione critica dei Sepolcri foscoliani 127
bilanciIl punto sulla Materialità nella #lologia
Alberto Cadioli, Dario Mantovani, Federico Saviotti, Premessa 143
Repertorio bibliogra#co ragionato. 1985-2007 a cura di Giovanni Biancardi, Alberto Cadioli, Dario Mantovani, Giancarlo Petrella, Stefano Resconi, Luca Rivali, Federico Saviotti 157