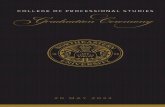FRA TURISMO ROMANTICO E TURISMO SESSUALE: I “BEACH BOYS” A MOMBASA, KENYA, Graduation thesis,...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of FRA TURISMO ROMANTICO E TURISMO SESSUALE: I “BEACH BOYS” A MOMBASA, KENYA, Graduation thesis,...
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA FACOLTÁ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN SCIENZE ANTROPOLOGICHE ED ETNOLOGICHE
FRA TURISMO ROMANTICO E TURISMO SESSUALE:
I “BEACH BOYS” A MOMBASA, KENYA
Relatore: Prof.ssa SILVIA BARBERANI
CORRELATORE: Prof.ssa CLAUDIA MATTALUCCI
Tesi di Laurea di: SARA FUMGALLI Matr. 743312
Anno Accademico: 2012 - 2013
Indice
Introduzione
1. Il fenomeno dei “beach boys”
2. Il campo: possibilità e ostruzioni
3. Fonti e considerazioni metodologiche
1. Un confronto critico fra categorie: turismo romantico e turismo sessuale
nel dibattito antropologico 10
1.1. Il turismo sessuale 10
1.2. Il viaggio “al femminile” 16
1.3. Il dibattito scientifico: turismo sessuale Vs turismo romantico 19
1.4. Tentativi di superamento della dicotomia concettuale turismo sessuale - turismo romantico 26
1.5. Riflessioni conclusive 30
2. La costruzione del Kenya come luogo turistico 32
2.1. Il Kenya: bellezze naturali e immaginario occidentale 32
2.2. Breve analisi dello sviluppo turistico in Kenya 37
2.3. “Hakuna matata”: un paradiso turistico senza preoccupazioni 42
2.4. La Coast Province in una prospettiva storica e geografica 46
2.5. Le politiche pubbliche e la produzione della marginalità 49
3. “The beach is my working place”: storie di vita, competizione e solidarietà 57
3.1. La storia di Bonnie 57
3.2. La storia di Nelson 62
3.3. “Beach boys” o beach operators? 65
3.4. Comunicare attraverso lo stile 67
3.5. Approcciare il turista: una questione di abilità, tempo e conoscenza 69
3.6. Harambee, generosità e competizione 72
4. La spiaggia come campo sociale e “luogo praticato” 75
4.1. Introduzione 75
4.2. Il processo di costruzione e di attraversamento dei confini fra luoghi a uso esclusivo dei turisti e
il “fuori” 77
4.3. I “beach boys” e le politiche nazionali 84
4.4. Interazioni fra turisti e “beach boys”: stereotipi e generalizzazioni 89
Conclusioni 95
Bibliografia 104
!
! 1!
Introduzione
1. Il fenomeno dei “beach boys”
Sulle spiagge di note località turistiche del Sud del mondo, è ormai piuttosto frequente
imbattersi in giovani uomini del posto che, con fare amichevole, approcciano i turisti offrendo
servizi di vario genere, anche sessuali. Come la letteratura di settore ci mostra, si tratta per lo
più di giovani di età compresa fra i 17 e i 30 anni circa, accomunati da un basso grado di
scolarizzazione e scarse prospettive socio-economiche, che cercano di guadagnarsi da vivere
“facendo affari” con i turisti. Sono giovani che, difficilmente, riescono a trovare un impiego
formale nell’industria turistica e che, quindi, operano ai margini, negli interstizi
dell’economia informale, creandosi occasioni di profitto. Essi si muovono nelle aree
frequentate dai turisti, in prevalenza le spiagge, svolgendo mansioni che facilitano il contatto
con gli stranieri: noleggio di attrezzature sportive o balneari, guide turistiche, vendita di
souvenir, safari e safari blue1 (Herold et al. 2001; Pruitt e LaFont 1995; de Albuquerque 1998;
Dahles e Bras 1999; Nyanzi et al. 2005). Alcuni studiosi del fenomeno (Jamison 1992;
Sánchez Taylor 2006) hanno riferito di come i “beach boys” costituiscano una parte
significativa del paesaggio turistico. L’industria turistica vende vacanze verso destinazioni
lontane come “un’esperienza culturale” e, in quanto tale, si affida alla popolazione locale per
fornire un volto e un carattere a quello che altrimenti sarebbe solo un hotel, una spiaggia e,
dunque, una vacanza standard per turisti occidentali. Dipende quindi dal settore turistico
informale, che “affianca” l’industria formale, la fornitura di quel “colore locale” che non può
essere data dal personale dell’albergo e dai tour operator. L’attività economica informale dei
locali è, quindi, fondamentale per l’economia turistica; sebbene non tutti i turisti vogliano
vivere la propria vacanza all’interno dei confini confortevoli dei grandi hotel e dei resort all
inclusive, quelli fra loro che aspirano a un’esperienza meno standardizzata si rivolgono ai
lavoratori del settore informale per avere un assaggio dell’“autentica” realtà del posto. I
ricercatori, che hanno approfondito questo aspetto, hanno posto l’accento sulla dimensione
imprenditoriale delle attività dei “beach boys”, coniando nuove definizioni quali “broker”
(Dahles e Bras 1999; Bergan 2011; Brown 1992) o “broker culturali” (Venables 2009; Pruitt e
LaFont 1995; Brown 1992), o ancora, “venditori di esperienze culturali” (Sánchez Taylor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Safari!è!una!parola!swahili!che!significa!viaggio!ed!è!comunemente!usata!dai!kenioti!e!dai!turisti!per!descrivere!varie!tipologie!di!gite,!pensate!per!i!turisti,!nei!parchi!naturalistici!per!osservare!la!flora!e!la!fauna!del!luogo!e!nelle!riserve!marine!della!costa.!
! 2!
2000). Questi autori comprendono nel contesto della piccola imprenditoria del settore
informale le attività di hustling dei “beach boys”, che, strategicamente, sfruttano abilità
personali e network di relazioni coltivate nel tempo per fare affari con i turisti. Essi sono
descritti come intermediari che gestiscono fonti e flussi di informazioni, mettono persone
diverse in contatto fra loro, direttamente o indirettamente, compensando le lacune nella
comunicazione fra host e guest (Dahles e Bras, 1999; Crick 1992; Nyanzi et al. 2005). Oltre al
ruolo di mediatori, Brown (1992: 367) ne ha evidenziato la funzione di innovatori, nel
momento in cui introducono, fra la popolazione locale, nuovi tratti comportamentali, nuove
idee e stili, e di “gestori” della quantità e della qualità della comunicazione fra i due gruppi.
Quando, per esempio, i “beach boys” portano i turisti a visitare i loro villaggi, come spesso
accade, essi sottolineano gli aspetti di povertà, di diversità delle condizioni e dello stile di
vita, dei bisogni, incoraggiando i turisti a sostenere economicamente le loro famiglie o altri
membri della comunità (Brown 1992; Bergan 2011). I “beach boys” sono, in definitiva,
specialisti del network il cui capitale, fatto di capacità personali e relazioni estese, si forma
nel contesto non istituzionalizzato della spiaggia. Come molti autori hanno rilevato (Herold et
al. 2001; Pruitt e LaFont 1995; Sánchez Taylor 2000; Brown 1992; Hodge 2001; Venables
2009; Dahles e Bras 1999), al di là del guadagno immediato che possono ottenere dalla
vendita di safari, souvenir o tour nei villaggi, l’aspirazione principale di questi giovani locali
è quella di intessere rapporti con i turisti che possano durare nel tempo. Spesso, infatti, alcuni
di questi servizi sono forniti a titolo gratuito perché l’obiettivo finale è quello di avvicinarsi ai
guest e ottenere fiducia e amicizia che potranno, eventualmente, tradursi in un supporto
economico al termine della vacanza. È in questo quadro che s’inseriscono le relazioni fra
turiste occidentali e uomini locali, interpretabili, come vedremo nel primo capitolo, nella
cornice teorica del turismo romantico (Pruitt e LaFont 1995; Dahles e Bras 1999; Meisch
2002) o del turismo sessuale (de Albuquerque 1998; Kempadoo 2001; Sánchez Taylor 2000;
O’Connel Davidson 1998). Che siano definiti in termini sessuali o romantici, questi rapporti
rappresentano per i giovani del posto un’opportunità per acquisire un’indipendenza
economica, uno status sociale superiore e prestigio nel gruppo dei pari. Le prime ricerche,
condotte da Cohen (1971) e Bowman (1989), hanno indagato il contesto socio-antropologico
delle condizioni di vita dei ragazzi palestinesi in Israele e le aspettative da loro riposte nelle
turiste (in particolare la possibilità di emigrare). Soltanto negli anni Novanta, sono stati
presentati i primi studi sistematici sul fenomeno (Pruitt e LaFont 1995; de Albuquerque 1998;
Sánchez Taylor 2000; Karch e Dann 1981; O’ Connell Davidson 1996), che hanno
interessato, in particolar modo, l’area geografica dei Caraibi, affrontando la tematica relativa
! 3!
alla categorizzazione delle relazioni fra turiste occidentali e giovani uomini locali: turismo
sessuale o turismo romantico?
A queste sono seguite altre ricerche, svolte sia nelle isole caraibiche sia in altre parti del
mondo, che hanno approfondito l’analisi in direzione di un ampliamento e un superamento
dei paradigmi del turismo sessuale e romantico (Herlod et al. 2001; Cabezas 2004;
Weichselbaumer 2012; Frohlick 2007; Jacobs 2009; Meiu 2011; Dahles e Bras 1999).
Definiti in modi diversi, secondo l’area geografica, − pinguero2 (Hodge 2001) Jinteros3
(Cabezas 2004) a Cuba, sanky pankys4 nella Repubblica Dominicana (Herold et al. 2001;
Sánchez Taylor 2001), rent-a-dread5 in Giamaica (Pruitt e LaFont 1995); “beach boys” a
Barbados, Trinidad e Tobago, Kenya, Indonesia e Sri Lanka (de Albuquerque 1998;
Weichselbaumer 2012; Meiu 2011; Kibicho 2005; Omondi 2003; Kasfir 2004), côtéman6 in
Senegal (Venables 2009) e bumsters o bomsas7 in Gambia (Nyanzi et al. 2005; Brown 1992)
– essi condividono alcuni aspetti peculiari e ricorrenti nella gestione delle loro relazioni con le
turiste straniere8. Generalmente sono i “beach boys” a dare inizio al rapporto; la scelta
dell’obiettivo dipende dalle motivazioni del ragazzo ma, generalmente, la sua preferenza si
orienterà su una donna giovane e bella se desideroso di una conquista sessuale e di prestigio
sociale (frequentare una giovane donna bianca può essere motivo di invidia da parte degli altri
ragazzi), mentre mirerà a una donna matura se il risultato vuole essere, prevalentemente, di
carattere pecuniario. Nella scelta della turista, i beach boys mostrano di essere consapevoli
della vulnerabilità femminile: molte di queste donne, sia per età sia per caratteristiche fisiche,
poco attraenti nei loro paesi d’origine, non sono abituate a ricevere attenzioni e sono
potenzialmente più disposte a lasciarsi corteggiare e, magari, a innamorarsi. Inoltre, i “beach
boys” suppongono che le donne mature siano più facoltose e, dunque, più disposte a elargire
denaro. Nella fase di avvicinamento, essi mettono in atto una serie di tecniche di seduzione !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2 Il termine spagnolo “pinguero”, che deriva da pinga, un termine slang che sta per pene, utilizzato a Cuba per categorizzare gli uomini che offrono servizi sessuali nel settore turistico (Cabezas 2004: 994). 3 La parola di lingua spagnola “jinteros” deriva da jinete che significa cavallerizzo/a e dal verbo Jinetear: cavalcare. Il termine jinetera è emerso negli anni Novanta a Cuba durante l’espansione del turismo di massa in seguito al collasso del blocco sovietico (Cabezas 2004: 993). 4 sanky pankys è un’espressione giocata sulle parole inglesi hanky panky, utilizzata nella Repubblica Dominicana per definire la prostituzione maschile (l’espressione “beach boys”, è impiegata in modo equivalente). Essi fecero la loro prima comparsa negli anni Settanta quando tour organizzati per gay erano diffusi nella zona; oggi, invece, lavorano principalmente con turiste bianche di mezza età in cerca di storie d’amore e di avventura con giovani di colore (Cabezas 2004: 995). 5 Rent-a-dread è un termine che è stato coniato per definire gli uomini che hanno legami con donne straniere in Giamaica e rimanda ai dreadlocks portati dalla maggior parte di questi ragazzi (Pruitt e LaFont 1995: 424). 6 Côtéman deriva dal termine francese côté che significa “parte” e vuole alludere al fatto che i “beach boys” sono sempre dalla parte dei turisti (Venables 2009: 1). 7 Si suppone che bomsas derivi da una parola svedese che significa vagabando (Brown 1992: 363). 8 Le informazioni riportate da questo punto in avanti sono tratte dagli studi di Herold et. 2001; Nyanzi et al. 2005; Bergan 2011; Pruitt e LaFont 1995; Brown 1992; Peake 1989; Venables 2009; Hodge 2001; Dahles e Bras 1999; Cabezas 2004.!
! 4!
per presentarsi come uomini educati, amichevoli, affascinanti, nonché felici di poter essere
d’aiuto. La menzione degli aspetti economici dei servizi offerti è accuratamente sottaciuta per
avvalorare l’impressione di essere affidabili e genuinamente interessati alle turiste.
L’adulazione è una delle principali strategie di seduzione: considerazioni e apprezzamenti
sull’aspetto della donna, e sul suo modo di vestire, sono profusi nel tentativo di instaurare una
connessione che potrebbe sfociare in una relazione. Ancor prima di iniziare l’approccio, i
beach boys mettono in atto una serie di tattiche e atteggiamenti funzionali alla messa in
mostra della propria bravura e virilità. Una volta stabilito un rapporto, quando avvertono che
la donna è emotivamente coinvolta, i ragazzi possono raccontare della propria situazione
finanziaria, delle difficoltà che affrontano ogni giorno, del dovere che hanno verso gli altri
membri della propria famiglia, magari malati o bisognosi di assistenza negli studi, nella
speranza di spingere quest’ultima a offrire il suo aiuto. La richiesta di denaro non avviene mai
in maniera diretta ma in modi velati e allusivi. Il tempo gioca un ruolo molto importate: se la
domanda, sebbene indiretta, è fatta troppo presto, quando la turista non si sente ancora legata
affettivamente, potrebbe compromettere il rapporto e causare l’allontanamento della donna. Il
sostegno economico può anche iniziare al termine della vacanza, una volta che la partner sarà
tornata a casa. In alcuni casi, questi rapporti possono durare nel tempo: i partner mantengono i
contatti attraverso telefonate, mail e sms, e la turista cercherà di fare visita ogni volta che le
sarà possibile. La lontananza della donna consente al beach boy di intraprendere nuovi
rapporti con altrettante straniere, se lo ritiene opportuno. Riuscire a stabilire relazioni con
turiste occidentali costituisce un obiettivo primario perché rende concreta la possibilità di
realizzare le loro aspirazioni: aprire un business proprio, ottenere un biglietto aereo per far
visita alla propria compagna in Europa o, addirittura, il matrimonio e la migrazione.
2. Il campo: possibilità e ostruzioni
Sono stata a Mombasa, in Kenya, la prima volta nel 2008, in occasione di un progetto di
volontariato in un orfanotrofio di Likoni − un quartiere a Sud della città − abitato da bambini
orfani di genitori morti a causa del virus dell’HIV. Durante il mese speso a Mombasa, pur non
frequentando spiagge di alberghi e resort internazionali, mi capitò spesso di sentir parlare
delle opportunità che l’industria turistica può fornire ai giovani con un titolo di studio. In
particolare, un giovane dell’orfanotrofio che sarebbe, poi, diventato un amico, allora,
studiava, presso un college in città, per lavorare come receptionist in uno degli alberghi della
! 5!
costa. La speranza di trovare un lavoro fu presto delusa, nonostante mesi spesi a fare stage
presso gli alberghi della costa; ora, Isaac vive in Germania con la sua fidanzata tedesca.
L’esperienza vissuta a Likoni ha guidato la scelta dell’oggetto di questa tesi. Ho fatto ritorno a
Mombasa, per un brevissimo periodo di tre settimane, per fare, una seppur estremamente
modesta, “esperienza sul campo”, che mi consentisse di raccogliere alcune informazioni da
mettere in dialogo con le ricerche pubblicate in materia. Non sapendo di preciso cosa
aspettarmi in loco e considerando il tempo molto limitato della mia permanenza in Kenya,
prima della partenza, non ho stabilito, se per la mia analisi avrei adottato il punto di vista dei
beach boys, oppure delle turiste occidentali coinvolte nelle relazioni con giovani locali,
lasciando che la contingenza dell’esperienza guidasse la scelta. Così è stato. Il primo giorno in
cui mi sono recata sulla spiaggia di Mombasa beach, sono stata affiancata da un giovane di
circa trent’anni, che ha dichiarato di lavorare nel settore turistico come guida e boat operator.
È in questo modo che ho fatto la conoscenza di Bonnie, con il quale ho avuto, per tutta la
durata della mia permanenza, incontri quotidiani programmati. Da subito, ho cercato di
spiegare i motivi della mia presenza a Mombasa ma, naturalmente, soprattutto all’inizio, non
è stato facile: i tentativi di offrirsi come guida in città, o di accompagnarmi in una gita in
barca, presto, sono stati seguiti da lusinghe e apprezzamenti sul mio aspetto fisico, il mio
modo di vestire, la mia nazionalità. Non ha fatto mistero di volere una relazione con una
donna europea, possibilmente italiana, benché negasse di averne avute altre in precedenza. In
effetti, in qualità di donna bianca europea di trentacinque anni, possedevo molti requisiti per
rientrare nel target dei beach boys. Il poco tempo a disposizione non ha permesso lo sviluppo
di un rapporto di fiducia ma, a differenza delle esperienze riportate da alcune ricercatrici
(Venables 2009; Bergan 2011), non mi sono mai sentita in pericolo o in situazioni di forte
imbarazzo. Il rapporto con Bonnie, in un certo senso, mi ha precluso ulteriori contatti con altri
ragazzi della spiaggia, a eccezione di Nelson, un giovane boat operator di venticinque anni,
da poco arrivato a Mombasa Beach, che ho avuto modo di conoscere la mattina del mio
secondo giorno. È stato molto chiaro come, fin da subito, fossi stata in qualche modo
“etichettata” di appartenenza di Bonnie. Non solo gli altri giovani presenti sulla spiaggia
evitavano di parlare con me ma, quando mi vedevano arrivare, mi avvisavano riguardo a dove
fosse Bonnie, o a cosa stesse facendo, affinché lo aspettassi. Quando ho domandato a Bonnie
il perché di questi comportamenti, la risposta è stata che tutti erano stati informati della nostra
“amicizia storica” (ha raccontato che ci eravamo conosciuti su facebook): questo, ha
motivato, mi avrebbe dato protezione e uno status tale che gli altri ragazzi della spiaggia non
mi avrebbero disturbato. Lo stesso lavoro di dissuasione è stato fatto con me: Bonnie mi ha
! 6!
ripetutamente messo in guardia dagli altri boat operator, spiegandomi che non avrei dovuto
fidarmi di chiunque, perché non tutti erano brave persone come lui. Così, ho optato per
mantenere un rapporto privilegiato con Bonnie e Nelson, abbandonando l’idea iniziale di
avere un rapporto orizzontale con molti interlocutori in favore di uno verticale con due. La
contingenza del campo apre possibilità e allo stesso tempo ne preclude altre; la mia
esperienza, seppure brevissima, non si è sottratta a questa condizione.
Il periodo trascorso a Mombasa ha coinciso con la bassa stagione turistica; questo ha avuto
risvolti sia positivi sia negativi: la scarsa presenza di turisti sulla spiaggia, consentiva a
Bonnie di avere molto tempo libero a disposizione, tempo che molto spesso ha deciso di
spendere con me; invece, la carenza di turiste straniere non mi ha permesso di osservare,
quindi incontrare e possibilmente intervistare, donne che avessero una relazione con un
giovane del posto. L’assenza fisica di queste coppie non ha significato, però, che tali relazioni
non fossero presenti nei discorsi dei “beach boys”. Bonnie, per esempio, ha più volte parlato
di amici trasferiti in Europa, in visita alle loro fidanzate, o che semplicemente ricevevano
somme di denaro mensili perché, come dichiarato da Bonnie, “queste donne non vogliono che
il loro ragazzo lavori sulla spiaggia dove potrebbe trovare un’altra donna”.
Non avendo avuto la possibilità di osservare né tantomeno interagire con questo aspetto della
vita dei “beach boys”, ho ritenuto di concentrare l’analisi sulle attività da loro svolte sulla
spiaggia, sulle interazioni fra loro e con i turisti, sia donne sia uomini. Ho così cercato di
indagare gli effetti di queste interazioni sui processi di rappresentazione dell'autenticità, sulle
percezioni dello spazio e le relative implicazioni politiche. Inoltre, il fatto che Bonnie, e in
parte anche Nelson, rifiutasse con fermezza la categoria di “beach boys” in favore di quella di
boat operator, e che tale presa di posizione si basasse sull’opposizione fra boat operators,
descritti come partecipanti, legittimi e professionali, dell’industria turistica, e “beach boys”,
definiti con attributi negativi quali truffatori, consumatori di droghe e illegittimi frequentatori
della spiaggia, mi ha spinto a questionare la legittimità dell’utilizzo del termine “beach boys”;
soprattutto alla luce del fatto che lo Stato strumentalizza l’opposizione fra le due categorie in
base ai suoi fini politici, come vedremo nel corso della tesi. La negazione di Bonnie mi ha
dunque spinto in direzione di una problematizzazione della categoria, che, appariva chiaro,
non poteva essere data per scontata.
Le relazioni fra turiste occidentali e giovani locali, invece, sono state indagate all’interno
dell’analisi del dibattito scientifico sorto intorno alla definizione di tali relazioni come
turismo sessuale o turismo romantico.
La tesi è suddivisa in quattro capitoli, oltre a introduzione e conclusione.
! 7!
Il primo capitolo propone un confronto critico fra le categorie di turismo sessuale e turismo
romantico, cercando di mostrare come entrambe le prospettive, seppure molto diverse,
finiscano per ricorrere a una concezione oggettivante degli attori sociali.
Il secondo capitolo è dedicato all’esame dei processi che hanno portato alla costruzione del
Kenya come luogo turistico, le politiche turistiche nazionali e il loro posizionamento rispetto
ai paradigmi coloniali e alle politiche turistiche internazionali. Si sono altresì messe in
relazione le politiche pubbliche e la produzione della marginalità nella regione costiera, sede
dei principali siti turistici della nazione.
Nel terzo capitolo sono raccontante le storie di vita di Bonnie e Nelson, con l’intento di
mettere in relazione le loro esperienze individuali con le forze macro-strutturali, per far
emergere i processi di inclusione/esclusione che producono diseguaglianze sociali e che
collocano i soggetti in condizioni di marginalità. Poi, sono state analizzate le modalità di
interazione fra “beach boys” tra loro e con i turisti.
L’ultimo capitolo, facendo riferimento al concetto di campo sociale elaborato da Bourdieu e
alla nozione di luogo e di spazio di de Certeau, tratta lo spazio della spiaggia come un luogo
complesso, animato da conflitti e regolato da rapporti di forza tramite cui i diversi attori
sociali si posizionano in una continua negoziazione al contempo dialogica e conflittuale. Le
spiagge emergono come spazi misteriosi di interferenza, dove i turisti possono interagire con i
“beach boys” e dove il loro denaro può essere attinto in modo incontrollabile da individui che
non sono membri ufficiali dell’industria turistica. La difficoltà dello Stato di controllare la
presenza dei locali sulla spiaggia è tradotta in un supposto senso d’insicurezza esperito dai
turisti.
3. Fonti e considerazioni metodologiche
Il metodo che ho adottato si è basato su conversazioni piuttosto informali con gli interlocutori.
Sin dall’inizio, l’utilizzo del registratore si è dimostrato un ostacolo al rapporto che, nella
visione dei miei interlocutori, doveva assumere una connotazione amicale; dopotutto, ai loro
occhi, ero e continuavo ad essere una turista occidentale, sebbene abbia tentato di negoziare la
mia posizione nei termini di una studiosa universitaria. Benché si sia trattato principalmente
di conversazioni informali aperte, ho cercato di individuare alcuni argomenti, o temi chiave,
come guida al discorso; mi sono spesso confrontata con loro riguardo alle mie riflessioni e
interpretazioni, pur chiedendomi, al contempo, quanto l’esplicitazione di determinate
! 8!
valutazioni non influenzasse le loro risposte, orientandole in determinate direzioni. Tuttavia,
ero e sono consapevole che la natura della comprensione è dialogica e negoziale: essa deriva
non solo dalla cooperazione fra ricercatore e nativo, ma anche dalla reciproca manipolazione
e dagli aggiustamenti delle categorie di pensiero fra gli interlocutori (Malighetti 2004: 56). Le
interpretazioni del ricercatore e del nativo si fondono e si relazionano in uno scambio
circolare (secondo il modello della circolarità ermeneutica di Gadamer) che produce un
orizzonte di conoscenza superiore, che oltrepassa la propria conoscenza ma anche quella
dell’altro.
Ho cercato di mantenere un comportamento il più trasparente possibile, rendendo chiaro che,
al termine delle conversazioni, avrei annotato quanto emerso sui miei quaderni, come
materiale di studio per l’elaborazione della tesi.
Ho osservato più che partecipato per arrecare il minor danno possibile alle persone che mi
stavano aiutando: la mia presenza, in certe circostanze, avrebbe potuto ostacolare le attività e i
loro tentativi di stabilire contatti con nuovi turisti. Dunque, ho preferito rimanere in disparte e
concordare con Bonnie e Nelson appuntamenti fissi, che si sono svolti non solo sulla spiaggia,
ma anche passeggiando per i villaggi vicini alla costa. Questo ha permesso di creare situazioni
ottimali in cui io e i miei interlocutori abbiamo potuto conversare privatamente, o quasi, senza
dispersioni.
Nelle intenzioni originarie, avrei voluto avere un rapporto orizzontale con molti interlocutori
per restituire una polifonia di voci e prospettive; ho lasciato, però, che il processo di ricerca e
la casualità dei primi incontri scegliessero per me, cosicché progressivamente si è delineata la
figura di Bonnie come interlocutore privilegiato, affiancato da Nelson.
Inoltre, ho cercato di non dimenticare che la mia relazione con loro non era neutra e paritaria:
il fatto di essere donna, bianca ed europea è stato un aspetto determinante sia nel momento
dell’incontro sia per tutta la durata del rapporto, nel senso che ha creato le condizioni per
l’interazione e ha permeato i nostri scambi. Questo mi ha dato l’opportunità di sperimentare
di persona alcune delle strategie messe in atto dai beach boys per entrare in contatto con i
turisti, anche se, allo stesso tempo, non ha reso i rapporti sempre facili. Dal loro punto di
vista, avrei potuto aiutarli economicamente e, invece, chiedevo, a titolo gratuito (o quasi se si
considerano qualche sigaretta e qualche drink che abbiamo condiviso), il loro tempo e la loro
partecipazione al mio progetto, allineandomi con le posizioni dei turisti che, pagando per le
loro vacanze, si aspettano dai locali dedizione e accoglienza una volta arrivati a destinazione.
Ho vissuto quindi la contraddizione di volermi dissociare dall’immagine prodotta dai media e
dall’industria turistica che bolla il loro comportamento come deviante e pericoloso, al fine di
! 9!
deresponsabilizzarsi nei confronti di quella parte della popolazione che è stata tenuta ai
margini dello sviluppo turistico, pur trovandomi in una posizione privilegiata rispetto alla mia
classe, nazionalità e “razza”.
Data la brevità della mia permanenza sul campo e la modestia della quantità delle
osservazioni e dei dati raccolti, ho cercato di mettere il più possibile in dialogo quanto
ottenuto con le ricerche condotte in precedenza fra i “beach boys” a Mombasa e a Malindi di
Meiu (2008; 2011a; 2011b; 2012), Bergan (2011), Peake (1989); Jamison (1999); Kibicho
(2005). Queste osservazioni sono state poi confrontate con le ricerche sul fenomeno condotte
anche in altre parti del mondo, con attenzione particolare alla letteratura prodotta sulle
interazioni fra “beach boys” e turiste europee e nordamericane nei Caraibi. Qui, infatti, il
fenomeno ha incontrato l’interesse di molti studiosi che, a partire dagli anni Novanta, ne
hanno proposto un’analisi sistematica, punto di riferimento degli studi a seguire, non solo
nella regione del Caribe ma anche in altre parti del mondo. L’attenzione particolare che ho
dedicato a questa produzione scientifica non è dovuta soltanto a motivi quantitativi, ma anche
a considerazioni sulla storia coloniale che l’Africa e le isole dei Caraibi hanno condiviso − da
cui sono derivati comuni stereotipi razzisti relativi alla Blackness − e sulle similitudini
esistenti nei modelli di turismo di massa (basati principalmente sullo sfruttamento di sole,
mare e spiagge) che hanno caratterizzato lo sviluppo turistico in queste aree geografiche.
Per quanto riguarda l’esame delle politiche turistiche keniote, ho privilegiato una certa
“località” delle fonti, perlopiù produzioni accademiche del dipartimento del turismo della Moi
University.
Vorrei, infine, precisare che i nomi degli interlocutori utilizzati in questa tesi sono fittizi, nel
rispetto della loro privacy e della volontà che hanno espresso.
Ringraziamenti
Un ringraziamento particolare alla Professoressa Silvia Barberani per i preziosi suggerimenti
e commenti, e per la grande disponibilità che mi ha messo nella condizione di lavorare al
meglio alla tesi.
Grazie a Valentina Gervasoni per la premura con cui ha riletto il testo.
Infine, la mia gratitudine alla mia famiglia per l’amore e la fiducia, e soprattutto a Mauro per
il sostegno costante, la pazienza e la cura.
!!
! 10!
1. Un confronto critico fra categorie: turismo romantico e turismo sessuale nel dibattito
antropologico
1.1. Il turismo sessuale
Lo stereotipo tradizionale che ricorre nei discorsi di senso comune, interpreta il turismo
sessuale come un’attività del tempo libero intrapresa da uomini che viaggiano nei paesi in via
di sviluppo − dell’Asia, dell’Africa, dei Caraibi e dell’America Latina − in cerca di piaceri
sessuali a pagamento generalmente non disponibili, o quanto meno non allo stesso prezzo, nei
loro paesi d’origine (Enloe 1989; O’ Connell Davidson 1996).
Questa definizione di turismo sessuale rimanda a due aspetti: alla dimensione internazionale
del fenomeno e della prostituzione, intesa come transazione finanziaria di sesso in cambio di
denaro fra uomini-clienti e donne-prostitute.
In riferimento al primo punto, alcuni studiosi hanno investigato i rapporti fra industria
turistica e turismo sessuale (Truong 1983; Kibicho 2005), le dinamiche della globalizzazione
nelle mete turistiche (Brennan 2004), le connessioni fra turismo sessuale e globalizzazione
(Wonders e Michalowski 2001 ) il rapporto fra turismo sessuale, militarizzazione e
colonizzazione (Enloe 1989; Nagel 2000; Kempadoo 2001) e quello fra turismo sessuale,
nazionalismo ed economia politica internazionale (Leheny 1995). Sebbene la prostituzione sia
un fenomeno antico e i servizi sessuali offerti ai viaggiatori vadano indietro nei secoli, risulta
evidente come oggi essa abbia raggiunto una scala senza precedenti: se prima era un servizio
accessibile soltanto per certi gruppi sociali, ora è progressivamente oggetto di una fruizione di
massa.
L’industria turistica offre tour organizzati chiamati “trips for man only”, destinati a clienti
uomini, che includono esplicitamente visite ai bordelli: Truong (1983: 533), per esempio,
stima che nel 1982 un milione di turisti giapponesi ha visitato la Tailandia, le Filippine, la
Korea del Sud, il Taiwan e Hong Kong con uno di questi pacchetti.
Wonders e Machalowski (2001: 456-457) nella loro analisi condotta nelle città di La Havana
e Amsterdam, interpretano il turismo sessuale come un prodotto di “forze globali”, dove per
forze globali si intendono i flussi globali di capitale, il mercato del lavoro globalizzato e le
industrie, le migrazioni di massa, e la nascita di città globali. Queste forze ne modellano la
produzione e il consumo. Nella loro prospettiva, ciò che è nuovo all’interno di questa
dinamica è come la prostituzione, in località specifiche del Sud del mondo, sia
! 11!
sovradeterminata da più vaste forze globali che ne facilitano la produzione ma anche il
consumo: la produzione del turismo sessuale è agevolata dal movimento planetario di corpi
attraverso confini, quale risultato di un’espansione della migrazione e del turismo; mentre il
consumo di turismo sessuale è favorito dalla mercificazione di corpi e desiderio (Wonders e
Machalowski 2001: 552; vedi anche Nagel [2000] che definisce il turismo sessuale come
“l’economia sessuale e globale del desiderio”).
Truong (1983: 544-545), imputa a una serie di fattori non direttamente connessi alla
commercializzazione dei servizi sessuali, il fatto che la prostituzione sia diventata un “oggetto
di commercio internazionale”. Questi fattori sono la nascita dei pacchetti vacanze all
inclusive, il progresso tecnologico nel campo dei trasporti, la crescita del reddito disponibile.
In particolare, i pacchetti all inclusive hanno consentito a molti turisti di raggiungere mete
lontane, che non avrebbero visitato altrimenti, grazie ai costi ridotti dei voli e degli alberghi,
cui si aggiunge anche la possibilità di accedere a servizi sessuali a basso costo.
Un elemento importante messo in luce da diversi studi (Truong 1983; Enloe 1989; Leheny
1995; Nagel 2000) è la relazione fra prostituzione e militarizzazione su scala globale che ha
consentito al turismo sessuale di costruirsi su un’organizzazione creata in precedenza (durante
la Guerra Fredda) per il riposo e lo svago dei soldati; in questo modo si individua un nesso fra
prostituzione in tempo di guerra e turismo sessuale. Riferendosi alla guerra in Korea, Nagel
(2000: 162) mostra come i bordelli e i locali che circondano le basi militari americane e le
aree dedicate al riposo e allo svago delle truppe siano diventati siti etnosessuali9, dove le
fantasie occidentali incontrano manifestazioni concrete di sessualità esotiche. Durante la
Guerra Fredda, la creazione di un network globale di basi e alleanze militari da parte degli
Stati Uniti e dei loro alleati, così come da parte del blocco sovietico e dei suoi alleati, ha
esteso il numero di stazioni militari in tutto il mondo. La militarizzazione globale intervenuta
nella seconda metà del XX secolo ha istituzionalizzato la prostituzione in molti paesi, su scala
senza precedenti, sopravvivendo al collasso dell’Unione Sovietica e alla fine della Guerra
Fredda (Nagel 2000: 164). Così, il turismo di massa oggi incontra una prostituzione
istituzionalizzata, ereditata dalle basi militari americane, elevandola a voce significativa del
mercato internazionale (Truong 1983: 544).
Richter (in dell’Agnese e Ruspini 2005: 3-21) e Ruspini (ivi, 2005) evidenziano le
connessioni fra mascolinità e turismo sessuale: l’industria del turismo sessuale ruota intorno
alle fantasie maschili ed è controllata dagli uomini. Le ricerche di alcuni autori − come
Pritchard e Morgan (ivi: 187-209), Caldas-Coulthard (ivi: 211-230) e Enloe (1989) −
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 Nagel (2000) utilizza il termine etnosessualità per indicare come razza e sesso siano intimamente interconnessi.
! 12!
mostrano come il linguaggio e l’iconografia della promozione turistica privilegino lo sguardo
maschile eterosessuale sopra ogni altro e come i paesaggi siano rappresentati con forti
connotazioni di genere, proprio per attrarre questo sguardo. Pritchard e Morgan sostengono
che “il linguaggio della promozione turistica è patriarcale in modo schiacciante: un linguaggio
nel quale i desideri e i bisogni delle donne sono riassorbiti in una norma maschile” (ivi: 202).
Tale stereotipizzazione del corpo femminile in funzione dello sguardo maschile
nell’“economia globale del desiderio”, ha un fondamento di matrice coloniale: la sessualità
era un particolare strumento di potere, centrale nella costruzione dell'Altro come diverso. Le
pratiche di dominio e le gerarchie razziste coloniali di superiorità e subordinazione sono
replicate nel turismo internazionale nel momento in cui le donne locali sono immaginate
come sessualmente più accessibili rispetto a quelle del proprio paese (Roland 2010; Crick
1989; Kempadoo 2001). In accordo con Kempadoo (2001) i consumatori del primo mondo e i
fornitori del terzo mondo, nel commercio del sesso, tendono a riprodurre stereotipi egemonici
basati su gerarchie di razza e genere in cui, coloro che hanno la pelle nera, sono rappresentati
come uomini sessualmente iperdotati, donne focose e sensuali, e subordinati.
Nonostante la predominanza del turismo sessuale maschile e la relativa mascolinizzazione del
fenomeno a livello di immaginario comune, a partire dagli anni Settanta, il numero delle
donne che visitano i Caraibi, il Kenya, o l’Asia sud-orientale e intrattengono relazioni sessuali
con giovani uomini locali, è in crescita (sebbene, è bene notare, non vi sia un mercato
organizzato della prostituzione maschile o un’industria formale che provvede ai desideri delle
turiste). Queste relazioni sono state oggetto di ricerca da parte di studiosi in Giamaica (Pruitt e
LaFont 1995; de Albuquerque 1998; Sánchez Taylor 2000), Barbados (Karch e Dann 1981),
Santo Domingo (Herlod et al. 2001; Sánchez Taylor 2000; Brennan 2004), Cuba (O’ Connell
Davidson 1996; Hodge 2001; Babb 2010; Cabezas 2004), Trinidad et Tobago
(Weichselbaumer 2012), Gambia (Nyanzi et al. 2005; Brown 1992); Costa Rica (Frohlick
2007), Ecuador (Meish 2002), Egitto (Jacobs 2009), Senegal (Venables 2009), Kenya
(Omondi 2003; Kibicho 2005; Meiu 2011.; Kasfir 2004), Indonesia (Dahles e Bras 1999),
Palestina (Bowman, 1989). Il turismo sessuale femminile è un fenomeno piuttosto recente che
esprime l’evoluzione delle pratiche turistiche connessa con il mutare delle identità di genere e
sessuali (Ruspini 2005: 37-38).
Considerando il turismo sessuale come aspetto dinamico dell’economia mondiale, Leheny
(1995) ha analizzato la relazione fra la crescita del numero di donne che viaggiano all’estero e
gli effetti profondi che tale crescita può avere sui calcoli economici che la classe politica di un
paese deve fare nello stabilire le proprie strategie di sviluppo. In particolare, l’autore ha
! 13!
esaminato il caso delle politiche nazionali tailandesi in relazione alla crescita del numero di
turiste giapponesi. Il miglioramento dello status delle donne in Giappone ha comportato un
incremento del loro potere d’acquisto e del numero dei loro viaggi all’estero, andando a
costituire una voce importante nel mercato turistico asiatico. Questo incremento potrebbe
costituire, sostiene Leheny (1995: 380), il catalizzatore del declino del mercato sessuale
tailandese: il fatto che le donne giapponesi non considerano la Tailandia fra le destinazioni
turistiche più apprezzate, a causa della sua nomea internazionale di meta del turismo sessuale
maschile, ha spinto il governo tailandese ad adoperarsi per modificare la propria immagine e
rendersi così appetibile agli occhi delle nuove protagoniste del mercato turistico. In questo
modo Leheny ha mostrato come le condizioni socio-culturali presenti in un paese possano
essere trasmesse a un altro paese attraverso i meccanismi del mercato (1995: 368) e come il
turismo sessuale non sia né naturale né endemico, bensì il risultato di decenni di scelte
politiche e casualità (1995: 381). Queste considerazioni sono importanti perché allontanano
dal rischio di naturalizzazione del turismo sessuale, mettendo in evidenza come esso esista
sulla base di una domanda e di un’offerta, nonché di una combinazione instabile di
nazionalismo, sessualità e potere economico che non ha nulla a che vedere con la presunta
promiscuità e disponibilità sessuale di determinati gruppi etnici.
Gli studi hanno contribuito a problematizzare la definizione di turismo sessuale come
scambio monetario per l’ottenimento di prestazioni sessuali, riflettendo su situazioni in cui
l’aspetto pecuniario è occultato o espresso in altre modalità (regali, supporto finanziario a
parenti malati, etc.), a favore di una connotazione della relazione in termini romantici o di
amicizia.
La tendenza a ridurre la concezione del turismo sessuale ai soli aspetti commerciali, prende
corpo in due prospettive concorrenti che a lungo hanno guidato la teorizzazione del
fenomeno: da una parte, quella che vede le prostitute come vittime sessuali (femminismo
radicale), dall’altra, quella che le interpreta come attori investiti di potere (femminismo
liberale) (Herold et al. 2001: 978-979). Il dibattito teorico sul turismo sessuale si è
principalmente incentrato sulle questioni relative al patriarcato e alla dominazione maschile,
attribuendo agli uomini il ruolo di sfruttatori e alle donne quello di vittime subordinate e
passive (Sánchez Taylor 2006). A questo riguardo Enloe (1989: 36) afferma che “il turismo
sessuale non è un’anomalia, ma un filone dell’industria turistica di genere […] che ha bisogno
del patriarcato per sopravvivere”. Dagli anni Settanta, l’approccio tradizionale alla
prostituzione delle femministe radicali, secondo cui essa va intesa come una forma di
sfruttamento, è stato messo da parte in favore di una nuova prospettiva teorica che la
! 14!
considera, piuttosto, come un lavoro meritevole di rispetto come ogni altra occupazione
legittima (Phillips e Dann in dell’Agnese e Ruspini 2005: 366-367). Sebbene la seconda
prospettiva riconosca alle sex workers un’agency che le emancipa dalla definizione riduttiva
di vittime passive, entrambe le concezioni limitano la comprensione alla sola dimensione
della transazione finanziaria.
Ryan (2000) e Oppermann (1999), nel tentativo di espandere questa visione tradizionale del
turismo sessuale, considerata inadeguata e semplificatoria, propongono un’analisi che tenga
conto di altri casi e scenari. Ryan propone che il turismo sessuale “possa essere descritto
come un incontro sessuale che avviene mentre si è lontano da casa” (Ryan 2000: 36). Questa
definizione ha il pregio di riconoscere che esistono diverse tipologie di turismo sessuale e
differenti soggetti che vi partecipano, ma presenta anche delle criticità. Innanzitutto la
categoria così delineata, rischia di essere troppo inclusiva per rendere significativo il concetto
di turismo sessuale e ne esclude un aspetto molto importante, ovvero quello delle relazioni
asimmetriche di potere. Inoltre, essa non chiarisce cosa si debba intendere per incontro
sessuale: quest’ultimo deve essere limitato all’atto della penetrazione o può comprendere altri
aspetti come la masturbazione o il sesso orale?
L’analisi di Oppermann (1999) problematizza lo stereotipo tradizionale che vede nel turismo
sessuale una sottocategoria della prostituzione, prendendo in considerazione, oltre a quello
dello scambio pecuniario, cinque ulteriori parametri: lo scopo del viaggio, la durata
temporale, il sistema di relazione, l’incontro sessuale e, infine, la questione di chi sia, fra i due
soggetti del rapporto, chi viaggia (Oppermann 1999: 252). Dall’analisi di questi parametri
emergono altri aspetti del fenomeno: gli scopi del viaggio e le attività intraprese dal turista
sono raramente lo scopo e l’attività esclusivi (il turismo è per sua natura molteplice rispetto
agli scopi perseguiti e alle attività svolte); molti incontri sembrano aver luogo senza un
passaggio diretto di denaro (sebbene il profitto economico resti il movente primario dei
fornitori di sesso) e questo fatto influenza la percezione del turista che si convince di trovarsi
in compagnia di “un’amica”; i rapporti iniziati con un servizio sessuale fornito in cambio di
denaro, nel tempo, possono evolvere in una relazione continuativa e talvolta anche in un
matrimonio; l’incontro sessuale non è limitato all’atto della penetrazione ma può
comprendere una serie di altre pratiche che includono anche internet e le linee telefoniche
erotiche; infine, la cospicua percentuale di prostitute straniere indica che, in molti scenari, è la
prostituta a viaggiare “svolgendo il ruolo di turista d’affari”10 (Oppermann 1999).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10!Nella sua analisi Opermann prende in considerazione il turismo sessuale eterosessuale, ma esiste anche un fiorente turismo sessuale omosessuale in cui, come nel caso delle prostitute che viaggiano verso i siti turistici per incontrare potenziali clienti, possono essere i lavoratori del sesso uomini a spostarsi.!A questo riguardo, si veda
! 15!
Per rendere conto di questi aspetti, la prospettiva di Oppermann impiega la nozione di
continuum, contrapposta a una definizione netta e riduttiva di turismo sessuale, avvalorando
la tesi secondo cui le dimensioni del fenomeno siano più d’una, così che il turismo sessuale
andrebbe osservato su una scala pluridimensionale:
I parametri presi in considerazione non consentono drastiche classificazioni ‘bianco o nero’, ma
ciascuno di essi dà luogo piuttosto a un continuum graduale. […] (Le specifiche situazioni di
turismo sessuale) possono occupare l’estremità dello spettro in uno o più parametri e,
simultaneamente, collocarsi all’estremità opposta per altre variabili” (Oppermann 1999: 255).
Più avanti precisa:
Potremmo dire che il turista “ideale” è colui che si prende una vacanza con la deliberata
intenzione di avere rapporti sessuali, sta lontano da casa almeno per 24 ore, incontra il suo
fornitore erotico per la prima volta, ha un rapporto come risultato di uno scambio diretto di
denaro e ottiene la gratificazione sessuale nel corso di incontri relativamente di breve durata. Ma,
in generale, questo tipo ideale non esiste (Oppermann 1999: 261).
Dall’analisi di Oppermann si delineano alcune riflessioni importanti per la teorizzazione del
fenomeno in riferimento alla questione dello sfruttamento − primaria nel quadro teorico del
femminismo radicale, in cui le prostitute sono viste nella posizione dello sfruttato e i turisti in
quella degli oppressori. Oppermann (1999: 254) osserva come già diversi autori si siano
domandati, ad esempio, se gli uomini ottengano effettivamente ciò che vogliono o se, in
realtà, desiderino qualcosa di più del puro e semplice godimento fisico, sentendosi quindi
delusi dall’approccio commerciale della prostituzione. Questa potrebbe essere una delle
ragioni per cui molti uomini si recano in paesi in via di sviluppo dove il loro denaro può
presumibilmente comprare non soltanto sesso ma anche tenerezza (Oppermann 1999: 255).
Inoltre, il fenomeno della “prostituzione a finale aperto”11 − dove una relazione iniziata come
un mero interscambio commerciale può facilmente trasformarsi in un legame più
impegnativo, che mette in gioco un coinvolgimento personale che si concretizza, per esempio,
nell’invio di denaro tra un incontro e l’altro (Phillips e Dann in dell’Agnese e Ruspni 2005:
363-364) − insinua il dubbio su chi sia effettivamente la parte sfruttata. Già O’ Connell
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il saggio di Matteo Alcano, Sulla carne degli altri. Forme di capitale, immobilità e dipendenza fra gli ex lavoratori del sesso a Bali (Indonesia) (in Vignato 2010: 131-150), che riferisce di come molti giovani emigrino da Giava a Bali in cerca di lavoro nel mercato del sesso per omosessuali.!!11 Definizione coniata da Cohen (“Thai Girls and Farang Men: The Edge of Ambiguity”, Annals of Tourism Research, n. 9 (1982), pp. 402-428) per indicare il tipo di relazione che si stabilisce fra una prostituta tailandese e un farang (un turista maschio, di provenienza occidentale).
! 16!
Davison, nel suo studio sul turismo sessuale a Cuba (1996), aveva individuato tre categorie di
turisti sessuali, di cui soltanto una è riconducibile alla categoria idealtipica del turista sessuale
che si reca in un paese lontano per avere incontri erotici a pagamento: il “macho” che usa i
corpi femminili mercificati per provare la propria mascolinità; il “misogino”, che si ritiene
una vittima delle proprie pulsioni e che non tollera i termini contrattuali imposti dalle
prostitute occidentali, preferendo rivolgersi a donne di paesi in via di sviluppo che non
impongono limiti sulla durata e sulle caratteristiche delle prestazioni; infine, il terzo tipo di
turista sessuale è quello che O’ Connell Davidson definisce “l’inconsapevole” che si illude di
sviluppare un rapporto di carattere romantico, aiutato dal fatto che, in genere, la relazione
inizia in termini apparentemente non commerciali e spesso la ricompensa non viene
corrisposta in denaro ma in doni o aiuti finanziari per un membro della famiglia.
Queste riflessioni sono riprese nel dibattito scientifico che ruota intorno alla classificazione
del fenomeno delle donne occidentali, che viaggiano in paesi in via di sviluppo intrattenendo
relazioni sessuali con i giovani uomini locali. Ma prima di affrontare tale dibattito, vorrei
soffermarmi brevemente sul tema del viaggio come momento importante della costruzione del
genere.
1.2. Il viaggio “al femminile”
Il viaggio per le donne non ha mai costituito un momento della costruzione del genere
femminile (dell’Agnese e Ruspini 2005). Al contrario, per gli uomini il viaggio ha
storicamente ricoperto un ruolo formativo importante della loro identità di genere (Leed 2007;
Löfgren 2006; Urbain 2003). Nel Settecento, il Grand Tour doveva servire ai giovani
aristocratici di sesso maschile per apprendere le bellezze artistiche della classicità e le norme
delle culture e delle civiltà altrui. Oltre ai motivi più edificanti, il viaggio doveva servire come
“rito di passaggio”, anche da un punto di vista sessuale, sebbene questo aspetto fosse perlopiù
sottaciuto. Come spiega dell’Agnese:
Il Grand Tour rappresentava un momento centrale nella costruzione identitaria dell’aristocrazia
britannica che vi prendeva parte. Era infatti un momento di edificazione del Sé che toccava tanto
la distinzione sociale e culturale, quanto la dimensione nazionale e la collocazione di genere di
chi aveva il privilegio di parteciparvi. Grazie alla possibilità acquisita, nel corso del viaggio di
istruzione, di sfoggiare il proprio “gusto” di esteta e connoisseur, infatti, il grand-turista poteva
collocarsi all’interno del gruppo elitario degli aristocratici colti. Contemporaneamente, l’intensa
! 17!
rete di contatti con altri grand-turisti della medesima estrazione e provenienza che veniva
intessuta nel corso del viaggio, e la costante possibilità di confortare la propria superiorità
culturale tramite il confronto con le realtà “esterne” […] offriva al grand-turista la possibilità di
costruire la propria identità di stampo nazionale pur mantenendo il dovuto distacco rispetto alle
componenti “inferiori” della stessa popolazione britannica (in dell’Agnese e Ruspini 2005: 92).
Nell’Ottocento il Grand Tour è stato progressivamente sostituito dal viaggio d’avventura in
cui l’esperienza dell’Altrove seguiva altre modalità. Le forme di avventura erano i viaggi di
esplorazione, l’esperienza della frontiera e la cosiddetta “avventura coloniale”: tutte
esperienze coniugate al maschile, al contrario delle terre da esplorare e conquistare che,
invece, erano descritte con attributi femminili: esotiche, sensuali, lussureggianti, passive.
L’avventura costituì, a partire dalla fine del Settecento, una delle basi della virilità normativa
britannica e poi di quella americana e occidentale (dell’Agnese in dell’Agnese e Ruspini
2005: 2005: 96). Un aspetto interessante, che emerge nella letteratura relativa ai viaggi
d’avventura e alle imprese coloniali, è come forme classiche di sfruttamento dell’epoca
fossero interpretate in senso “romantico”, anticipando le modalità auto-illusorie caratteristiche
di una parte del turismo sessuale contemporaneo (dell’Agnese in dell’Agnese e Ruspini 2005:
98).
Se da un lato la mascolinità si costruiva anche attraverso il viaggio, la femminilità, per
tradizione, era rappresentata da una donna accucciata accanto al focolare; questo però non ha
impedito ad alcune donne di viaggiare secondo le modalità del Grand Tour o del viaggio
d’avventura. Le donne che viaggiavano, lo facevano generalmente per motivi di salute, per
devozione, o per seguire i propri uomini, non certo per piacere o a scopo educativo; anche le
poche donne che riuscivano a partire per il Grand Tour, prima, e per i viaggi alla scoperta di
paesi lontani, poi, (l’Ottocento vide anche una crescita considerevole del numero delle
viaggiatrici), lo facevano per affermare la propria autonomia e superare le convezioni
tradizionalmente imposte al loro ruolo12, non certo per motivi formativi come per gli uomini
(dell’Agnese e Ruspini 2005; Bauer 2013; Leed 2007; Löfgren 2006).
Diverse autrici (dell’Agnese e Ruspini 2005; Sánchez Taylor 2000; Bauer 2013; Leed 2007)
hanno evidenziato come per le donne il viaggio rappresentasse un’occasione per rivendicare
per sé le definizioni di “esploratore” e “avventuriero”, comunemente attribuite agli uomini. In
questo senso, le donne hanno utilizzato il viaggio per mascolinizzare le loro identità, più che
per affermare la loro femminilità.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12!Le aspettative sociali connesse all’identità femminile prevedono la funzione procreatrice, genitrice, educatrice e sostegno del maschio (Ruspini in dell’Agnese e Ruspini 2005: 40).!
! 18!
Oggi, in seguito all’avvento del turismo di massa, all’accesso delle donne nel mondo del
lavoro con la conseguente possibilità di contare su una loro indipendenza economica, e il
movimento per l’emancipazione sessuale, le modalità del viaggio “al femminile” sono
cambiate. Donne scandinave e nordeuropee hanno iniziato, a partire dagli anni Sessanta, a
viaggiare nel Sud dell’Europa, in Italia, Grecia e Spagna, dove uomini locali erano ben
disposti a presentarsi come parte delle attrazioni locali (Bauer 2013: 22). Negli anni Settanta,
donne canadesi e americane iniziarono a muoversi in massa verso i Caraibi, dove incontrare
giovani uomini neri sessualmente iperdotati, sulla scorta degli stereotipi razzisti di matrice
coloniale (dell’Agnese 2005: 108). Quest’ultima attitudine, così come il collezionismo
praticato dalle cosiddette Yellow Cabs giapponesi, cioè quelle giovani donne che cercano di
accumulare più incontri sessuali possibile con uomini non giapponesi, osserva dell’Agnese (in
dell’Agnese e Ruspini 2005: 108), è un comportamento tipicamente maschile che
sembrerebbe riconfermare, aggiungo io, la propensione delle donne a mascolinizzare la
propria identità piuttosto che a trovare modi alternativi di affermare la propria femminilità.
A questo riguardo, Pruitt e LaFont (1995) hanno messo in evidenza come per alcune donne
occidentali il viaggio sia divenuto la strada più accessibile per esplorare nuovi territori del sé e
costruire nuove identità di genere. Se prima il viaggio rappresentava per poche e un modo per
rompere i confini di genere, oggi questa funzione del viaggio può essere sfruttata da un
numero sempre più crescente di donne, tanto da essere diventato parte delle attività che
strutturano il genere femminile. Gli incontri sessuali fra turiste occidentali e giovani uomini
locali di paesi in via di sviluppo, costituiscono, per le due autrici, un’arena per il
cambiamento, in cui è possibile sperimentare nuovi comportamenti di genere ed espandere i
confini dei requisiti convenzionali della femminilità. Tuttavia, affermano Pruitt e LaFont
(1995: 436), queste donne sono simultaneamente attratte verso nozioni convenzionali di
mascolinità e, in particolare, quelle più strettamente associate con il dominio. Più lontano le
donne spingono il confine del comportamento femminile, incorporando qualità
convenzionalmente definite come maschili − come l’assunzione di ruoli dominanti all’interno
della relazione (grazie al loro status economico e sociale che si traduce in potere e controllo)
− tanto più esse si confrontano con idee interiorizzate di potere maschile, riproducendo la
dicotomia di genere, costruita su relazioni di potere gerarchico, che è propria della loro norma
culturale. Rompere taboo e sfidare tradizioni, concludono le autrici, apre inesplorati territori
di relazioni sociali. Il risultato non è mai certo e porta con sé la possibilità di riprodurre molto
di ciò che si sta sfidando Pruitt e LaFont (1995: 438). In questo senso, Sánchez Taylor (2000:
46) riferisce di come alcune turiste sessuali attraversino i domini abitualmente di pertinenza
! 19!
degli uomini, rivestendo ruoli di potere tradizionalmente attribuiti al genere maschile, per
riaffermare la loro femminilità.
Storicamente, l’onore femminile è stato associato ai suoi tradizionali legami con la purezza e
la passività sessuale (purché esclusivamente eterosessuale): “l’espressione della sessualità
femminile era ritenuta sospetta e, al contempo, considerata la causa di certe malattie cui gli
uomini erano immuni” (Ruspini in dell’Agnese e Ruspini 2005: 39). Inoltre, dal momento che
l’onore sociale era tributato a coloro che confermavano gli attributi idealizzati dei loro ruoli di
genere, le donne eterosessuali non ritenute desiderabili dagli uomini, oppure senza legami o
lesbiche, erano a rischio di perdere il loro onore all’interno della comunità (Sánchez Taylor
2006: 47). Nelle società occidentali contemporanee, gli ideali sociali di femminilità risiedono
tuttora nel corpo della donna e nel suo comportamento eterosessuale: le donne che compaiono
nelle campagne pubblicitarie, nei film, nelle riviste, sono giovani, sexy e capaci di attrarre lo
sguardo maschile; anche i personaggi televisivi che sembrano sfidare i ruoli di genere, come
le protagoniste della serie tv Sex and the City, finiscono per essere preoccupate di trovare un
uomo o di diventare madri. In conclusione, sostiene Sánchez Taylor (2006: 48), non vi è una
vera e propria preoccupazione da parte delle donne di sfidare le strutture patriarcali di potere e
la tradizionale enfasi sulla differenza di genere è ri-attuata continuamente nella cultura
popolare occidentale. Così, le donne che nei loro paesi di origine sono rifiutate a causa
dell’età e/o delle rotondità del loro corpo, tornano a sentirsi desiderate da giovani uomini di
paesi lontani e, dunque, a esistere come oggetti sessuali, “vere” donne. Alcune di queste
donne possono riappropriarsi anche degli aspetti della cura legati al loro ruolo di genere,
convincendosi di avere conquistato un “nobile selvaggio” e di averlo guidato sulla strada
verso la civilizzazione. Che sia per l’una o per l’altra ragione, Sánchez Taylor (2000: 48)
sostiene che esse utilizzino il turismo sessuale per ricostruire le loro identità: l’Altro diviene
uno specchio che riflette l’immagine di femminilità scelta da ciascuna turista.
1.3. Il dibattito scientifico: turismo sessuale Vs turismo romantico
Nella loro analisi dei rapporti fra turiste occidentali e uomini locali in Giamaica, Pruitt e
LaFont (1995) coniano il termine romance tourism, turismo d’idillio o romantico, per
distinguere queste relazioni da quelle del turismo sessuale. Se quest’ultimo, sostengono le
autrici, conferma e riproduce i tradizionali ruoli di genere, e rinforza le relazioni di potere
fondate sulla dominazione maschile e la subordinazione femminile, al contrario, il turismo
! 20!
romantico offre un’arena per il cambiamento, uno spazio sociale in cui poter sperimentare
nuove identità di genere. Per elaborare la loro tesi, le due ricercatrici si sono basate su
interviste, analisi quantitative e informatori-chiave di entrambi i sessi. Lo scopo della loro
ricerca non è stato stabilire se questi uomini fossero o meno prostituti, ma mostrare il
significato peculiare che questi legami rivestono per i partner e rendere conto della loro lettura
della situazione. Nessuna delle controparti considera la propria relazione un mero scambio
pecuniario, piuttosto entrambe enfatizzano gli aspetti del corteggiamento e del
coinvolgimento affettivo, e costruiscono le loro liaisons nei termini di storie d’amore e
rapporti a lungo termine (Pruitt e LaFont 1995: 423). Lo studio delle due autrici privilegia il
punto di vista degli attori sociali e stabilisce una differenziazione fra turismo sessuale e
turismo romantico primariamente sulla base dell’asse del genere.
De Albuquerque (1998) rifiuta fermamente la categoria di turismo romantico e rivendica
l’appartenenza delle relazioni fra turiste straniere e giovani uomini locali alla categoria
analitica del turismo sessuale. La sua analisi si basa su una ricerca svolta nei Caraibi, in
particolare in Giamaica e Barbados, e su interviste condotte prevalentemente con uomini
locali, più disposti, secondo l’autore, a lasciarsi intervistare rispetto le turiste. A differenza di
Pruitt e LaFont, de Albuquerque sostiene che la maggioranza delle turiste siano alla ricerca di
sesso occasionale ben più che di storie romantiche, pur riconoscendo che alcune di esse
s’innamorano sinceramente di uomini del posto. Partendo dalle motivazioni che spingono le
donne a viaggiare verso paesi in via di sviluppo e a intrattenere relazioni con gli uomini del
posto, de Albuquerque (1998) ha classificato le turiste sessuali in quattro tipologie: le
“debuttanti” o neofite; le turiste sessuali “situazionali”, ben disposte a fare sesso con i “beach
boys” pur non viaggiano con questo preciso intento; le “veterane” il cui obiettivo è di
sperimentare sesso anonimo; infine, le “reduci” che hanno stabilito una relazione
continuativa. La posizione dell’autore si basa sull’assunto che le donne, investite oggi di
maggior potere economico e sociale, siano motivate da fantasie razzializzate di uomini
ipersessualizzati, così come accade nel turismo sessuale maschile; “spendere notti con il big
bamboo è per le turiste nordamericane ed europee un’altra attività della vacanza: se non
soddisfacente, almeno piacevole, come tutte le altre attrazioni turistiche (de Albuquerque
1998: 57).
Kempadoo (2001), sulla scia delle riflessioni di de Albuquerque, osserva come le liaisons fra
turiste e “beach boys” siano prodotte e configurate non solo lungo l’asse del genere ma anche
lungo quello dell’etnicità e della razza, della nazionalità e della classe. La sua è una
prospettiva marxista che imputa alla condizione economicamente e politicamente privilegiata
! 21!
dei turisti occidentali, che si recano in paesi in via di sviluppo, l’aspetto più problematico del
turismo sessuale. La ricerca di Kempadoo, condotta in tutta la regione dei Caraibi, ha come
oggetto il turismo sessuale sia maschile sia femminile e si prefigge di condurre un’analisi del
fenomeno priva di giudizi morali, che presti attenzione alle specificità storiche e contestuali, e
incentrata sullo studio della prostituzione come una forma di lavoro che si struttura secondo
una molteplicità di rapporti di classe, razza e genere. Benché l’autrice riconosca come le
donne intervistate descrivano le loro relazioni con uomini locali nei termini di storie d’amore,
rifiutando di applicare a se stesse la definizione di turiste sessuali, e come gli stessi uomini
preferiscano definirsi come “beach boys”, “gigolo”, “hustler”, piuttosto che sex worker, la sua
analisi non prescinde dagli aspetti economici che regolano questi rapporti. Per Kempadoo, la
distinzione fra turismo romantico e sessuale potrebbe essere appropriata per descrivere
l’attitudine delle turiste a negare gli aspetti economici delle loro liaisons, ma non per rendere
conto delle esperienze dei giovani locali, che intraprendono relazioni con le straniere prima di
tutto per ottenere vantaggi materiali. Inoltre, l’autrice (2001: 50) riferisce come, nei Caraibi,
donne e uomini siano costruiti nell’immaginazione dei turisti come soggetti-oggetti
sessualmente razzializzati – il macho nero iperdotato e la donna nera focosa e disponibile – il
cui ruolo principale è quello di servire e gratificare i turisti. Donne e uomini occidentali
condividono la medesima posizione privilegiata, economica e di razza, all’interno dell’ordine
globale. Il genere e la sessualità sia per gli uomini sia per le donne, sono quindi costruiti, nel
contesto internazionale, come parte del servizio fornito dal terzo al primo mondo: i corpi di
colore diventano (o continuano a essere) i luoghi per la costruzione del potere e del benessere
di nordamericani e europei (Kempadoo 2001: 50). È così che, conclude Kempadoo (2001:
40), i Caraibi emergono come un terreno di gioco per popoli e paesi più ricchi, dove le
relazioni sessuali fra locali e turisti occidentali, finiscono per rinforzare e perpetuare non solo
diseguaglianze globali di genere ma anche schemi duraturi di dominio e subordinazione fra il
Nord e il Sud del mondo.
La posizione di Kempadoo, meritevole di avere incluso nella concettualizzazione del turismo
sessuale femminile anche le implicazioni politiche intrinseche al fenomeno, è condivisa da
O’Connell Davidson (1998; 2001) il cui studio sul turismo sessuale, a Cuba e nella
Repubblica Dominicana, è considerato fra i più dettagliati degli anni Novanta. L’autrice, in
riferimento al concetto di turismo romantico, sostiene che le turiste si illudono di vivere
relazioni romantiche, ma che, in realtà, il loro, sia un ruolo di sfruttamento vero e proprio, non
dissimile da quello dei turisti uomini, e che questo ruolo sia imputabile ai privilegi economici,
politici, di razza e di classe, di cui godono i turisti occidentali. L’analisi di O’Connell
! 22!
Davidson dialoga con le posizioni delle femministe radicali, rifiutando la preminenza
accordata al concetto di patriarcato rispetto all’analisi del ruolo del turismo nell’economia
internazionale. Per l’autrice, è proprio il turismo sessuale femminile a costituirne la
dimostrazione: dal momento che il potere maschile nel turismo sessuale non è semplicemente
patriarcale, ma anche economico e razziale, anche le donne possono assumere le medesime
posizioni di potere e controllo degli uomini (nei termini di potere di classe e di razza). Queste
riflessioni sono state approfondite in diversi articoli da Sánchez Taylor (2000; 2001; 2006)
che ha evidenziato l’urgenza di un approccio teorico che tenga conto delle ineguaglianze di
classe e razza, e non solo di genere, per poter comprendere la diversità e la complessità degli
scambi economico-sessuali fra turiste e locali, spesso riduttivamente incasellati dal dibattito
teorico nelle definizioni di turismo sessuale maschile e turismo romantico femminile. Punto di
partenza dello studio dell’autrice, la cui ricerca si svolge in Giamaica, Repubblica
Dominicana e Cuba, e indaga il punto di vista di entrambe le controparti, è la tesi secondo cui
le relazioni economico-sessuali, che le turiste intrattengono con i “beach boys”, siano basate
sulle medesime diseguaglianze globali, economiche e sociali, che sorreggono il fenomeno del
turismo sessuale maschile (Sánchez Taylor 2006: 43-44). Il turismo sessuale, sostiene
Sánchez Taylor (2000: 42-43), offre ai turisti, donne e uomini, l’opportunità di affermare una
particolare identità di genere e razza. I turisti sessuali viaggiano nei paesi del Sud del mondo
non solo per approfittare di servizi sessuali economici, ma anche perché, in questi paesi,
percepiscono come i ruoli di genere e razza siano stati mantenuti nel “giusto” ordine, a
differenza dei loro paesi di origine dove si sentono minacciati e disorientati dalle
rivendicazioni politiche dei neri (e dagli stranieri in generale) e dalle domande di reciprocità e
uguaglianza, anche sessuale, provenienti da mogli e compagne (vedi anche O’Connell
Davidson 2001). Allo stesso modo il turismo sessuale femminile sembra riflettere la
preoccupazione di invertire e restaurare un ordine particolare all’interno del quale assicurare
la propria posizione e il proprio potere. Nello spazio liminale delle vacanze, lontano da casa,
le turiste possono consumare fantasie razziste dell’uomo di colore descritto come
“iperdotato”, “primitivo”, “naturale”, “atletico”, oggettivando gli uomini locali nello stesso
modo in cui le donne di colore sono oggettivate come “Altre” dai turisti sessuali (Sánchez
Taylor 2000: 47). Così, sostiene l’autrice, i corpi dei giovani del posto diventano merci che
permettono a donne occidentali benestanti di esperire forme alternative di potere e controllo.
Le turiste, che viaggiano in Giamaica o nella Repubblica Dominicana in cerca di
romanticismo o sesso, sfruttano gli uomini del caribe nel senso che, intenzionalmente o non
intenzionalmente, approfittano delle diseguali strutture di potere, locali e globali, in modo da
! 23!
ottenere la propria soddisfazione sessuale e per affermare o consolidare la loro posizione nelle
gerarchie di genere, razza e sessualità. Queste considerazioni portano Sánchez Taylor a
sostenere che la nozione de-sessualizzata di turismo romantico nasconde, in realtà, la
complessità delle relazioni fra benestanti donne occidentali e giovani uomini locali, perlopiù
disoccupati e senza istruzione. Ciò che viene celato nel concetto di turismo romantico è la
dimensione dello sfruttamento concepito, come per Kempadoo (2001), sulla base di
ineguaglianze di classe, razza e potere economico, mentre viene dato spazio a una nozione di
identità di genere essenzializzata che concepisce le turiste nei termini di innocenza e passività.
Il genere, afferma l’autrice (2001: 761), non è una categoria unitaria indifferenziata in base
alla classe o alla razza, e le relazioni di potere coinvolte negli incontri eterossesuali non sono
sempre identiche, anche se, i discorsi impliciti nella nozione di turismo romantico, li
dipingono come tali.
Se il modello teorico del turismo romantico non può rendere conto della complessità del
fenomeno, sostiene l’autrice, anche l’approccio teorico del femminismo radicale risulta
riduttivo, perché esclude il turismo sessuale femminile sulla base di un concetto di
sfruttamento e vittimizzazione fortemente di genere: turismo sessuale e prostituzione sono
considerati espressione del potere patriarcale maschile e della subordinazione femminile.
Questo approccio, evidenzia Sánchez Taylor (2006: 45), ha reso difficile analizzare i modi in
cui gli uomini possono essere sessualmente sfruttati dalle donne. Inoltre, la prospettiva teorica
del femminismo radicale, assimilando i termini di “sfruttamento sessuale” e “vittimizzazione
sessuale”, ha impedito di poter parlare di un individuo sessualmente sfruttato senza implicare
automaticamente che si tratti di una persona umiliata e sofferente. In accordo con Sánchez
Taylor (2006: 45), questa definizione è problematica non solo perché sottostima le
disuguaglianze politiche ed economiche nel mondo, ma anche perché implica che la vittima
sia un individuo passivo privo di agency e che le donne non possano essere agenti sessuali
esse stesse. Il concetto di sfruttamento sessuale, quindi, per l’autrice, non implica
necessariamente che lo sfruttatore usi violenza e nemmeno che lo sfruttato si percepisca come
una vittima (Sánchez Taylor 2006: 52). La critica che Sánchez Taylor muove al femminismo
radicale riguarda, in definitiva, il pericolo di incorrere nell’accettazione di modelli
essenzialisti di genere in riferimento alla sessualità e allo sfruttamento, all’interno dei quali il
comportamento sessuale delle donne è interpretato e giudicato in maniera differente rispetto a
quello degli uomini, semplicemente perché esse sono donne. In questo senso la prospettiva di
Sánchez Taylor è molto vicina a quella di Pruitt e LaFont (1995), nonostante questo aspetto
del loro studio sia stato messo in secondo piano rispetto alla nozione di turismo romantico da
! 24!
loro proposta. Anche le due autrici, infatti, nell’analizzare i risultati della loro ricerca in
Giamaica, sostengono come le relazioni fra turiste e “beach boys” dimostrino come dominio e
potere non siano statici, bensì variabili e situazionali, costantemente negoziati e contestati. E
come entrambe le nozioni, dunque, andrebbero sganciate dal sesso biologico (Pruitt e LaFont
1995: 437).
Le prospettive teoriche di Kempadoo, O’ Connell Davidson e Sánchez Taylor sono state
fortemente contestate da Jeffreys (2003), esponente del femminismo radicale. Affermare che
anche le donne partecipano al turismo sessuale, sostiene l’autrice, è problematico perché
oscura gli aspetti legati al dominio maschile e alla violenza. Inoltre, il termine “turismo
sessuale” richiama la sfera del divertimento e del tempo libero, sottostimando i danni che tale
attività può infliggere alla popolazione locale. Pertanto, sostiene Jeffreys (2003: 24), sarebbe
più opportuno impiegare la definizione di “turismo di prostituzione” per indicare gli uomini
che viaggiano con l’obiettivo di intraprendere sesso a pagamento, e quella di “turismo
sessuale” per descrivere donne e uomini che viaggiano aspettandosi di avere incontri sessuali
ma di natura non commerciale. Il cosiddetto turismo sessuale femminile, in definitiva, è,
secondo l’autrice, un fenomeno differente, che ha poco a che fare con la prostituzione.
L’analisi delle differenze fra turismo sessuale femminile e maschile mettono in evidenza
diversità sostanziali in termini di scala (quello femminile è un fenomeno numericamente più
piccolo rispetto a quello maschile e non esiste un’industria del sesso per clienti donne),
potere, effetti, conseguenze e significati, determinate dalle differenti posizioni che gli attori
sociali occupano all’interno della gerarchia dei sessi (Jeffreys 2003: 225). In particolare,
sostiene l’autrice, a differenza del turismo sessuale maschile − in cui le donne servono
sessualmente gli uomini anche con pratiche umilianti (come nel caso, per esempio, dei “No
Hands Bar” tailandesi, dove le ragazze scivolano sotto i tavoli per masturbare gli uomini
seduti) e sono esposte a possibili atti di violenza e dunque al pericolo per la propria
incolumità − i giovani uomini nel turismo sessuale femminile non sono soggetti alle
medesime pratiche sessuali umilianti né sono esposti allo stesso grado di pericolo. Essi, al
contrario, mantengono il controllo dell’interazione sessuale13, proprio come accadrebbe in
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13!A questo proposito de Albuquerque (2008: 56) riferisce di come i “beach boys” escludano dalle pratiche sessuali con le turiste occidentali alcune prestazioni: il cunnilingus, i baci che sono ridotti al minimo, così come ogni deviazione dalla posizione del missionario. Inoltre, Leonore Lyons e Michele Ford, nel loro saggio intitolato Lavoro del sesso e soggettività: storie dalle isole Riau (Indonesia) (in Vignato 2010: 111-129), hanno evidenziato come anche le prostitute possano controllare la natura dello scambio sessuale. Le autrici riferiscono di come alcune prostitute che operano nel mercato del sesso delle isole Riau, stabiliscano delle frontiere fra la vita lavorativa e quella familiare andando in cerca dei “buoni” clienti e rifiutando alcune pratiche sessuali come il sesso anale e di gruppo. La stabilità della frontiera fra i due ambiti, sostengono le autrici, viene minacciata quando i clienti chiedono l’instaurazione di relazioni di tipo “innamorata”, come spesso accade nel contesto delle isole Riau. Se da un lato queste relazioni attentano alla frontiera che separa il loro senso di sé dal loro lavoro,
! 25!
qualsiasi altra relazione sessuale con una donna, in virtù del loro privilegio maschile e della
costruzione della sessualità maschile dominante. Non vi è nemmeno traccia di danni
traumatici causati dalla reiterata violazione del proprio corpo, come accade per le donne che
devono dissociarsi per sopravvivere mentre i loro corpi sono usati come oggetti (Jeffreys
2003: 229). Al contrario, in accordo con Kempadoo (2001), Jeffreys (2003: 228-229) sostiene
che il modo in cui le relazioni fra turiste e “beach boys” hanno inizio, e continuano nel tempo,
siano in sintonia con la costruzione della sessualità maschile dominante (nei Caraibi): le
donne sono conquistate attraverso strategie di seduzione e corteggiamenti serrati, e il fatto di
avere incontri sessuali con numerose donne, addirittura bianche, è simbolo di mascolinità e
contribuisce, pertanto, ad aumentare lo status sociale nel gruppo dei pari. Se le donne
ottengono un rafforzamento della loro femminilità da queste esperienze, questa stessa
femminilità non dà alle donne un maggiore status sociale, come invece accade per gli uomini,
né tantomeno fra le turiste, che intrattengono relazioni sessuali con giovani locali, si creano
legami comunitari, come nel caso degli uomini, dove il turismo sessuale contribuisce a
cementare la loro supremazia maschile e a riprodurre legami sociali fra i membri maschi della
comunità “turistica” (Jeffreys 2003: 231; O’ Connel Davison 2001: 16). Infine, l’autrice
sostiene che, se le donne detengono potere nei confronti dei loro partner locali, si tratta
esclusivamente di un potere economico destinato a essere temporaneo, come dimostrano le
relazioni a lungo termine di donne che, dopo essersi trasferite nei Caraibi ed essere divenute
mogli di un uomo del posto, smettono di godere dei privilegi legati alla classe e alla razza e,
in alcuni casi, subiscono violenze e maltrattamenti (Jeffreys 2003: 230).
L’analisi di Jeffreys muove, dunque, da una prospettiva teorica che comprende il turismo
sessuale (o di prostituzione secondo la definizione dell’autrice) come un fenomeno di genere,
prima che di classe e di razza. Per analizzare il turismo sessuale maschile e femminile
l’autrice utilizza categorie analitiche fisse: il turismo sessuale femminile è indagato sulla base
di categorie impiegate per l’analisi del turismo sessuale maschile, senza valutare che le
categorie potrebbero essere espanse per comprendere nuovi e diversi aspetti di potere e di
controllo. Se si parte dall’assunto teorico secondo cui il genere non è dato, ma socialmente
costruito, allora sarebbe plausibile pensare che prerogative e caratteristiche attribuite alla
mascolinità e alla femminilità, potrebbero cambiare. La prospettiva teorica di Jeffreys che
pone l’accento sulle differenze, così come quella di Pruitt e LaFont, che individua la categoria
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!dall’altro, esse consentono di guadagnare di più ed evitare la parte “peggiore” del lavoro. Le due autrici ricorrono al concetto di “lavoro emotivo” per indicare una forma di lavoro che implica uno scambio sia sessuale sia emotivo, mostrando come, a dispetto del rischio, le donne vadano alla ricerca proprio di questa forma di lavoro emotivo perché rende possibile il tipo di relazione stabile che consente loro di abbandonare l’industria del sesso (Lyons e Ford in Vignato 2010: 127).!
! 26!
di turismo romantico per differenziare le motivazioni e i comportamenti delle turiste che
intraprendono relazioni sessuali con uomini locali, da quelli dei turisti sessuali, adottando
dunque il punto di vista degli attori sociali, rischiano di aderire agli stereotipi di genere
dominanti che concepiscono l’espressione della sessualità femminile solo nell’ambito di
relazioni affettive.
Le categorie di turismo romantico e turismo sessuale femminile elaborate rispettivamente da
Pruitt e LaFont (1995) e de Albuquerque (1998), rappresentano due idealtipi nel dibattito
scientifico che si sforza di classificare le relazioni sessuali fra turiste e “beach boys”.
L’osservazione attraverso categorie della realtà, per sua natura composita e complessa, rischia
di essere un tentativo riduttivo che finisce con l’oscurare le molteplici sfaccettature che
accompagnano queste interazioni.
1.4. Tentativi di superamento della dicotomia concettuale turismo sessuale - turismo
romantico
Lo studio di Cabezas, condotto a Cuba e nella Repubblica Dominicana, parte dalla
considerazione che molte ricerche si sono soffermate sulle relazioni fra “lavoratori freelance”,
o “beach boys”, e turiste occidentali nei contesti pubblici dei siti turistici, ignorando i
lavoratori impiegati nel settore turistico formale quali partecipanti del mercato del sesso.
Dall’analisi, dunque, delle relazioni fra impiegati degli hotel e ospiti, l’autrice asserisce la
necessità di una cornice teorica più complessa per rendere conto degli accordi fluidi che
hanno luogo fra host e guest.
Invece di operare in spazi socializzati e istituzionalizzati del sex work, come accade nel
Sudest asiatico o in Europa occidentale e negli Stati Uniti, dove sono diffuse forme di
contratto o di lavoro coatto, i nuovi percorsi del mercato sessuale, a Cuba e nella Repubblica
Dominicana, sono di tipo opportunistico, fluido e ambiguo (Cabezas 2004: 996-997).
L’economia sessuale opera all’interno di complessi turistici altamente sorvegliati o nelle
strade dove giovani uomini e donne approcciano gli stranieri. Le transazioni che hanno luogo
sono difficili da riconoscere e categorizzare come forme di lavoro; esse sfidano, sostiene
l’autrice (2004: 1003), le nostre nozioni di amore privo di interessi economici e di lavoro
privo di sessualità.
La maggior parte dei sex worker (uomini e donne) intervistati da Cabezas (20004: 999) a
proposito delle loro liaisons con turiste occidentali, rifiutano di parlare di soldi, preferendo
! 27!
dichiarare di avere ricevuto regali o aiuti per sé e la propria famiglia. Evitando di definire i
loro rapporti con le turiste occidentali in termini di scambio commerciale, essi possono creare
ed espandere possibilità molteplici per le loro relazioni, evitando di precludersi l’eventualità
di relazioni a lungo termine, che possano anche sfociare in un matrimonio o nella migrazione,
e di confermare un’identità di prostitute/i che non desiderano attribuire a se stessi (Cabezas
2004: 999). Questi rapporti mostrano come il turismo sessuale non abbia a che fare soltanto
con sesso e denaro, ma anche con altri tipi di possibilità: ogni relazione con i turisti, sessuale
o no, è percepita come un potenziale vantaggio dai locali e questo fatto definisce il turismo
sessuale come un’attività contingente e a finale aperto, i cui confini sono sfumati e intrecciati
con elementi di romance, tempo libero, consumo, viaggio all’estero e matrimonio.
Esperienze che raccontano di relazioni che durano nel tempo indicano come gli elementi
coinvolti in quello che viene definito turismo sessuale, possano essere fluidi, eterogenei e
ambigui e andare oltre la cornice concettuale totalizzante che definisce queste relazioni nei
termini oppositivi di vittime e oppressori o di mere transazioni commerciali: “Un’economia
dei sentimenti è al lavoro e problematizza assunzioni semplicistiche” (Cabezas 2004: 996).
In conclusione, Cabezas (2004: 1010) ritiene che i cubani e i dominicani sfidino e modellino
le loro condizioni di subordinazione all’interno dell’economia globale, erodendo e
confondendo i confini che dividono amore e denaro, sentimento e lavoro. Essi navigano negli
interstizi delle strutture di genere e razza imposte dall’industria transnazionale del turismo e
dallo Stato: questo offre loro la possibilità di scappare dalla povertà attraverso l’amore,
l’amicizia, la compagnia o il sesso con i turisti.
La ricerca di Herold, Garcia e Moya (2001), indagando le motivazioni alla base del
coinvolgimento delle turiste in rapporti con la popolazione maschile locale nella Repubblica
Dominicana, conferma l’impossibilità di definire in modo semplicistico tali relazioni come
turismo strettamente sessuale o, sul versante opposto, come turismo romantico, e rifiuta le
posizioni accademiche che definiscono il turismo sessuale esclusivamente nei termini dello
scambio pecuniario. Gli autori riferiscono come le motivazioni delle turiste varino in maniera
considerevole, concentrandosi talvolta sull’idillio, talaltra sul sesso; propongono quindi
quattro nuove categorie attraverso cui classificare le turiste che, rispetto a quelle elaborate da
de Albuquerque (1998), tengano conto anche delle loro aspettative antecedenti: le “turiste
romantiche debuttanti” che non hanno previsto in anticipo la possibilità di rimanere coinvolte
in un rapporto con un giovane uomo locale e che interpretano la loro relazione nei termini del
romanticismo; le “turiste sessuali debuttanti”, che avevano previsto il loro coinvolgimento e
che sono interessate soprattutto agli aspetti sessuali; le “reduci romantiche” sono coloro che
! 28!
ritornano perché sono desiderose di mantenere in vita il loro rapporto d’amore; le “turiste
sessuali impegnate” che ritornano con l’obbiettivo di massimizzare il piacere sessuale
perlopiù con un partner con il quale desiderano passare la maggior parte del tempo; infine, “le
turiste sessuali d’avventura” che prediligono esperienze sessuali occasionali con partner
diversi (Herold et al. 983-984). Dalla loro ricerca emergono anche casi di donne interessate
soltanto alla compagnia, senza che né l’amore né il sesso entrino in gioco; questo dato li porta
ad affermare la possibilità di introdurre un nuovo concetto, quello di turismo di “compagnia”
(Herold et al. 2001: 994). Un aspetto interessante introdotto da questo studio è la riflessione
sull’elemento etnico come variabile importante da tenere in considerazione quando si voglia
studiare la sessualità delle turiste. Le turiste canadesi, per esempio, sono risultate essere più
audaci e permissive delle altre donne nei loro rapporti con i “beach boys”; queste differenze
etniche, sostengono gli autori (Herold et al. 2001: 995), trovano riscontro in alcune ricerche
sulla sessualità in Canada. L’elemento etnico emerso nella ricerca di Herold, Garcia e Moya,
porta a riflettere sul rischio di trattare le turiste occidentali come un gruppo omogeneo e
indistinto, privando l’analisi della valutazione dei loro background socio-culturali. Se
certamente esistono differenze di genere fra uomini e donne, questo non esclude la possibilità
che esistano differenze anche nella sessualità di donne provenienti da paesi diversi, che si
aggiungono e influenzano le motivazioni personali e le attitudini caratteriali.
Frohlick ricorre al concetto di “scambi fluidi” per comprendere la fluidità e la corporeità delle
relazioni fra turiste, europee e nordamericane, e giovani uomini di una località sulla costa
caraibica del Costa Rica, Puerto Viejo. In questi scambi, riferisce la ricercatrice (2007: 139),
l’intimità gioca un ruolo importante: gli uomini locali, situati al di fuori della mascolinità
egemonica portoricana (basata sull’idea di uomo quale responsabile del mantenimento
economico della famiglia), offrono la propria intimità a titolo gratuito, o come merce di
scambio per ottenere vantaggi economici, acquisire status sociale e identità cosmopolite,
regolare la mobilità delle donne occidentali (che sono libere di andare e venire a loro
piacimento). Gli uomini “danno” gratuitamente se stessi e i loro fluidi corporei a donne
straniere ma, allo stesso tempo, negano l’intimità alle donne che desiderano un rapporto
esclusivo e non solamente sessuale. Frohlick osserva come gli uomini abbiano imparato a
riconoscere il valore economico e simbolico di particolari forme di intimità che le donne si
aspettano e richiedono loro (Frohlick 2007: 155). Gli uomini usano dunque questo potere per
influenzare la mobilità associata alle donne straniere e ottenere vantaggi materiali in modi
diversi come, per esempio, la diffusione di informazioni personali e intime delle turiste, o la
minaccia dell’infedeltà (Frohlick 2007: 160).
! 29!
Se molti studiosi hanno concettualizzato il fenomeno di donne occidentali che intraprendono
relazioni etno-sessuali con uomini locali nei termini di turismo sessuale o turismo romantico
− nozioni che implicano il privilegio di donne occidentali che agiscono in qualità di
consumatrici di sesso o romanticismo fornito da corpi mercificati di uomini con un colore
diverso della pelle − l’obiettivo di Frohlick è quello di contribuire a una comprensione più
sfumata di questo fenomeno in cui sessualità, desiderio di intimità e controllo sociale sono
negoziati dagli attori locali in modi complessi. Lo studio di Frohlick ha il merito di porre in
rilievo l’agency degli uomini locali, configurati nella sua analisi come soggetti attivi e non
soltanto come oggetti mercificati, mostrando i modi in cui l’intimità viene manipolata in
funzione di un esercizio di potere e controllo.
Nell’ottica di un superamento della dicotomia che oppone turismo sessuale e turismo
romantico, Weichselbaumer (2012) ricorre al concetto di “carnevalesco” per interpretare le
relazioni fra turiste occidentali e uomini locali a Trinidad e Tobago. Questo concetto, che
implica il rovesciamento delle gerarchie sociali, mantenendo la struttura binaria che separa
l’“alto” e il “basso”, ma anche la trasgressione dalla purezza delle gerarchie, con la
conseguente indistinzione fra i due opposti, è in grado di cogliere, sostiene l’autrice (2012:
1223), gli effetti trasgressivi ma anche conservativi presenti nelle relazioni fra occidentali,
bianche e benestanti, e uomini locali, neri e con un basso grado di scolarizzazione. Il
carnevalesco, con il suo rovesciamento dell’ordine convenzionale e la sua celebrazione della
sessualità, è rappresentato da queste relazioni in cui le divisioni di classe e razza sono
costantemente trasgredite e dove ciascuna delle controparti può rivendicare diverse forme di
potere sulla base di sessualità, genere, etnia, età o classe, indipendentemente dalla diversità
delle esperienze e delle motivazioni che spingono gli uni e gli altri a intessere relazioni fra
loro.
Un elemento importante, sollevato da Weichselbaumer, che, tuttavia, non ha ricevuto molta
attenzione all’interno del dibattito (si veda però anche Dahles e Bras 1999), è l’aspetto del
contesto “straordinario” delle vacanze in cui questi incontri hanno luogo. Il “carnevalesco”
coglie la dimensione liminale della vacanza che consente esperienze fuori dall’ordinario
(Weichselbaumer 2012: 1224). Ryan e Kinder (1996) riferiscono di come i turisti si ritrovino
in una condizione liminale, non solo perché le vacanze rappresentano una sospensione dal
lavoro e dalla vita quotidiana, ma anche perché offrono la possibilità di agire fuori dai copioni
ordinari della vita di tutti i giorni. I due autori mostrano, inoltre, come il coinvolgimento in
incontri sessuali a pagamento sia anch’essa un’attività liminale, in sintonia con le motivazioni
che stanno alla base del turismo. E dunque, la rapidità con cui vengono costruite le relazioni,
! 30!
l’intensità con cui vengono vissute, la propensione a mettere in atto comportamenti disinibiti
e a fidarsi di uomini appena conosciuti, sono tutti elementi che emergono nei racconti delle
turiste e che sono associabili alla dimensione liminale della vacanza (Weichselbaumer 2012:
1224). Così, quando le relazioni instaurate durante le vacanze non vengono mantenute nel
tempo, consentendo alle turiste di tornare all’ordine convenzionale al termine della vacanza,
si manifestano gli aspetti conservativi del “carnevalesco”: in questi casi, il coinvolgimento
con l’“Altro” non rompe la reiterazione e gli stereotipi di razza, genere e sessualità ma, al
contrario, ribadisce l’ordine di razza e classe, mostrando come il “carnevalesco” porti
simultaneamente con sé il potenziale sia per gli effetti trasgressivi sia per quelli conservatori
(Weichselbaumer 2012: 1228).
1.5. Riflessioni conclusive
Il dibattito sul turismo sessuale femminile sembra focalizzarsi su una questione: le donne
possono essere considerate in una posizione dominante in qualità di consumatrici di turismo
sessuale? Alcuni studi mostrano come le turiste che intraprendono relazioni sessuali con
uomini locali occupano la medesima posizione di sfruttatori delle loro controparti maschili
(de Albuquerque 1998; Kempadoo 2001; Sánchez Taylor 2001, 2006); altri sostengono che in
realtà le donne fanno qualcosa di diverso non ascrivibile allo sfruttamento, definito nei
termini di turismo romantico (Dahles e Bras 1999; Jeffreys 2003). Gli studi mostrano come le
analisi del turismo sessuale femminile siano centrate sulle interazioni fra turiste occidentali e
giovani uomini locali che hanno luogo nei contesti circoscritti dei siti turistici (la spiaggia, i
locali, i resort, le discoteche, le strade). I luoghi dove host e guest si incontrano, sono
considerati come unità di spazio distinte e isolate e lo sforzo analitico si concentra sulle
modalità dei loro scambi (economici? Affettivi?). Questa potrebbe essere una delle ragioni
alla base della comune tendenza a considerare gli attori sociali in termini essenzializzanti,
scorporando le soggettività dal contesto più vasto dei rapporti familiari e comunitari. I “beach
boys” non sono solo giovani che cercano di attrarre turiste occidentali, sono anche padri, figli,
mariti, membri di una comunità. Le loro soggettività non si definiscono esclusivamente in
rapporto ai turisti ma, al contrario, occupano posizioni molteplici. I “beach boys”, in
definitiva, non sono una categoria ma soggetti reali con un corpo e una storia. Questo implica
anche una de-contestualizzazione e una de-storicizzazione dei luoghi dell’interazione turistica
(ad eccezione di Cabezas 2004 e Meiu 2011). Allargare il campo al più vasto contesto sociale
! 31!
in cui gli attori sono inseriti, potrebbe aiutare a integrare l’analisi del turismo sessuale
femminile con le implicazioni che le relazioni fra turiste occidentali e giovani uomini locali
hanno sulle comunità di appartenenza, sui rapporti di genere fra uomini e donne del posto, e
su loro stessi. Bauer (2013: 25), per esempio, ha posto interrogativi sulle implicazioni che tali
relazioni possono avere anche sulla salute: ricorrere alla definizione di turismo sessuale
potrebbe contribuire a incrementare un falso senso di sicurezza e influenzare l’utilizzo dei
preservativi per proteggersi dal rischio di contrarre malattie veneree e infettive come l’HIV.
Uno studio molto interessante condotto da Meiu (2011) fra i “beach boys” di etnia Samburu a
Mombasa, ha evidenziato come dalla teorizzazione del turismo sessuale femminile (ma anche
maschile) sia stata esclusa la categoria analitica dell’incorporazione. In accordo con Meiu
(2011: 107), anche quando il corpo è presente nel dibattito, viene trattato semplicemente
come un oggetto del consumo o come un oggetto consumatore, mentre gli effetti incorporati
di queste relazioni e dei conseguenti processi di riconfigurazione delle identità di genere
messi in atto, non sono stati ancora esplorati.
!!!!!!!!!!!!!!!
! 32!
2. La costruzione del Kenya come luogo turistico
2.1. Il Kenya: bellezze naturali e immaginario occidentale
La costa keniota14 si estende per circa 450 km: dal confine nord con la Somalia al confine sud
con la Tanzania, offre un’incredibile varietà di habitat e bellezze naturali. Le spiagge di
finissima sabbia bianca sono lambite dalle tiepide acque dell’Oceano Indiano, ricche di fauna
e flora marina. Verso sud, quasi al confine con la Tanzania, si estende il Parco marino di
Wasini, un paradiso composto da piccoli atolli corallini, famoso per la facilità con cui è
possibile avvistare branchi di delfini. Verso nord si trova invece l’arcipelago di Lamu, spesso
definito dagli stessi kenioti un luogo magico. Antico insediamento swahili, Lamu è oggi
un’importante destinazione turistica soprattutto per viaggiatori zaino in spalla che qui possono
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!14!Le informazioni che seguono sono tratte dall’edizione italiana della guida turistica Lonely Planet a cura di Parkinson T., Phillips M. e Gourlay W., Kenya, Torino, EDT, 2006 e dalla mia esperienza diretta do alcuni dei luoghi menzionati.!
! 33!
camminare in labirinti di stradine percorse da abitanti, da turisti e da asini ma non certo dai
veicoli a motore, e ammirare bellissime spiagge e splendide moschee. Fra Wasini e Lamu si
trova la seconda città più grande del paese, Mombasa, con le antiche architetture della Old
Town, il grande porto − il principale del paese − le attività commerciali e industriali e le
spiagge di finissima sabbia bianca sia a nord − come Nyali, Bamburi e Shanzu − sia a sud,
nel più recente centro turistico di Diani Beach sorto in corrispondenza della cittadina di
Ukunda. A circa 120 km a nord di Mombasa si trovano i centri di Malindi e di Watamu, un
tempo florida città-stato swahili il primo e piccolo villaggio di pescatori il secondo, ed oggi
località turistiche celebri in tutto il mondo.
La barriera corallina si estende da sud quasi senza interruzioni sino a Malindi, seppure alcune
conformazioni di coralli si possano trovare anche nel mare di Lamu. I banchi di corallo
costituiscono un’importante attrazione turistica ma svolgono anche la preziosa funzione di
sbarramento delle onde oceaniche e, quindi, di protezione della flora marina e delle
mangrovie. Numerose foreste di mangrovie si trovano, infatti, lungo la costa, in particolare
nell’arcipelago di Lamu e a sud di Watamu dove costeggiano le sponde di strette insenature,
come il Mida Creek noto per la sua varietà di uccelli. Le mangrovie sono una risorsa di
estrema importanza sia perché costituiscono una fonte di legname per la costruzione di case e
imbarcazioni, sia perché svolgono la preziosa funzione di mantenere le acque libere
dall’inquinamento e dai residui fangosi trasportati dai fiumi, che rischierebbero di rovinare
irrimediabilmente i banchi di corallo e la vegetazione marina. I due maggiori fiumi kenioti
sfociano nell’Oceano Indiano: il fiume Tana e il Sabaki. Il primo è il più lungo e, dopo aver
percorso 850 km dal monte Kenya, sfocia presso Ungwana Bay formando il Tana Delta ricco
di numerosi laghi. Il fiume Sabaki ha origine nella regione montuosa che si sviluppa intorno a
Nairobi e prende il nome di Galana River nel suo ultimo tratto prima di incontrare l’oceano a
nord di Malindi. Questi fiumi e i laghi del Tana Delta costituiscono una fondamentale risorsa
sia per le coltivazioni, sia per l’allevamento e la pesca; a causa dei sedimenti trasportati dalle
loro acque, essi rappresentano anche una minaccia per gli habitat costieri (mangrovie,
vegetazione marina e coralli) e per la qualità estetica delle spiagge.
Subito a ridosso della costa si estendono anche vaste foreste; la più grande, la Arabuko-
Sokoke si estende fra Kilifi e Malindi e possiede un'enorme biodiversità di flora e fauna fra
cui specie animali rare; essa costituisce un luogo sacro per alcuni Mijikenda15 sebbene i
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15!Il termine Mijikenda deriva dalla parola nove e designa la popolazione Bantu, stimata in 1.2 milioni, che comprende nove sotto-gruppi: Wagiriama, Wadigo, Wachonyi, Wakauma, Wajibana, Waribe, Warabai, Waduruma e Wakambe. I Mijikenda si stanziarono originariamente in nove villaggi, denominati Kaya, collocati
! 34!
provvedimenti messi in atto per la protezione di queste aree abbiano proibito ai locali di
utilizzare alcune specie di alberi per i propri usi domestici (produzione di mobili e carbone) e
la raccolta di erbe a scopo curativo.
Questa regione, che prende il nome di Coast Province, è separata dal resto del paese da una
zona molto arida: il deserto del Taru che si estende per 150 km dalla costa verso l’interno e
comprende diversi distretti amministrativi: Kilifi, Kwale, Lamu, Malindi, Mondasa, Taita
Taveta e Tana River.
Oltre a svariate bellezze naturali, la regione costiera offre importanti monumenti e siti
archeologi: rovine di tombe, case e moschee che attestano un illustre passato. Ci sono quattro
siti di rovine di antiche città a Gede, Ungwana, Shanga e Omere e due parzialmente ancora
abitati a Pate e Siyu. Di questi, solo la città arabo-africana di Gede e il portoghese Fort Jesus a
Mombasa sono sotto la tutela del National Museums of Kenya.
La costa è stata per secoli al centro di intensi traffici commerciali che la resero a lungo la
parte più economicamente sviluppata dell’attuale Kenya. I centri costieri connettevano
l’immediato entroterra a numerose destinazioni oltremare. I dhow 16 percorrevano tratte
oceaniche fino a raggiungere il Medioriente e l’attuale India (Foeken at al. 2000: 5). Per
secoli mercanti, mercenari, colonizzatori e conquistatori si sono avvicendati nel commercio di
beni di valore come l’avorio e l’ebano ma anche di schiavi, animali esotici, spezie e frutti
tropicali (Kasfir 2004: 320). Ogni ondata di migranti, conquistatori e cercatori di fortuna –
Shirazi, Omani, Hadhrami, Portoghesi e inglesi – ha diffuso in queste zone le proprie
tradizioni e la propria eredità socio-culturale, dando forma a quella che poi è stata identificata
come “Costa Swahili” (Kasfir 2004: 320).
Curiosamente, le campagne pubblicitarie delle catene alberghiere e dei tour operator puntano
non sull’interesse dei turisti per i siti archeologici e la cultura swahili ma sul più spendibile
incanto delle calde acque dell’Oceano Indiano, della barriera corallina e delle spiagge di
sabbia bianca orlate da palme (Kasfir 2004: 322).
Sin dalle fasi iniziali del boom turistico che andò sviluppandosi lungo la costa dell’Africa
occidentale, a partire dagli anni Settanta, compagnie aeree come Lufthansa iniziarono a
vendere pacchetti all inclusive per Mombasa comprensivi di volo e soggiorno in resort, simili
a quelli venduti negli Stati Uniti per i resort dei Caraibi, dove i turisti finiscono per spendere
un tempo molto ridotto al di fuori dell’hotel e della rispettiva spiaggia, e difficilmente
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!sulla cima delle colline lungo il dorsale che si trova dietro la piana costiera. Ciascun Kaya definì nel corso del tempo un gruppo distinto. 16!I dhow sono tradizionali imbarcazioni arabe dotate di un’unica vela triangolare.!
! 35!
incontrano la cultura locale al di fuori delle uscite opzionali per ristoranti e negozi di souvenir
del luogo (Kasfir 2004; p. 322).
L’enfasi è dunque posta sul paesaggio esaltato per i suoi aspetti esotici e incontaminati. Il
disinteresse verso la dimensione storica rappresentata dai siti archeologici può essere
compresa nei termini di un confronto che, fin dall’era coloniale, ha visto contrapporsi la
società civilizzata occidentale e la barbarie e l’arretratezza dei popoli colonizzati. Attraverso
il confronto con l’altro − esotizzato e primitivo − l’europeo può confermare i propri traguardi
secondo il modello coloniale dell’immaginario dell’altro-africano (Wels 2002: 64). Gli
europei vogliono vedere l’Africa e gli africani nello stesso modo in cui li hanno immaginati,
basandosi sulla costruzione della rappresentazione dell’altro di matrice coloniale. “Il viaggio
turistico è sovente una sorta di volo nostalgico lontano dalle implicazioni della vita moderna”
(Aime 2005: 127), una sorta di fuga, quindi, da una realtà considerata meno autentica verso
una realtà che rappresenta ciò che si era prima dell’avvento del capitalismo industriale.
Queste considerazioni si basano sul presupposto che alcune società siano rimaste congelate in
un tempo lontano, in contrapposizione quindi alla modernità occidentale. D’altro canto il
turista, spiega Aime:
è affamato di emozioni; e le emozioni non si nutrono di elementi razionali e
oggettivi, ma si muovono sul piano intimo e personale, nascono dallo stupore di
fronte alla stranezza del mondo. Perché possa sbocciare nelle nostre menti, questa
stranezza deve affondare le radici nel diverso, nell’altro da noi. Non a caso,
pubblicità e dépliant turistici spesso ritraggono i nativi come se avessero tradizioni
statiche, in opposizione con le capacità di sviluppo dell’Occidente (Aime 2005, p.
128).
In aggiunta, più il contrasto è enfatizzato, più sembra confermare la superiorità dell’Europa
(Wels 2002, p.58). L’idea dell’Africa in Europa si basa sulla nozione occidentale di estetica
romantica che affonda le sue radici nel Romanticismo (Wels 2002: 55). Secondo Wels
l’immaginario europeo del paesaggio africano è spesso espresso nei termini di un “paradiso
perduto” (Wels 2002: 56), dove vivono animali selvaggi e nobili guerrieri; nel caso del Kenya
i Masai a sud e i Samburu, i Turkana e i Pokot a nord. In questo modo l’Africa è concepita
come un luogo che offre la possibilità di scoprire ed esperire una natura selvaggia e indomita,
distante dal paesaggio addomesticato e industrializzato dell’Europa. “L’uso del termine
‘Eden’ per definire i paesaggi africani da una prospettiva europea è probabilmente una delle
metafore più forti per descrivere le norme di una perfetta estetica naturale” (Wels 2002: 56). È
! 36!
a questo immaginario17 che i tour operator fanno riferimento nelle loro brochure per spingere i
turisti a visitare le destinazioni proposte. Il potere dell’immaginario europeo deve essere preso
in considerazione se si vogliono comprendere le dinamiche che informano l’incontro o, come
direbbe Aime, l’“incontro mancato” con l’Altro. Il turista è attratto dalla diversità cosicché è
la differenza a essere costantemente sottolineata; ma il turista è allo stesso modo respinto dal
timore generato dalla diversità dell’altro, tanto che tale diversità deve essere gestita nel
contesto protetto offerto dai viaggi organizzati. Il governo keniota stesso, mediante il Kenya
Touristic Development Corporation (KTDC) – organo semi-governativo istituito nel 1965 e
deputato alla messa in atto delle politiche di sviluppo turistico – porta avanti una
considerevole campagna di marketing turistico. Il KTDC possiede nove uffici turistici al di
fuori dei confini nazionali, principalmente nelle capitali di Stati Uniti, Europa e Estremo
Oriente, che promuovono l’immagine della nazione come ideale meta turistica utilizzando
slogan quali “The Land Out Africa”, coniato dal famoso e pluripremiato film hollywoodiano
Out of Africa (1985) con Meryl Streep e Robert Redford, e quello di taglio più nazionalistico
“Kenya all of Africa in one country” (Dieke 1991: 272).
Accanto all’immagine desiderabile dell’Africa come paradiso perduto, si affianca quella più
temibile di terra di promiscuità e violenza tribale, luogo di arretratezza contrapposto alla
modernità occidentale. La figura dell’esploratore o del cacciatore che si addentra senza paura
in un territorio selvaggio ancora inesplorato, esercita tutt’oggi un grande fascino. Intrapresi
inizialmente con le grandi battute di caccia da Teddy Roosevelt nelle prime due decadi del
XX secolo, i safari di caccia per ricchi clienti si sono gradualmente trasformati nei pacchetti
“camera safari” all inclusive che offrono diverse sistemazioni: dai più spartani campi tendati,
ai lodge stellati dotati di tutti i comfort fino alle sistemazioni di lusso gestite da rinomate
compagnie internazionali come Abercrombie and Kent (Kasfir 2004: 322). Significative le
parole che Roosevelt ha usato per descrivere i safari di caccia: “There are no words that can
tell the hidden spirit of the wilderness that can reveal its mistery, its melancholy and its
charm. There is delight in the hardy life of the open, in the fight with rifle in hand, in the thrill
of the fight with dangerous game”18.
Se da un lato il turista vuole vivere l’esperienza dei primi esploratori che si avventuravano
con temerarietà nel continente africano, dall’altro questa esperienza deve essere edulcorata dei
suoi elementi più pericolosi e perturbanti. I pacchetti vacanze sono organizzati in modo tale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17 Barberani definisce immaginario turistico l’insieme di immagini, figure e simboli veicolate da mass media, pubblicità e letteratura di viaggio, le quali agiscono direttamente sulle motivazioni turistiche condizionando le modalità di interazione tra hosts e guests (2006: 213). 18!Roosvelt T., African Game Trails: An Account of the African Wanderings of an American Hunter-Naturalist, London, Syndacate, 1909; citato in Dieke 1991, p. 274!
! 37!
che i turisti vengano trasportati con mezzi privati nei loro resort subito dopo essere scesi
dall’aereo. Una volta arrivati nei resort vivono la propria vacanza in un ambiente protetto e
costruito ad hoc per soddisfare i loro bisogni; qui anche le escursioni sono gestite in modo da
risparmiare agli ospiti seccature, imprevisti, attese, code. Tutto, insomma, è concepito per
proteggere i turisti “dall’esperienza del lato più oscuro dell’Africa, la povertà, la fame, la
brutalità, la malattia, lo sporco, la corruzione, le guerre civili” (Bruner 2001: 901). Gli aspetti
che potrebbero turbare gli animi dei turisti sono, dunque, metodicamente lasciati fuori dal
quadro, sebbene questo non sia sempre possibile.
2. 2. Breve analisi dello sviluppo turistico in Kenya
Il turismo riveste in Kenya un’importanza fondamentale. Esso costituisce un aspetto primario
dell’economia del paese, in particolare per quel che concerne le entrate del governo e i
proventi in valuta estera. Nel 2005 il settore ha contribuito per il 12 % al prodotto interno
lordo (Kibicho 2005); ha dato occupazione nel settore del lavoro formale e informale a circa
560.000 persone (State of the Coast Report 2009). La rilevanza del turismo in Kenya è
cresciuta in concomitanza all’aumento esponenziale dei turisti internazionali che da 65.000
nel 1963, sono passati a 340.000 nel 1972 e a 800.000 nel 1992 (Sindiga 1994: 46), fino a
1,78 milioni nel 2012 (Daily Nation, 31 agosto 2013). Sebbene il 2012 abbia visto una
diminuzione dei turisti da Francia, Olanda e Austria, è stata registrata una crescita dei
visitatori provenienti da Cina, India e Emirati Arabi (Kenya Tourism Report 2012). Il nuovo
flusso turistico proveniente da Oriente potrebbe aprire una fase di cambiamento le cui
implicazioni sono ancora da valutare.
Prima degli anni Sessanta, il turismo in Kenya era costituito da un esiguo numero di
viaggiatori facoltosi, principalmente europei e americani, che avevano a disposizione tempo e
risorse per viaggi di piacere (Irandu 2004: 135). In generale il turismo in Kenya, sia quello dei
safari sia quello balneare, era focalizzato sui bisogni dei coloni bianchi e di occasionali
avventurieri europei (Dieke 1991: 274). In origine la maggiore attrattiva era costituita dai
parchi e dalle riserve che sorsero numerosi fra gli anni Quaranta e Sessanta andando a coprire
oggi l’8% di tutta la superficie del paese. Ai primi turisti che li visitarono negli anni
Cinquanta e Sessanta, i parchi offrivano un luogo dove poter cacciare, pescare, collezionare
trofei e in generale osservare la fauna selvatica (Irandu 2004: 135). Qui i visitatori potevano
abbattere animali per la carne, le pelli e l’avorio, oppure catturare esemplari da vendere
! 38!
all’estero. Il governo, sempre più preoccupato del futuro del turismo e della minaccia al
patrimonio naturalistico rappresentato dalla caccia di sussistenza e di frodo, vietò
l’abbattimento degli animali selvatici. Il governo iniziò dunque a promuovere gli aspetti del
paese legati alla ricchezza della flora e della fauna, all’unicità dei suoi ecosistemi e alla
bellezza dei suoi paesaggi che includono, oltre alla savana, le montagne vulcaniche e le
splendide spiagge (Irandu 2004, Sindiga 1999).
Il turismo costiero, invece, fu in origine un turismo di tipo domestico. Esso nacque in maniera
spontanea senza che esistessero sistemazioni dove poter alloggiare i turisti. Durante gli anni
Venti e Trenta alcuni residenti europei, principalmente contadini delle “White Highlands”,
presero a frequentare la costa come meta delle loro vacanze apprezzandone il clima mite e le
spiagge di sabbia (Sindiga 2000: 226). Inizialmente, questi turisti domestici scelsero
Mombasa come meta principale delle loro vacanze, per poi spostarsi, nel tempo, verso nord, a
Malindi. Nel dopoguerra Malindi divenne il posto prescelto da molti europei dell’interno dove
ritirarsi al termine della propria attività lavorativa, per via delle migliori condizioni climatiche
e del costo delle abitazioni relativamente economico, e continuò a essere una destinazione
vacanziera per i residenti europei in Kenya fino all’Indipendenza. Il turismo internazionale
sulla costa, composto principalmente da turisti europei, ebbe inizio soltanto dopo il 1962,
quando furono introdotti i primi voli charter e quindi i primi pacchetti vacanze tutto-compreso
(Sindiga 2000: 227). L’aeroporto di Mombasa venne ricostruito fra il 1976 e il 1978 per
accogliere voli diretti provenienti dall’Europa. Fu realizzato anche il piccolo aeroporto di
Malindi in grado di accogliere velivoli di medie dimensioni.
La combinazione dei due aeroporti permise a molti turisti di volare direttamente sulla costa,
incrementando il flusso turistico in questa zona fino a trasformare il Kenya in una rinomata
destinazione del turismo di massa. Inoltre in Kenya, a differenza di alcuni paesi rivali come la
Tanzania e l’Uganda, ma anche i Caraibi e l’Asia, le spiagge sono molto vicine ai parchi
nazionali consentendo così ai turisti di abbinare un safari al soggiorno balneare (Dieke 1991:
275).
Come in altre parti del paese, anche sulla costa l’espansione del turismo non ha seguito una
pianificazione razionale. Investitori privati presero l’iniziativa e costruirono strutture ricettive
laddove era possibile, mentre il governo intervenne solo in un secondo momento, a giochi
fatti, per ampliare e rinforzare le infrastrutture esistenti – strade, forniture di acqua ed
elettricità – nella stretta fascia costiera costellata da alberghi e lontane dai centri abitati dalla
popolazione locale, contribuendo a rafforzare la già forte differenza materiale fra locali e
! 39!
turisti (Sindiga 2000). Dieke (1991), citando il temine coniato da Gareth Richards19, parla di
unplanned ribbon development, per descrivere lo sviluppo disordinato degli alberghi sulla
costa e l’inadeguata fornitura di sistemazioni per la popolazione residente.
Le entrate del governo provenienti dal turismo includono imposte sui consumi e dazi
doganali, tasse aeroportuali, quote di ammissione ai parchi e alle riserve nazionali, imposte
versate dai lodge e dai campi tendati per l’occupazione del suolo nei parchi. La nazione perde
tuttavia una grande quantità di denaro nei mancanti introiti del traffico aereo operato da
compagnie straniere e delle attività gestite dai tour operator internazionali. Il modello di
vacanza prevalente è quello del pacchetto all inclusive, solitamente organizzato direttamente
dai paesi di provenienza, che lascia poco margine di gestione e possibilità di guadagno agli
operatori turistici locali. Spesso i tour operator stranieri ottengono dagli alberghi prenotazioni
di camere in blocco con forti riduzioni sui prezzi grazie al loro potere contrattuale, talvolta
fino al 50% in meno rispetto ai prezzi normali. Essi, inoltre, preferiscono negoziare i prezzi in
scellini kenioti in modo da trarre vantaggio sui frequenti deprezzamenti della moneta
nazionale (Sindiga 1994: 49).
I mancati introiti di valuta straniera sono particolarmente alti nel caso del turismo costiero.
Secondo Sindiga (2000) una stima di questa perdita ammonta tra il 62% e il 68% per i turisti
che optano per una vacanza “sole e mare” e che viaggiano con compagnie straniere, e tra il
12% e il 23% per quelli che viaggiano con la Kenyan airlines.
È bene dunque notare come il turismo internazionale sia controllato da imprenditori stranieri
– principalmente europei – e come le ricadute sulla popolazione locale, in termini di benefici
e vantaggi, come la creazione di posti di lavoro in loco e di sviluppo in generale, siano
minime (Sindiga 1991; Irandu 2004). La maggior parte degli alberghi e dei tour operator sono
nelle mani di imprenditori stranieri, così come le posizioni professionali di tipo manageriale
all’interno dell’industria turistica: in particolare di tedeschi, svizzeri, italiani e inglesi, che
hanno contribuito a incrementare la popolarità del Kenya come destinazione turistica ideale
fra i loro connazionali e ad alimentare una tipologia di turismo definibile di massa.
L’immagine di Mombasa, e delle altre destinazioni turistiche della costa, che appare in
televisione, sui siti internet e nelle brochure turistiche, è solitamente costruita e presentata da
gruppi esterni che non necessariamente rappresentano gli interessi economici e i valori
culturali della popolazione locale (Akama e Kieti 20009: 745). Come conseguenza, le
immagini e i messaggi utilizzati dalle compagnie multinazionali che promuovono pacchetti
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19!Richards G., “Planning for the Future Development of the Tourist Sector in Kenya”, in Pinfold T. e Norcliffe G (a cura di), Development Planning in Kenya: Essays on the Planning Process and Policy Issues, Geographical Monographs 9, 1980, pp. 141-156.!
! 40!
turistici, riflettono i valori culturali e i sistemi economici occidentali, e le relazioni storiche ed
economiche che esistono fra paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo sin dall’epoca
coloniale (Akama e Kieti 20009: 745).
In accordo con Sindiga (2000: 229), nel settore dell’economia turistica a partire dagli anni
Settanta, hanno avuto crescente rilievo joint venture (aziende compartecipate) o alleanze
nelle quali erano coinvolti capitali internazionali, multinazionali, aziende straniere e capitale
pubblico e privato. La maggior parte delle grandi imprese del settore turistico sono joint
venture con la partecipazione di capitali locali generalmente stanziati dalla Kenya Tourist
Development Corporation (KTDC) (Sindiga 1994, p. 46). Le modalità di gestione sono
specificate in contratti che riguardano gli aspetti finanziari delle concessioni governative, del
livello di concorrenza e degli oneri dovuti agli investitori per servizi tecnici e gestionali. Le
compagnie straniere solitamente spingono per ottenere il massimo ritorno possibile e
insistono sul delocalizzare lo staff tecnico e manageriale. Una joint venture fornisce accesso
alle conoscenze, alle professionalità e ai canali di distribuzione consentendo un maggiore giro
d’affari e un più alto rendimento (Sindiga 2000: 229).
Ci sono poi altri casi in cui il franchising è la modalità prescelta. In questo caso, un’azienda
locale si associa a una straniera utilizzando il suo marchio. La produzione, il know-how, il
marketing e i controlli di qualità sono garantiti attraverso un controllo periodico e o dalla
presenza di un rappresentante che risiede in loco. Ad ogni modo, la responsabilità e i rischi
che accompagnano l’attività ricadono sulla compagnia locale (Sindiga 2000: 229).
Secondo Sindiga (2000: 229), gli accordi di joint venture assicurano che gli investitori esteri
gestiscano l’attività e controllino le transazioni finanziarie nel loro interesse, piuttosto che in
quello del Kenya. La joint venture, come modalità di impresa, ha fornito alle multinazionali
una sicurezza contro il rischio politico di nazionalizzazione. Per assicurarsi alti profitti le
multinazionali firmano contratti di gestione che garantiscono pieno controllo dell’impresa,
anche finanziario. In questo modo si assicurano che il capitale investito generi profitti nelle
nazioni di origine. In Kenya, in generale, c’è una piccola partecipazione locale nella proprietà
e nella gestione dei grandi alberghi e nelle attività di tour operator: esse sono limitate alle
guest house e ai piccoli alberghi. Nell’intermediazione turistica i kenioti possiedono piccole
aziende che stipulano contratti di subfornitura con i grandi tour operator per piccoli compensi.
Molte delle attività tendono a essere integrate verticalmente. Questo significa che, per
esempio, un tour operator possiede al tempo stesso una compagnia aerea e una catena di hotel.
In Kenya molti tour operator internazionali hanno agenzie locali che si occupano delle
! 41!
operazioni di terra mentre l’ospitalità e il viaggio sono gestiti da velivoli e da alberghi di loro
proprietà (Sindiga 2000: 229).
Il turismo in Kenya si caratterizza per un alto grado di stagionalità dovuto alle condizioni
climatiche del paese, che prevedono una stagione secca da dicembre a marzo, una stagione
delle piogge da aprile a giugno e una stagione delle brevi piogge da luglio a novembre che
corrisponde al boom delle vacanze che hanno per oggetto i safari. La stagionalità riflette
anche le abitudini dei turisti internazionali, che tendono a viaggiare principalmente durante i
cosiddetti periodi di vacanza: l’estate, il Natale e la Pasqua (Dieke 1991: 279). La stagionalità
ha come conseguenza la frequente chiusura di molti alberghi durante la stagione delle piogge
da maggio a giugno: molti impiegati perdono il lavoro alla fine del periodo di alta stagione
quando la presenza dei turisti è al suo apice. Inoltre il mercato del lavoro, con le sue
fluttuazioni stagionali, non riesce ad assorbire la domanda di lavoro di una popolazione in
costante crescita. Molti, fra coloro che non riescono ad ottenere un lavoro fisso, entrano nel
settore del lavoro informale come venditori di manufatti artigianali, guide della città,
procacciatori di safari, massaggiatori, venditori ambulanti, baristi ecc. (Kibicho 2005). Il
turismo costituisce, infatti, un importante bacino anche per il settore dell’impiego informale
che sfrutta nicchie occupazionali lasciate libere dall’economia formale.
In termini di opportunità di impiego, Sindiga mette in evidenza come nel 1994, il turismo
rappresentasse l’8.8% del moderno settore del lavoro dipendente nel paese, riportando un
aumento minimo rispetto al 8.3% registrato nel 1988. Se confrontato alla forza lavoro
complessiva dell’intero paese, l’impiego nel settore turistico nel 1994 costituiva soltanto
il’1.36%: un dato piuttosto marginale (Sindiga 1994: 48). Un secondo aspetto che influisce
sulle possibilità di impiego è costituito dal fatto che l’industria turistica è geograficamente
concentrata a Nairobi, in alcuni parchi e riserve nazionali e sulla costa; questa concentrazione
influisce anche sulle possibilità di impiego che rimangono localizzate in precise e ristrette
aree geografiche. Questo implica che, anche qualora esistessero impieghi disponibili, intere
regioni del paese non beneficerebbero di eventuali possibilità di impiego nell’industria
turistica (Sindiga 1994: 51). Come già accennato, le posizioni manageriali sono spesso
occupate da stranieri, mentre i locali svolgono mansioni più umili in posizioni subordinate,
percependo salari molto bassi (Sindiga 1996: 698). La maggior parte degli impieghi creati dal
turismo, infatti, si trova nel settore della ricezione alberghiera che offre occupazioni
nell’ambito del servizio di sala, delle pulizie, della manutenzione della struttura,
dell’accoglienza e della preparazione dei pasti. In parte le ragioni sono dovute a una carenza
di competenze e specializzazioni da parte del personale locale (Sindiga 1994: 51).
! 42!
Storicamente, in Kenya l’unica istituzione incaricata della formazione di operatori
dell’industria turistica è il Kenya Utalii College, istituito nel 1973 con l’intento di formare
manodopera adatta a lavorare nel settore turistico e di “fornire informazioni e conoscenza sia
per i residenti sia per i turisti […] in modo da costruire un ponte che riduca la grande lacuna
rispetto ai reciproci background sociali e culturali […] e promuovere una maggiore
comprensione gli uni degli altri così da ridurre la frizione sociale”20. Il KUC offre corsi che
includono hotel management, guide turistiche, operazioni di viaggio, cucina ma anche
seminari e corsi di aggiornamento per chi lavora già in ambito turistico ma con un target che
si rivolge alle grandi catene alberghiere e che ignora le strutture ricettive di piccoli e medie
dimensioni che invece poterebbero rappresentare una grande promessa per l’espansione del
mercato del lavoro (Sindiga 1994: 50). Questi corsi, mette in evidenza Sindiga, rivestono una
certa importanza ma il loro impatto è piuttosto limitato dal momento che molti lavoratori non
hanno budget sufficiente per coprire costi di formazione e inoltre, molte imprese preferiscono
assumere personale non qualificato e sotto pagato piuttosto che investire nella formazione
(Sindiga 1996: 700). Per incontrare la crescente domanda di manodopera in seguito alla
vertiginosa crescita del settore turistico, nacquero, nei primi anni Novanta, nuovi corsi di
diploma di medio livello sia pubblici sia privati (Sindiga 1994, 1996) e fu istituito presso la
Moi University il B.Sc. Program destinato a formare personale altamente qualificato, in grado
di svolgere mansioni di carattere gestionale che potesse competere con il personale straniero.
2. 3. “Hakuna matata”: un paradiso turistico senza preoccupazioni
Una volta che una vacanza in Kenya ha inizio, non è difficile avere l’occasione di sentire la
canzone Jambo Bwana: durante una gita in barca, una serata in albergo o ancora durante un
safari. Questa canzone, scritta a metà degli anni Ottanta dal gruppo musicale dei Them
Mushrooms e cantata per la prima volta in un hotel di Mombasa, è diventata in breve tempo
un greatest hit, una sorta di “inno nazionale turistico”, ancora conosciuto e cantato in tutto il
Kenya (Bruner 2001).
La canzone Jambo Bwana è una sorta di benvenuto rivolto ai turisti che visitano il Kenya.
Centrale nella canzone è la frase “Hakuna Matata” che in swahili significa nessun problema,
nessuna preoccupazione. La frase stessa ha una sua storia: negli anni Settanta, in seguito a un
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!20!Migot-Adholla S. E., Mkang K. G. C e Mbindyo J., Study on Tourism in Kenya with Emphasis on the Attitudes of Residents of Kenya Coast, IDS Consultancy report 7, Nairobi, University of Nairobi, 1982, p. 17 (trad. mia) ; citato in Dieke 1991, p. 282!
! 43!
tumulto politico in Uganda e negli stati confinanti del Kenya, le parole swahili Hakuna
Matata furono utilizzate come slogan politico per dire che il Kenya era salvo e per rassicurare
i rifugiati come i cittadini kenioti. Soltanto dopo essere entrata a pieno titolo nella canzone dei
Them Mushrooms, questa espressione è stata associata sempre più al turismo (Bruner 2001),
anzi, si potrebbe ben dire che sia diventata una sorta di colonna sonora delle vacanze dei
turisti internazionali che, una volta tornati a casa, potranno anche riferire ad amici e parenti
qualche parola in swahili. Ma le parole della canzone Hakuna Matata non sono prerogativa
dei turisti: anche i locali si appropriano di questa espressione seppur con finalità differenti.
Non è difficile, infatti, essere approcciati e accolti dagli host con le espressioni rassicuranti di
Hakuna matata e “Please feel at home”. Non si tratta solo di una forma di cortesia ma di un
approccio che rivela l’adesione alla promozione propria del governo di un’immagine del
paese come di un luogo in grado di offrire relax e divertimento, lontano da qualsiasi problema
e in totale sicurezza.
L’importanza del turismo per il paese sul piano economico – rappresentato da un introito che
si attesta intorno ai 96-98 miliardi di scellini kenioti nel biennio 2011- 2012 (Daily Nation, 31
agosto 2013) – ma anche su quello del prestigio internazionale, fa sì che la preoccupazione
circa il benessere di questo settore sia una costante per il governo e per gli organi di stampa
attraverso i quali si esprime. Tuttavia, l’instabilità politica del Kenya ha rappresentato fin
dagli anni Settanta un serio problema per lo sviluppo del settore turistico. A metà degli anni
Settanta e all’inizio degli anni Ottanta la crescente tensione con la confinante Tanzania – che
portò alla chiusura del confine fra i due paesi nel 1977 – e i conflitti armati con la vicina
Uganda, causarono una drastica riduzione del flusso turistico negli anni compresi fra il 1977 e
il 1982.
Nel 1997 si è registrata una significativa battuta d’arresto nella crescita del numero degli
arrivi internazionali: nel giro di pochi mesi numerosi alberghi della costa furono costretti a
chiudere a causa delle numerosissime cancellazioni di pacchetti vacanze che seguirono i
sanguinosi scontri avvenuti a Likoni, un quartiere a sud di Mombasa. Successivamente nel
2002 l’attacco suicida di matrice islamica in un albergo frequentato da turisti israeliani a
Mombasa ha fortemente incrinato l’immagine del Kenya come destinazione turistica idilliaca
promossa dal paese. A questi eventi si aggiunge l’intervento militare keniota in Somalia,
avviato nel 2011 con l’intento di reprimere l’attività di Al-Shabaab, gruppo estremista
islamico, e di ridurre la pirateria nelle acque dell’Oceano Indiano al confine fra Kenya e
Somalia per favorire il transito e l’approdo al porto di Mombasa delle navi da crociera. Queste
azioni militari, finalizzate al contenimento dell’instabilità somala e, quindi, alla protezione
! 44!
dell’industria turistica e marittima nel paese, sono state accompagnate dal timore di eventuali
ripercussioni e vendette di Al-Shabaab, anche alla luce del fatto che l’intervento keniota in
Somalia era stato inizialmente condotto senza l’approvazione della comunità internazionale
(The Daily Maverick, 27 settembre 2013).
Più recentemente, l’attacco terroristico del 21 settembre 2013 nel centro commerciale di
Westagate, a Nairobi, in cui sono rimaste uccise sessantotto persone e ferite quasi duecento
fra connazionali e stranieri, ha profondamente minacciato la percezione del Kenya come
destinazione turistica sicura, determinando un calo immediato del flusso turistico a dispetto
delle rassicurazioni profuse dai rappresentanti del governo. Qualche mese prima il governo,
preoccupato per la stagione turistica che si stava avviando verso il suo picco, e a tutela
dell’immagine del paese come paradiso tropicale di relax e divertimento, prometteva
l’intensificarsi dei controlli di polizia in tutto il paese per garantire la sicurezza dei locali e dei
turisti. In un articolo dal titolo significativo “You are safe, Lenku assure tourists”, il ministro
degli interni Joseph ole Lenku, garantiva che il governo avrebbe intensificato la forze di
polizia nelle località turistiche di tutto il paese per assicurare ai turisti vacanze in tutta
sicurezza (Daily Nation, 29 giugno 2013). Durante il simposio annuale che vede riunirsi
presso il Sarova Beach Resort di Mombasa albergatori, tour operator e agenzie di viaggi di
tutto il paese, Lenku ha dichiarato: “Colgo questa opportunità per assicurare ai turisti che
stanno arrivando numerosi per l’alta stagione, che il paese è molto sicuro per le vacanze […] I
tour operator e le agenzie di viaggio di tutto il mondo dovrebbero quindi consentire ai loro
clienti di visitare il Kenya per i safari e le vacanze al mare sulla costa (Daily Nation, 29
giugno 2013).
Nel 2012, la diminuzione del numero dei voli charter che volano direttamente su Mombasa –
anche a causa dei problemi relativi alla sicurezza –, ha portato a una riduzione del 20% del
numero degli arrivi (Daily Nation, 31 agosto 2013). Articoli allarmanti sulla stampa nazionale
che registrano il calo del flusso turistico sono piuttosto frequenti, così come gli articoli che
rassicurano sia il paese sia gli stranieri sulla sicurezza nazionale. Anche la concorrenza di
paesi africani come la Tanzania, Zanzibar, le isole Mauritius e il Sudafrica, che propongono
un’offerta turistica simile a quelle del Kenya (spiagge, mare e parchi naturali), ma con
standard più elevati e a un prezzo più competitivo, costituisce un fattore di forte
preoccupazione. La percezione dei rappresentanti del governo è che il turismo in Kenya stia
perdendo l’occasione per accedere a un mercato più esclusivo, attestandosi su un mercato
destinato unicamente al turismo di massa. “Zanzibar continua a rappresentare una minaccia
per la costa dal momento che i turisti prediligono destinazioni esclusive” ha dichiarato Hyllis
! 45!
Kandie, segretaria di Gabinetto per gli Affari, il Commercio e il Turismo dell’East African
Community (Daily Nation, 17 settembre 2013).
L’andamento altalenante del turismo e i rischi di battute d’arresto del flusso turistico in
seguito a eventi che compromettono la sicurezza nazionale, ha portato il paese a elaborare
strategie che potessero sopperire a eventuali cali del numero di turisti stranieri, dovute anche
alla forte stagionalità che caratterizza il settore turistico in Kenya.
Nel 1984 il governo ha istituito il Domestic Tourism Council (DTC) con l’incarico di
promuovere il turismo domestico in Kenya. In particolare questo ente, che coordina sia il
settore pubblico sia quello privato, si prefigge di realizzare alcuni obiettivi molto significativi
fra i quali la promozione dell’unità e dell’integrazione nazionale, il trasferimento delle risorse
dalle zone più ricche delle nazione a quelle più povere e l’agevolazione per i locali a
beneficiare degli investimenti governativi per le infrastrutture turistiche, includendo sia i
parchi sia le riserve. Il turismo in Kenya, infatti, è fortemente orientato verso il
soddisfacimento dei bisogni e delle richieste di visitatori stranieri a discapito dei locali. Le
destinazioni turistiche sono quelle predilette dal turismo internazionale: parchi naturalistici,
spiagge e città, mentre mete alternative, che poterebbero maggiormente attrarre il turismo
domestico, non sono state sino ad oggi oggetto di sviluppo.
Uno studio condotto nel 1996 da Isaac Sindiga della Moi University, ha messo in evidenza
come per le classi medie e basse sia difficile partecipare al turismo domestico a causa dei
costi elevati per gli standard locali, considerando anche che le strutture turistiche, così come i
trasporti, sono piuttosto dispendiosi (Sindiga 1996). Il DTC ha incoraggiato l’istituzione
sistemazioni in albergo a prezzi ridotti per i locali durante la bassa stagione, che va da aprile a
giugno, tariffe scontate per i trasporti pubblici e per le entrate ai parchi e alle riserve.
Nonostante queste agevolazioni la maggior parte dei kenioti resta comunque estranea al
turismo domestico. Una delle ragioni della debolezza del turismo domestico, sostiene Sindiga,
“sono le tacite politiche che vogliono che i kenioti visitino le stesse attrazioni e gli stessi
luoghi frequentati dai turisti stranieri” (Sindiga 1996: 26), con il risultato di avere i siti
turistici tradizionali congestionati per il sovrannumero di visitatori. Sindiga dunque propone
una diversificazione turistica in termini di prodotto, mercato e aree geografiche. Molte attività
e attrazioni sono oggi poco sfruttate: siti preistorici e archeologici come il lago Turkana,
Olorgesalie e Hyrax Hill, i numerosi parchi e alcune riserve nazionali (cinquantasette in
totale) di cui soltanto la metà viene attualmente visitata. Questi luoghi poterebbero costituire
mete alternative che porrebbero rimedio ai problemi legati al costo del trasporto. Anche sulla
costa potrebbero essere incoraggiate attività alternative rispetto alla combinazione sole-
! 46!
spiaggia-mare come, per esempio, la pesca sportiva e le gite nelle numerose foreste di
mangrovie della zona. Infine, un network di alberghi di piccole e medie dimensioni offrirebbe
nuove possibilità per turisti con diverse capacità economiche, senza privare i kenioti della
possibilità di usufruire delle strutture che generalmente ospitano i turisti stranieri (Sindiga
1996: 28). Queste strategie ovvierebbero anche alle consistenti perdite che il paese registra a
causa della prevalenza delle tipologie di vacanza all inclusive e della forte presenza di
imprenditori e manager stranieri che possiedono più del 50% della ricettività alberghiera
(Sindiga 1996: 29).
2.4. La Coast Province in una prospettiva storica e geografica
In passato la striscia di terra che corre lungo la costa del Kenya era caratterizzata da
un’intensa partecipazione all’economia dell’Oceano Indiano. Ognuna delle principali città
lungo la costa da Vanga a Lamu possedevano il proprio porto e i propri mercanti e avevano
rapporti con altri centri della costa, con la Somalia, l’Oman e l’India. Le rotte oceaniche
collegavano la costa anche a Sud con altre zone dell’Africa Orientale come Zanzibar (Cooper
2000: 115). La costa era un importante centro produttivo, in particolare, di grano e noci di
cocco che venivano spediti in Arabia e nella regione dell’Oceano Indiano. Nel XIX secolo la
costa venne assoggetta all’autorità amministrativa del Sultano di Zanzibar, anch’egli un arabo
dell’Oman, sebbene ogni centro mantenne una certa autonomia (Cooper 2000: 116). Nel corso
di questo secolo si sviluppò una prosperosa agricoltura di piantagione basata sul lavoro degli
schiavi provenienti da lontane regioni dell’Africa centrale; le città portuali della costa
accrebbero il loro coinvolgimento nel commercio con l’Oceano Indiano.
L’inizio della conquista coloniale, nel 1895, segnò il principio di una profonda trasformazione
nell’organizzazione dello spazio e nella fitta rete di collegamenti e contatti commerciali che
integravano la costa, sia lungo la sua estensione sia con il più vasto bacino geografico
dell’Oceano Indiano. Il commercio costiero e l’importanza di porti come Malindi e Lamu
declinò velocemente (Cooper 2000: 116). Da una striscia stretta e lunga costellata di centri
portuali ben connessi fra loro, la costa si è trasformata in un unico punto cruciale, Mombasa,
attraverso cui collegare regioni distanti come le Highlands, Nairobi, la Rift Vallery e
l’Uganda, al mondo esterno. Uno snodo dunque verso l’esterno per l’economia di import-
export dell’Africa Orientale e, in modo minore, un centro regionale (Cooper 2000: 116).
! 47!
In quest’ottica la linea ferroviaria, completata nel 1901, fu costruita per collegare la costa
(Mombasa) alle sponde del lago Victoria (Kisimu). Secondo l’amministrazione coloniale la
ferrovia avrebbe consentito lo sfruttamento delle risorse del paese ma il rendimento della
produzione agricola e dell’estrazione mineraria non erano al tempo sufficienti a massimizzare
il suo sfruttamento. Per risolvere il problema, il governo coloniale, attivò politiche di sviluppo
dell’area compresa fra il lago e la costa attraverso la creazione di insediamenti contadini
(bianchi) (Meilink 2000: 13). Nella visione coloniale “la costa e le Highlands avrebbero
dovuto costituire due poli gemelli dell’agricoltura capitalista in Kenya” (Cooper 2000: 118).
Molti sforzi furono fatti per favorire lo sviluppo della regione costiera. Tuttavia gli esiti
dell’agricoltura di piantagione non soddisfecero le attese del governo coloniale a causa delle
condizioni ecologiche sfavorevoli e della carenza di forza lavoro. In aggiunta la popolazione
indigena venne forzata a lavorare nelle piantagioni “bianche” attraverso l’imposizione del
pagamento di imposte (Meilink 2000: 13).
Nel 1907 l’abolizione della schiavitù portò al declino dell’economia di piantagione e molti fra
gli ex schiavi e i Mijikenda si stabilirono abusivamente sulle proprietà terriere della costa.
Vicino a Mombasa questi cercarono lavori occasionali, anche di una sola giornata, che
potessero consentire loro di mantenere allo stesso tempo l’attività agricola. Presto la necessità
di lavoratori a lungo termine, spinse la città a rivolgersi agli immigrati che arrivavano dalle
regioni dell’interno: Kikuyu, Luo e Luya. A partire dagli anni Venti, la cospicua
immigrazione rese sempre più vulnerabile la posizione dei lavoratori della costa che persero il
loro accesso privilegiato al lavoro occasionale e diede origine a una crescente tensione e a una
costante competizione che continuano ancora oggi (Cooper 2000). La rottura dei precedenti
sistemi di lavoro rispecchiò una rottura nell’organizzazione dello spazio. Le aree più esterne
della città si riempirono di immigrati dalle regioni dell’interno. Gli arabi e gli swahili che
poterono rivendicare i propri diritti di proprietà sulla terra impiegarono parti di questi terreni
per costruire case da affittare ai lavoratori immigrati tracciando quelli che sarebbero poi
diventati quartieri della working class (Cooper 2000: 119). All’inizio del periodo coloniale
non era chiaro se un individuo fosse un mijikenda o uno swahili: l’appartenenza etnica era
situazionale, relazionale e modificabile. Questa concezione dell’identità flessibile piena di
sfumature rendeva difficile per l’amministrazione coloniale comprendere come collocare i
nativi all’interno di precise nicchie nell’economia coloniale. I colonizzatori tentarono di
introdurre un sistema classificatorio delle appartenenze etniche che potesse scardinare la
flessibilità delle interazioni sociali e la fluidità delle attribuzioni identitarie, istituendo rigidi
confini etnici. Applicando il principio organizzatore del dividi et impera, l’amministrazione
! 48!
coloniale si adoperò per allontanare i commercianti swahili dai distretti rurali e i
commercianti mijiknda da quelli urbani. In accordo con Cooper (2000: 120-121), prima della
colonizzazione non esisteva una linea di demarcazione fra le aree limitrofe alla costa e quelle
più interne del paese così come non esisteva una dicotomia fra la fascia costiera e le aree
“Mijikenda” situate dietro di essa. Piuttosto, si potevano individuare complessi meccanismi di
differenziazione e affiliazione comuni radicati nei mutevoli rapporti politici ed economici che
le persone sviluppavano attraverso il commercio, l’istruzione, l’organizzazione religiosa, e le
alleanze politiche. Il fatto che le persone sviluppassero relazioni attraverso dinamiche
clientelari, famigliari come nel caso di matrimoni interrazziali, e di scambi economici, era per
gli ufficiali coloniali una questione annosa; i loro sforzi classificatori hanno contribuito molto
a creare divisioni su base etnica che l’Occidente ha interpretato come una caratteristica
congenita dell’Africa.
Nel 1907, la decisione del governo coloniale di spostare la capitale da Mombasa a Nairobi e il
concomitante cambiamento delle politiche coloniali di sviluppo, che, da quel momento, si
concentrarono sull’entroterra (nelle cosiddette “White Highlands”), aggravarono la situazione
(Meilink 2000: 13). Qui, infatti, i coltivatori bianchi godevano di una posizione privilegiata
nella prima decade del XX secolo: consistenti incentivi come la realizzazione di strade, la
ricerca agraria e la disponibilità di crediti e sovvenzioni, erano concentrati esclusivamente in
questa regione (Meilink 2000: 13). Al contrario nelle aree coltivate dagli autoctoni era vietata
la coltivazione delle colture da reddito, come tè e caffè, che avrebbero potuto entrare in
competizione con la produzione dei coloni (Meilink 2000: 13).
Le aree dell’altopiano si sono sviluppate con un passo più celere rispetto alle aree
pianeggianti e questo è strettamente legato alle politiche di governo che fin dai tempi della
colonizzazione hanno avvantaggiato le regioni con un maggior potenziale, a discapito di
quelle considerate meno produttive (Meilink 2000: 15). Oltre alle considerazioni di tipo
economico, anche fattori politici hanno giocato un ruolo importante nella distribuzione
geografica delle sovvenzioni pubbliche: le province più avvantaggiate sono state quelle la cui
base etnica coincideva con quella del Presidente. Thomas P. Wolf (2000) osserva come in
Kenya vi sia una sempre maggiore preoccupazione rispetto all’accentramento del potere, nel
contesto di una crescente orientamento etnico della politica − che avvantaggia i kikuyu,
gruppo etnico dei presidenti Kenyatta − e una messa in discussione della legittimità della
classe di governo nazionale. Le spinte autonomiste delle regioni sono state nel tempo sempre
più frequenti, soprattutto nel caso della Costa. Qui, nel 1999, si è costituito un gruppo
secessionista, il Mombasa Republican Council (MRC), poi dichiarato fuorilegge dal governo
! 49!
nel 2010, ma riammesso nella scena politica dalla corte suprema nel luglio dello stesso anno.
Il movimento risponde alla percezione sempre più diffusa fra la popolazione della costa, di
una discriminazione economica e politica da parte del governo: "We have been made slaves
in our own land", nelle parole del leader del gruppo, Ruwa (The Guardian, 6 settembre 2012).
In un recente articolo apparso sul quotidiano Daily Nation si afferma che “il 69% della
popolazione dichiara che non c’è alcuna figura pubblica che rappresenti l’interesse degli
abitanti della costa (Daily Nation, 1 novembre 2013). Le questioni principali ruotano attorno
alla proprietà terriera e al tema dell’occupazione: il fatto che molti dei migliori lotti siano
nelle mani di proprietari di altre parti del paese, secondo il MRC, è frutto delle politiche
clientelari del primo presidente keniano Jomo Kenyatta; inoltre molti degli impieghi offerti
dal settore turistico non sono occupati dalla popolazione della costa, bensì, dalla popolazione
immigrata dalle regioni dell’interno. Il MRC rivendica l’indipendenza della Costa che,
nell’ottica del concilio, non avrebbe mai dovuto essere integrata nel Kenya all’Indipendenza,
supportando la propria tesi con una serie di documenti storici, ritenuti però falsi dal governo
(The Guardian, 6 settembre 2012).
2.5. Le politiche pubbliche e la produzione della marginalità
La provincia della Costa si inserisce in un quadro nazionale dove l’ineguaglianza è
profondamente radicata nella struttura sociale. La questione delle diversità regionali è molto
rilevante e ha importanti implicazioni in termini di distribuzione del welfare fra la
popolazione (Meilink 2000: 12). Alcuni studi (Hoorweg et al. 2000; Meilink 2000; Foeken et
al. 2000; Kenya Government 2004) hanno messo in evidenza come la regione costiera soffra
storicamente di una condizione di marginalità rispetto ad altre aree del paese. Il turismo, come
più volte ribadito, non ha significato per la maggior parte della popolazione un miglioramento
delle condizioni di vita. Oltre alla già discussa considerazione di un mercato turistico gestito
in larga misura da imprenditori stranieri, vi sono altri elementi da considerare. In primo luogo,
il turismo potrebbe costituire uno sbocco per alcuni mercati come quello agricolo, in
particolare quello costituito dai piccoli produttori. Questo non è il caso però della costa, dove
il settore turistico si dimostra più orientato verso prodotti provenienti dalle regioni più interne
e grandi produttori. Nonostante la presenza di numerosi alberghi nella regione, i contadini
della costa si trovano, infatti, nella condizione di non poter vendere i propri prodotti a questi
potenziali acquirenti. In secondo luogo, la popolazione locale non beneficia delle possibilità
! 50!
di impiego offerte dal settore turistico perché ricoperte, nella maggior parte dei casi, da
immigrati provenienti da altre regioni del paese (Sindiga 2000). Inoltre, l’impiego di molti
terreni della striscia costiera, fra i più fertili della regione, per la costruzione di alberghi ha
limitato ulteriormente la possibilità di espandere l’agricoltura e di contenere la costante
crescita della popolazione (Dieke 1991: 280). Allo stesso tempo, la creazione dei numerosi
parchi e riserve nazionali per soddisfare le richieste del wildlife tourism ha creato numerosi
conflitti con i gruppi sociali che abitavano quegli spazi o che impiegavo queste terre per
pascolare il proprio bestiame. La questione è estesa anche alle aree adiacenti ai parchi e alle
riserve dove il divieto abbattere qualsiasi animale selvatico si è scontrato con i tradizionali
diritti di caccia di alcuni gruppi etnici come, per esempio, i Masai (Dieke 1991). In alcuni
distretti come Taita Taveta, molti ranch per l’allevamento di bestiame e fattorie sorgono ai
confini del Tasvo National Park; qui i greggi sono spesso attaccati da predatori come i leoni e
i ghepardi mentre gli elefanti, i maiali selvatici e i babbuini devastano le coltivazioni. La
stessa cosa avviene nelle aree limitrofe alla Shimba Hills National Reserve comportando gravi
danni alle famiglie che vivono e lavorano in queste zone (Foeken 2000: 37).
Le necessità dell’economia turistica hanno finito per scontrarsi con l’economia agro-pastorale
e le politiche pubbliche per lo sviluppo turistico hanno considerato con difficoltà le necessità
della popolazione locale e l’impatto ambientale conseguente all’espansione del settore
turistico.
La regione costiera soffre tutt’oggi di una condizione di svantaggio e di marginalizzazione
con un’elevata incidenza di povertà rispetto al resto del paese. È stato stimato che a Mombasa
più del 50% della popolazione vive sotto la soglia di povertà, guadagnando meno di un
dollaro al giorno (Akama e Kieti 2009: 737). Sebbene la Coast Province risenta degli stessi
problemi che attanagliano l’interno Kenya − scarse infrastrutture, mancanza di un buon
servizio sanitario, corruzione, tensioni etniche, cattiva gestione del bene pubblico – nel caso
della costa vi sono alcuni fattori che la affliggono in modo particolare: alcuni limiti
infrastrutturali e strutturali, nonché la degradazione ambientale.
I principali limiti infrastrutturali riguardano la fornitura di acqua ed elettricità, le scarse
opportunità di commercio del prodotto agricolo locale, il sistema stradale e il persistente
problema della proprietà terriera su cui torneremo in seguito.
La fornitura elettrica è in larga parte dipendente dalla rete nazionale; questo implica che il
razionamento sia frequente, con l’aggiunta di ripetuti cali di tensione. Fuori da Mombasa e dai
centri abitati, lungo le strade asfaltate, l’elettricità è fornita da generatori che sono però
disponili soltanto in alcuni luoghi (Foeken 2000: 40).
! 51!
La regione costiera soffre anche di una cronica carenza nella fornitura di acqua sia per uso
domestico sia per usi industriali e agricoli. A eccezione dei fiumi Sabaki (Galana) e Tana, che
costituiscono la maggiore fonte di acqua per l’irrigazione e per gli usi domestici, gli affluenti
e i piccoli fiumi sono quasi del tutto stagionali. Soprattutto nelle zone più aride della regione,
anche le fonti di acqua sotterranee sono scarse.
La situazione si è aggravata a partire dagli anni Settanta quando nella zona furono costruiti i
primi alberghi che richiesero un ingente consumo di acqua a vantaggio dei propri ospiti
internazionali, ma anche in seguito alla crescita demografica (dovuta anche all’immigrazione
di persone da altre parti del paese in particolare nel caso del distretto di Mombasa) e
all’espansione del settore industriale (Hoorweg et al. 2000: 400-401). Per ovviare alla carenza
di acqua sono stati costruiti sui tetti cisterne per la raccolta dell’acqua piovana e sono stati
scavati pozzi soprattutto dagli alberghi lungo la costa, che hanno messo a rischio la qualità
dell’acqua della falda acquifera a causa delle intrusioni di acqua marina e dell’inquinamento
dovuto ai liquami scaricati direttamente in mare. L’acqua potabile rimane un grosso
problema: in molte zone di Mombasa, in particolare negli slum e negli insediamenti abusivi ai
margini della città, completamente privi di acqua potabile e fognature, l’approvvigionamento
di acqua potabile avviene attraverso taniche trasportate su carretti di legno trainati a piedi. Ad
aggravare il problema, il 65% della provincia costiera non ha alcun sistema fognario ma
soltanto fosse settiche e latrine che contribuisco all’inquinamento della falda acquifera. Anche
le aree servite dal sistema fognario, tuttavia, sono causa di inquinamento dal momento che
spesso i liquami vengono scaricati direttamente in mare, minacciando la salute pubblica e la
vita marina (State of the Coast Report 2009).
La rete stradale è concentrata principalmente intorno ai centri commerciali e industriali. Molte
zone rurali della costa sono servite da strade strette e sterrate che rendono difficili i trasporti e
i collegamenti. La mancanza di un’efficiente rete stradale nella regione non consente lo
sviluppo di un mercato in cui commercializzare con efficienza, per esempio, i prodotti
agricoli dei piccoli imprenditori locali. Anche a Mombasa le strade, fatta eccezione per le
arterie che attraversano il centro cittadino, sono frequentemente non asfaltate causando non
pochi problemi di viabilità durante la stagione delle piogge, quando il terreno non riesce ad
assorbire completamente l’acqua, causando ristagni e grosse pozze. Alcune strade della città
sono anche troppo strette per i veicoli commerciali pesanti che vanno e vengono dal porto
(Kenya 1989 citato in Foeken 2000: 59). Il turismo influenza la distribuzione delle
infrastrutture sulla costa a vantaggio dei turisti ma non dei locali: è soprattutto nelle aree in
! 52!
cui sorgono le strutture ricettive per i turisti che lo sviluppo di infrastrutture, come le strade e
la fornitura di acqua e elettricità, è perseguito (Foeken 2000: 41).
La regione soffre anche di un elevato livello di malnutrizione rispetto al resto del paese. La
malnutrizione è un problema diffuso in Kenya, ma la Costa non ha mostrato i segni dei
miglioramenti che, a partire dagli anni Ottanta, sono stati registrati nel resto del paese
(sebbene il tasso di malnutrizione sia leggermente sceso negli anni Novanta). L’attuale deficit
alimentare non costituisce una novità: esso affonda le sue radici nel periodo coloniale, quando
la priorità dello sviluppo agricolo fu data alle “White Highlands” tanto che, anche oggi, il
settore turistico si rivolge alle zone interne del paese per quanto riguarda
l’approvvigionamento di generi alimentari (Klaver, Mwadime: 282-283). La provincia della
costa, inoltre, è caratterizzata da una scarsa fertilità del suolo, fatta eccezione per il Kwale
District, le Shimba Hills e alcune colline isolate a Nord di Kilifi, e da un clima che non
favorisce lo sviluppo dell’agricoltura21. Il clima è contraddistinto da un basso tasso di
piovosità e da un’elevata variabilità del tasso delle precipitazioni. Lungo la fascia costiera il
clima presenta un’unica stagione delle piogge che va da aprile a giugno, seguita da un periodo
di brevi piogge che dura fino a novembre, ovvero fino all’inizio della stagione secca. Verso
l’interno a partire da una distanza di circa 15-25 km dalla costa, le stagioni delle piogge
tendono a essere due di egual intensità (Foeken 2000: 32). Il grado di piovosità, tuttavia, varia
sensibilmente di anno in anno, ma anche rispetto agli stessi mesi in anni differenti, e infine
rispetto a luoghi diversi; la distribuzione irregolare delle piogge durante l’anno può causare
periodi di siccità, o, al contrario, piogge eccesive concentrate in un medesimo periodo,
possono causare ristagni di acqua nel suolo che portano alla distruzione delle colture. Ad ogni
modo il ciclo delle piogge spesso non coincide con il ciclo agrario rendendo molto difficili le
coltivazioni (Foeken 2000: 32).
In conclusione, la Coast Province ha la più alta proporzione di terre a basso potenziale
agricolo rispetto a tutte le altre province del paese, a eccezione della North Eastern Province
(Kenya 1991: 93 citata in Foeken 2000: 34).
A queste carenze connaturate si aggiunge il fatto che molti tratti di terra sono occupati da
piantagioni di anacardi e alberi da cocco, riducendo così la superficie disponibile per le
coltivazioni di colture di base come il mais e la cassava. In termini di produzione di beni
alimentari la regione costiera è auto-sufficiente per meno del 50%; questo determina
l’importazione da altre province di una larga parte dei prodotti agricoli (Klaver e Mwadime
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!21!La Coast Province comprende anche Tsavo National Park Est e Ovest che occupa una superficie di 10.000 km2 e consiste in una pianura relativamente piatta con una piovosità piuttosto bassa e quindi con un potenziale agricolo molto limitato. Inoltre in questa area l’agricoltura e gli insediamenti sono vietati (Foeken 200, p. 29).
! 53!
2000: 292). Per i nuclei familiari questo si traduce nella necessità di acquistare la maggior
parte degli alimenti necessari al proprio sostentamento. Inoltre, l’elevata dipendenza
dall’acquisto di derrate alimentari significa che ogni variazione nel rifornimento degli
alimenti e nel loro prezzo potrebbe gravare pesantemente sul bilancio familiare perché non
possono essere facilmente compensate dalla coltivazione di sussistenza o da extra impieghi
(Klaver e Mwadime 2000: 292). La recente liberalizzazione del commercio del mais (il cui
prezzo e la cui distribuzione prima veniva gestita direttamente dal governo), ha portato a un
costante aumento del suo costo a partire dal 1992 con le evidenti ripercussioni sull’economia
familiare (Klaver e Mwadime 2000: 292).
Il problema della proprietà della terra costituisce una delle maggiori fonti di tensione e
discontento fra le popolazioni della costa. La questione ha radici profonde e riflette in modo
significativo i cambiamenti storici avvenuti nell’ultimo secolo e le conseguenti variazioni
nelle dinamiche dei rapporti fra i gruppi etnici che popolano la costa e nei rapporti di potere
che comprendono, per estensione, il governo centrale, gli investitori stranieri del settore
turistico e alcuni gruppi etnici di altre parti del paese.
Durante il periodo coloniale, la fascia costiera era sotto la sovranità del sultano ma sovrintesa
dall’amministrazione britannica. In seguito all’abolizione della schiavitù nel 1907, i
proprietari terrieri swahili e arabi concessero agli occupanti abusivi delle loro piantagioni, i
Mijikenda, di coltivare la terra e usufruire dei prodotti degli alberi da frutto. Con
l’introduzione del Coast Settlemnt Act del 1908, però, la situazione cambiò: furono emessi
titoli di proprietà a favore di individui e compagnie e le terre abbondonate furono assegnate
alla Corona. L’amministrazione coloniale onorò i titoli di proprietà degli arabi, mentre, al
contrario, la maggior parte delle rivendicazioni dei Mijikenda sulla costa furono respinte;
ampie superfici di terra arida e sterile dell’entroterra divennero terre in concessione ai nativi
(Hoorweg 2000: 312). Durante le negoziazioni per l’indipendenza, i diritti terrieri degli
Omani e degli Zanzibaresi furono confermati dal neo governo indipendente e questo perpetuò
la condizione di occupanti abusivi dei Mijikenda e degli ex schiavi che avevano lavorato nelle
piantagioni arabo-swahili, nonostante alcuni di loro avessero vissuto su queste terre per più di
una generazione con diritti di usufrutto (Hoorweg et al. 2000: 402). Tale condizione continua
ancora oggi: molte famiglie abitano su terre di cui non possono rivendicare diritti di proprietà,
nonostante i primi proprietari arabi non siano più rintracciabili, e rischiano quotidianamente
di essere sfrattati con poco preavviso senza alcuna compensazione per eventuali
miglioramenti apportati all’appezzamento di terra. Questo si traduce anche in un ostacolo per
lo sviluppo economico dato che, in assenza di diritti, non è possibile ottenere prestiti e
! 54!
ipoteche. Inoltre, i contadini che occupano terre di cui non sono proprietari hanno
comprensibilmente poco interesse a fare investimenti finalizzati al miglioramento della
produttività o anche più semplicemente all’applicazione di tecniche di coltivazione finalizzate
al mantenimento della fertilità del suolo, preferendo adottare tecniche, quali tagliare e
bruciare parti di foresta, che risultano essere più facili ed economiche (State of the Coast
Report 2009).
Come in molti altri Paesi in Africa, anche in Kenya i settlement schemes (schemi di
assegnazione) sono stati introdotti per provvedere alla necessità di assegnare lotti di terra a
famiglie che ne erano prive e a occupanti abusivi, ma anche per incrementare la produzione
agricola e l’ottimizzazione dell’utilizzazione delle risorse fisiche e umane del paese (Hoorweg
2000: 310). In particolare, nella regione costiera i settlement schemes furono introdotti a
partire dagli anni Sessanta-Settanta e costituirono la più importante attività di sviluppo con
circa 17.000 lotti che avrebbero dovuto ospitare circa 134.000 persone (Hoorweg 2000: 310).
Da subito risultò evidente come questi piani di insediamento e sviluppo fossero intrecciati con
dinamiche di potere e rapporti clientelari. È un fatto piuttosto frequente quello che vede il
governo assegnare terreni a politici locali per poi fare poco dopo marcia indietro per servire
interessi stranieri o di altre parti del paese (Hoorweg et al., 2000: 402). Anche il favoritismo è
determinante nell’assegnazione di lotti a individui politicamente ben connessi (Hoorweg
2000: 313).
L’industria turistica è entrata a pieno titolo nelle dinamiche che soggiacciono ai settlement
schemes costituendo un’importante variabile che influisce sulla determinazione del valore
della terra. Molte persone cercano di occupare abusivamente terre statali (ma anche terre che
appartengono a privati) per fini speculativi con la speranza di poterle rivendere a un prezzo
molto più alto. Più i lotti sono vicini ad aree di sviluppo turistico più sono ambiti, così come
quelli vicini alle strade e alle spiagge (Hoorweg 2000: 313). In accordo con Hoorweg (2000)
questi eventi esercitano una profonda influenza sull’attitudine dei locali: frustrazione a causa
dei risultati raggiunti senza sforzo da coloro che sono riusciti a speculare sui terreni e
risentimento per essere privati di ciò che avrebbe potuto spettare loro, considerando che molto
frequentemente i lotti migliori finiscono nelle mani di ricchi stranieri. Essi contribuiscono
anche a diffondere l’idea che corruzione e clientelismo siano mezzi più adatti per conseguire
vantaggi economici piuttosto che impegno e dedizione.
A oggi la situazione è lontana dall’essere risolta: solo il 44% della popolazione possiede titoli
di proprietà della terra che occupano mentre il 41% ne è privo (Daily Nation, 1 novembre
2013). Quasi ogni giorno i quotidiani riportano casi di sfratto e diatribe che ruotano intorno al
! 55!
tema della proprietà. Episodi come la demolizione di quaranta case a Kisauni all’inizio di
dicembre, che ha causato la morte di tre persone e ha lasciato all’addiaccio 1000 residenti,
compresi bambini, sono soltanto uno dei numerosi casi che testimoniano la mancanza di una
volontà politica seriamente impegnata ad affrontare il problema della proprietà della terra. La
popolazione, come conseguenza, lamenta la non curanza del governo nei confronti dei propri
bisogni rinvigorendo il proprio senso di frustrazione e abbandono (Daily Nation, 5 dicembre
2013).
Ai limiti fisici appena elencati si associano alcuni problemi strutturali. I livelli di salute e di
malattia sono condizionati da un numero di fattori associati a infrastrutture mediche di bassa
qualità, il clima tropicale e la povertà. Il livello dei servizi sanitari non differisce dal resto dal
paese, ma qui le strutture mediche sono concentrate a Mombasa e nei centri lungo la costa,
mentre nelle aree rurali dell’entroterra sono distanti e qualitativamente più carenti. La Coast
Province ha sempre avuto il tasso più alto di mortalità infantile rispetto al resto del paese,
sebbene statistiche più recenti indichino un qualche miglioramento. Il clima umido costituisce
un ambiente ideale per l’insorgere di alcune patologie, prima fra tutte la malaria, ma anche
infezioni intestinali e schistosomiasi (Hoowerg et al. 2000: 403).
La regione costiera resta una delle regioni con il più basso tasso di alfabetizzazione del paese.
I risultati degli studenti negli esami nazionali sono inferiori rispetto ad altre parti del paese. Vi
è una mancanza di strutture per la formazione secondaria e terziaria (Hoorweg 2000: 403).
Un’indagine dell’Ipsos, realizzata nel 2013, riporta che il 41% della popolazione della regione
costiera non ha completato la scuola primaria (Daily Nation, 1 novembre 2013). Solo un terzo
della regione possiede un’educazione che vada oltre la scuola primaria e soltanto il 7% ha
frequentato la scuola secondaria, registrando il fallimento delle politiche pubbliche volte a
incentivare l’alfabetizzazione della popolazione residente, come la FPE (Free Primary
School) (Daily Nation, 1 novembre 2013). Queste politiche, pur contribuendo ad alleggerire le
spese dell’istruzione sostenute dalle famiglie per l’istruzione de propri figli, non tengono
conto di altre importanti voci di costo come i trasporti e i libri che pesano fortemente sul
budget familiare. La povertà, inoltre, spinge molte famiglie a impiegare i propri figli in
attività lavorative o a indurli a chiedere l’elemosina. Vicino ai centri turistici, o lungo le
strade che portano ai parchi nazionali, non è raro vedere bambini che attendono il passaggio
delle jeep cariche di turisti per rincorrerle supplicando per qualche moneta o caramella. Le
donne in particolare presentano un tasso di alfabetizzazione ancora più basso, come
conseguenza dei rapporti di genere e della divisione del lavoro: questo influisce sulla cura dei
! 56!
figli, specialmente sulle questioni relative alle norme igieniche e alla dieta alimentare (Klaver
e Mwadime: 288).
La popolazione locale si trova per lo più nella condizione di non riuscire a interagire
sistematicamente con chi detiene il potere, su basi più eque e consapevoli, per negoziare in
modo efficace le questioni che affliggono il loro benessere. I locali dovrebbero essere messi
in grado di costruirsi competenze e possibilità che permettano loro di accedere a opportunità
economiche e condizioni di vita decorose. La mancanza di una forte organizzazione sociale
rende difficile la costruzione di tali competenze e possibilità e il potere legislativo, da solo,
non può creare le condizioni perché questa costruzione avvenga. I residenti necessitano di un
contesto stimolante attraverso l’educazione, la motivazione e il supporto di organizzazioni
politiche e professionali illuminate che lavorino con loro e per conto loro; essi necessitano
anche di strategie turistiche e politiche pubbliche concepite per supportare uno sviluppo
socio-economico sostenibile. (Akama e Kieti 2009: 743).
! 57!
3.“The beach is my working place”22: storie di vita, competizione e solidarietà
3.1. La storia di Bonnie
Ho incontrato Bonnie il giorno dopo il mio arrivo in Kenya sulla spiaggia antistante al
Voyager Beach Hotel, un albergo che sorge vicino al piccolo centro residenziale di Nyali a
nord di Mombasa. Volevo fare una corsa sulla spiaggia e dopo qualche metro soltanto, un
ragazzo a piedi scalzi, con indosso un paio di pantaloncini lunghi fino al ginocchio e una
camicia azzurra sbottonata, portata sopra una t-shirt bianca, si è avvicinato e ha iniziato a
correre con me. Dopo i primi convenevoli23 relativi alla nazionalità, alla durata della mia
permanenza in Kenya e alla data del mio arrivo, Bonnie si è mosso in direzione di un
corteggiamento piuttosto serrato, come era plausibile aspettarsi24. Oltre a farmi complimenti
per il mio aspetto, non ha fatto mistero di ciò di cui era in cerca: una fidanzata straniera,
possibilmente italiana “because I like Italians, I think they are good people”; e così nel caso in
cui io non avessi voluto esserlo, almeno avrei potuto essergli d’aiuto per trovarne una in
Italia, fra le mie amiche. Bonnie, infatti, mi disse di non volere più una compagna keniota
perché riteneva che le donne keniote fossero troppo costose e interessate soltanto al denaro.
L’insistenza con cui sondava la possibilità di trovare una fidanzata italiana fra le mie amiche,
mi ha fatto comprendere la sua urgenza di intraprendere una relazione con una donna straniera
per uscire da una situazione di ansia e incertezza, forse dovuta anche all’età, non più
giovanissima, se paragonata a quella della maggior parte dei suoi colleghi. L’età è un fattore
molto importante perché essere ragazzi nel pieno della giovinezza li rende appetibili agli
occhi delle turiste straniere, ma l’avanzare degli anni restringe progressivamente le possibilità
di avere successo.
Bonnie ha trent’anni, è un giriama − uno dei novi sottogruppi etnici Mijikenda − originario
del distretto di Kilifi, ubicato sulla costa fra Mombasa e Malindi. Porta piccoli dreadlocks,
tagliati recentemente, ma che vorrebbe far ricrescere, e si fa chiamare con un nickname
mutuato dal nome di un famoso cantante reggae giamaicano. La madre vive tutt’oggi a Kilifi,
mentre il padre si è trasferito da qualche anno a Mombasa dopo la separazione dalla moglie.
Quando abitava a Kilifi, il padre di Bonnie coltivava la terra. Nei distretti di Malindi e di
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!22!Espressione spesso utilizzata da Bonnie per descrivere la sua relazione con la spiaggia. 23 Sebbene si tratti di domande fatte con la finalità di “agganciare un turista”, esse non sono casuali. Al contrario, mirano a raccogliere alcune preziose informazioni che potranno essere sfruttate anche in momenti successivi. 24 Essendo una donna di trentaquattro anni, italiana, che appariva come qualsiasi altra turista, possedevo quelle caratteristiche che parzialmente mi collocavano nella categoria di donne ambite dai “beach boys”.!!
! 58!
Kilifi, circa il 90% della popolazione dipende fortemente dall’agricoltura. Le colture di mais,
fagioli e cassava sono le più diffuse; la cassava in particolar modo, essendo la più resistente
alla siccità (State of the Coast Report 2009). Secondo una modalità piuttosto diffusa sin dai
primi anni del XX secolo, avviata in seguito all’abolizione della schiavitù, la famiglia di
Bonnie aveva occupato abusivamente, insieme ad altri membri del villaggio in cui risedevano,
uno dei terreni lasciati incolti dai vecchi proprietari, probabilmente zanzibaresi, che avevano
abbandonato la costa dopo il declino dell’agricoltura schiavista di piantagione. Non potendo
esibire alcun diritto di proprietà, furono costretti in seguito ad abbandonare la terra che
avevano occupato, trovandosi nella situazione, condivisa da molti abitanti della costa, di non
avere più accesso né alla casa né alla terra.
Per ragioni storiche i Mijikenda furono svantaggiati in termini di possedimenti terrieri. In
accordo con Hoorweg (2000), alla fine del XIX secolo, i tre maggiori gruppi che popolavano
la costa erano gli swahili, gli arabi e i Mijkenda. Gli arabi e gli swahili erano concentrati
principalmente nelle città e lungo la fascia costiera, mentre i Mijikenda, che costituivano la
maggioranza della popolazione, vivevano principalmente nell’interno, sebbene lavorassero
anche sulla costa nelle piantagioni arabo-swahili. L’economia dei Mijikenda si basava
principalmente sull’agricoltura; essi erano coinvolti anche nel commercio di breve e lunga
distanza fra le città della costa e l’interno. Queste attività commerciali crebbero notevolmente
nel corso del XIX secolo e permisero a molti Mijikenda di spostarsi più vicino alla costa.
Tuttavia, la forza politica e militare dei residenti costieri swahili e arabi ostacolò lo
stanziamento dei Mijikenda in quelle aree. Quando durante la seconda metà del XIX secolo
l’agricoltura di piantagione arabo-swahili, basata sullo sfruttamento degli schiavi, divenne il
perno dell’economia costiera, i Mijikenda cessarono di essere i maggiori fornitori di prodotti
agricoli (cereali in particolare) delle città della costa e persero anche la loro posizione di
intermediari nel commercio costiero (Hoorweg 2000: 312). Dopo l’abolizione della schiavitù
nel 1907, l’economia di piantagione, non riuscendo a trovare un’adeguata soluzione alla
mancanza di lavoro schiavile, si avviò verso il declino, lasciando incolte numerose ex-
piantagioni. È qui che molti Mijikenda si stabilirono insieme agli ex-schiavi dopo aver
abbandonato le terre più aride dell’interno. L’occupazione abusiva di terre “abbondonate” di
proprietà di privati o dello stato, è una pratica a cui molti kenioti ricorrono anche in tempi più
recenti, come nel caso della famiglia di Bonnie, dal momento che il problema legato alla
proprietà terriera non ha ancora incontrato una volontà politica disposta ad affrontare
seriamente la situazione.
! 59!
Bonnie fu costretto ad abbandonare gli studi dopo aver terminato la scuola primaria per
permettere anche agli altri fratelli e sorelle, sette in tutto, di avere un’istruzione primaria.
Inizialmente, affiancò il padre nel lavoro nei campi, ma, in seguito allo sfratto, decise di
spostarsi verso Mombasa e cercare lavoro nell’industria turistica. Qui trovò lavoro come
cameriere in un piccolo albergo della costa a nord di Mombasa. Nei suoi racconti Bonnie
descriveva questo periodo, di circa un anno, come un’esperienza negativa che aveva
completamente disatteso le sue aspettative. In particolare, ciò che descriveva con maggior
delusione, era il tempo passato a lavorare, anche 10-12 ore al giorno, per una paga
insufficiente, con il rischio di perdere il lavoro al termine dell’alta stagione: il compenso
giornaliero era intorno ai 500-700 ksh (circa 5-6 euro), ma poteva scendere ulteriormente
durante la stagione delle piogge. Alla domanda: “Hai provato a cercare lavoro anche nei
grossi alberghi internazionali come il Voyager?”, Bonnie ha risposto che i posti disponibili
sono occupati da immigrati dalle regioni interne del Kenya che spesso possono fare
affidamento su una migliore formazione scolastica. La competizione fra la popolazione della
costa e quella proveniente dall’interno ha radici storiche molto profonde: risale all’incirca agli
anni Venti del secolo scorso quando la crescente immigrazione dalle regioni dell’interno del
paese, di kikuyu, luo e luya − più disponibili a rivestire impieghi a lungo termine rispetto ai
loro colleghi della costa, così come le nuove esigenze delle attività portuali richiedevano −,
rese più vulnerabile la posizione dei lavoratori autoctoni. La regione costiera, un tempo luogo
del lavoro forzato, fu così al centro di un nuovo mito, quello dei nativi sfaticati (Cooper 2000:
118). Questo mito mantiene la sua efficacia ancora oggi: la popolazione nativa della costa
continua a essere denigrata con gli appellativi di sfaticati e illetterati. Nei discorsi di senso
comune è frequente il ricorso a tali considerazioni per legittimare atteggiamenti discriminatori
ma anche politiche di marginalizzazione messe in atto dalle amministrazioni distrettuali e
regionali.
Oltre a queste considerazioni di carattere generale, nello specifico, i giriama furono oggetto di
una pressione maggiore da parte dell’amministrazione coloniale, rispetto agli altri gruppi
etnici presenti sulla costa: i britannici introdussero la “hut tax25”, che veniva raccolta con ogni
mezzo possibile, ed ebbero per i giryama una scarsa considerazione politica. Bonnie
riecheggiando i ricordi del nonno, un allevatore di bestiame del distretto di Kilifi, descrive
così questo periodo storico: “It was terrible during that time anyway my grandfather he was
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25 La hut tax è un tipo di tassazione introdotta dai colonialisti britannici in Africa basata su ogni abitazione o nucleo famigliare, pagabile in denaro, in grano o con il lavoro. Questa tassa, oltre che a raccogliere denaro, serviva a indurre la popolazione autoctona a lavorare a servizio dell’economia coloniale. !
! 60!
very strong”. Ogni Natale, quando la famiglia si riunisce a Kilifi, il nonno di Bonnie racconta
dei tempi della colonizzazione, in cui i britannici, nell’intento di sostituire la manodopera
schiavile con una working class disposta a lavorare, dietro compenso, nell’economia
coloniale, forzavano la popolazione nativa ad abbandonare la coltivazione della terra e le loro
attività pastorali per dedicarsi a quelle coloniali:
My grandfather use to stay in Kilifi the way to Malindi so the britain they were all over in Kilifi
and Mombasa mostly so they were being forced by the Britain coz they use to have guns […] My
grandfather he was very lucky, because he use to have a lot of cattle by that time, he was at the bush
grazing when the people find him he didn’t know anything, he use to tell us, if he could know then
he could run away and the big problem they use to catch people so that they could go and collect
some shells at the beach for making some earrings and necklaces so that they can trasport to there
country26.
I tristi racconti, ma anche pieni di orgoglio, del nonno fanno dire a Bonnie di non
simpatizzare per gli inglesi: parla con loro ma non è interessato a stabilire alcun legame. In
seguito alla crescente immigrazione dalle regioni dell’interno, che fornì al governo coloniale
un bacino dove attingere manodopera, i britannici scelsero presto di emarginare la
popolazione nativa a favore di quella immigrata, più disposta ad adattarsi alle necessità
produttive coloniali.
Dopo l’esperienza fallimentare nel mercato formale del lavoro, Bonnie incontrò un amico di
vecchia data che possedeva un catamarano, ottenendo da lui un lavoro come procacciatore di
clienti e manutentore dell’imbarcazione, insieme ad altri cinque ragazzi. In seguito alla morte
dell’amico, avvenuta qualche mese dopo la sua “assunzione”, Bonnie fu nuovamente nella
condizione di cercare un impiego. Mi ha raccontato di aver pensato a uno zio proprietario di
una barca nonché barcaiolo a Mombasa Beach. Decise di cercarlo nella speranza di ottenere
un lavoro e una raccomandazione che potesse facilitarlo nell’ottenimento della licenza,
rilasciata dal Kenya Wildlife Service (KWS), che gli avrebbe consentito di lavorare
ufficialmente sulla spiaggia come boat operator. Sulla licenza che mi ha mostrato con
orgoglio, infatti, è riporta la sigla MBOA: Mombasa Boat Operators Association.
Quando ho incontrato Bonnie, erano già alcuni anni che lavorava come boat operator, senza
essere soddisfatto. Più volte ha ribadito l’intenzione di voler cambiare vita, perché il lavoro
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!26!Questa!citazione!è!tratta!da!uno!scambio!email!intercorso!con!Bonnie!successivamente!al!mio!rientro!in!Italia.!La!traslitterazione!cause/coz!e!their/there!deriva!dall’apprendimento!quasi!esclusivamente!orale!della!lingua!inglese!avvenuto!attraverso!le!interazioni!con!i!turisti.!Nella!forma!scritta!spesso!le!parole!si!compongono!sulla!base!della!loro!pronuncia!come!nel!caso!frequente!di!that/dat,!my/ma,!da/the.!!
! 61!
sulla spiaggia non gli dà garanzie. Lavorare come boat operator lo espone alle continue
fluttuazioni del flusso turistico che, durante la bassa stagione, si riduce notevolmente,
compromettendo le opportunità di assicurarsi dei guadagni. Il Voyager Beach Hotel, a
differenza della maggior parte degli alberghi della zona, che chiudono nei mesi compresi fra
aprile e giugno, rimane aperto e offre tariffe agevolate per i kenioti e per i gruppi, come nel
caso delle scolaresche. Questo consente all’albergo di trarre vantaggio da un turismo di tipo
domestico durante il periodo delle piogge, ma questo non sembra giovare a coloro che
operano sulla spiaggia. Bonnie mi ha spiegato che, a differenza dei turisti stranieri, i kenioti
conoscono già la maggior parte delle attrattive offerte dai beach operator, dato che nella
maggior parte dei casi tornano abitualmente sulla costa per passare le vacanze. Inoltre molti
degli oggetti venduti sulla spiaggia, come gli animali della savana intagliati nel legno e i
braccialetti masai, non costituiscono una novità per i turisti domestici e, in conclusione, le
loro possibilità economiche sono spesso inferiori rispetto a quelle dei turisti occidentali,
perlomeno nella percezione di Bonnie.
Al momento del mio incontro con Bonnie, la bassa stagione si avviava verso la fine. La sua
preoccupazione e quella degli altri ragazzi che operavano sulla spiaggia, era costantemente
ribadita inducendolo a immaginare un futuro diverso. Nelle nostre conversazioni questo
futuro prendeva le forme concrete del lavoro come taxista che, nella visione di Bonnie,
costituisce un impiego migliore, che offre maggiori possibilità di lavorare anche durante il
periodo delle piogge. Ma l’impossibilità di raggiungere la somma necessaria all’ottenimento
della licenza richiesta per praticare la professione, al momento, gli impedisce la realizzazione
di questa aspirazione.
Dopo l’attacco terroristico del 21 settembre 2013, nel centro commerciale di Westgate a
Nairobi, il turismo ha subito una forte contrazione; naturalmente questo fatto ha avuto riflessi
immediati anche sui lavoratori della spiaggia. A luglio, quando ho lasciato Bonnie, le nostre
chiacchierate descrivevano le speranze e le fantasie sui futuri guadagni che avrebbe potuto
investire in un corso di italiano per migliorare la comunicazione con i turisti italiani o, ancora
di più, nel conseguimento della licenza per guidare un taxi, fondate sul presupposto che l’alta
stagione che stava per iniziare, avrebbe finalmente migliorato la situazione. L’attacco
terroristico avvenuto proprio all’inizio della nuova stagione turistica, ha stravolto le sue
aspettative. Non ho più visto Bonnie ma, attraverso le email e i messaggi che saltuariamente
ci scambiamo, so che, al momento27, rinuncia a recarsi quotidianamente in spiaggia, il suo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!27 Il momento temporale a cui si fa riferimento, corrisponde alla stesura di questo capitolo: dicembre 2013.!
! 62!
“luogo di lavoro” − come lui stesso lo ha più volte definito − perché non ci sono turisti,
ammettendo: “I am totally broke”.
3.2. La storia di Nelson
Nelson ha lunghi dreadlocks raccolti in una coda; cura molto il suo look composto spesso da
un paio di Rayban, larghi pantaloncini al ginocchio con tasche laterali, portati con la vita
abbassata secondo la moda occidentale, una t-shirt smanicata e un paio di Nike ai piedi.
Quando gli ho chiesto il perché dei dreadlocks, ha risposto “It’s a matter of fashion”. Tiene
molto al suo aspetto e alla cura di pelle e capelli. Spesso durante le nostre chiacchierate, ha
raccontato che, quando se lo può permettere, acquista un olio per capelli per proteggerli dal
sole e una lozione per il corpo per nutrire la pelle e renderla più morbida dato che, in seguito
alle lunghe ore di esposizione a sole, vento e acqua di mare, tende a disidratarsi e a diventare
secca. Anche Nelson è un giriama e lavora sulla spiaggia come boat operator. Ha venticinque
anni e vorrebbe avere una relazione con una straniera possibilmente sua coetanea, ma anche
se fosse più matura, andrebbe bene lo stesso. Non desidera necessariamente andare in Europa;
o meglio, per lui, restare in Kenya o trasferirsi in Europa è indifferente.
Nelson è originario di Mtwapa, una cittadina che si trova sulla costa a circa 16 km a nord di
Mombasa, ed è attraversata dalla Malindi Road, la strada che da Mombasa conduce a Watamu
e Malindi. Da un punto di vista economico, Mtwapa è il centro maggiormente sviluppato
dell’area: la vicinanza con Mombasa fornisce uno sbocco per il commercio dei prodotti
agricoli e l’acquisto di lotti di terra da parte di proprietari benestanti (in rapporto agli standard
locali) offre stimoli alle attività economiche (Hoorweg 2000: 318).
La madre di Nelson coltiva alberi da frutto e vende i suoi prodotti alimentari quasi
quotidianamente a Marikiti, il mercato centrale di Mombasa. Il padre morì quando Nelson
stava frequentando il college; per lui questo significò dover abbandonare gli studi e cercare
un’occupazione per contribuire al sostentamento della madre e delle due sorelle, di cui si
sente responsabile essendo l’unico uomo di casa. Il suo sogno era di lavorare nel turismo
come tour leader, per questo motivo stava frequentando il college e imparando molte lingue.
Dopo aver abbandonato la scuola, Nelson iniziò, privo di licenza, a lavorare su una spiaggia
vicino a Mtwapa, scegliendo questo impiego perché “I lived closed to the beach”. Dai suoi
racconti emerge che molti ragazzi iniziano a lavorare sulla spiaggia in questo modo, offrendo
ai turisti visite ai loro villaggi, o a Mombasa, procacciando oggetti come collanine e
! 63!
braccialetti su richiesta, senza avere una licenza e una qualifica specifica che legittimi la loro
attività. Come è accaduto per altri giovani giriama, alcuni turisti, nel suo caso italiani, hanno
provveduto a pagargli la licenza di boat operator rilasciata dal KWS. È forse opportuno
chiedersi se via sia una connessione fra la storica resistenza giriama alla penetrazione
capitalistica dell’impero britannico e la ricerca dei giovani giriama di opportunità di guadagno
all’interno dell’economia informale. La “Hut tax” era stata introdotta a questo scopo: indurre i
giriama a offrirsi come lavoratori salariati alle dipendenze dell’amministrazione coloniale.
Nonostante la loro opposizione, i britannici vinsero la guerra e obbligare i giriama a un
accordo di pace. Tuttavia in seguito a una carestia, i britannici rimossero le restrizioni imposte
in precedenza sull’utilizzo della terra e sospesero le richieste di lavoro; dato che erano rimase
ben poche risorse da sfruttare, i britannici ricollocarono i loro ufficiali dall’interno, dove
erano stanziati i giriama, presso la fascia costiera28. L’economia giriama di piccola scala,
basata sulla produzione di grano destinato all’esportazione, che era stata storicamente
interconnessa al più esteso mercato dell’Oceano Indiano, si trovò distaccata e dipendente
dall’economia coloniale a partire dagli anni Venti 29 . Questi eventi storici potrebbero
influenzare le scelte dei giovani giriama di oggi, inducendoli a preferire un impiego
nell’economia informale o un piccolo business autogestito, al lavoro dipendente. Nonostante
queste considerazioni, credo sia necessario non cadere nel rischio di una retorica della
resistenza giriama che sottovaluti gli aspetti legati alla povertà e alla mancanza di formazione
scolastica grazie alla quale potrebbero competere con i gruppi etnici immigrati da altre parti
del paese per l’assegnazione di lavori qualificati all’interno dell’economia formale.
Nel 2012 l’albergo che sorgeva sul tratto di spiaggia dove lavorava Nelson chiuse i battenti ed
egli fu quindi costretto spostarsi. Decise di avvicinarsi a Mombasa, escludendo, però,
l’affollata Bamburi beach dove, secondo la sua esperienza, ci sarebbe stata troppa
concorrenza. Nei sobborghi di Mombasa viveva uno zio cui si rivolse quando stava cercando
un impiego e con cui ora condivide una stanza in affitto. Quando lo incontrai, Nelson, stava
lavorando a Mombasa Beach soltanto da pochi mesi e non si era ancora creato un network di
amicizie fra i colleghi boat operator. Egli mi ha spiegato che sebbene sulla sua licenza ci sia
scritto il nome della prima spiaggia in cui ha lavorato, è possibile cambiare luogo di lavoro,
purché si venga ammessi dal chairman della spiaggia prescelta. Infatti, è obbligatorio fare
richiesta al capo che presiede una data spiaggia con la funzione di regolare le presenze, i
rapporti e le eventuali dispute fra gli operatori che vi lavorano, prima di potervi accedere !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!28!Brantley!C.,!The2Giriama2and2colonial2resistance2 in2Kenya.21800:1920,! Berkley,!University! of! California!Press,!1981,!p.!152;!citato!in!Eid!Bergan!2011:!85!!29!ivi:2152U153!!
! 64!
liberamente per svolgere attività turistiche. In seguito alla sua ammissione, Nelson è stato
legittimato a operare come procacciatore e accompagnatore di turisti alle dipendenze di uno
dei capitani che possiedono un’imbarcazione utilizzata per i safari blue30. I capitani reclutano
ragazzi più giovani, solitamente fra i giriama, che li aiutino a trovare turisti disposti a pagare
per una gita in barca nel Mombasa Marine Park, antistante al litorale. Il parco marino offre
una lunga barriera corallina su cui è possibile camminare quando c’è bassa marea e numerose
varietà di pesci tropicali. Se l’accordo con i turisti va a buon fine, i ragazzi percepiscono una
parte della somma versata per il safari blue.
Nelson, nel periodo di tre settimane che ho speso a Mombasa, non si è recato quotidianamente
sulla spiaggia; essendo un periodo di bassa stagione, con poche possibilità di concludere
affari con i turisti, decideva spesso di restare a casa evitando di spendere a vuoto la giornata
sulla spiaggia. A maggior ragione considerando che, come molti altri beach operators, Nelson,
per raggiungere la spiaggia, deve sobbarcarsi circa un’ora di strada viaggiando con i matatu31
che, benché siano un mezzo piuttosto economico per spostarsi, costituiscono comunque un
costo che incide sul bilancio personale, soprattutto durante la bassa stagione, quando le
opportunità di guadagno sono notevolmente ridotte.
Anche per Nelson, i mesi di bassa stagione rappresentano una fonte di grande
preoccupazione. La scarsa presenza di turisti, i numerosi alberghi chiusi, le piogge che
tengono i pochi ospiti lontani dalle spiagge, restringono le occasioni di contatto e dunque di
“make a business with some tourists”. Come Bonnie, anche Nelson impiegava il suo tempo
libero forzato per immaginare un futuro migliore che gli consentisse di smettere di vivere alla
giornata. Nelle nostre conversazioni, ha espresso costantemente la sua insoddisfazione e la
quotidiana difficoltà di assicurarsi un qualche guadagno, seppur minimo, che gli consentisse
di affrontare i mesi di bassa stagione per arrivare all’inizio dell’alta stagione, quando, egli
sperava, le cose sarebbero andate meglio. Anche lui vorrebbe cambiare la sua vita con un
impiego che possa garantirgli una maggiore stabilità economica. La sua prima scelta è fare il
taxista, ma per guidare un taxi serve innanzi tutto una licenza e, inoltre, è necessario fare un
periodo abbastanza lungo di affiancamento che si ottiene principalmente attraverso contatti
personali e raccomandazioni. Anche per Nelson, la difficoltà di mettere da parte la somma !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!30 I safari blue sono gite in barca nel Mombasa Marine Park, che prevedono attività di snorkeling nei pressi della barriera corallina dove si concentra la maggior parte della fauna marina. Durano all’incirca due ore e sono effettuate in diversi orari del giorno a seconda delle maree. I prezzi non sono fissi ma variano rispetto al numero dei turisti, alla stagione e alla propensione dei turisti di accettare o meno l’offerta. 31!I!matatu! sono!minubus!di!14!posti!più!un!autista!e!un!conduttore!che!raccoglie! i! soldi!e!comunica!al!conducente! quando! fermarsi! e! riprendere! la! corsa.! Essi! costituiscono! un! mezzo! di! trasporto! pubblico!economico! e! molto! utilizzato! dai! kenioti! ma! sporadicamente! dai! turisti.! I! matatu! seguono! linee!prestabilite!ma!non!vi!sono!fermate!prefissate:!le!persone!possono!salire!o!scendere!su!richiesta!quasi!in!ogni!momento.!!
! 65!
necessaria al compimento dell’iter professionale richiesto, gli impedisce per il momento di
abbandonare la spiaggia.
3.3. “Beach boys” o beach operators?
Quando ho spiegato a Bonnie le ragioni della mia permanenza in Kenya e gli ho chiesto dei
“beach boys”, lui ha negato perentoriamente la presenza di qualsiasi beach boy a Mombasa
Beach dato che, da parecchio tempo, non erano più ammessi a lavorare sulla spiaggia. A
differenza sua, ha tenuto a sottolineare, i “beach boys” non possiedono la licenza e hanno una
condotta biasimevole: fanno uso di droghe (sebbene Bonnie ammetta di fumare marijuana
quando ne ha la possibilità) e spesso si prendono gioco dei turisti chiedendo loro un anticipo
per procurare alcuni articoli su richiesta, senza poi farsi più trovare. Per spiegarmi la
differenza fra lui e loro, Bonnie insisteva soprattutto sulla diversità del loro approccio al
turista. Non possedendo una licenza, essi si devono preoccupare più di altri della Polizia
Turistica, che potrebbe sanzionarli o detenerli in prigione per alcuni giorni. Questa condizione
di costante preoccupazione impedisce loro di avere tempo a disposizione per stabilire un
contatto, o ancor più, un legame con i turisti. Il loro approccio, dunque, è più diretto e, nelle
parole di Bonnie, interessato solo al business. Al contrario, Bonnie investe tempo e pazienza
per creare una connessione con il turista che può anche non sfociare nella realizzazione di un
guadagno immediato, ma che potrebbe concretizzarsi nella possibilità di un profitto futuro:
“you don’t know what he will decide to do for you at the end of the holiday”. Bonnie ha più
volte citato a questo proposito un proverbio keniota molto significativo: “Patience is a big egg
that hatches a big bird”.
Quando gli ho domandato se fosse stato a conoscenza del fatto che gli impiegati dell’albergo
li appellano con il nome di “beach boys” senza fare distinzioni, ha risposto che la cosa non gli
piaceva affatto, dal momento che lui possiede una licenza che lo identifica ufficialmente come
boat operator; alcuni di loro, ha ribadito, non hanno seguito le regole e si sono comportati
male; questo ha portato le persone a fare di tutta l’erba un fascio, classificandoli tutti quanti
come “beach boys”. Bonnie attribuisce alla denominazione una serie di connotazioni
negative, enfatizzando per contrapposizione il suo comportamento onesto e la legittimità della
sua posizione sulla spiaggia. Ha affermato ripetutamente di non avere amici fra i “beach
boys”; non solo, qualora si fossero presentati sulla spiaggia, li avrebbe cacciati personalmente
(collocandosi in questo modo nella posizione della polizia turistica, preposta dal governo a
! 66!
pattugliare le spiagge e a proteggere gli interessi dei turisti). Queste affermazioni sono state
smentite dai fatti in più occasioni: non solo ragazzi senza licenza erano presenti sulla spiaggia
di Mombasa Beach e di Nyali ma ho visto Bonnie salutarli e scambiare con loro qualche
parola (che non ho compreso data la mia mancata conoscenza della lingua swahili).
Identificare se stesso e i “beach boys” in termini dicotomici e oppositivi, contribuisce a
rimarcare la legittimità del suo operato sulla spiaggia e, viceversa, a condannare apertamente
(per lo meno con i turisti) i “beach boys”, causa del biasimo generale. Assegnare ai “beach
boys” tutti quei comportamenti che sono fonte dello stigma sociale, gli consente di dare una
presentazione positiva di se stesso. Il tentativo di creare una linea di demarcazione fra un
“noi” e un “loro” passa anche attraverso l’aspetto esteriore. Ogni operatore sulla spiaggia è
tenuto a indossare una divisa con un colore diverso a seconda dell’attività svolta: nel caso dei
boat operator essa consiste in una camicia azzurra. Bonnie, come altri boat operator – sebbene
non tutti – indossava sempre la sua divisa, ad eccezione di quando doveva essere lavata. È
stata una delle prime cose che mi ha mostrato in occasione del nostro primo incontro,
asserendo che ora lavorava nel settore del turismo come boat operator.
Nelson, dal canto suo, preferiva essere chiamato beach operator piuttosto che “beach boy”
ma, a differenza di Bonnie, aveva un atteggiamento più tollerante nei confronti di chi non
possiede la licenza. Egli riconosce che bene o male tutti hanno iniziato senza licenza
nell’attesa di mettere da parte abbastanza denaro per fare domanda o di trovare qualche turista
disposto ad aiutarli.
Quando ho chiesto ad alcuni membri dello staff di uno degli alberghi che sorgono su
Mombasa Beach dove lavorano Bonnie e Nelson, chi fossero i “beach boys”, essi riunirono in
questa definizione tutti coloro che lavorano sulla spiaggia dai cammellieri ai venditori di
souvenir, ai boat operators senza considerare le differenze di età perché, nelle parole di
Mohammed, addetto alle piscine presso il Voyager Beach Hotel: “They live at the beach, it
doesn’t matter how old are they, age it’s just a number”. Al loro arrivo in albergo, i turisti
sono solitamente allertati della presenza dei “beach boys” e inviati a non intrattenere rapporti
di alcun tipo con loro.
Come vedremo più approfonditamente nel quarto capitolo, i rappresentanti del governo,
spesso, parlano dei “beach boys” come di un problema che rischia di compromettere
l’attrattiva del Kenya come destinazione turistica e che, quindi, deve essere risolto in maniera
radicale. Nei discorsi pubblici volti a promuovere piani di confinamento destinati alla
comunità che opera sulle spiagge, essi non fanno distinzioni fra operatori con o senza licenza,
ricorrendo all’etichetta di “beach boys”.
! 67!
Kibicho (2009: 116), che ha condotto uno studio sul turismo sessuale sulla costa keniota,
individua tre categorie di beach operators riconosciute dal governo keniota: venditori di
souvenir, boat-operator locali e venditori di safari. Coloro che non rientrano in questa
classificazione sono considerati “beach boys”: lavoratori del sesso, guide e interpreti
improvvisati, spacciatori, venditori ambulanti di vivande. Tuttavia, le categorie non sono così
nette. I boat operator che ho incontrato a Mombasa Beach, lavorano principalmente alle
dipendenze di capitani di barche utilizzate per i safari blue, ma si adoperano anche in attività
collaterali, come accompagnare i turisti nei night club di Mombasa o a visitare i loro villaggi
e procurare souvenir su richiesta.
La categoria di “beach boys” appare, dunque, fluida, la cui definizione varia a seconda degli
interessi e delle percezioni di chi la definisce.
Rifacendosi alla classificazione enunciata dal governo, Bonnie e Nelson sembrano cercare
un’etichetta connotata positivamente per descrivere le loro pratiche. Ciò che sembra
interessante è come la legittimazione del proprio ruolo si basi sul possedere una licenza
rilasciata da un ente statale (KWS), seppure il promotore di tali categorizzazioni sia proprio lo
stesso governo che nella condanna pubblica dei “beach boys”, non fa differenze. Insistendo
sulla legittimità delle loro pratiche, Bonnie e Nelson si oppongono alle identità imposte dallo
staff dell’albergo, dai turisti, dal governo, dalla comunità, ma lo fanno passando attraverso il
riconoscimento ufficiale dello stato, lo stesso Stato che contribuisce a produrre la loro
esclusione.
3.4. Comunicare attraverso lo stile
Come molti altri giovani ragazzi che lavorano sulla spiaggia, principalmente giriama, Bonnie
e Nelson portano i dreadlock. Bonnie li aveva da poco tagliati, ma era determinato a farli
ricrescere, ed era molto attento alla loro cura: con una parte dell’incasso di un piccolo
business che aveva chiuso pochi giorni prima, con una turista tedesca, aveva comprato una
boccetta di olio per capelli per proteggerli dal sole e dal sale. I dreadlock sembrano costituire
una caratteristica del loro stile così come l’abbigliamento che segue la moda occidentale. I
capi più diffusi sono larghi pantaloncini lunghi fino al ginocchio abbinati a t-shirt o canotte,
jeans, infradito o sneakers, accompagnati da accessori quali braccialetti, collane e occhiali da
sole. L’abbigliamento costituisce una sorta di elemento che entra in gioco nell’interazione con
i turisti: esso può attirare la loro attenzione e costituire la base su cui lavorare per ottenere la
! 68!
loro fiducia. In uno studio condotto a Malindi nel 1996, Johanna Schoss ha analizzato il modo
di vestire di guide turistiche e “beach boys”, evidenziando come questi assemblino
coscientemente i propri capi di abbigliamento, seguendo uno stile preciso e identificabile, che
incorpora strategie alternative attraverso cui i locali si posizionano all’interno dell’economia
politica del turismo internazionale (1996: 181). Lo stile, si potrebbe dire, è una forma di
comunicazione intenzionale che vuole marcare una differenza e, quindi, un’appartenenza a un
dato gruppo di persone o, più in generale, a una comunità sovralocale di persone, quella dei
giovani occidentali moderni.
Vestirsi secondo la moda occidentale comunica la vicinanza dei “beach boys” agli stranieri.
Da un punto di vista pratico, essi hanno accesso a questi articoli attraverso i ricavi ottenuti dai
servizi offerti ai turisti, che consentono loro l’acquisto di capi dispendiosi, oppure, grazie a
doni ricevuti da questi ultimi, che attestano l’esistenza di un rapporto, quantomeno amicale,
fra loro. In ogni caso, il vestirsi all’occidentale come segno distintivo parla di un contatto
continuato fra turisti e “beach boys”.
Durante una delle mie passeggiate con Nelson, un ragazzo molto magro mi si è avvicinato
presentandosi e chiedendomi se volevo essere accompagnata a visitare il suo villaggio.
Nelson mi ha raccontato che quel ragazzo di ventisette anni, anch’egli giriama, lavorava sulla
spiaggia di Nyali sprovvisto di licenza. Il suo abbigliamento, sebbene consistesse in una t-
shirt e un paio di jeans, era meno curato: i vestiti erano sporchi e avevano dei buchi. Il non
avere la licenza lo esponeva maggiormente ai controlli della polizia turistica e lo costringeva a
lavorare su un tratto di spiaggia semi deserta (la maggior parte degli alberghi di quel tratto di
spiaggia resta chiusa durante la bassa stagione). Bergan nota come lo stile costituisca un
significativo spartiacque fra i “beach boys” che hanno una relazione con turiste straniere e chi
no: “beach boys” without foreign girlfriend often walk barefeet and wear clothes that are dirty
as opposed to the ones with foreign girlfriends. Moreover their approach to tourist is being
perceived as more desparate than the others” (2011: 33).
Da un punto di vista più esteso, indossare abiti occidentali potrebbe fare riferimento alla
volontà di marcare una differenza fra loro stessi e gli altri abitanti della costa, aspirando a
riconoscersi parte del “moderno mondo occidentale”. In una delle nostre conversazioni,
Bonnie mi ha spiegato che sarebbe facile per lui comprendere se qualcuno, per esempio, fosse
di Likoni (un quartiere periferico di Mombasa) dal modo in cui è vestito, prima ancora di
parlargli.
I dredlocks e il possedere un fisico atletico sono un altro tratto comune a molti “beach boys” e
hanno il vantaggio di essere molto più accessibili rispetto a vestiti e accessori. Kibicho (2009)
! 69!
ha notato come per alcuni “beach boys”, i dreadlocks significassero potere sessuale ed
erotico, marijuana, liberazione dalle forme di potere (2009: 117). La popolarità della musica
reggae fra i “beach boys” e l’utilizzo di nickname che fanno riferimento a Bob Marley e ad
altri famosi musicisti raggae giamaicani, fa pensare a una sorta di identità neo-Rasta32
(Bergan 2011: 33), sebbene, come messo in evidenza da Bergan , la scelta di portare i
dreadlocks nasca anche dalla consapevolezza di risultare attraenti agli occhi delle turiste
straniere.
Nella mia brevissima esperienza a Mombasa Beach, quando ho chiesto a Gabriel e Nelson il
perché portassero i dreadlocks, la loro risposta è stata: “it’s a matter of fashion”, ammettendo
di non conoscerne il significato. Pruitt e LaFont, nella loro ricerca fra i “beach boys”
giamaicani, hanno rilevato come l’utilizzo di un’identità rasta fornisca loro un modello di
mascolinità, che non dipende dal possedere denaro (199: 432). Credo che sarebbe interessante
approfondire questo aspetto per comprendere se il ricorso a elementi che rimandano a
un’identità rasta, costituisca uno strumento di ridefinizione delle concezioni di mascolinità
tradizionali fra i “beach boys” del Kenya.
3.5. Approcciare il turista: una questione di abilità, tempo e conoscenza
Ne L'invenzione del quotidiano (2001) Michel de Certeau elabora una distinzione tra i
concetti di strategia e tattica. Le strategie sono messe in relazione alle istituzioni che
esercitano il proprio potere sullo spazio; mentre le tattiche sono utilizzate dagli individui che
si muovono negli ambienti definiti dalle strategie. Se le strategie appartengono allo “spazio
del potere”, le tattiche sono pratiche descrivibili come espedienti dei “deboli” e determinate
dall’assenza di potere. Facendo riferimento a questa distinzione, gli espedienti messi in atto
dai “beach boys” per attirare l’interesse dei turisti, possono rientrare nella definizione di
tattiche. Essi, infatti, non esercitano controllo sulle precondizioni che possano portare, o
meno, alla realizzazione di un contatto con i turisti da cui potrebbe nascere un’amicizia o una
relazione affettiva. La spiaggia è una situazione che si presenta ricca di occasioni da sfruttare
ma anche di limitazioni che spesso esulano dal loro controllo: il numero dei turisti che
alloggeranno presso il Voyager Beach Hotel, l’andamento della bassa e dell’alta stagione, le
pressioni della polizia turistica, la presenza di altri contendenti che è una minaccia alle proprie
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!32!Rasta!è!un’abbreviazione!del!termine!Rastafarian,!un!movimento!religioso!nero!e!una!subUcultura!che!si!sviluppò!in!Giamaica!negli!anni!Cinquanta.!!
! 70!
opportunità di successo. In questo contesto, i “beach boys” attingono al proprio capitale
sociale e alle proprie abilità oratorie e seduttive (prerogativa essenziale per i “beach boys” in
generale) per riuscire a entrare in contatto con i turisti e, ancor meglio, con le turiste straniere.
Più volte nelle nostre conversazioni, Nelson e Bonnie, hanno parlato della competizione che
permea i rapporti fra i beach operators. Ciascuno di loro instaura un network di relazioni e
amicizie con alcuni colleghi che operano sulla medesima spiaggia. Grazie a queste reti
diventa possibile, per esempio, lavorare insieme in alcune occasioni: se due beach operator
sono in contatto con lo stesso turista, possono entrambi accompagnarlo a visitare uno dei
villaggi vicini alla costa, o a fare un safari blue, e spartirsi gli eventuali guadagni. Ma nel
momento in cui un turista fa la sua prima comparsa sulla spiaggia, ciascuno può tentare la sua
chance per creare un legame con lui. Quando ho parlato con Bonnie delle modalità di
approccio al turista, egli mi ha spiegato che ciascuno cerca di “attack the tourist in order to get
closer with him”. La parola attack è significativa perché, riprendendo il gergo militare della
parola tattica, rimanda all’idea di una sorta di campo di battaglia in cui non solo i colleghi
possono rappresentare i nemici, ma, in un certo senso, anche gli stessi turisti. Peake, che ha
condotto una ricerca a Malindi fra il 1981 e il 1982, descrive gli approcci insistenti dei “beach
boys” come una forma di attacco, “un modo di sfruttare gli sfruttatori”, sebbene questa
interpretazione sia problematica, dal momento che l’hastling è basato su una dipendenza
economica dai turisti (Peake 1989: 213).
Tuttavia, Bonnie ha precisato che in questa “partita” è lecito che vinca il migliore, senza che
gli altri competirors serbino del rancore.
La questione tempo sembra costituire un elemento fondamentale dell’approccio al turista. Più
tempo un beach boy riuscirà a passare con il turista, più possibilità avrà di stabilire una
connessione con lui che potrebbe portare a un guadagno immediato, o futuro. Riuscire a
ottenere del tempo da spendere con il turista, dunque, è il primo obiettivo e può essere
conseguito facendo o dicendo qualcosa che attiri la sua attenzione. Per farmi capire come
questo avvenga, Bonnie mi ha fatto un esempio: se un beach operator coglie l’interesse di un
turista per la fauna marina, ecco che può raccontargli del Mombasa National Park e dei pesci
che si possono vedere lì. A quel punto avrà ottenuto l’interesse del turista e potrà parlargli
delle attività che svolge sulla spiaggia, offrendogli i propri servizi. Nel caso in cui invece un
beach operator non riesca a dire o fare niente che possa interessare il turista, potrà solamente
offrirgli il proprio aiuto per visitare la città o procurare dei souvenir o prenotare un safari
blue, ma il contatto rimarrà superficiale. Se il turista deciderà, per esempio, di fare un safari
blue, sarà molto più probabile che si rivolgerà al primo ragazzo piuttosto che al secondo,
! 71!
sebbene entrambi offrano lo stesso tipo di servizio. Il vincitore, dunque, non sarà
necessariamente chi è riuscito ad avvicinarsi per primo al turista, ma chi sarà riuscito a
interessarlo e, quindi, a spendere abbastanza tempo con lui da riuscire a parlargli di sé e dei
servizi che può offrirgli.
Alla luce di queste considerazioni, emerge un secondo importante elemento: il capitale
culturale costituito dalla conoscenza delle lingue, delle norme culturali e delle abitudini
proprie della società europea, che i “beach boys” possono mettere in campo nel loro
avvicinamento ai turisti. Più il loro bagaglio di conoscenze è ricco, più argomenti di
conversazione potranno essere messi in campo una volta approcciato un turista. I “beach
boys” auspicano quindi di instaurare rapporti continuativi con i turisti anche per avere
l’opportunità di apprendere espressioni della loro lingua madre, aneddoti sul loro paese di
provenienza o sulla loro cultura, che potranno essere utilizzati in futuri contatti con nuovi
arrivati.
Nelle tre settimane che ho speso a Mombasa Beach, mi è capitato più volte di sentirmi
proporre di visitare i villaggi locali, anche da persone che avevo appena incontrato. La
frequenza e l’immediatezza con cui mi è stata fatta questa proposta mi ha molto sorpreso,
tanto che ne ho parlato più volte con Bonnie e Nelson. A detta loro, visitare i villaggi locali, è
per i turisti un’opportunità per comprendere come vive la gente del posto, mentre per chi
lavora sulla spiaggia costituisce un’occasione per spendere tempo con i turisti, cercando di
guadagnare la loro fiducia. Dal punto di vista dei turisti, visitare villaggi locali, può
rappresentare la possibilità di accedere alle back regions e scoprire una realtà percepita come
più “autentica” di quella esperita nel contesto artificiale degli alberghi. Così, per i “beach
boys”, proporre di accompagnare i turisti in visita presso i loro villaggi, può costituire una
risposta formulata per soddisfare il loro desiderio di autenticità, creando, allo stesso tempo, i
presupposti per futuri contatti e transazioni.
Inoltre, un concetto che hanno ribadito molto spesso è quello di “sharing ideas”, ovvero la
possibilità di dialogare con persone provenienti da luoghi diversi, e con stili di vita molto
differenti dai loro, in una sorta di scambio culturale. In diverse occasioni ho avuto la
percezione che l’interesse dei “beach boys” verso l’acquisizione di più informazioni possibile
e l’ottenimento della fiducia dei turisti, fosse un modo per sopperire alla loro mancanza di
controllo della situazione, incrementando gli strumenti che possano smentire o almeno ridurre
questa carenza, per collocarsi in una posizione di vantaggio.
! 72!
3.6. Harambee, generosità e competizione
La competizione è dunque un elemento caratterizzante delle interazioni fra “beach boys”.
Essa è resa ancora più accesa dal fatto che le risorse siano limitate. Sebbene il settore turistico
costituisca la seconda entrata dello stato e abbia avuto una crescita più o meno costante dagli
anni Settanta a oggi, è anche vero che il turismo è estremamente sensibile alla stabilità
politica del paese − spesso messa sotto minaccia da disordini e attentati (vedi cap. 2) – e alla
concorrenza con paesi vicini che presentano un’offerta turistica simile, alla stagionalità e alle
diverse annate. I turisti rappresentano dunque una risorsa limitata, finita e non garantita nel
tempo, la cui variazione si sottrae in gran parte al controllo dei beach boy. Gino Satta, nel suo
studio della pratica turistica dei pranzi con i pastori organizzati a Orgosolo nella Sardegna
rurale (2001), mostra come il mercato turistico possa essere interpretato in base a una
“ideologia dei beni limitati”, secondo la quale “esiste a disposizione del gruppo una quantità
‘finita’ limitata, di valori da dividere, di cui nessuno si può appropriare senza per questo
privarne qualcun altro” (Satta 20001: 153).
L’ideologia dei beni limitati può essere uno strumento utile per analizzare le caratteristiche
della competizione che permea le interazioni fra beach operators. Abbiamo visto come, per
avere successo con i turisti, sia decisivo poter contare sia sulle proprie abilità persuasive e
interpretative (utili queste ultime, per comprendere velocemente le attitudini e gli interessi dei
turisti), sia su un bagaglio di conoscenze e informazioni, che necessita costantemente di
essere aggiornato e arricchito con nuovi dati ed esperienze. Il terreno in cui mettere in atto
queste abilità e competenze, la spiaggia, è un campo libero in cui ciascuno può giocare la sua
partita. Ma sebbene chiunque abbia il diritto di approcciare un turista, colui che avrà successo
cercherà di stabilire con lui un legame esclusivo, muovendosi su due fronti. Riferendomi alla
mia breve esperienza, Bonnie durante le nostre prime interazioni, mi ha più volte allertato
sugli altri boat operators, che, come lui, lavoravano su quel tratto di spiaggia, scoraggiandomi
ad avere rapporti con loro: “They are not all good people, you can’t trust anybody”. Dall’altra
parte, mi ha invitato con una certa insistenza a rivolgermi a lui qualora avessi avuto bisogno
di qualcosa (un souvenir, un giro in città, ecc.): “I am not jelous but if you need something I
would like if you look for me”. Bergan, riferendosi ai “beach boys” di Malindi, nota come
l’essere un “beach boys” di successo non comporti soltanto status e riconoscimento ma anche
gelosia e calunnia (Bergan 2011: 40).
La competizione è resa più accesa dal fatto che il turista non rappresenta solo una fonte
economica di guadagno ma anche un capitale simbolico e sociale. Offrirsi di accompagnare i
! 73!
turisti nel proprio villaggio, o a visitare la città, non è finalizzato primariamente a un ritorno
economico immediato ma a stabilire una connessione con il turista attraverso il tempo speso
insieme e la condivisione di pensieri, punti di vista, informazioni (sharing ideas). La
socializzazione con i turisti che, avviene in uno spazio pubblico, è anche fonte di prestigio.
Poter mostrare agli altri di avere amici fra i turisti stranieri contribuisce a incrementare il
proprio status. Nelson parlando dello scambio di aneddoti e informazioni con i turisti ha
affermato: “I have the chance to learn more about Western countries so I can tell new stories
to my friends and they will hang on my lips”. Raccontare le proprie esperienze con i turisti ad
altri colleghi, o amici, e mostrare il proprio successo, può essere motivo di ammirazione. Dal
rapporto con i turisti e da ciò che ne può derivare in termini sia materiali sia simbolici,
dipende dunque il prestigio e il proprio status all’interno del gruppo
Peake (1989: 211) nota come lo status per un beach boy derivi dall’essere regolarmente visto
nelle aree frequentate normalmente dai turisti. Nella sua ricerca sui “beach boys” di Malindi,
Bergan (2011-2012) sottolinea come il successo di un “beach boys” sia fonte di ammirazione
e come essere visti in compagnia di giovani donne sia considerato status fra i “beach boys”,
confermando le valutazioni di Peake prodotte sullo stesso terreno più di venti anni prima
(Peake 1989: 212).
La generosità di cui a volte i “beach boys” si fanno promotori, esprime e consolida lo status
acquisito. Nelson e Bonnie mi hanno spiegato che, talvolta, a fine giornata, chi ottiene un
guadagno distribuisce qualche spicciolo a chi non ha concluso niente. Ho notato in più
occasioni che Nelson offriva le poche sigarette che aveva (avevamo condiviso un pacchetto di
sigarette comprato da me) ad amici e compagni sia quando era sulla spiaggia sia quando si
trovava nei centri abitati nei pressi degli alberghi. Nei periodi di alta stagione, quando le cose
vanno bene, può succedere che si esca la sera e i “beach boys” di maggiore successo offrano
un pasto e da bere ai meno fortunati. Come Peake (1989: 211) ha notato, al di là di possedere
vestiti di foggia occidentale e beni di varia natura associabili ai turisti stranieri, lo status
deriva anche dall’essere generoso con altri “beach boys”.
Tuttavia, i “beach boys” non sembrano essere impermeabili al tradizionale concetto keniota di
Harambee, un termine swahili che significa “pull together”. Questo concetto incorpora l’idea
di mutua assistenza, unione degli sforzi, reciproca responsabilità sociale e si applica nella vita
di ogni giorno sia fra i componenti di un nucleo familiare, sia fra i membri della comunità
allargata33. I “beach boys” sono dunque chiamati ad assistere economicamente non solo la
propria famiglia, come Bonnie e Nelson fanno ogni volta che possono, ma anche i membri !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!33 Mbithi M. P., Rasmusson R., Self Reliance in Kenya: The Case of Harambee, Uppsala, Scandinavian Institute of African Studies, 1997, p. 13
! 74!
meno fortunati del gruppo dei pari34. Avere successo li pone anche nella condizione di essere
coloro ai quali gli altri si rivolgono per chiedere favori, spiccioli per comprare una birra ecc.
La generosità manifestata dai “beach boys” in varie occasioni può quindi essere considerata
anche come un’adesione all’idea tradizionale di Harambee.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!34 Numerosi esempi che testimoniano queste pratiche sono documentati nelle ricerche di Bergan fra i “beach boys” di Malindi (2011) e di Hoogenraad fra i “beach boys” delle spiagge a sud di Zanzibar (2012).!
! 75!
4. La spiaggia come campo sociale e “luogo praticato”
4.1. Introduzione
In questo capitolo descriverò Mombasa Beach partendo dalla nozione di campo elaborata da
Bordieu e dalle definizioni di spazio e di luogo proposte da De Certeau, sia per far emergere
pratiche spaziali fortemente connotate sia per identificare gli attori sociali presenti sulla
spiaggia e le modalità di interazione fra loro.
De Certeau definisce lo spazio come “un incrocio di entità mobili […] animato dall’insieme
dei movimenti che si verificano al suo interno (2005: 175-176). A differenza del luogo, che è
già dato, lo spazio consente di esprimere quello che Manuela Tassan ha definito la “creatività
agentiva”35 degli attori sociali (Tassan 2010: 476). Per De Certeau, infatti, lo spazio è un
“luogo praticato” (2005: 175-176):
è un luogo l’ordine (qualsiasi) secondo il quale degli elementi vengono distribuiti entro rapporti
di coesistenza. Ciò esclude la possibilità che due cose possano trovarsi nel medesimo luogo.
[…] un luogo è dunque una configurazione istantanea di posizione. Implica un’idea di stabilità.
Si ha uno spazio dal momento in cui si prendono in considerazione i vettori di direzione,
quantità di velocità e la variabile del tempo. Lo spazio è un incrocio di entità mobili. È spazio
l’effetto prodotto dalle operazioni che l’orientano, lo circostanziano, lo temporalizzano e lo
fanno funzionare come una unità polivalente di programmi conflittuali o di prossimità
contrattuali (De Certeau 2005: 175-176).
L’enfasi posta sulle azioni dei soggetti rinvia a un’idea di spazio prodotta dai loro movimenti
che, a loro volta, possono essere associati a una storia (De Certeau 2005: 177). Il soggetto
agente non può dunque essere pensato se non in relazione a uno spazio connesso alle sue
attività e percezioni. Malighetti e Lazzarino, a proposito delle favelas di Rio de Janeiro,
utilizzano il temine luoghi/soggetti “per sottolineare la co-appartenenza dei due termini e la
dinamicità processuale che li contraddistingue” (Malighetti, Lazzarino 2010: 44). Questo
termine, infatti, “permette di affermare che senza interazione non vi è luogo e che le
interazioni si danno sempre in una cornice spaziale, cornice che individua inevitabilmente dei
luoghi” (Malighetti, Lazzarino 2010: 44). La relazione che gli attori sociali stabiliscono, il
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!35!Tassan ricorre a questa espressione per indicare come attraverso un gesto apparentemente naturale come camminare, gli attori sociali producano uno spazio soggettivamente esperito che, secondo De Certeau, si trasforma in un “luogo praticato” (Tassan 2010: 476). !
! 76!
“luogo praticato” e le loro traiettorie spaziali sono importanti nel contesto turistico della
spiaggia di Mombasa Beach perché rimandano a diverse modalità di appropriazione e utilizzo
dello spazio. Tali relazioni e pratiche rendono manifesti processi di esclusione e confinamento
che hanno accompagnato lo sviluppo turistico in Kenya, caratterizzato da una netta
separazione fra promotori dell’impresa turistica e popolazione locale, perlopiù esclusa dai
benefici economici derivati dal turismo.
La nozione di spazio proposta da De Certeau può essere integrata dal concetto di campo
sociale elaborato da Bourdieu, secondo il quale il campo descrive uno spazio sociale abitato
da individui attivi e operanti (Bourdieu li definisce infatti agenti) che sono in relazione l’uno
con l’altro. Con tale termine egli intende un:
microcosmo, ossia un piccolo mondo sociale relativamente autonomo all’interno del mondo
sociale più grande. […] Autonomo, secondo l’etimologia, vuol dire che ha una sua propria
legge, un suo proprio nomos, che detiene al suo interno il principio e la regola del suo
funzionamento. È un universo nel quale sono all’opera criteri di valutazione a lui propri e che
non hanno valore nei microcosmi vicini. Un universo obbediente alle proprie leggi, che
differiscono da quelle del mondo sociale ordinario. Chi entra [in un determinato campo] deve
operare una trasformazione, una conversione e, anche se quest’ultima non gli appare come tale,
anche se egli non ne ha coscienza, gli è tacitamente imposta, in quanto un’eventuale
trasgressione comporterebbe scandalo e esclusione36.
Bourdieu prende a esempio il campo magnetico all’interno del quale le particelle non possono
smettere di muoversi, per spiegare le dinamiche che si sviluppano all’interno di un campo
sociale:
campo di forze che si impone con la sua necessità agli agenti che vi operano, e insieme campo
di lotte al cui interno gli agenti si affrontano, con mezzi e fini differenziati a seconda della loro
posizione nella struttura del campo di forze, contribuendo così a conservarne o a trasformarne la
struttura37.
I campi sono dunque caratterizzati da rapporti di forza, spazi sociali in cui gli agenti sono in
lotta simbolica fra loro, ovvero, in competizione per un dato obiettivo.
È con queste premesse che intendo dunque trattare lo spazio “di interferenza” della spiaggia
come un luogo complesso, animato da conflitti e regolato da rapporti di forza, tramite cui i
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!36 P. Bordieau, Propos sur le champ politique, Lyon, Press universitaires de Lyon, 2000; citato in P. Bourdieu 2010: 20. 37!P. Bordieau, Ragioni pratiche, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 46-47; citato in P. Bourdieu 2010: 20!
! 77!
diversi attori sociali si posizionano in una continua negoziazione al contempo dialogica e
conflittuale.
Nel corso del capitolo saranno affrontate anche le politiche nazionali che regolano la presenza
di lavoratori informali sulle spiagge. In questo modo, si mostrerà come le forze sociali in
campo vadano oltre lo spazio “circoscritto” della spiaggia e agiscano sui soggetti e sulle loro
scelte.
4.2. Il processo di costruzione e di attraversamento dei confini fra luoghi a uso esclusivo dei
turisti e il “fuori”
Mombasa Beach nelle prime ore del mattino
La spiaggia antistante al Voyager Beach Hotel è un’insenatura relativamente piccola,
delimitata da due protuberanze rocciose, che si stende per circa duecento metri. Durante l’alta
! 78!
marea il mare invade completamente la spiaggia, impedendo l’accesso alla spiaggia sia ai
turisti sia ai locali. A seconda delle maree, ogni mattina tra le 8.30 e le 10.00, questi ultimi
giungono alla spiaggia e si dispongono secondo collocazioni prestabilite: le venditrici di etnia
Kamba allestiscono i loro parei colorati su file di stenditoi collocati nella parte centrale della
spiaggia; i venditori di monili e oggetti intagliati nel legno occupano il perimetro costituito
dalle rocce alle spalle della spiaggia, sopra le quali sorgono due resort (il Voyager Beach
Hotel e il Bahari Beach Hotel); i cammellieri somali passeggiano in attesa di turisti cui offrire
un giro sul cammello lungo la spiaggia. Vicino a riva, o seduti sui grossi scogli che affiorano
durante la bassa marea, sostano, quando non vi sono nuovi turisti da approcciare, i boat
operators – prevalentemente giriama – e i capitani delle barche pronte ad accompagnare i
turisti in un safari blue. I procacciatori di safari e i massaggiatori, principalmente di etnia
kamba o kikuyu, attendono i turisti vicino alle scale che dai resort scendono alla spiaggia. Il
mix etnico dei lavoratori che operano sulla spiaggia riecheggia in piccolo la diversità etnica
che caratterizza la popolazione della costa, in particolare quella dei principali centri urbani fra
cui il più grande: Mombasa. Mijikenda, arabi, indiani e swahili costituiscono i gruppi
numericamente più consistenti della popolazione autoctona. A partite dal post Indipendenza,
la costa ha attratto un numero sempre maggiore di immigrati dalle regioni interne del paese, in
cerca di opportunità offerte dallo sviluppo turistico dell’area. Luo, kamba, masai, samburu e
kikuyu e, in seguito, anche somali, si sono progressivamente stabiliti nella regione, in
particolare nei distretti di Mombasa e Kilifi, generando competizione e conflitti con la
popolazione indigena per ottenere posti di lavoro prevalentemente nell’industria turistica
(vedi cap. 2). Le divisioni etniche, che costituiscono tutt’oggi una realtà concreta e duratura
del paese, sono riproposte sulla spiaggia, dove ogni gruppo ha ricavato una sua nicchia
lavorativa all’interno dell’economia turistica informale, in base all’appartenenza etnica.
Durante la bassa stagione, il numero di lavoratori sulla spiaggia supera di gran lunga i pochi
turisti che si avventurano fuori dai confini degli alberghi. In questo periodo molti venditori di
safari e boat operators siedono per la maggior parte del tempo sui grossi scogli e guardano
verso i resort in attesa di vedere qualche ospite scendere le scale. Visivamente, appaiono
come una sorta di cordone che impedisce il libero accesso al mare (vedremo tra poco i
rapporti fra management alberghiero e beach operators e le politiche pubbliche che
regolamentano la loro presenza sulle spiagge sui cui affacciano i complessi turistici). Il
rapporto numerico fra turisti e locali a sfavore dei primi e il fatto che essi siano, nella maggior
parte dei casi, “nuovi” in un ambiente, percepito quindi come non familiare, contribuisce a
generare una sensazione di disagio, come se a essere fuori luogo fossero proprio i turisti che,
! 79!
per vivere la loro vacanza da sogno sulle candide spiagge del Kenya, hanno pagato somme
considerevoli di denaro. È una sensazione che io stessa ho provato in più di un’occasione nel
trovarmi quasi da sola sulla spiaggia di fronte a un numeroso gruppo di locali che mi
apparivano perfettamente a loro agio.
La presenza dei locali sulla spiaggia con le loro mercanzie e il loro andirivieni, e le alghe, che
soprattutto durante la stagione delle piogge infestano le spiagge, creano un’antitesi fra gli
spazi esterni agli alberghi e quelli interni, caratterizzati, invece, da un ordine meticoloso e da
un’accurata perfezione degli ambienti. Alcuni fra gli occupanti della spiaggia (boat operators,
venditori di safari e massaggiatori) indossano un’uniforme di colore diverso a seconda del
ruolo svolto, proprio come all’interno dei resort dove, per esempio, i giardinieri indossano
una divisa verde e le guardie una divisa interamente bianca, riproducendo la formalità
istituzionalizzata dell’interno anche all’esterno dei complessi alberghieri e creando in questo
modo una parziale continuità visiva fra il dentro e il fuori.
Mombasa Beach durante la bassa marea
Venditori e operatori che lavorano sulla spiaggia occupano un’area compresa fra due confini:
da una parte, quello del mare e quello dei resort, sorvegliati da guardie in divisa munite di
! 80!
manganelli, dall’altra. A destra e a sinistra i confini naturali formati dalle rocce chiudono la
spiaggia e impediscono il passaggio quando il mare la invade per alcune ore del giorno e della
notte. L’accesso alle strutture è costituito da una o più scale ed è precluso a tutti quelli che
non sono ospiti. Soltanto i clienti possono attraversare i confini degli hotel e giungere in riva
al mare scendendo le scale; tutti gli altri devono percorrere alcune stradine sterrate che la
collegano alla strada asfaltata. I movimenti che le persone possono compiere sono dunque
diversi: i turisti possono attraversare i confini e occupare lo spazio della spiaggia e quello dei
resort come ospiti legittimi; le traiettorie dei “beach boys” circoscrivono il perimetro degli
alberghi e incontrano i turisti negli spazi del fuori, più precisamente in prossimità degli
accessi, ovvero sulla spiaggia e in prossimità dell’ingresso principale, costituito da un grande
cancello sorvegliato. Quando l’alta marea sale, impedendo ai turisti di scendere in spiaggia, i
“beach boys” – ai quali essi avevano precedentemente commissionato qualche souvenir −,
possono incontrarli fuori dal cancello principale.
In corrispondenza delle principali località turistiche della costa keniota, i resort sorgono a
ridosso del litorale sabbioso e, nella maggior parte dei casi, molto vicini l’uno all’altro.
L’acquisto di terre costiere da parte di promotori dell’industria turistica per costruire strutture
ricettive, ha determinato in molti casi la chiusura, perlopiù illegale, degli accessi pubblici alle
spiagge (Daily Nation, 1 giugno 2013). Le spiagge di Mombasa − come quelle di Malindi,
Watamu e Diani − sono normalmente utilizzate anche dalla popolazione locale sia per le
attività legate alla pesca sia per quelle ricreative, soprattutto durante il fine settimana quando
molti giovani e famiglie con bambini, vi si recano per divertirsi e passare il tempo.
Attualmente, le uniche spiagge pubbliche a nord di Mombasa dotate di strade di accesso sono
Jomo Kenyatta e Nyali Beach; gli accessi alle restanti spiagge sui cui si affacciano gli hotel
sono stati sbarrati da mura che impediscono il transito a chiunque non sia ospite dell’albergo,
oppure, sono stati ridotti a stretti sentieri, rappresentando un problema per la pubblica
sicurezza in caso di evacuazione. In seguito alle proteste della popolazione locale cui viene
impedito il libero accesso alle spiagge, oltre che l’utilizzo delle risorse, la National Land
Commission (NLC) ha iniziato a muoversi in direzione di una verifica delle terre,
illegalmente acquistate da investitori stranieri, per ripristinare il libero accesso alle spiagge
pubbliche da parte dei locali (Daily Nation, 27 giugno 2013), mostrando come la
delimitazione di un terreno sia contingente e provvisoria. Alcuni provvedimenti, che hanno
portato all’abbattimento di mura costruite sulle strade che portano al mare, sono già stati
messi in atto, ma la percezione che lo stato non stia facendo abbastanza è molto diffusa fra gli
abitanti della costa (Daily Nation, 1 giugno 2013).
! 81!
Sentiero sterrato che dalla strada asfaltata porta a Nyali Beach
Tuttavia, al tentativo di confinamento della popolazione locale e degli operatori turistici che
lavorano sulla spiaggia al di fuori dagli spazi a uso esclusivo dei turisti, corrisponde un
confinamento di questi ultimi all’interno dei resort. Questi offrono ai loro clienti tutto ciò di
cui possono avere bisogno e, anche nel caso di tour organizzati ed escursioni, i contatti con la
realtà locale sono ridotti al minimo. Tutto è costruito per contenere i turisti all’interno di
strutture e percorsi preordinati, nel tentativo di mantenere un controllo sui beni di cui essi
sono portatori, come vedremo più avanti.
I confini rappresentati dagli alberghi e dai muri eretti in corrispondenza dei passaggi di
accesso al mare, rappresentano a livello fisico e visivo il confine che separa i turisti – e le loro
possibilità economiche grazie alle quali possono godere il meglio che il paese ha da offrire −
e i locali, parzialmente espropriati dei propri spazi ricreativi e lavorativi. Queste mura parlano
del processo di costruzione dell’industria turistica che, sin dalle prime fasi, ha escluso la
popolazione autoctona da un coinvolgimento diretto nel suo sviluppo e dal godimento dei
benefici economici da essa derivanti.
Vi sono dei limiti imposti dalle guardie dei resort unite a sollecitazioni reiterate che mettono
in evidenza dinamiche di occupazione e di respingimento. Nel tentativo di avere la possibilità
di approcciare per primi i turisti, i “beach boys” si avvicinano spesso alle scale da cui gli
! 82!
ospiti degli hotel scendono per raggiungere la spiaggia. È in prossimità delle scale che
avvengono i primi scambi verbali fra le parti. Le guardie in questi casi invitano i “beach
boys” a spostarsi più lontano per non impedire il passaggio. Io stessa, mentre stavo parlando
con Nelson, sono stata invitata a spostarmi in un modo che sapeva di un ordine piuttosto che
di un invito; quando ho chiesto alla guardia la motivazione di questa richiesta, mi è stato
risposto che impedivamo il passaggio sebbene la scala fosse larga più di tre metri e vi era
dunque tutto lo spazio necessario per consentire ad altre persone di passare. Bonnie e Nelson
mi hanno spiegato che in molte occasioni essi intimano loro di allontanarsi cercando di
relegarli ai margini della spiaggia. Talvolta capita, come mi ha raccontato Nelson, che le
guardie si rivolgano loro in swahili nel momento in cui stanno parlando con gli ospiti, così
che questi ultimi non possano comprenderli; la reazione però non è quella di seguire l’ordine,
bensì fingere di non sentirli. Ho sentito spesso le guardie rivolgersi ai “beach boys” con gli
appellativi di “rasta”, “no hair”, “shaggy hair”, che sintetizzano una caratteristica fisica
ridicolizzandola. Il ricorso a questi nomignoli, oltre a categorizzare un preciso gruppo di
persone, identificandole attraverso uno stile che si differenzia volontariamente dal resto dalla
popolazione della costa, contribuisce a enfatizzare una distanza fra un “noi” − partecipanti
regolari dell’economia formale e rappresentanti dell’industria turistica istituzionalizzata −, e
un “loro”, occupanti illegittimi di uno spazio destinato ai turisti. L’istituzione di mura, limiti e
divieti, comporta, da parte degli attori sociali, il susseguirsi di azioni generative per il
mantenimento dei confini che, non essendo dati una volta per tutte, possono essere messi in
discussione e attraversati.
Sulla base dei racconti di Bonnie e Nelson, i rapporti fra “beach boy” e guardie, dipendenti
dei resort non sono sempre espressi in termini conflittuali. Sebbene allo staff alberghiero sia
proibito fare affari con i clienti, può capitare che se un ospite dell’albergo chieda a un
membro dello staff un aiuto per eventuali acquisti o servizi, questi si rivolga a uno dei “beach
boys” concedendogli poi una commissione. Può anche capitare che, per la stessa ragione, il
membro dello staff scelga di consigliare all’ospite un “beach boy” in particolare che, al
termine della transazione, condividerà con lui una parte dei guadagni. Le guardie possono
dunque assumere, talvolta, il ruolo di intermediari fra i clienti dei resort e i “beach boys”,
talaltra possono anche svolgere il ruolo di informatori fornendo a questi ultimi notizie
sull’afflusso dei turisti, su numero e provenienza degli ospiti e, più in generale, su ciò che
accade all’interno delle strutture. Nel rapporto fra “beach boys” e membri dello staff, i turisti
svolgono un ruolo fondamentale poiché è soltanto con loro che i confini possono essere
attraversati ed è possibile negoziare la propria posizione rispetto agli altri attori sociali.
! 83!
Quando per esempio un “beach boy” si accorda con un turista per incontrarsi fuori dal
cancello principale e questi non si presenta, le guardie lo costringono ad allontanarsi
impedendogli di sostare davanti al cancello, anche se conosce il nome dell’ospite. Se però
quest’ultimo si presenta allora le guardie iniziano a comportarsi in modo amichevole (anche
nella speranza di ottenere un piccolo compenso), consentendogli, le volte successive, di
aspettarlo al di qua del cancello.
L’unico modo per i “beach boys” di entrare in uno dei resort è essere l’accompagnatore di un
ospite. Secondo le parole di Nelson: “Only you have the power to let me in”. In più di
un’occasione Bonnie e Nelson hanno messo in evidenza come nel caso in cui fossero entrati
con un turista all’interno dell’hotel, lo staff avrebbe dovuto trattarli con gli stessi riguardi,
mostrando grande interesse per questa possibilità.
I “beach boys” fanno un uso mirato dello spazio. Come ha riferito Peake (1989: 211), lo
status per un “beach boy” deriva dall’essere visto regolarmente nelle aree frequentate dai
turisti, dando l’impressione di essere ricco senza darsi troppo da fare per diventarlo. Miriam
Eid Bergan, che ha condotto una ricerca fra i “beach boys” di Malindi per la sua tesi di master
presso la University of Bergen nel 2011, ha riscontrato la medesima attitudine nei “beach
boys” di maggiore successo. La loro preferenza accordata ai locali frequentati dai turisti,
persino durante la bassa stagione (fatto che consente alla maggior parte di queste attività di
restare aperte anche in assenza di visitatori e residenti europei), segnala alla popolazione
locale e agli altri “beach boys” che essi hanno disponibilità economiche e dunque status
(Bergan 2011: 87). Peake riporta di casi in cui la presenza di “beach boys” in locali per turisti
è diventata talmente predominante che questi ultimi hanno finito per frequentarli sempre più
raramente. Queste appropriazioni degli spazi turistici sono vissute dai “beach boys” come
vere e proprie conquiste (Peake 1989: 213). Per estensione, sostiene Peake, l’appropriazione
di spazi per turisti e anche di un leisure life style (attraverso uno stile di vita rilassato, ma
anche attraverso un particolare tipo di abbigliamento) può essere compreso come un tentativo
di catturare l’intero mondo dei turisti.
I “beach boys”, dunque, fanno un uso strategico degli spazi a uso dei turisti, che risponde al
desiderio di controllare il loro mondo, o almeno, di mostrarsi parte della cultura (del tempo
libero) occidentale (Bergan 2011: 87). Le “pratiche di sconfinamento” descritte finora
mostrano come i confini possano anche essere attraversati. Essi sono dunque situazionali
perché variano a seconda del soggetto e della relazione che un determinato soggetto mantiene
con gli altri attori sociali. Come messo in evidenza da De Certeau, i confini sono elusivi e gli
spazi non sono costituiti da rigidi insiemi di norme e regole, perfettamente messe in opera e
! 84!
rispettate, ma sono pratiche spaziali (spazi praticati), caratterizzate da trasgressione,
manipolazione, resistenza e appropriazione (De Certeau 2005). I movimenti degli attori
sociali, che circoscrivono lo spazio e attraversano confini, possono anche essere interpretati in
accordo alla prospettiva di Ingold (2000), secondo il quale il movimento costituisce una
forma continua di appropriazione simbolica degli spazi. Questa interpretazione del
movimento è particolarmente interessante se si considerano le spiagge di Mombasa come
luoghi conflittuali, in cui diversi attori sociali, ma anche forze governative, sono in
competizione per il controllo delle risorse disponibili in quel luogo.
I “beach boys”, quindi, attraverso i loro spostamenti spaziali e la loro stabile presenza sulle
spiagge, vivificano gli spazi del “dentro” e del “fuori”, e nel momento in cui li attraversano,
rompono − seppure temporaneamente − le delimitazioni spaziali naturali e artificiali,
delineando tragitti carichi di significato. Il loro uso strategico degli spazi a uso dei turisti, la
loro presenza sulle spiagge costantemente ribadita a livello sia pratico sia discorsivo, le loro
traiettorie che attraversano e circoscrivono gli spazi, possono essere interpretati come tentativi
di territorializzazione di uno spazio su cui essi rivendicano diritti di accesso e da cui deriva
anche la loro posizione sociale − l’essere un “beach boy” − secondo la definizione di territorio
proposta da Godelier nel saggio “L’ideale e il materiale”:
Se si designa per territorio un settore della natura e, quindi dello spazio sul quale una
società rivendica e garantisce, a una parte o a tutti i suoi membri, dei diritti di accesso, di
controllo e di uso e di tutte o di una parte delle risorse che vi si trovano, risorse che la
società desidera e che è in grado di sfruttare (1985: 87).
Nelle loro pratiche spaziali, i “beach boys”, intersecano altre pratiche (quelle dei turisti), ma
anche attori sociali e discorsi, facendoli apparire; essi rendono visibili alcune possibilità e
interdizioni dell’ordine spaziale, le fanno allo steso tempo essere, attraversando i confini ed
eludendo le chiusure spaziali imposte. Il camminare, dice De Certeau, è “un’appropriazione
dello spazio attraverso un io, ha altresì come funzione quella di porre l’altro di fronte a questo
io e di creare così un’articolazione congiuntiva e disgiuntiva di luoghi (2005: 153).
4.3. I “beach boys” e le politiche nazionali
La posizione del governo keniota nei confronti dei “beach boys” è, ed è stata ambivalente, sin
dagli anni Ottanta – gli anni in cui l’industria turistica iniziò la sua crescita esponenziale. Da
! 85!
un lato, il governo ha cercato di rispondere alle sollecitazioni dei manager alberghieri, che
spesso hanno lamentato una noncuranza da parte delle forze politiche nei confronti di quella
che per loro costituisce una minaccia allo sviluppo turistico, ovvero la presenza sulle spiagge
dei “beach boys”, che impediscono ai turisti di godersi la vacanza in tranquillità; dall’altro, i
tentennamenti degli apparati di governo nella gestione della situazione esprimono la
consapevolezza, da parte delle forze politiche, dell’interesse che una parte del turismo
internazionale manifesta per i “beach boys” (sia le turiste interessate a intraprendere relazioni
sessuali o affettive con giovani uomini locali, sia i turisti intenzionati a entrare in contatto la
cultura del posto al di fuori dell’esperienza standardizzata offerta dalle strutture turistiche).
Ne sono dunque conseguite politiche che, anche quando effettivamente applicate, non hanno
mai portato a soluzioni definitive e a prese di posizione nette, nemmeno da parte del
management alberghiero. Infatti, i provvedimenti adottati sono oscillati fra tentativi di
confinamento al di fuori delle spiagge e sforzi di ordinamento, attraverso meccanismi di
identificazione, come l’obbligo di indossare uniformi e badge.
Il primo progetto di legge38, proposto all’inizio degli anni Novanta dall’allora Ministro del
turismo Nicholas Biwott, iniziato ma in seguito abbandonato a causa dell’opposizione di
alcuni leader politici legittimava in un certo senso l’hustling, pur cercando al contempo di
esercitare su di esso un controllo attraverso l’emissione di licenze e l’obbligo di indossare
uniformi e badge. Un secondo disegno di legge, il Tourism Bill − promosso nel 2007
dall’attuale Ministro del turismo Najib Balala − intendeva ricollocare i “beach boys” sulle
strade di accesso al mare, anziché sulle spiagge. A Mombasa, l’amministrazione locale ordinò
agli operatori turistici di piccola scala che, dietro provvigione, impiegavano locali per vendere
safari sulle spiagge − di trasferirsi, entro il 10 marzo 2009, in un nuovo spazio a Bamburi (a
nord di Mombasa) destinato alla costruzione di negozi di souvenir (Daily Nation, 16 febbraio
2009). Il governo, in questo modo, intendeva risolvere simultaneamente due questioni: la
presunta congestione delle spiagge dovuta all’ingente presenza di “beach boys”, accusati, fra
l’altro, di arrecare disturbo ai turisti, e il monopolio dell’offerta turistica. Riducendo il
numero di procacciatori di clienti, il monopolio del business legato alla vendita di safari,
sarebbe confluito nelle mani di pochi grandi tour operator (Daily Nation, 16 febbraio 2009),
con conseguenti enormi vantaggi in termini economici.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!38!Provvedimenti simili sono stati adottati anche in altri paesi africani con gli stessi obiettivi. Si veda per esempio Naomi Brown, "Beach Boys as Culture Brokers in Bakau Town. Gambia", Community development journal, vol. 27, n. 4 (1992), pp. 365-366
! 86!
Il progetto provocò reazioni risentite da parte della comunità operante sulle spiagge
all’interno dell’economia turistica informale. I “beach boys” espressero il loro disappunto
attraverso manifestazioni che coinvolsero più di 4000 dimostranti (Daily Nation, 16 febbraio
2009). Il programma, mai approvato, ma allo stesso tempo mai abbandonato, è stato
riconsiderato nel 2011 dal Ministro del turismo, con l’aggiunta, accanto al piano di
ricollocamento dei “beach boys” in aree separate, di una significativa integrazione: la
registrazione obbligatoria “per ottimizzare i loro servizi e sradicare gli operatori illegali”
(Daily Nation, 29 marzo 2011). In occasione di un meeting con i rappresentanti degli
operatori, il Ministro Balala, per spiegare i contenuti del nuovo provvedimento di legge, ha
commentato: “Questa legislazione è una buona cosa per i beach operators perché avremo
unità di gestione che saranno ufficializzate. Oltre a perseguire i propri interessi commerciali,
essi saranno anche coinvolti in attività finalizzate al miglioramento della sicurezza e della
pulizia [sulle spiagge]. […] Attualmente, tutti gli operatori sono stati etichettati con il nome di
‘beach boys’, un’identità negativa associata con il molestare i turisti, il furto, la vendita di
droghe e la prostituzione. Ma questo finirà e la Polizia Turistica potrà lavorare con un gruppo
legalmente riconosciuto” (Daily Nation, 29 marzo 2011).
Ancora nel 2013, mentre ero a Mombasa, il Daily Nation riportava come il distretto di Kilifi
avesse stanziato 40 milioni di scellini per la creazione di aree commerciali destinate ai beach
operators che, una volte ultimate, avrebbero determinato il loro allontanamento dalle spiagge
(Daily Nation, 9 luglio 2013).
Un’altra strategia promossa dal governo per arginare il “problema” dei “beach boys”, ha
previsto l’incremento della polizia turistica sulle spiagge. Il governo nel 2012 ha messo a
diposizione del KWS, 150 milioni di scellini per “migliorare e rinnovare il prodotto ‘spiaggia’
che è stato a lungo la maggiore attrazione [turistica del paese]” (Daily Nation, 15 marzo
2012). Per raggiungere l’obiettivo, il KWS ha rinforzato la sicurezza sulle spiagge, destinando
alle principali località turistiche un certo numero di agenti.
Nella quotidianità delle interazioni fra “beach boys” e forze dell’ordine, le politiche e i
provvedimenti governativi si applicano raramente nelle loro originarie intenzioni,
traducendosi piuttosto in pratiche negoziali. Vorrei a questo proposito raccontare un episodio
indicativo accaduto proprio durante il mio ultimo giorno in Kenya.
Mentre parlavo con Bonnie sulla spiaggia, abbiamo visto la Polizia Turistica portare via un
ragazzo in manette e, poco dopo, due uomini vestiti in blu insieme a un poliziotto e a un
secondo ragazzo sempre in manette. Nell’attraversare la spiaggia antistante al Voyager Beach
Hotel, uno dei ragazzi si è rivolto a Bonnie in swahili e, successivamente uno degli agenti,
! 87!
sempre in swahili, ha avvertito Bonnie che sarebbero tornati per vedere anche la sua licenza.
Bonnie mi ha spiegato che il mese prima la Polizia Turistica, all’interno di un’operazione
volta a “ripulire” le spiagge fra Mombasa e Malindi, aveva fermato i presenti e ritirato alcune
licenze. I due ragazzi, infatti, non avevano più la loro licenza e per questo rischiavano di
essere arrestati e trattenuti. Bonnie ha spiegato come per riavere la licenza sia necessario
passare attraverso il chairman della spiaggia che, a sua volta, avrebbe dovuto rivolgersi al
KWS per riottenere la licenza, dietro corrispettivo di una somma di denaro. Stavamo
parlando di questo, quando Bonnie ha ricevuto una telefonata. Si trattava di uno dei ragazzi
portati via poco prima dalla Polizia Turistica che, dalla spiaggia vicina al Voyager, lo
chiamava per chiedere in prestito 1000 scellini (circa 10 euro) da consegnare al poliziotto per
essere liberato. “In alcuni casi se dai loro qualcosa, può essere che ti lascino stare. Altre
volte, pretendendo di vedere la licenza, la trattengono chiedendoti soldi per riaverla indietro.
Io non intendo più consegnare la mia licenza nelle mani della Polizia Turistica, io ho il diritto
di stare sulla spiaggia, non ho né rubato né spacciato” (Bonnie, 6 luglio 2013). Il commento
di Bonnie relativo al trattamento della polizia, descritto come ingiusto, riconduceva il
comportamento corrotto degli agenti all’agenda politica del presidente che, a seguito dei costi
ingenti sostenuti durante la compagna elettorale, tentava di rientrare delle spese. La
percezione di Bonnie, condivisa anche da altri “beach boys” con cui ho avuto modo di
parlare, è quella di un Presidente interessato ad arricchire se stesso e il gruppo etnico a cui
appartiene, i Kikuyu.
Nella visione di Bonnie, la Polizia Turistica è un’estensione del presidente che, per perseguire
i suoi scopi, vessa la popolazione, a eccezione dei kikuyu. L’opinione espressa da Bonnie per
spiegare l’azione della Polizia Turistica si può inquadrare all’interno di una visione dello
Stato corrotto, capace di pensare unicamente ai suoi interessi. In quanto unica forma della
presenza statale, le forze dell’ordine insinuano, presso la popolazione locale, la convinzione
che le istituzioni siano poteri arbitrari e corrotti.
L’esibizione del potere da parte degli agenti di polizia davanti ai turisti incuriositi, come
l’ammanettare un ragazzo e il lento attraversare la spiaggia, è funzionale alla trasmissione di
un senso di sicurezza e protezione. Il trattamento che riservano ai “beach boys”,
indipendentemente dal fatto che essi possiedano, o no, una licenza, concorda con il linguaggio
utilizzato da politici e media, ma anche dai manager e dallo staff alberghiero: appellandoli
con termini quali “minaccia” o “pericolo” (Daily Nation, 2 dicembre 2012), e accusandoli di
prostituzione, furto, consumo e spaccio di droghe, senza fare distinzioni, contribuiscono alla
criminalizzazione della loro condizione.
! 88!
Tali interventi esemplari, unitamente alle politiche governative volte ad arginare la presenza
dei “beach boys” sulla spiaggia, mostrano come lo Stato si forzi di marginalizzare e
rinchiudere secondo la logica oppositiva del dentro/fuori. Il governo costruisce confini fisici e
virtuali fra chi è legittimato a operare sulla spiaggia e chi no. Attraverso la sorveglianza
operata dalla Polizia Turistica e quella esercitata dall’industria del turismo, nella forma
discorsiva che presenta i “beach boys” come minaccia allo sviluppo turistico e pericolo per la
sicurezza dei turisti, lo Stato aspira a ottenere il controllo su uno spazio percepito come
confuso, dove i flussi di denaro fra turisti e locali, sfuggono al controllo statale. Le spiagge
emergono come spazi misteriosi di interferenza dove i turisti possono interagire con i “beach
boys” e dove il loro denaro può essere attinto in modo incontrollabile da individui che non
sono membri ufficiali dell’industria turistica. Le relazioni fra gli attori sociali e, per
estensione, lo Stato, assumono una natura prevalentemente conflittuale, in relazione al
controllo delle risorse rappresentate dai turisti. L’impossibilità dello Stato di definire con
precisione il numero e la provenienza dei “beach boys” che frequentano le spiagge, genera un
senso di ansietà che si esprime sia nelle azioni disorganiche, attraverso cui esso cerca di
monitorare e controllare la loro affluenza, sia nei ricorrenti articoli della stampa nazionale,
perlopiù interessati a diffondere l’immagine di un governo in grado di gestire la situazione e
volto a favorire lo sviluppo turistico del paese. È bene notare come la stampa specializzata
fornisca un contributo importante alla costruzione dell’immaginario turistico (“paradiso
tropicale”, “paese del sorriso”, “paese ospitale” ecc.) che, sebbene fortemente stereotipata, è
profondamente rassicurante dal momento che esclude dal quadro gli aspetti delicati e
complessi dei paesi presentanti, come, per esempio, le condizioni politiche, sociali ed
economiche dei luoghi di destinazione (vedi cap. 2). Il contatto dei turisti con la popolazione
locale può portare, pertanto, allo svelamento dei problemi e delle contraddizioni che
caratterizzano i siti turistici, minando l’immagine di società semplici, con popoli accoglienti e
sorridenti, animati da una grande voglia di vivere nonostante le difficoltà, promossa dalla
pubblicistica turistica e dalle politiche nazionali.
Nei discorsi pubblici la presenza incontrollata dei locali sulle spiagge è così tradotta in un
supposto senso di insicurezza esperito dai turisti: la difficoltà di stabilire chi può beneficiare
degli scambi commerciali, spinge lo Stato a connotare negativamente i contatti fra
popolazione autoctona e turisti, allorquando al disorientamento del primo viene fatta
corrispondere una diminuzione della sicurezza dei secondi.
Tale corrispondenza legittima lo Stato ad attuare pratiche di esclusione nei confronti di una
parte della popolazione locale (in favore della sicurezza e della tutela dei turisti),
! 89!
deresponsabilizzandosi della condizione di marginalità rispetto al settore turistico con cui tale
fetta della popolazione è costretta a convivere.
4. 4. Interazioni fra turisti e “beach boys”: stereotipi e generalizzazioni
Abbiamo visto come la spiaggia sia popolata da persone di diversa provenienza etnica e come
esse si siano divise il mercato dell’offerta turistica ricavando nicchie occupazionali sulla base
delle differenti appartenenze etniche. I rapporti fra gli attori sociali presenti sulla spiaggia, che
comprendono anche le guardie degli alberghi, sono spesso caratterizzati da tensioni dovute sia
al reciproco posizionarsi all’interno dell’economia turistica, formale o informale, sia alla
competizione per i possibili vantaggi economici derivanti dal contatto con i turisti.
A Mombasa non sono rari i conflitti fra samburu e masai o giriama, per l’ottenimento, o
perfino per la monopolizzazione, dell’accesso ai resort turistici. Nel 2005, per esempio,
cinque samburu ilmurran39 furono pugnalati a morte in uno scontro con un gruppo di giryama
(Meiu 2009: 119). I conflitti emergono anche all’interno di medesimi gruppi etnici e sono per
lo più causati da invidia e competizione (Meiu 2009: 120). Sulla spiaggia, eventuali scontri o
tensioni sono regolamentate da un chairman: egli decide chi può essere ammesso a lavorare
sulla spiaggia e chi no; in caso di diatribe, può stabilire la colpevolezza o l’innocenza
dell’accusato e la sanzione cui sarà soggetto (per esempio, il divieto di recarsi sulla spiaggia
per un dato periodo). Il chairman è incaricato anche di gestire i rapporti con il KWS e con i
manager alberghieri nel caso in cui, per esempio, gli ospiti lamentino presso l’hotel di aver
avuto qualche problema con i “beach boys”. In quel caso il chairman dovrà indagare
sull’accaduto e giudicare il provvedimento da adottare contro chi sarà ritenuto responsabile.
Come più volte Bonnie ha ribadito: “There are rules and regulations on the beach that we
must follow to be allowed to stay here”. Queste regole comprendono: indossare l’uniforme,
non ammettere nessuno alla spiaggia senza il consenso del chairman, rispettare la fauna e la
flora marina, secondo il regolamento che vige nei parchi marini della costa.
I rapporti fra beach operators e turisti, come anche tra beach operators fra loro, sono
comunemente mediati da stereotipi. Durante una delle nostre conversazioni, Bonnie ha
evidenziato come la sua simpatia nei confronti dei turisti fosse condizionata dalla loro
nazionalità. Gli italiani (evidentemente perché io stessa lo sono) erano in cima alla sua scala
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!39!lmurrani (plurale: ilmurran) è una parola Maa (la lingua parlata dai masai) che significa “giovane uomo” o “guerriero”. Il periodo durante il quale un uomo è lmurrani è un intervallo di tempo che va dai quindici anni, momento in cui un ragazzo è iniziato attraverso la circoncisione, e finisce con l’inizio di una nuova fascia di età.
! 90!
di gradimento, seguiti da francesi e dai tedeschi che però, a suo dire, preferiscono “stare sulle
loro”. Gli italiani, al contrario, risultano essere più amichevoli e disposti alla conversazione e
a farsi accompagnare in tour per la città, per locali e safari blue. Una valutazione a parte
spetta agli inglesi, che, nell’opinione di Bonnie, non godono di molta considerazione.
Memore del vissuto dei suoi familiari durante i tempi della colonizzazione, egli dice di
provare ostilità verso i britannici responsabili, in passato, di vessazioni e oppressioni ai danni
della popolazione locale. Sottolinea come il suo atteggiamento verso di loro sia puramente
interessato all’ottenimento di un vantaggio economico, senza alcun interesse nello stabilire un
qualsiasi tipo di relazione.
De Albuquerque (1998: 51) ha osservato come fra i ”beach boys” della Repubblica
Dominicana vi sia una gerarchia di preferenze accordate alle turiste sulla base di nazionalità,
ricchezza, età e attrattiva: le canadesi francofone sono considerate più emancipate in fatto di
pratiche sessuali e più disponibili, e dunque più facili da avvicinare; seguono poi le canadesi
anglofone e le italiane, mentre le americane sono giudicate le più difficili da persuadere
perché più prevenute rispetto alla possibilità di avere rapporti sessuali con uomini di colore.
Bergan (2011: 92) ha notato come fra i “beach boys” di Malindi vi sia la convinzione che tutti
i wazungu40 siano ricchi. In particolare, gli attributi di ricchezza e benessere dei turisti variano
in base all’età: più un turista è giovane, meno sarà benestante. Molte relazioni fra “beach
boys” e turiste occidentali, infatti, coinvolgono donne mature, ovvero il target privilegiato.
La pratica di stereotipare l’altro non è un’esclusiva dei turisti occidentali. In contrapposizione
alla nozione di “orientalismo” proposta da Edward Said (1979), quella di “occidentalismo” si
riferisce alle immagini stilizzate dell’Occidente41. Queste due nozioni sono utili per delineare
i diversi stereotipi utilizzati per descrivere l’alterità nelle relazioni fra “beach boys” e turiste
occidentali.
Gli stereotipi ricorrenti fra locali e fra questi e i turisti, interessano non solo gli aspetti legati
all’appartenenza etnica, ma anche le sfere della sessualità e del genere. Le relazioni sono
orientate anche dagli stereotipi di genere e dalle aspettative sociali connesse con
l’appartenenza a un genere oppure all’altro. Per i locali, il fatto che le turiste occidentali siano
bianche è spesso indice di una sessualità perversa (Meiu 2009: 125). Neville Hoad, autore del
volume African Intimacies: Race, Homosexuality, and Globalization (2007), suggerisce come
gli attacchi discorsivi verso la sessualità occidentale, in Africa, “possano essere visti come !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!40!Il termine swahili wazungu (muzungu al singolare) è utilizzato comunemente in Kenya per indicare i bianchi. A Mombasa, quando si vuole evitare di essere capiti dagli stranieri occidentali, si ricorre anche al termine mgozo. 41 James. G. Carrier, “Introduction”, in J. G. Carrier (a cura di), Occidentalism Images of the West, New York, Oxford University Press, 1995, citato in Bergan 2011: 92!
! 91!
una risposta ad […] antecedenti attribuzioni di primitivismo [nei confronti degli africani], e
come un ribaltamento dell’accusa razzista di ritardo mentale e/o degenerazione” 42. Le donne
bianche tendono a essere percepite attraverso questo prisma dell’immoralità che rende la loro
sessualità non-cristiana e, allo stesso tempo, non-africana (Meiu 2009: 125).
Pruitt e LaFont (1995: 430) scrivono che “l’alterità esotica” è stata costruita enfatizzando gli
aspetti della passionalità e della naturalità; in particolare l’uomo di colore è percepito come
più vicino alla sua eredità africana, impersonata nell’identità Rasta. Incarnando accuratamente
lo stile rasta, essi divengono attrazioni “culturali” (Albuquerque 1998: 91; Pruitt e LaFont
1995: 425). “I venditori di esperienze culturali”, afferma Sánchez Tayor, “devono essere i
portatori di identità molto specifiche di razza e di genere” (2000: 48).
L’autrice riferisce di come, a Cuba, in Giamaica e in Repubblica Dominicana (2000), i
giovani locali agiscano in accordo con il mito della sessualità maschile “nera” che descrivere
gli uomini come superdotati (big bamboo), per incontrare le fantasie erotiche “razzializzate”
delle turiste occidentali. In Repubblica Dominicana, sostiene Sánchez Tayor, i Sanky Pankies
ritengono anche di essere più romantici e sessualmente più attenti ai bisogni femminili,
rispetto agli uomini occidentali (Sánchez Tayor 2000: 50).
A Mombasa e a Malindi, Peake (1989) e Bergan (2011) mostrano come i “beach boys” siano
convinti che risulteranno più attraenti agli occhi delle turiste straniere se portano i dreadlocks
ed esibiscono fisici prestanti e atletici per soddisfare gli standard occidentali di bellezza e
appetibilità sessuale. In Gambia, Nyanzi, Rosenberg-Jallow e Bah, osservano come i “beach
boys” credano e agiscano sulla base del mito che attribuisce loro una forza sessuale superiore
e una speciale virilità” (2005: 565).
De Albuquerque a proposito dei “beach boys” caraibici scrive: “È stato ipotizzato che
l’incessante celebrazione dell’immaginario fallico è, in parte, una risposta giocosa allo
stereotipo bianco della primitiva potenza sessuale dei neri” (1998: 50).
In epoca coloniale, il corpo del nero è stato oggetto di una costruzione, fatta di occultamenti e
manipolazioni, volta a dimostrare una presunta superiorità morale dell’Occidente, come
evidenzia Ivan Bargna: “Il corpo del primitivo e in particolare del nero è sempre fortemente
sessualizzato facendone nel contempo oggetto di angoscia (invidia del pene del nero) e di un
piacere più facilmente accessibile (la nera che, nella sua sauvagerie, viene assimilata alla
prostituta)” (2009: 26). Al nero si associano quindi la sensualità, il piacere, la trasgressione,
l’erotismo, la libertà dalle regole. La sessualità “nera” è immaginata come “istintiva” e
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!42 !Nevill Hoad, African Intimacies: Race, Homosexuality, and Globalization, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2007, p. 56, citato in Meiu 2009: 125!
! 92!
“primitiva” e, dunque, molto più disinibita, appassionata e permissiva se paragonata a quella
“bianca”. A cavallo del secolo, il rapporto con l’alterità nera è mediato attraverso le immagini
pubblicitarie che contribuiscono a diffondere nel grande pubblico, una certa percezione
dell’Africa e degli africani. Il corpo del nero è utilizzato per reclamizzare prodotti come il
caffè, il tabacco, lo zucchero e le spezie: tutti generi di consumo ritenuti eccitanti ed esotici,
legati al godimento e all’istintività. Molte pubblicità in cui il corpo del nero è protagonista, ne
enfatizzano l’atleticità, contribuendo a instaurare un rapporto estetico con i corpi (Bargna
2009).
Si instaura un parallelo fra le rappresentazioni di paesaggi realizzate da esploratori europei
secondo la poetica romantica ottocentesca, come Livingstone e Burton, raccolte in volumi
come Africa and Its Exploration as Told by Its Explorers (1980?) e i corpi degli africani: se i
primi sono raffigurati come spazi “naturali” e “incontaminati”, caratterizzati da una natura
selvaggia e lussureggiante, pronti per essere occupati, i secondi condividono con i primi la
medesima apparente disponibilità a essere conquistati. La sessualità permissiva a loro
attribuita è associata al desiderio di un paradiso perduto.
Anche oggi, la pubblicistica turistica ripropone immagini di paradisi naturali e di natura
selvaggia a uso e consumo dei turisti. In concomitanza allo sviluppo del settore turistico, lo
stato postcoloniale iniziò a mercificare un certo patrimonio culturale fortemente basato su
paradigmi coloniali.
Nel secondo capitolo, è stato analizzato come il Kenya sia promosso dal mercato turistico
internazionale, come un luogo culturalmente diverso, per incontrare il desiderio di esotico che
spinge i turisti occidentali a viaggiare verso mete lontane. Tale diversità è stata costruita sulle
dicotomie di naturale e civilizzato, primitivo e moderno, esotico e mondano, tempo libero e
lavoro, tradizione e innovazione.
In particolare, nei discorsi sulla diversità culturale keniota, i masai − con i loro corpi magri e
slanciati, e il loro portamento nobile e fiero − sono emersi quale gruppo etnico
rappresentativo del patrimonio culturale della nazione e forse anche dell’Africa in generale.
Le politiche nazionali del turismo sono dunque aderenti alle immagini stereotipate diffuse dai
media globali, e si allineano con la produzione visuale e testuale promossa dall’industria
turistica internazionale e con la domanda del mercato globale, emergendo come una
destinazione del turismo sessuale che propone, fra le altre, rappresentazioni erotizzate di
masai e samburu.
I “beach boys” del gruppo etnico dei giriama, di cui anche Bonnie e Nelson fanno parte,
sembrano agire in accordo con gli stereotipi dominanti che attribuiscono alla popolazione
! 93!
locale nera un’identità iper-sessualizzata. Rispetto a questa, i “beach boys” si collocano in una
posizione di contiguità che permette loro di trarre vantaggio dalla richiesta di fantasie erotiche
“razzializzate”. In particolare, nel caso dei giovani giriama, sembra esserci anche una
coincidenza fra lo stereotipo keniota relativo al loro gruppo etnico e quello delle turiste
straniere. La popolazione locale attribuisce ai giriama qualità di “good lovers”: essi stessi
sembrano ricorrere a questa idea di superiorità sessuale sia nelle conversazioni con kenioti sia
con turisti (Bergan 2009: 93). Tale attitudine mostra come le nozioni locali siano in accordo
con gli stereotipi globali dell’alterità esotica e rende complesso stabilire, qualora esistesse, un
confine fra realtà e rappresentazione.
Nelle loro analisi dell’incontro hosts-guest, il sociologo del turismo Mac Cannell prima e
l’antropologo del turismo Bossevein poi, hanno applicato la prospettiva di Goffman – che
definisce la vita quotidiana degli individui come caratterizzata dalla presenza di due piani
paralleli, quello pubblico definito front-stage (ribalta) in cui l’attore mette in scena il suo io
sociale e il backstage (retroscena) in cui l’individuo torna a essere se stesso – all’interazione
turistica, dove le front regions designano la ribalta, luogo dell’incontro fra host e guest, e le
back regions il retroscena, ovvero la sfera privata degli ospitanti (Barberani 2006: 89-90). La
metafora teatrale, che paragona le front regions al palcoscenico e le back regions alle quinte,
consente di individuare due dimensioni: una pubblica in cui i locali mettono in atto processi di
rappresentazione dell’autenticità, e una nascosta e segreta, inaccessibile agli estranei e
pertanto ritenuta più autentica e per questo più desiderabile (Barberani 2006: 90).
In questo senso la spiaggia potrebbe essere considerata il palcoscenico, dove i locali mettono
in atto processi di “autenticità rappresentata” per assecondare le esigenze dei turisti, e le
relazioni sessuali fra i giovani uomini del posto e le turiste, un modo per queste ultime di
penetrare nell’intimità delle back regions.
Tuttavia, le interazioni fra giovani locali e turisti occidentali, fanno parte della quotidianità
degli host, rendendo difficile l’opposizione fra realtà e rappresentazione: anche la
rappresentazione fa parte della realtà e, per questo, non può essere considerata meno autentica
di un presunto retroscena (Barberani 2006: 123).
Inoltre, se i “beach boys” si comportano in accordo a una generalizzata rappresentazione
occidentale del Black African, il turismo in un paese straniero diventa un’estensione delle
immagini diffuse dai media e dai promotori turistici a livello globale. Come scrive Barberani,
l’insieme complesso di immagini mentali – che rappresentano proiezioni soggettive
culturalmente e storicamente determinate –, figure, simboli e immagini veicolate dai mass
media, pubblicità, fotografie, film e letteratura di viaggio, delineano l’immaginario turistico,
! 94!
che agisce direttamente sulle motivazioni turistiche e condiziona le modalità di interazione tra
host e guest (Barberani 2006: 213-214). La popolazione autoctona può cercare di appropriarsi
e adeguarsi agli elementi che costituiscono l’immaginario turistico dei guest; nel caso dei
“beach boys”, questo si traduce nell’incarnare stereotipi globali dell’alterità esotica di matrice
coloniale come strategia per capitalizzare sulla loro diversità etnica e sulla loro identità
culturale43.
Così, le turiste in cerca di un incontro con il diverso, rappresentato da giovani kenioti attraenti
e seducenti, entrano più che altro in contatto con un’immagine familiare della blackness.
Pertanto, nell’incontro fra turiste e “beach boys”, lo stereotipo agisce come una sorta di
confine virtuale che, se da un lato, è funzionale alla definizione della diversità sulla base di
nozioni condivise, dall’altro, contribuisce a stabilire e a mantenere un confine netto tra se
stessi e gli altri.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!43!Meiu fa ricorso al concetto di capitale etno-erotico per indicare sia l’abilità del soggetto di apparire “primitivo” o culturalmente diverso sia la sua probabilità di soddisfare gli standard occidentali di bellezza e appetibilità sessuale (2012: 6).
! 95!
Conclusioni
Il temine “beach boys” è impiegato dai media, dall’industria turistica e in letteratura per
indicare giovani locali che lavorano sulle spiagge destinate ai turisti, offrendo servizi di vario
genere, anche sessuali. Nel corso della tesi, ho cercato di mostrare come questa definizione
sia ricca di sfumature e contraddizioni dense di significato. In Kenya, il governo gioca con
l’opposizione delle categorie di “beach boys” e beach operators, impiegandole
alternativamente secondo il messaggio politico che sceglie di veicolare: generalmente, ricorre
al termine “beach boys” quando intende enfatizzare gli aspetti di minaccia e pericolo che essi
rappresentano per lo sviluppo turistico del paese e per la sicurezza dei turisti; mentre utilizza
quello di beach operators quando intende promuovere azioni finalizzate al monitoraggio e al
controllo, e piani di confinamento della comunità che opera sulle spiagge in aree dedicate,
separate da quelle a uso dei turisti. Nel primo caso, attribuisce ai “beach boys” comportamenti
delinquenti quali il furto, la prostituzione, lo spaccio di droghe, per giustificare pratiche di
esclusione (in favore della sicurezza e della tutela dei turisti) nei confronti di quella parte
della popolazione locale che, priva di prospettive socio-economiche, sopravvive ai margini
dell’economia turistica formale, cercando di sfruttare abilità e network di relazioni personali,
per crearsi opportunità di guadagno; nel secondo caso, opera una differenziazione fra “beach
boys” e beach operators nel tentativo di attuare politiche di ordinamento che prevedono
meccanismi di identificazione, come il rilascio di licenze e l’obbligo di indossare uniformi,
funzionali al perseguimento del controllo su uno spazio percepito come confuso, dove i flussi
di denaro fra turisti e locali sfuggono al controllo statale.
Ne emerge come il ricorso alla categoria di “beach boys” sia strumentalizzato dal governo per
criminalizzare una parte della popolazione locale, deresponsabilizzandosi così rispetto alla
condizione di marginalità sociale con cui tale fetta della popolazione è costretta a convivere.
La confusione, generata dal ricorso strategico a entrambe le categorie, è altresì funzionale a
impedire una vera e propria legittimazione della presenza e delle attività di questi uomini sulla
spiaggia; lo Stato mantiene una posizione ambivalente che gli permette di assecondare sia le
richieste insistenti del management alberghiero e di parte della popolazione turistica − che
vorrebbero vedere le spiagge libere dagli hustlers − sia di non disattendere le aspettative di
quei turisti che, oltre al lusso e al comfort delle loro sistemazioni, si aspettano di vivere
un’esperienza culturale, di incontrare, cioè, un po’ di quel colore locale rappresentato dalla
popolazione autoctona, o ancora, che desiderano autenticare il loro soggiorno in Kenya
attraverso una relazione intima con un giovane del posto. A questo proposito, Jamison (1999:
! 96!
952) scrive di come i “beach boys” costituiscano una parte importante del paesaggio di “sole
e divertimento” a Malindi, riferendo anche di come gli alberghi della costa assumano
atteggiamenti ambivalenti nei loro confronti: alcuni hotel gestiti da italiani ingaggiano beach
boys locali come guide turistiche full-time da assegnare a gruppi di ospiti internazionali;
mentre, al contrario, resort gestiti da tedeschi e inglesi sono soliti consigliare ai loro clienti di
evitarli (Jamison 1999: 953).
Nell’edizione italiana della nota guida turistica internazionale, Lonely Planet, all’interno di un
paragrafo intitolato “Pericoli e contrattempi”, si legge:
I cosiddetti beach boys saranno un fastidio, non c’è nulla da fare; oltre a sesso e souvenir, spesso
offrono anche droghe. Non di rado l’offerta di stupefacenti fa parte di una messa in scena in cui a un
certo punto appare anche un finto poliziotto che confisca le droghe estorcendo una grossa multa
(2006: 214).
L’edizione inglese li descrive come:
Beach boys – young Kenyan men who walk along the beaches selling everything from
woodcarvings to marijuana as well as sexual favours – are a fact of life at the big resorts and their
dogged persistence can be wearing. All you can do is refuse politely; they should move on quickly
enough (1996: 169).
Queste considerazioni rendono chiara la difficoltà che s’incontra nello stabilire chi sia
effettivamente compreso in questa categoria. Sono da considerarsi “beach boys” tutti i giovani
uomini che operano sulle spiagge del Kenya, come si evince dalle parole della guida turistica,
oppure è possibile distinguere un gruppo speciale?
I confini incerti di tale categorizzazione trovano spazio anche nei discorsi di senso comune in
cui il termine “beach boys” tende a essere riferito a coloro che lavorano sulla spiaggia,
indipendentemente dall’attività svolta e dall’età. Il personale dell’albergo e le persone del
posto, talvolta, riuniscono sotto questa denominazione tutti gli operatori, dai cammellieri ai
curio dealers44, ai boat operators, senza considerare le differenze di età. Meiu (2012: 24), per
esempio, mostra come molti elders45 del gruppo etnico dei Samburu, invecchiati sulla costa
per poi fare ritorno nei loro villaggi nel Kenya settentrionale senza alcun risparmio, siano
chiamati dagli altri membri della comunità “beach boy elders” o “elders of Mombasa”, per
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!44 Con questo termine si indicano i venditori di souvenir come braccialetti masai e animali della savana intagliati nel legno.!45 Con il termine elder si indica, fra i Samburu, la classe di età degli anziani, preceduta da quella dei giovani, moran, e ancora prima, da quella dei ragazzi pre-adolescenti.
! 97!
ridicolizzare il loro desiderio di ritornare giovani sulle spiagge della costa, nella speranza di
trovare una donna straniera con cui instaurare una relazione affettiva.
In uno studio sul turismo sessuale in Kenya, Kibicho (2009: 116) riferisce di come il governo
keniota riconosca ufficialmente tre categorie di beach operators: venditori di souvenir, boat-
operator locali e venditori di safari. Coloro che non rientrano in questa classificazione sono
considerati beach boys: sex workers, guide e interpreti improvvisati, spacciatori, venditori
ambulanti. Nella pratica, tuttavia, le categorie non sono così nette: i boat operator, che ho
conosciuto a Mombasa Beach, per esempio, lavorano principalmente alle dipendenze di
capitani di barche utilizzate per accompagnare i turisti in gite in barca, ma si adoperano anche
in attività collaterali, come organizzare tour in città o nei villaggi della costa e procurare
souvenir su richiesta.
Questi giovani rifiutano l’etichetta di “beach boys”, scegliendo di autodefinirsi hustlers,
beach operators o boat operators. Una propensione comune, emersa anche fra i beach boys di
Malindi (Peake 1989; Kibicho 2005; Bergan 2011), a conferma della volontà di dare
un’immagine positiva di sé, rifuggendo alle connotazioni negative implicite in questa
categorizzazione. Nel caso di uno dei ragazzi operanti a Mombasa Beach, il rifiuto arriva
anche a negare la presenza dei “beach boys” che, nella sua visione, con i loro comportamenti
sbagliati, sono stati la causa dell’attuale disprezzo per i giovani che, come lui, lavorano sulla
spiaggia. L’opposizione fra se stesso e i cosiddetti “beach boys” si basa sul fatto che questi
ultimi, a differenza sua e degli altri boat operators, non possiedono la licenza e non sono
dunque legittimati a lavorare con i turisti. Anche quando, durante le conversazioni, sono
emersi rimandi alle relazioni che alcuni di loro intrattengono con turiste occidentali, queste
non sono mai state espresse esclusivamente in termini di scambio pecuniario. Al contrario, in
riferimento, per esempio, ai tentativi di seduzione messi in atto da uno degli interlocutori nei
miei confronti, l’interesse per una “fidanzata italiana” si esprimeva, enfatizzando, da un lato,
la delusione nei confronti delle donne locali, interessate soltanto al denaro, dall’altro,
l’indipendenza e l’emancipazione delle turiste in fatto di valori e pratiche sessuali. Descriversi
come un ragazzo deluso e desideroso di intraprendere un rapporto basato sull’amore e non
sullo sfruttamento economico, gli consente di non identificarsi come un sex worker, rifiutando
anche l’associazione fra “beach boys” e prostituzione, prodotta dallo Stato.
I giovani, che operano a Mombasa Beach, si rifanno dunque alla classificazione enunciata dal
governo, che oppone “beach boys” e beach operators, per legittimare positivamente le loro
pratiche. È interessante come la legittimazione del loro ruolo sia basata sul possedere una
licenza rilasciata da un ente statale, il Kenyan Wildlife Service (KWS), benché il promotore di
! 98!
tali categorizzazioni sia proprio lo stesso governo che, nel condannare pubblicamente i “beach
boys”, opportunamente non fa differenze, contribuendo a produrre la loro esclusione. Inoltre,
possedere una licenza, contrariamente a quanto auspicato, non offre garanzie né contro i piani
di confinamento del governo né contro le azioni arbitrarie della Polizia Turistica – l’organo
statale incaricato della sicurezza dei siti turistici. Se nella forma discorsiva, questi giovani
locali aderiscono alla classificazione promossa dallo Stato per legittimare la propria
posizione, nella pratica emergono le contraddizioni insite nelle politiche pubbliche volte a
disciplinare la presenza e le attività della popolazione locale sulle spiagge turistiche, e nella
loro attuazione: le pratiche spaziali e le interazioni delle persone che operano sulla spiaggia,
esplorate nel quart capitolo della tesi, mostrano come, in realtà, i rapporti fra gli attori sociali
e, per estensione, lo Stato, assumano una natura prevalentemente conflittuale, in relazione al
controllo delle risorse rappresentate dai turisti per cui sono in competizione.
In letteratura, il ricorso alla categoria di “beach boys” per definire gli uomini locali che
intraprendono relazioni intime con turiste occidentali, nella speranza di ottenere un supporto
economico continuativo o, addirittura, un biglietto aereo per l’Europa, non è dunque esente da
conseguenze e rileva la problematicità di questa categorizzazione. Nella tesi ho cercato di
dimostrare come questa categoria non sia né neutra né “data” ma, al contrario, negoziata e
strumentalizzata, sebbene, a causa della brevità della mia permanenza a Mombasa, io non sia
riuscita a indagare approfonditamente né il punto di vista dei giovani locali sulle loro relazioni
con le turiste stranire, né il punto di vista della comunità cui questi ragazzi appartengono.
L’analisi sarebbe stata sicuramente più completa se fossi riuscita a indagare se il rifiuto della
definizione di “beach boys” sia espresso soltanto di fronte ai turisti, oppure, se questo temine
venga utilizzato dai questi giovani per descriversi fra loro.
Credo, tuttavia, sia necessario esplorare gli aspetti problematici che si celano dietro la
definizione di “beach boys”, per non cadere in facili generalizzazioni e per non assecondare le
pratiche di marginalizzazione che lo stato mette in atto nei confronti di quella parte di
popolazione esclusa non solo dalla condivisione dei benefici derivanti dal turismo, ma anche
da alcuni diritti sociali come il diritto allo studio, alla casa, al lavoro.
Nella tesi ho affrontato, poi, il dibattito scientifico sorto attorno alla necessità di definire le
relazioni intime fra uomini locali e turiste occidentali nei paesi a Sud del mondo nei termini di
turismo sessuale femminile o turismo romantico, cercando di mostrare come la priorità degli
studi sia stata quella di stabilire se le donne potessero collocarsi in una posizione di dominio
pari a quella dei consumatori del turismo sessuale.
! 99!
Alcuni studiosi hanno posto l’attenzione sugli aspetti dei rapporti di forza e di potere che le
turiste condividono con gli uomini dediti al turismo sessuale nei paesi in via di sviluppo,
cercando di integrare la prospettiva di genere con altri assi di differenza: la classe, la “razza”,
la nazionalità (de Albuquerque 1998; O’Connel Davidson 1998; Sánchez Taylor 2000, 2001,
2006; Kempadoo 2001). Secondo questi ricercatori, le turiste consumano fantasie razziste di
matrice coloniale dell’uomo di colore, descritto come “iperdotato”, “primitivo”, “naturale”,
“atletico”, oggettivando gli uomini locali nello stesso modo in cui le donne di colore sono
oggettivate come “Altre” dai turisti sessuali (Sánchez Taylor 2000: 47). Dunque, esse,
intenzionalmente o no, sfruttano i giovani del posto, approfittando delle diseguali strutture di
potere, locali e globali, per ottenere la propria soddisfazione sessuale e per affermare, o
consolidare, la loro posizione nelle gerarchie di genere, razza e classe. Questi autori ne
indagano, così, non solo gli aspetti relativi ai rapporti di genere, ma anche le implicazioni
politiche, mostrando come le relazioni sessuali fra locali e turiste occidentali finiscono per
rinforzare e perpetuare schemi duraturi di dominio e subordinazione fra Nord e Sud del
mondo.
Per contro, la definizione di turismo romantico, coniata da Pruitt e LaFont (1995) e accolta in
seguito da altri studiosi (Meisch 2002, Dahles e Bras 1999, Jeffreys 2003), ha cercato di porre
l’accento sulle differenze che intercorrono fra comportamenti di donne e uomini,
primariamente sulla base dell’asse del genere. Se il turismo sessuale, sostengono le autrici,
conferma e riproduce i tradizionali ruoli di genere, rinforzando le relazioni di potere fondate
sulla dominazione maschile e la subordinazione femminile, al contrario, il turismo romantico
offre un’arena per il cambiamento, uno spazio sociale in cui poter sperimentare nuove identità
di genere. Questa prospettiva privilegia il punto di vista degli attori sociali che, nel descrivere
la loro relazione, ne enfatizzano gli aspetti del corteggiamento e di coinvolgimento affettivo,
definendo le loro liaisons nei termini di storie d’amore e rapporti a lungo termine (Pruitt e
LaFont 1995: 423).
Jeffreys, esponente del femminismo radicale, sostiene le posizioni di Pruitt e LaFont:
dichiarare che anche le donne partecipano al turismo sessuale, afferma l’autrice, è
problematico perché oscura gli aspetti legati al dominio maschile e alla violenza (Jeffreys
2003: 24). Ma, al contrario di Puitt e LaFont, che evidenziano come le relazioni fra turiste e
“beach boys” siano la dimostrazione di come le nozioni di dominio e potere non siano
statiche, bensì variabili e situazionali, costantemente negoziate e contestate e, dunque,
sganciate dalla sessualità biologica, Jeffreys (2003: 225) ritiene che donne e uomini occupino
posizioni differenti all’interno della gerarchia dei sessi. Questo si traduce in una diversità in
! 100!
termini di potere e controllo che gli uomini possono esercitare sulle donne ma non viceversa.
Il modo in cui le relazioni fra turiste e “beach boys” hanno inizio, e continuano nel tempo,
sono in sintonia con la costruzione della sessualità maschile dominante: le donne sono
conquistate attraverso strategie di seduzione e corteggiamenti serrati; e il fatto di avere
incontri sessuali con numerose donne, addirittura bianche, è simbolo di mascolinità e
contribuisce, pertanto, ad aumentare lo status sociale nel gruppo dei pari (Jeffreys 2003: 228-
229). Inoltre, se le donne ottengono un rafforzamento della loro femminilità da queste
relazioni, questa stessa femminilità non dà alle donne un maggiore status sociale, come invece
accade per gli uomini; né, tantomeno, si creano legami comunitari fra le turiste, che
intrattengono relazioni sessuali con giovani locali, come nel caso degli uomini, dove, invece,
l’esperienza condivisa contribuisce a cementare la loro supremazia maschile e a riprodurre
legami sociali fra i membri maschi della comunità “turistica” (Jeffreys 2003: 231; O’ Connel
Davison 2001: 16). In questi studi il potere è dunque concettualizzato in termini di status e le
interazioni in termini di scambio.
Ricerche successive (Herold et al. 2001; Cabezas 2004), vicine al punto di vista degli attori
sociali, hanno riferito di come le motivazioni delle turiste possano variare in maniera
considerevole, concentrandosi talvolta sull’idillio, talaltra sul sesso, avvalorando, così,
l’impossibilità di definire questa tipologia di rapporti in modo semplicistico o come turismo
romantico o, all’opposto, come turismo strettamente sessuale, e di concepire quest’ultimo
esclusivamente nei termini di transazioni commerciali.
La ricerca condotta da Cabezas (2004) ha mostrato come gli uomini locali evitino di definire
le loro liaisons con le straniere in termini di scambi pecuniari, per non rischiare di precludersi
l’eventualità di relazioni a lungo termine che possano sfociare anche in un matrimonio o nella
migrazione (Cabezas 2004: 999). Questi rapporti rivelano come il turismo sessuale non abbia
a che fare soltanto con sesso e denaro, ma anche con altri tipi di possibilità: ogni relazione con
i turisti, sessuale o no, è percepita come un potenziale vantaggio dai locali. Questo fatto
definisce il turismo sessuale come un’attività contingente e a finale aperto, i cui confini sono
sfumati e intrecciati con elementi di romance, tempo libero, consumo, viaggio all’estero e
matrimonio. Racconti di relazioni che durano nel tempo puntualizzano come gli elementi
coinvolti in quello che viene definito turismo sessuale, siano fluidi, eterogenei e ambigui,
capaci di andare oltre la cornice concettuale totalizzante che definisce queste relazioni nei
termini oppositivi di vittime e oppressori, o di mere transazioni commerciali (Cabezas 2004:
996).
! 101!
Gli studi di Frohlick (2007) e Weichselbaumer (2012) proseguono in direzione di una
comprensione più sfumata del fenomeno, mostrando come sessualità, desiderio di intimità,
controllo e potere siano negoziati dagli attori sociali in modi complessi. Ricorrendo al
concetto di “scambi fluidi” (Frohlick 2007) e di “carnevalesco” (Weichselbaumer 2012),
evidenziano come le controparti possano rivendicare diverse forme di potere sulla base di
sessualità, genere, etnia, età o classe, indipendentemente dalla diversità di esperienze e
motivazioni che spingono gli uni e gli altri a intessere relazioni fra loro. Questi studi hanno
contribuito a espandere la comprensione delle relazioni di potere e a problematizzare
l’associazione non circostanziata fra il maschile e il potere, nell’ottica di un superamento della
dicotomia concettuale fra turismo romantico e turismo sessuale.
È interessante notare come le voci che hanno alimentato il dibattito scientifico, a partire dalla
metà degli anni Novanta, e gli studi del fenomeno che sono seguiti, siano stati
prevalentemente femminili e come le analisi abbiano privilegiato una prospettiva di genere.
Come hanno rilevato dell’Agnese e Ruspini (2005: XX) “le donne, rispetto agli uomini,
hanno maggiormente utilizzato, incentivato e contribuito al consolidamento della prospettiva
teorica e di ricerca sensibile alle differenze di genere (gender-sensitive) cioè alle
caratteristiche, bisogni, esigenze specifiche di donne e uomini”. Le prospettive teoriche che
hanno caratterizzato gli studi sul turismo sessuale femminile, o turismo romantico, riflettono
anche gli sviluppi e i cambiamenti che hanno accompagnato lo studio antropologico del
genere e delle relazioni di genere. Sin dall’inizio, lo studio del genere si è focalizzato
sull’analisi delle asimmetrie nei rapporti e nelle opportunità, sui rapporti di forza e
sull’ineguale distribuzione di potere tra uomini e donne, ma, tra gli anni Ottanta e Novanta, è
stato registrato “uno spostamento dell’attenzione dalla differenza tra (le culture; gli uomini e
le donne) alla differenza all’interno di (una stessa cultura; le donne; gli uomini)” (Mattalucci
2012: 9). Se nelle analisi iniziali dell’antropologia femminista, l’accento era posto sulle
somiglianze fra donne e fra queste e gli uomini, nella riflessione successiva è stata messa in
discussione “l’unità della categoria di ‘donna’ e il fatto che la differenza fra sessi fosse
prioritaria e potesse essere separata da altre disparità di potere, come quelle legate alla ‘razza’,
alla classe sociale, all’orientamento sessuale ecc.” (Mattalucci 2012: 9).
Ciò che tuttavia rimane inesplorato negli studi condotti finora sul “turismo sessuale
femminile”, sono gli effetti incorporati di queste relazioni e dei conseguenti processi di
riconfigurazione delle identità di genere messi in atto. Le analisi del fenomeno si sono
concentrate sulle interazioni fra turiste occidentali e giovani uomini locali che hanno luogo
nei contesti circoscritti dei siti turistici (la spiaggia, i locali, i resort, le discoteche, le strade). I
! 102!
luoghi dove host e guest s’incontrano, sono considerati come unità di spazio distinte e isolate
e lo sforzo analitico si concentra sulle modalità dei loro scambi (economici? Affettivi?).
Questo ha implicato anche una de-contestualizzazione e una de-storicizzazione dei luoghi
dell’interazione turistica (ad eccezione di Cabezas 2004 e Meiu 2011), che potrebbe essere
una delle ragioni alla base della comune tendenza a considerare gli attori sociali in termini
essenzializzanti, scorporando le soggettività dal contesto più vasto dei rapporti familiari e
comunitari. I “beach boys” non sono solo giovani che cercano di attrarre turiste occidentali:
sono anche padri, figli, mariti, membri di una comunità. Le loro soggettività non si
definiscono esclusivamente in rapporto ai turisti ma, al contrario, occupano posizioni
molteplici. I “beach boys”, in definitiva, non sono una categoria ma soggetti reali, con un
corpo e una storia. Allargare il campo al più vasto contesto sociale in cui gli attori sono
inseriti, potrebbe aiutare a integrare l’analisi del “turismo sessuale femminile” con gli effetti
che queste relazioni hanno sulle comunità di appartenenza, sui rapporti di genere fra uomini e
donne del posto, e su loro stessi. Bauer (2013: 25), per esempio, ha posto interrogativi sugli
effetti che tali relazioni possono avere anche sulla salute: ricorrere alla definizione di turismo
romantico potrebbe contribuire a incrementare un falso senso di sicurezza e influenzare
l’utilizzo di preservativi per proteggersi contro il rischio di contrarre malattie veneree e
infettive, come l’HIV.
In accordo con Meiu (2011), la teorizzazione del “turismo sessuale femminile” (ma anche
maschile) dovrebbe comprendere la categoria analitica dell’incorporazione. Anche quando il
corpo è presente nel dibattito, viene trattato semplicemente come un oggetto del consumo o
come un soggetto consumatore, senza che gli effetti incorporati delle riconfigurazioni delle
identità di genere in relazione ai processi globali, siano indagati. Nella sua ricerca condotta in
Kenya nel 2005, Meiu (2011: 106-107) ha mostrato come i giovani samburu che instaurano
relazioni intime con turiste straniere sulle spiagge di Mombasa, finiscano per incorporare gli
effetti della mercificazione neo-imperialistica dei loro corpi a uso e consumo dei turisti e gli
effetti del biasimo morale espresso nei termini della sessualità da parte della loro comunità di
origine. Tali effetti incorporati, ha rilevato Meiu, hanno modellato differenti tipologie di
mascolinità fra i samburu: sia fra i giovani che, dalle regioni settentrionali del Kenya, si sono
spostati sulla costa, sia fra quelli che sono rimasti nei villaggi. La categoria analitica
dell’incorporazione potrebbe essere impiegata per indagare gli effetti delle relazioni fra
uomini locali e turiste occidentali non solo fra gli host, ma anche fra i guest, considerando
anche che, per le turiste, queste relazioni si iscrivono nella dimensione liminale delle vacanze.
Se, come messo in evidenza da Pruitt e LaFont (1995) il turismo romantico o sessuale, offre
! 103!
alle donne un’arena per il cambiamento, uno spazio sociale in cui poter sperimentare nuove
identità di genere, sarebbe interessante analizzare le implicazioni che tali sperimentazioni
hanno sulla riconfigurazione della femminilità delle turiste occidentali non solo nello spazio
liminale della vacanza, ma anche nella dimensione quotidiana vissuta nei paesi di origine.
Come si traduce l’adozione di nuove identità di genere esperita durante il periodo delle
vacanze nella vita di tutti i giorni e nei rapporti con gli uomini del proprio background socio-
culturale? La vacanza è un’esperienza extra-ordinaria perché rappresenta una sospensione dal
lavoro e offre la possibilità di agire fuori dai copioni ordinari della vita quotidiana; ma è
anche una condizione temporanea e tale temporaneità potrebbe influire sugli effetti che le
relazioni vissute con uomini locali hanno sulle possibili riconfigurazioni delle femminilità
delle donne europee e nordamericane, nella consapevolezza che queste non costituiscono un
gruppo omogeneo e indistinto. Come ha evidenziato Mattalucci, “in ogni società non esiste
una sola ideologia di genere, un’unica definizione del maschile e del femminile, una divisione
dei ruoli univoca rispetto al genere” (2012: 9); non esiste dunque una categoria unica e
universale di “donna” e il maschile e il femminile, e la sessualità sono investiti di significati
che possono variare a seconda del contesto culturale (Mattalucci 2012: 9).
! 104!
Bibliografia
State of the Coast Report. Towards Integrated Management of Coastal and Marine Resources
in Kenya, Nairobi, National Environment Management Authority (NEMA), 2009
Aime M., L' incontro mancato. Turisti, nativi, immagini, Torino, Bollati-Boringhieri, 2005
Akama J. S. e Kieti D., Tourism and Socio-economic Development in Developing Countries:
A Case Study of Mombasa Resort in Kenya, Journal of Sustainable Tourism, vol. 15, n. 6
(2009), pp. 735-748
Akama J., Sterry P., Cultural Tourism in Africa: Strategies for the New Millenium, Arnhem,
ATLAS, 2002
Allison S., La Guerra arriva a Nairobi, The Daily Maverick, Sudafrica, 27 settembre 2013.
Appadurai A., Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy, Theory Culture
Society, n. 7 (1990), pp. 295-310
Askew K. M., Female Circles and Male Lines: Gender Dynamics along the Swahili Coast,
Africa Today, Vol. 46, No. 3-4 (1999), pp. 67-102
Babb F. E., Sex and Sentiment in Cuban Tourism, Caribbean Studies, Vol. 38, No. 2
(2010), pp. 93-115
Bandyopadhyay R., A paradigm shift in sex tourism research, Tourism Management
Perspectives, n. 6 (2013), pp. 1-2
Barberani S., Antropologia e turismo. Scambi e complicit� culturali nell'area mediterranea,
Milano, Guerini e Associati, 2006
Bargna I. L., Il mito dell�arte primitiva: una critica antropologica, in Sironi V. A. (a cura di),
Arte e cervello, Bari, Edizioni B.A. Graphis, 2009
Bauer I. L., Romance tourism or female sex tourism?, Travel Medicine and Infectious
Disease, n. 12 (2014), pp. 20-28
Bergan E. M., �There is no love here�. Beach boys in Malindi Kenya, Master thesis,
Department of Social Anthropology, University of Bergen, 2011
! 105!
Bourdieu P., Participant Objectivation, The Journal of the Royal Anthropological Institute,
vol. 9, n. 2 (2003), pp. 281-294
Bourdieu P., Per una teoria della pratica con tre studi di etnologia cabila, Milano, Raffaello
Cortina, 2003
Bourdieu P., Sul concetto di campo in sociologia, Roma, Armando Editore, 2010
Bowman G., Fucking Tourists: Sexual Relations and Tourism in Jerusalem's Old City,
Critique of Anthropology, vol. 9, n. 2 (1989), pp. 77-93
Brennan D., Women Work, Men Sponge, and Everyone Gossips: Macho Men and
Stigmatized/ing Women in a Sex Tourist Town, Anthropology Quarterly, vol. 77, n. 4
(2004), pp. 705-733
Brown N., "Beach Boys as Culture Brokers in Bakau Town. Gambia", Community
development journal, vol. 27, n. 4 (1992), pp. 361-370
Bruner E. M. e Kirshenblatt-Gimblett, Maasai on the Lawn: Tourist Realism in East Africa,
Cultural Anthropology, vol. 9, n. 4 (1994), pp. 435-470
Bruner E. M., The Masaai and the Lion King: Authenticity, Nationalism, and Globalization
in African Tourism, American Ethnologist, vol. 28, n. 4 (2001), pp. 881-908
Swain B. M., Gender in Tourism, Annals of Tourism Research, vol. 22, n. 2 (1995), pp. 247-
266
Cabezas A. L., Between Love and Money: Sex, Tourism, and Citizenship in Cuba and the
Dominican Republic, Signs, vol. 29, n. 4 (2004), pp. 987-1015
Connell R. W. e Messerschmidt J. W., Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept,
Gender and Society, vol. 19, n. 6 (2005), pp. 829-859
Cooper F., Colonial History, Hoorweg,J., Foeken,D.W.J. e Obudho,R.A. (a cura di), Kenya
Coast Handbook, Amburgo, Lit Verlag, 2000, pp. 115-127
Crick M., Representations of International Tourism in the Social Sciences: Sun, Sex, Sights,
Savings, and Servility, Annual review of Anthropology, vol. 18 (1989), pp. 307-344
Dahles H. e Bras K., Entrepreneurs in Romance. Tourism in Indonesia, Annals of Tourism
Research, vol. 26, n. 2 (1999), pp. 267-293
! 106!
De Albuquerque K., In Search of the Big Bamboo, Transition, n. 77 (1998), Annals of
Tourism Research, vol. 22, n. 2 (1995), pp. 48-57
Dieke P. U. C., Policies for tourism development in Kenya, Annals of Tourism Research,
Vol. 18, n. 2 (1991), pp. 269-294
Eastman C. M., “Who Are the Waswahili?”, Africa: Journal of the International African
Institute, Vol. 41, No. 3 (1971), pp.228-236
Eastman C. M., Tourism in Kenya and the Marginalization of Swahili, Annals of Tourism
Research, vol. 22, n. 1 (1995), pp. 172-185
Emerson R. M., Power-Dependence Relations”, American Sociological Review, vol. 27, n. 1
(1962), pp. 31-41
Enloe C., Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics,
University of California Press, 1990
Epprecht M., New Perspective on Sexualities in Africa: Introduction, Canadian Journal of
African Studies, vol. 43, n. 1 (2009), pp. 1-7
Foeken D., Hoorweg J. E Obudho R.A., The Kenya Coast: a regional study, in Hoorweg,J.,
Foeken D. W.J. e Obudho R.A. (a cura di), Kenya Coast Handbook, Amburgo, Lit Verlag,
2000, pp. 3-10
Frohlick S., Fluid Exchanges: The Negotiation of Intimacybetween Tourist Women and
Local Men in a Transnational Town in Caribbean Costa Rica, City & Society, vol. 19, n. 1
(2007), pp. 139 - 168
Garcia-Ramon D. M., Canoves G., Valdovinos N., Farm Tourism, Gender and the
Environment in Spain, Annals of Tourism Research, vol 22, n. 2 (1995), pp. 267-282
Maurice Godelier, L'ideale e il materiale. Pensiero, economie, società, Roma, Editori Riuniti,
1985
Gutmann M. C., Trafficking in Men: The Anthropology of Masculinity, Annual Review of
Anthropology, vol. 26 (1997), pp. 385-409
Harvey D., Between Space and Time: Reflections on the Geographical Imagination, Annals
of the Association of American Geographers, vol. 80, n. 3 (1990), pp. 418-434
! 107!
Hodge G. D., Colonizing the Cuban Body, in Chomsky A., The Cuba Reader. History,
Culture, Politics, Durham NC, Duke University Press, 2003
Herold E., Garcia R., DeMoya T., Female Tourist and Beach Boys. Romance or Sex
Tourism?, Annals of Tourism Research, vol. 28, n. 4 (2001), pp. 978-997
Hoogenraad H., Men at play. Freedom and alternative ordering through (romantic)
intercultural relationships at the beach in Zanzibar, Master thesis, Research Master African
Studies, 2010-2012
Hoorweg, J., The Experience with Land Settlement, in Hoorweg,J., Foeken,D.W.J. e
Obudho,R.A. (a cura di), Kenya Coast Handbook, Amburgo, Lit Verlag, 2000, pp. 309-326
Hoorweg, J., Foeken, D.W.J. e Obudho, R.A., The Kenya Coast: a Regional Study, in
Hoorweg,J., Foeken,D.W.J. e Obudho,R.A. (a cura di), Kenya Coast Handbook, Amburgo,
Lit Verlag, 2000, pp. 3-9
Hughes L., �Beautiful Beasts� and Brave Warriors: The Longevity of Maasai Stereotype, in
Romanucci-Ross L., De Vos G. A. e Tsuda T. (a cura di), Ethnic Identity: Problems and
Prospects for the Twenty-First Century, Lanham, MD, AltaMira Press, 2006, pp. 264-294
Irandu E. M., The role of tourism in the conservation of cultural heritage in Kenya, Asia
Pacific Journal of Tourism Research, vol. 9, n. 2 (2004), pp. 133-150
Jacobs J., Have sex will travel: romantic �sex tourism� and women negotiating modernity in
the Sinai, Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography, vol. 16, n. 1 (2009),
pp. 43-61
Jamison D., Masks without Meaning: Notes on the Processes of Production, Consumption,
and exchange in the Context of First World � Third World Tourism, Journal of
Macromarketing, vol. 19, n. 8 (1999), pp. 8-19
Jamison D., Tourism and Ethnicity. The Brotherhood of Coconuts, Annals of Tourism
Research, vol. 26, n. 4 (1999), pp. 944-967
Jeffreys S., Sex Tourism: do women do it too?, Leisure Studies, vol. 22, n. 3 (2003), pp.
223-238
Kafir S. L., Slam-Dunking and the Last Noble Savage, Visual Anthropology, vol. 15, n. 3-4
(2002), pp. 369-385
! 108!
Kafir S. L., Tourist Aesthetics in the Global Flow: Orientalism and �Worrior Theatre� on
Swahili Coast, Visual Anthropology, vol. 17, n. 3-4 (2004), pp. 319-343
Karch C. A. e Dann G. H., “Close Encounters of the Third World”, Human Relation, n. 34
(1981), pp. 249-268
Kempadoo K., Freelancers, Temporary Wives, and Beach Boys: Researching Sex Work in
the Caribbean, Feminist Review, n. 67, Sex Work Reassessed (2001), pp. 39-62
Kibicho W., Tourism and the Sex Trade in Kenya�s Costal Region, Journal of Sustainable
Tourism, vol. 13, n.3 (2005), pp. 256-280
Kinnaird V. e Hall D. R., Understanding tourism processes: a gender-aware framework,
Tourism Management, vol. 17, n. 2 (1996), pp. 95-102
Klaver W. e Mwadime R., Food Consumption and Nutrition, in Hoorweg,J., Foeken,D.W.J.
e Obudho,R.A. (a cura di), Kenya Coast Handbook, Amburgo, Lit Verlag, 2000, pp. 279-295
Leed E. J., La mente del viaggiatore. Dall'Odissea al turismo globale, Bologna, Il Mulino,
2007
Leheny D., A Political Economy of Asian Sex Tourism, Annals of Tourism Research, vol.
22, n. 2 (1995), pp. 367-384
Lorber J., The Social Construction of Gender, in T. Cohen , Men and Masculinity: A�Text
Reader, Belmont, CA: Wadsworth, 2001, pp. 121-124
Löfgren O., Storia delle vacanze, Milano, Bruno Mondadori, 2001
Malighetti R., Il Quilombo di Frechal. Identità e lavoro in una comunità brasiliana di
discendenti di schiavi, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2004
Malighetti R, Lazzarino R., Violenza e limite. Conversazione sul lavoro di ricerca in una
favela carioca, I Quaderni del CREAM, n� 10 (2010), pp. 27-57
Mattalucci C., Introduzione, in Mattalucci C. (a cura di), Etnografie di genere. Immaginari,
relazioni e mutamenti sociali, Lungavilla (PV), Edizioni Altravista, 2012
Meilink H., The Kenya Coast in National Perspective, in Hoorweg,J., Foeken,D.W.J. e
Obudho,R.A. (a cura di), Kenya Coast Handbook, Amburgo, Lit Verlag, 2000, pp. 11-26
! 109!
Meisch L. A., Gringas and Otavale�os. Changing Tourist relations, Annals of Tourism
Research, vol. 22, n. 2 (1995), pp. 441-462
Meiu G. P., �Beach Boys Elders� and �Young Big-Men�: Queering the Temporalities of Aging
in Kenya�s Ethno-Erotic Economies, winner of the Benedetta Jules-Rosette Graduate Paper
Award, 2012
Meiu G. P., �Mombasa Morans�: Embodiment, Sexual Morality, and SumburuMen in Kenya,
Canadian Journal of African Studies, vol. 43, n. 1 (2011), pp. 105-128
Meiu G.P., On Difference, Desire and the Aesthetics of the Unexpected: The White Maasai
in Kenyan Tourism, in Skinner J. e Theodossopoulos D., Great Expectations. Immagination
and Anticipation on Tourism, New York � Oxford, Berghahn Books, 2011, pp. 96-113
Meiu G. P., Riefenstahl on safari. Embodied contemplation on East Africa, Anthropology
Today, vol. 24, n. 18, (2008) pp. 18-22
Morrell R. e Scott S., Men in the Third World: Postcolonial Perspective on Maculinity in
Kimmel M. S., Hearn J., Connell R. W (a cura di), The Handbook of Studies on Men and
Masculinities, Thousand Oaks, California, Sage Pubblications, 2005, pp. 90-113
Nagel J., States of Arousal/Fantasy Islands: Race, Sex, and Romance in the Global Economy
of Desire, American Studies, vol. 41, n. 2/3 (2000), pp. 159-181
Nyanzi S., Rosenberg-Jallow O. e Bah O., Bumsters, Big Black Organs and Old White Gold:
Embodied Racial Myths in Sexual Relationships of Gambian Beach Boys, Culture, Health &
Sexuality, vol. 7, n. 6 (2005), pp. 557-569
O�Connell Davidson J., Sex Tourism in Cuba, Race and Class, vol. 38 (1996), pp. 39-48
O�Connell Davidson J., The Sex Tourist, the expatriate, his Ex-Wife and her �Other�: The
Politics of Loss, Difference and Desire, Sexualities, vol. 4, n. 5 (2001), pp. 5-24
Omondi Rose K., Gender and Political Economy of Sex Tourism in Kenya�s Coastal Resorts,
paper presented at the Internation Symposium / Doctorial Course on Feminist Perspective on
Global Economic and Political Systems and Women�s struggle for Global justice at
Sommoroya Hotel, Tromso, Norvegia, 24-26 settembre 2003
! 110!
Ondimu K. I., Cultural Tourism in Kenya, Annals of Tourism Research, vol. 29, n. 4 (2002),
pp. 1036-1047
Oppermann M., Sex Tourism, Annals of Tourism Research, vol. 26, n. 2 (1999), pp. 251-
266
Parkin D., Swahili Mijikenda: Facing Both Ways in Kenya, Journal of the International
African Institute, vol. 59, n. 2 Social Stratification in Swahili Society (1989), pp. 161-175
Parkinson T., Phillips M. e Gourlay W., Kenya, Torino, EDT, 2006
Peake R., Swahili Stratification and Tourism in Malindi Old Town, Kenya, Africa: Journal
of the International African Institute, vol. 59, n. 2 (1989), pp. 209-220
Pruitt D., LaFont S., For Love and Money. Romance Tourism in Jamaica, Annals of
Tourism Research, vol. 22, n. 2 (1995), pp. 422-440
Ryan C. e Kinder C., “Sex, tourism and sex tourism:fulfilling similar needs?”, Tourism
Management, Vol. 17, No. 7 (1996), pp. 507-518
Renne E. P., Introduction to Special Issue: Sexuality and Generational Identities in Sub-
Saharan Africa, Africa Today, vol. 47, n. 3-4 (2000), pp. 7-12
Ringer Greg, Gender posed: The people behind the postcards, in Pritchard A., Morgan N.,
Ateljevic I., Harris C. (a cura di), Tourism and Gender: Embodiment, Sensuality and
Experience, Oxford, CABI Publishing, 2007, pp. 219-234
Roland L. Kaifa, Tourism and the Commodification of Cubanidad, Tourist Studies, vol. n. 3
(2010), pp. 3-18
Rubin G., "The traffic in women; notes on the political economy of sex", in R. Reiter (a cura
di)�Toward an anthropology of women, New York, Monthly Review Press, 1975, pp. 157-210
Said, E., Orientalismo, Torino, Feltrinelli, 1999
Sanchez Taylor J., Dollars Are a Girl�s Best Friend? Female Tourists� Sexual Behaviour in
the Caribbean, Sociology, vol. 35, n. 3 (2001), pp. 749-764
Sanchez Taylor J., Female Sex Tourism: A Contradiction in Terms?, Feminist Review, n.
83, Sexual Moralities (2006), pp. 42-59
! 111!
Sanchez Taylor, J. Tourism and �embodied commodities�: sex tourism in the Caribbean in
Clift Stephen e Carter Simon (a cura di), Tourism and Sex: Culture, Commerce and Coercion,
Londra, Pinter, 2000
Satta G., Turisti a Orgosolo. La Sardegna pastorale come attrazione turistica, Napoli,
Liguori Editore, 2001
Schoss J., Dressed to shine: work, leisure, and style in Malindi, Kenya in H. Hendrickson,
Clothing and Difference. Embodied Identities in Colonial and Post-Colonial Africa, Durham
e Londra: Duke University Press, 1996
Silberschmidt M., Disempowerment of Men in Rural and Urban east Africa: Implications for
Male Identity and Sexual Behavior, World Development, vol. 29, n. 4 (2001), pp. 657-671
Sindiga I., Domestic Tourism in Kenya, Annals of Tourism Research, vol. 23, n. 1 (1996),
pp. 19-31
Sindiga I., International Tourism in Kenya ans the marginalization of the Waswahili,
Tourism Management, vol. 17, n. 6 (1996), pp. 425-432
Sindiga I., Tourism, Hoorweg,J., Foeken,D.W.J. e Obudho,R.A. (a cura di), Kenya Coast
Handbook, Amburgo, Lit Verlag, 2000, pp. 223-236
Sindiga I., Tourism Education in Kenya, Annals of Tourism Research, vol. 23, n. 3 (1996),
pp. 698-701
Sindiga I., Wildlife-based Tourism in Kenya: Land use conflicts and government
compensation policies over protected areas, The Journal of Tourism Studies, vol. 6, n. 2
(1995), pp 45-55
Stren R., Urban Policy and Performance in Kenya and Tanzania, The Journal of Modern
Studies, vol. 13, n. 2 (1975), pp. 267-294
Thanh-Dam Truong., The Dynamics of Sex Tourism: The Case of Southeast Asia,
Development and Change, n. 13 (1983), pp. 533-553
Tamale S., African Sexualities: a Reader, Cape Town, Pamapazuka Press, 2011
Tassan M., Situare il movimento, mappare le pratiche: processi di territorializzazione in una
comunità amazzonica di afrodiscendenti”, Quaderni di Thule X, Perugia, Edizione CSACA
Onlus, 2010, pp. 475-488.
! 112!
Urbain J. D., L'idiota in viaggio. Storia e difesa del turista, Roma, Aporie, 1997
Veijola S. e Jokinen E., The Body in Tourism, Theory, Culture & Society, vol. 11 (1994),
pp. 125-151
Venables E., �If you give me some sexing, I might talk to you�: researching the Senegalese
beach-boys �at my side�, Anthropology Matters Journal, vol. 11, n. 1 (2009), pp. 1-11
Vignato S. (a cura di), Soggetti al lavoro. Un’etnografia della vita attiva nel mondo
globalizzato, Torino, Utet, 2010
Weichselbaumer D., Sex, romance and the carnivalesque between female tourists and
Caribbean men, Tourism Management, n.33 (2012) 1220-1229
Riferimenti bibliografici internet
Anon., “Hotels want beach boys kicked out", Daily Nation (3 novembre 2010)
http://www.nation.co.ke/business/news/Hotels+want+beach+boys+kicked+out/-
/1006/1046066/-/4rjgurz/-/index.html
Anon., “Kenya Tourism Report Q2 2012", Business monitor international (13 marzo 2012)
http://www.marketresearch.com/Business-Monitor-International-v304/Kenya-Tourism-Q2-
6855247/
Anon., “Sh150m shot in the arm for Kenyan beach line", Daily Nation (15 marzo 2012)
http://www.nation.co.ke/business/news/Sh150m-shot-in-the-arm-for-Kenyan-beach-line-/-
/1006/1367118/-/g2t09nz/-/index.html
Anon., “Kenya seeks to attract more business tourists", Daily Nation (25 marzo 2013)
http://www.nation.co.ke/business/news/Kenya-seeks-to-attract-more-business-tourists/-
/1006/1862826/-/c6n8f5/-/index.html
Anon., “You are safe, Lenku assures tourists", Daily Nation (29 giugno 2013)
http://www.nation.co.ke/News/-/1056/1899422/-/w2o48jz/-/index.html
Anon., “Let global airlines run scheduled flights to Mombasa, urges Kandie", Daily Nation (2
luglio 2013)
! 113!
http://www.nation.co.ke/Features/smartcompany/-/1226/1901154/-/p1rq0e/-/index.html
Anon., “Overhaul NSSF to fight poverty, urges Kambi”, Daily Nation (5 luglio 2013)
http://www.nation.co.ke/business/news/Overhaul-NSSF-to-fight-poverty-urges-Kambi/-
/1006/1906296/-/bfpmve/-/index.html
Anon., “Conference tourism puts Kenya on the global map", Daily Nation (8 luglio 2013)
http://www.nation.co.ke/Features/smartcompany/Conference-tourism-puts-Kenya-on-the-
global-map/-/1226/1908854/-/8b7nwaz/-/index.html
Anon., “Hoteliers want new zones for beach trades", Daily Nation (9 settembre 2013)
http://www.nation.co.ke/business/news/Hoteliers-want-new-zones-for-beach-traders/-
/1006/1910074/-/view/printVersion/-/4u7ajqz/-/index.html
Anon., “Tourists urged to visit despite attack”, Daily Nation (27 settembre 2013)
http://www.nation.co.ke/counties/Tourists-urged-to-visit-despite-attack/-/1107872/2009184/-
/view/printVersion/-/10aifbk/-/index.html
Anon., “Confusion as pupils return to school but teachers stay away”, Daily Nation (18 luglio
2013)
http://www.nation.co.ke/News/Confusion-as-pupils-return-to-school-but-teachers-stay-away/-
/1056/1919266/-/bndp5y/-/index.html
Anon., “Hoteliers want more flights”, Daily Nation (19 settembre 2013)
http://www.nation.co.ke/counties/Hoteliers-want-more-flights/-/1107872/1999852/-/a139a4/-
/index.html
Anon., “Westgate: EU withholds travel advisory on Kenya”, Daily Nation (25 settembre
2013)
http://www.nation.co.ke/news/EU-withholds-travel-advisory-on-Kenya-/-/1056/2007352/-
/xbq8hlz/-/index.html
Anon., “Tourism remains stable despite terror attack”, Daily Nation (25 settembre 2013)
http://www.nation.co.ke/business/Tourism-remains-stable-despite-terror-attack/-
/996/2006766/-/15ei2il/-/index.html
Achuka V., “Slum tourism: The new fad for foreigners visiting Kenya”, Daily Nation (7
settembre 2013)
http://www.nation.co.ke/lifestyle/lifestyle/Slum-tourism-The-new-fad-for-foreigners-visiting-
Kenya-/-/1214/1983218/-/124nxwh/-/index.html
! 114!
Atieno W., “Police issue tough rules to Coast hoteliers”, Daily Nation (30 settembre 2013)
http://www.nation.co.ke/Mombasa/Police-issue-tough-rules-to-hoteliers/-/519978/2013198/-
/jgnmsh/-/index.html
Atieno W., “Blame game as Kisauni residents still in the cold after demolitions”, Daily
Nation (5 dicembre 2013)
http://www.nation.co.ke/counties/mombasa/Kisauni-residents-in-the-cold-after-demolitions/-
/1954178/2099452/-/11httm8/-/index.html
Bocha G., “Foreigners turn Coast into sin haven”, Daily Nation (15 giugno 2013)
http://www.nation.co.ke/news/Foreigners-turn-Coast-into-sin-haven/-/1056/1884322/-
/95ss8j/-/index.html
Chonghaile C. N., "Kenya coast secessionists play on fear of outsiders – the wabara", The
Guardian (6 settembre 2012)
http://www.theguardian.com/world/2012/sep/06/kenya-ocean-coast-secessionist-party
Dolan G., “Poverty and illiteracy Coast’s scourge”, Daily Nation (1 novembre 2013)
http://www.nation.co.ke/oped/Opinion/Coast-Devolution-Education-Jubilee/-
/440808/2056532/-/vvuiukz/-/index.html
Gibendi R., “Tourism under pressure to look for new source markets”, Daily Nation (11
settembre 2013)
http://www.nation.co.ke/business/-/996/1989142/-/4n5ndx/-/index.html
Gibendi M., “Tourism shakes over political uncertainty”, Daily Nation (17 settembre 2013)
http://www.nation.co.ke/lifestyle/smartcompany/Tourism-shakes-over-political-uncertainty/-
/1226/1995530/-/13qjdxp/-/index.html
Jenje B., “Residents want beach access roads opened”, Daily Nation (1 giugno 2013)
http://www.nation.co.ke/News/Residents-want-beach-access-roads-opened/-/1056/1869604/-
/a4ixfu/-/index.html
Jenie B., “Anti-graft, land agencies pull down wall erected on beach access route”, Daily
Nation (27 giugno 2013)
http://www.nation.co.ke/News/-/1056/1896820/-/w2q42az/-/index.html
Kibirige A., "Get yourself a man in three steps", Daily Nation (22 agosto 2008)
http://www.nation.co.ke/Features/saturday/-/1216/461922/-/view/printVersion/-/rsm9myz/-
/index.html
! 115!
Kibiringe A., “Insecurity and poaching headache at the Coast”, Daily Nation (30 settembre
2013)
http://www.nation.co.ke/lifestyle/smartcompany/Insecurity-and-poaching-headache-at-the-
Coast/-/1226/2013240/-/cdkokm/-/index.html
Kitimo A., "Beach boys oppose plan to evict them", Daily Natiom (16 febbraio 2009)
http://www.nation.co.ke/News/regional/-/1070/531136/-/view/printVersion/-/t8rqbu/-
/index.html
Mumo M., “Writing on the wall for Kenya’s tourism”, Daily Nation (30 settembre 2013)
http://www.nation.co.ke/lifestyle/smartcompany/Writing-on-the-wall-for-Kenya-s-tourism/-
/1226/2013234/-/12dc7bcz/-/index.html
Munene M., “How sex tourists beat the law in coastal havens”, Daily Nation (2 novembre
2013)
http://www.nation.co.ke/business/How-sex-tourists-beat-the-law-in-coastal-havens/-
/996/2057852/-/mymtwx/-/index.html
Ndurya M., "Beach operators to be licensed", Daily Nation (29 marzo 2011)
http://www.nation.co.ke/business/news/Beach+operators+to+be+licensed/-/1006/1135084/-
/t6mdph/-/index.html
Nyabiage J., "Playground of the rich sparks airline scramble", Daily Nation (24 agosto 2009)
http://www.nation.co.ke/Features/smartcompany/-/1226/644626/-/3fnrus/-/index.html
Nyassy D. e Ringa M. , "Hoteliers insist closure a normal phenomenon", Daily Nation (27
aprile 2009)
http://www.nation.co.ke/Mombasa/-/519978/591740/-/msfa4h/-/index.html
Nyassy D., "Tourism body in bid to rein in beach boys", Daily Nation (2 dicembre 2009)
http://www.nation.co.ke/Mombasa/-/519978/816378/-/oatjp4/-/index.html
Nyassy D., “Governors accused of plot to plunder funds”, Daily Nation (8 luglio 2013)
http://www.nation.co.ke/Counties/Governors-accused-of-plot-to-plunder-funds/-
/1107872/1909012/-/1h6eug/-/index.html
Odero C., "Why Kenyan men fail the fashion test", Daily Nation (18 settembre 2010)
http://www.nation.co.ke/Features/lifestyle/Why-Kenyan-men--fail-the-fashion-test-/-
/1214/1013300/-/mk7ki9/-/index.html
! 116!
Pohl O., "Kenya Cracking Down on 'Beach Boys,' Gigolos Serving Tourists", The New York
Times (14 febbraio 2002)
http://www.nytimes.com/2002/02/14/world/kenya-cracking-down-on-beach-boys-gigolos-
serving-tourists.html
Ringa M., “Hoteliers set for tourist boom”, Daily Nation (25 giugno 2013)
http://www.nation.co.ke/News/Hoteliers-set-for-tourist-boom-/-/1056/1894510/-/uhp2f/-
/index.html
Ringa M., “Business meetings keep hotels afloat”, Daily Nation (21 maggio 2013)
http://www.nation.co.ke/News/Business-meetings-keep-hotels-afloat-/-/1056/1859060/-
/wmt4j2/-/index.html
Ringa M., “Traders decry all-inclusive tourist deals”, Daily Nation (23 settembre 2013)
http://www.nation.co.ke/lifestyle/smartcompany/Traders-decry-all-inclusive-tourist-deals/-
/1226/2004428/-/7c9a8iz/-/index.html
Masinde J., “Coast tourism hangs on hope as numbers dwindle”, Daily Nation (31 agosto
2013)
http://www.nation.co.ke/business/Coast-tourism-hangs-on-hope-as-numbers-dwindle-/-
/996/1975012/-/13l927az/-/index.html
Ringa M., “You are safe, Lenku assures tourists”, Daily Nation (29 giugno 2013)
http://www.nation.co.ke/news/-/1056/1899422/-/pt8mmv/-/index.html
Ringa M., “Board to set up water firm for Coast counties”, Daily Nation (10 giugno 2013)
http://www.nation.co.ke/counties/Board-to-set-up-water-firm-for-Coast-counties/-
/1107872/1878220/-/9oof8kz/-/index.html
Ringa M., “Squatters invade Waitiki farm after Ruto reveals ministry will buy land”, Daily
Nation (17 dicembre 2013)
http://www.nation.co.ke/counties/mombasa/Squatters-invade-Waitiki-farm/-
/1954178/2114054/-/brin1n/-/index.html
Wahome W., “Travel agency predicts tourism will recover”, Daily Nation (24 settembre
2013)
http://www.nation.co.ke/news/Travel-agency-predicts-tourism-will-recover-/-
/1056/2005884/-/2huvkkz/-/index.html
!