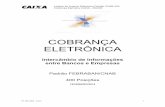Disme doner ne me vint onches a gré». La tematica socio-economica nel Jeu d’Adam
Transcript of Disme doner ne me vint onches a gré». La tematica socio-economica nel Jeu d’Adam
Letteratura e denaroIdeologie metafore rappresentazioni
Atti del XLI Convegno Interuniversitario(Bressanone, 11-14 luglio 2013)
a cura di Alvaro Barbieri e Elisa Gregori
Questo volume è stato stampato con il contributodel Dipartimento di Studi linguistici e letterari
dell’Università degli Studi di Padova
ISBN 88-6058-048-X© 2014 Esedra editrice s.r.l.via Palestro, 8 - 35138 PadovaTel e fax 049/723602e-mail: [email protected]
INDICE
Alvaro Barbieri, Elisa Gregori Premessa IX
Nicolò Pasero Dellecosechecresconoconillorouso,edialtreancora 1
Francesco Mosetti Casaretto Letteraturamediolatinaedenaro 11
Carla Piccone«Vincitamorcensus».Ildenaronellecommedieelegiache 33
Andrea Ghidoni Imagerydellaricchezzanellechansons de geste 47
Marco Infurna Comesisposauneroeepico.OstentazioneesperperodiricchezzanellacanzonedigestadiAymeri de Narbonne 55
Tiziano Pacchiarotti Sull’“impresa”cavallerescaelesueimplicazionimercantili.«Lipremiersvers»dell’ Erec et Enide 65
Lucilla Spetia Ildenaro,iltempo,illavoro,lacarità.Sistemidivalorierealtàmaterialinell’ Yvain diChrétiendeTroyes 81
Sonia Maura Barillari«Dismedonernemevintonchesagré».Latematicasocio-economicanel Jeu d’Adam 95
Mario ManciniRoman de la rose:orooEtàdell’oro? 113
Poalo CanettieriIlFioreeilfiorino 129
Cornelia KlettkeIlvagliodibeniterreniecelesti.Eticaeconomicaed“economiadell’anima”nella Commedia diDante 155
Helmut MeterIldenaroelaFortunanelDecameron.Sualcunenovelledellasecondagiornata 191
Vincenza Tamburri Letteraturaepovertà.IlSacrum commercium sancti Francisci cum domina Paupertate 211
Annamaria Annicchiarico Lui/LeieildenaronelMedioevocatalano.FraCurial e GüelfaelaFaula de Neptuno i Diana 221
Veronica Orazi Ildenarocorruttore.Ideologieerappresentazioni.DalLibro del Buen AmorallaCelestina 235
Michael Ryzhik Motivipecuniariineivolgarizzamentigiudeo-italiani 247
Lucia Bertolini IdeologiaesentimentodeldenaronelleoperelatineevolgaridiLeonBattistaAlberti 257
Ivano Paccagnella«Leruberiedellausura».Montidipietà,predicazione,mercatoeletteratura 275
Mauro Canova «Dogcoinsgold».L’impossibiletragediadeldenaroeilTimon of AthensdiWilliamShakespeare 293
Antonio Iurilli «Dichiararelirovesciconliscrittorieliscrittorico’rovesci».Moneteescritturastorica 311
Bruno Capaci Ilquartesedelloscrittore.Scrittoriappagati,scrittoribenremuneratiescrittoripaganti.Autoreehomo oeconomicusnelsecolodeiLumi 321
Roberto De RomanisCanoneecopyright.Unadelletantestoriedidenaro 331
Maria Luisa WandruszkaNathan il saggio(1779).Mercatoeverità 345
Fabio Danelon«Nei Promessi sposi siparlasempredidenaro».Ildenarodel/nelromanzodiAlessandroManzoni 357
Patrizia Zambon Lacommittenza.Scrittori,pubblico,rivistenellatemperierisorgimentale.NotedaNievo 369
Elisa Gregori«Unepluied’or».“Liquidità”deipersonaggibalzachiani 383
Luca Pietromarchi Flaubert:l’educazionecommerciale 393
Pierluigi Pellini Denaroliquidoecapitaleanonimo.ZolaversoilNovecento 401
André Weber Calcoloefollia.IlsottofondomiticodelmondofinanziarioinL’argentdiZola 419
Igor TchehoffLemetaforeconcettualideldenaroinIl paese di cuccagna diMatildeSerao 427
Marialuigia Sipione«Starmaleoggipernonstarpeggiodomani».DenaroedeticaneLa malora diBeppeFenoglio 439
Adone Brandalise«Acherontamovebo».Simbolicoerealenella Filosofia del denaro diGeorgSimmel 449
Tommaso Meozzi IldenarocomevertiginespazialeeimplosioneinLe mosche del capitale diPaoloVolponi 457
Emanuele Zinato «Sesterzoenergetico».ScritturaedenaroinPaoloVolponi 465
Gerhild Fuchs LaPianuraPadanadiGianniCelati«doveiquattrinihannofattointornoasélaterrabruciata» 479
Simona CarrettaIlromanzodinanziall’«epocadelpragmatismo».DaMoneydiMartinAmisaCosmopolisdiDonDeLillo 491
Remo Ceserani Romanzidallecapitalidell’altafinanza.InparticolaresuCapitaldiJohnLanchester 503
Indicedeinomi 511
Sonia Maura Barillari
«DISME DONER NE ME VINT ONCHES A GRÉ»LA TEMATICA SOCIO-ECONONICA NEL JEU D’ADAM
L’episodio dedicato a Caino e Abele – il secondo, e centrale, dei tre che compongono il Jeu d’Adam 1 – è senz’altro il meno studiato,2 a fronte dell’acribia critica che hanno sollecitato, e messo alla prova, quello relati-vo ad Adamo ed Eva e, soprattutto, l’Ordo prophetarum. Esso si sviluppa in poco più di 150 versi e, dal punto di vista della partizione contenutistica, costituisce la sezione più breve dell’opera. In realtà le coordinate interpre-tative mutano sensibilmente qualora si consideri la scansione performativa, o cronotopica,3 della rappresentazione, ritmata da un alternarsi di parti salmodiate in latino – le due lectiones e i sette responsoria intonati dal coro in risposta alla prima lectio 4 – e di parti recitate in volgare.5 Adottando questa
1 Composto attorno alla metà del XII secolo plausibilmente in area insulare, il Jeu d’Adam – o, come riporta l’intitolazione incipitaria presente nel solo manoscritto che lo tramanda (Tours, Bibliothèque municipale, n° 927, cc. 20r -40r), Ordo representacionis Ade – viene infatti abitualmente suddiviso in tre sezioni definite in base a criteri tematico-contenutistici: la pri-ma in cui si ripercorre la storia di Adamo ed Eva, la seconda incentrata sull’uccisione di Abele da parte di Caino, l’Ordo prophetarum che conclude l’opera.
2 Particolarmente interessanti a questo proposito sono W. C. Calin, Cain and Abel in the Mystère d’Adam, in «The modern language review», 58/2 (1963), pp. 172-176; e L. R. Muir, Liturgy and drama in the anglo-norman Adam, Oxford, Blackwell, 1973, pp. 83-92.
3 Per il concetto di cronotopo, cioè, come lo definisce Bachtin, quell’«interconnessione sostanziale dei rapporti temporali e spaziali dei quali la letteratura si è impadronita artisti-camente» per cui il tempo si configura quale «quarta dimensione dello spazio» è scontato il rinvio a M. Bachtin, Le forme del tempo e del cronotopo nel romanzo. Saggi di poetica storica, in Id., Estetica e romanzo, Torino, Einaudi, 1979 [ed. or.: Moskva, Chudozestvennaja literatura, 1975], pp. 231-405, a p. 231. Per un inquadramento generale sulla formulazione del concetto di cro-notopo da parte di Michail Bachtin si vedano S. Tagliagambe, L’origine dell’idea di cronotopo in Bachtin, in F. Corona (a c. di), Bachtin teorico del dialogo, Milano, Franco Angeli, 1986, pp. 35-78; C. Diddi, Sulla genesi e il significato del cronotopo in Bachtin, in «Ricerche slavistiche» n. s., 7 (2009), pp. 143-156; e A. Ponzio, Il cronotopo nell’opera di Bachtin, in «Quaderni di semantica», XXXIII/2 (2012), pp. 273-290.
4 Tratta, come i sette responsoria, dall’ufficio della domenica di Settuagesima, esordisce con «in principio creavit Deus celum et terram» e corrisponde al dettato di Gn 1-25. La secon-da lectio del Jeu, che introduce l’Ordo prophetarum, corrisponde invece all’undicesimo capitolo del sermone pseudo-agostiniano (ora attribuito a Quodvultdeus, vescovo di Cartagine nel V secolo) Contra Judaeos, Paganos et Arianos.
5 In merito al rapporto latino/volgare all’interno dello stesso testo si veda P. Zumthor, Un
SONIA MAURA BARILLARI96
prospettiva, si noterà come il passo in questione si inserisca in un segmento testuale più ampio, a sua volta suddiviso in due “movimenti”6 introdotti rispettivamente dai responsori «Ecce Adam quasi unus»7 (ovvero il sesto), e «Ubi est Abel frater tuus?»8 (il settimo e ultimo), e chiusi dalla seconda lettura che segna l’abbandono della tematica veterotestamentaria (nonché della connotazione liturgica pre-pasquale) e l’avvio della “sfilata” dei profe-ti, inseribile nella liturgia dell’Avvento.
La partizione interna del Jeu
I LECTIO (Gn 1-25)
R1 - Formavit igitur Dominus
Adamo ed Eva prima di entrare nell’Eden vv. 1-88: 88 vv.
R2 - Tulit ergo Dominus hominem
Le gioie dell’Eden vv. 89-100: 12 vv.
R3 - Dixit Dominus ad Adam
La tentazione, la caduta vv. 101-386: 286 vv.
R4 - Dum deambularet
La cacciata vv. 387-512: 126 vv.
R5 - In sudore vultus tui
L’angelo guardiano vv. 513-518: 6 vv.
R6 - Ecce Adam quasi unus
Adamo ed Eva fuori dall’Eden / Caino e Abele vv. 519-722: 204 vv.
R7 - Ubi est Abel frater tuus?
Maledizione di Caino vv. 723-744: 22 vv.
problème d’esthétique médiévale: l’utilisation poétique du bilinguisme, in «Le Moyen Age», LXVI/3 (1960), pp. 301-336; sull’impiego strutturale della tecnica della “farcitura” nel Jeu cfr. W. Noo-men, Le Jeu d’Adam. Étude descriptive et analytique, in «Romania», 89 (1968), pp. 145-193, passim.
6 Traggo il concetto dalla terminologia musicale in cui il termine è utilizzato per indicare la sezione di un componimento che preveda al suo interno più parti delimitate nel tempo da una sospensione nell’esecuzione.
7 Questo il testo completo: «Ecce Adam quasi unus ex nobis factus est, sciens bonum et malum: Videte ne forte sumat de ligno vitae, et vivat in aeternum. Versus: Cherubim et flammeum gladium atque versatilem ad custodiendam viam lignum vitae. Videte ne forte sumat de ligno vitae, et vivat in aeternum». Le Jeu d’Adam (Ordo representacionis Ade), publ. par W. Noomen, Paris, Champion, 1971, p. 50.
8 Questo il testo completo: «Ubi est Abel frater tuus? dixit Dominus ad Cain. Nescio Do-mine, numquid custos fratris mei sum ego? Et dixit ad eum: quid fecisti? Ecce vox sanguinis fratris tui Abel clamat ad me de terra. Versus: Maledictus eris super terram, quae aperuit os suum, et suscepit sanguinem fratris tui de manu tua. Ecce vox sanguinis fratris tui Abel clamat de terra». Ivi, p. 63.
LA TEMATICA SOCIO-ECONONICA NEL JEU D’ADAM 97
II LECTIO (Contra Judaeos, Paganos et Arianos, XI)
Ordo prophetarum vv. 745-944: 200 vv.
1. Isoglosse: l’ordinamento feudale
La porzione di testo così individuata, corrispondente ai vv. 519-744, pa-lesa in effetti un’unitarietà di fondo, avendo quale comun denominatore la vita sulla terra dopo la cacciata dal paradiso terrestre: l’esistenza di Adamo ed Eva condannati a guadagnarsi il pane con il sudore della fronte,9 quel-la dei loro figli incrinata da una latente discordia. Esistenze, le une come le altre, poste sotto il segno del lavoro e della morte. Tale unitarietà, già perspicua in ragione dell’ambientazione terrena degli avvenimenti narrati, in contrapposizione tanto con quella edenica dell’esordio quanto con la dimensione escatologica che caratterizza l’Ordo prophetarum, è avvalorata e resa più coesa dalla presenza di tre isoglosse che innervano i due brani ora intersecandosi, ora sovrapponendosi, e improntando le vicende dei proge-nitori della stirpe umana e della loro progenie sulle dinamiche del lavoro, del denaro, dei legami vassallatici.
Isoglosse che si intensificano proprio nei versi aventi come protagonisti Caino e Abele, dove i termini relativi ai processi economici e agli assetti ge-rarchici a essi connessi – utilizzati sia in senso proprio sia in quello traslato, metaforico – si accumulano potenziandosi reciprocamente fino a delineare un quadro relazionale, comprendente i due fratelli e il Creatore, capace di riflettere appieno il contesto sociale e giuridico del tempo.
Lungi dall’essere ispirati dall’affetto, o più genericamente da un qual-siasi sentimento,10 i rapporti che legano i tre attanti di questo episodio, e governano il loro agire determinandone azioni e reazioni, sono di natura prettamente feudale, come chiaramente esprime il lessico impiegato da Abele a qualificarli: Dio, a cui gli uomini sono subiect,11 deve essere servito12
9 A questo proposito merita di essere segnalato come nel Jeu la condanna a un duro lavoro comminata da Dio al solo Adamo sia estesa – almeno dal punto di vista della rappresentazio-ne scenica – a comprendere anche Eva, presentata mentre coltiva assieme al compagno una terra avara di frutti anziché, come vorrebbe l’iconografia “vulgata” conformemente al dettato biblico (Gn. 3, 16), intenta ad allattare i figli e filare la lana. Così infatti recita la didascalia in conclusione del sesto responsorio: «tunc Adam habebit fossorium et Eva rastrum et incipient colere terram, et seminabunt in ea triticum. Post quam seminaverint ibunt sessum in loco aliquantulum, tanquam fatigati labore». Qui come in seguito si cita da Adamo ed Eva. Le Jeu d’Adam: alle origini del teatro sacro, edizione critica, traduzione e note a c. di S. M. Barillari, Roma, Carocci, 2010 (a p. 210)
10 A dispetto del «ferm amor» (v. 598) e della «grant dilection» (v. 607) che, in forma ottativa, Abele auspica debbano sussistere fra lui e il fratello.
11 Così Abele a Caino: «seum tot tens subject al criator» (v. 595).12 Di servir si registrano tre occorrenze, tutte significativamente collocate all’esordio
SONIA MAURA BARILLARI98
e obbedito13 perché questi li difenda, e in lui occorre avere fiance.15 Con-travvenire a ciò è definito revel,16 estrif,17 e considerato, oltre che un atto di villania,18 una manifestazione di felonie,19 violazione in grado di minare alle sue fondamenta qualsiasi regime che dalla fedeltà vicendevole faccia derivare la propria stabilità politica, giuridica e sociale. D’altro canto, allo stesso campo semantico, e al medesimo ordine di valori, rinvia anche la terminologia di cui si serve Caino per muovere la sua accusa – ingiusta, infondata – al fratello che più di lui godeva del favore divino: «tu es traïtres tot provez!» (v. 682), lo calunnia, e la risposta, a discolpa, ricalca da presso il biasimo imputatogli («unches n’amai de fere traïson», v. 684), quasi a voler conferire maggior forza e icasticità alla negazione con l’affiancarla all’insinuazione infamante. A petto della mite rassegnazione con cui Abele affronta la morte riponendo ogni sua fede in Dio, la fellonia di Caino è dettata da orgoglio («nen aez envers lui orguil!», lo rimprovera il fratello al v. 627) che non solo è il primo, e l’origine di tutti i peccati («initium omnis peccati est superbia», recita l’Ecclesiaste 10, 15), quello di cui si è macchiato Lucifero20 e che ha instillato nei cuori di Eva e di Adamo, ma è anche il
dell’episodio, quasi a voler esplicitare e ribadire, per bocca di Abele, l’imprescindibile pre-supposto su cui si fonda l’accordo col Creatore: «de Deu servir ne seom pas vilain!» (v. 594), «ensi servum que conquerroms s’amor» (v. 596), «si servum Deu que li vienge a plaisir» (v. 599). Del resto servir e service sono anche i termini che compendiano il tipo di rapporto che Figura (così è denominato l’ente divino nelle didascalie del Jeu, la prima delle quali lo identifica nel Salvator) avrebbe inteso istituire con le sue creature, enunciandone lo scarno principio basi-lare a Eva («a moi servir met ton porpens», v. 31), che l’accetta di buon grado («le ton pleisir, le ton servise / frai, sire, en tote guise», vv. 47-48) così come farà di lì a breve il suo compagno («en toi servir metrai [met] ma volenté. / . . . / Ma volenté ne serrad ja si dure / qu’a toi servir ne soit tote ma cure», vv. 79 e 79-80). E servise è del resto il lemma usato con sarcasmo da Figura per designare l’operato di Eva in disobbedienza alle norme divine («jo toi rendrai ta deserte, / jo t’en donrai por ton servise», vv. 450-451), e si noti che anche deserte, ‘ricom-pensa’, etimologicamente è riconducibile allo stesso ambito semantico, essendo deverbale di desservir < lat. desservire, ‘servire con zelo’.
13 «Se de bon cuer le voloms obeïr / n’averont nos almes poür de perir», vv. 601-602.14 «Preom lui qu’il nus doinst s’amor / e nus defende de mal noit e jor», vv. 637-638.15 Come fa Abele: «en Deu est tote ma fiance», v. 692. Anche se ciò non lo salverà dall’ira
di Caino che gli rinfaccia: «ja ne t’avra mestier fiance», v. 720.16 Così suona il monito di Abele nei confronti del fratello («nen fai ja vers Deu revel», v. 626),
a cui fanno eco le parole di Figura a Caino dopo che l’assassinio è stato perpetrato: «es tu ja entrez en revel?», v. 724.
17 Ancora Figura a Caino, al verso immediatamente successivo: «tu as comencié vers moi estrif!» (v. 725).
18 Cfr. il succitato v. 594.19 In questi termini Figura designa il comportamento di Caino: «mult en fais grant felo-
nie», v. 735.20 Cfr. Is 14, 12-14: «quomodo cecidisti de caelo, Lucifer, fili aurorae? Deiectus est in ter-
ram, qui deiciebatis gentes, qui dicebas in corde tuo: “In caelum conscendam, super astra Dei exaltabo solium meum, sedebo in monte conventus in lateribus aquilonis; ascendam super altitudinem nubium, simil ero Altissimo”». Sulla riflessione esegetica che portò all’elabora-
LA TEMATICA SOCIO-ECONONICA NEL JEU D’ADAM 99
vizio “feudale” per eccellenza, più di ogni altro insidioso in quanto tende a sovvertire l’ordine della società, impostato su un rigido e sostanziale equili-brio fra subordinazione e supremazia.21 E laddove la colpa sia ispirata dalla superbia l’unica reazione possibile non può che essere la vendetta: Caino perpetra il suo delitto per vendicarsi del presunto – o preteso – tradimento di Abele («io men voldrai vengier de toi», v. 680) che gli preannunzia come certezza l’intervento vindice di Dio quale giusto castigo per l’iniquità di cui sarà vittima («Deu vengera en toi ma mort», v. 706).
I due fratelli stessi si comportano come vassalli fra loro ostili, prossimi al conflitto, conflitto presagito dalle parole di Abele («por quei avra entre nus dous tençon? / Tote la terre nos est mis a bandon!», vv. 609-610) che nei rimanti tençon : bandon estrinsecano appieno uno scoperto riassetto del racconto biblico in accordo con i principi e le consuetudini di un feudale-simo maturo: la tençon – la guerra, lo scontro armato – è necessariamente messa in relazione con una terra su cui si ha giurisdizione,22 e la cui signoria deriva da un potere superiore. Un conflitto che assume contorni concre-ti nell’aspro monito di Caino ai vv. 621-622: «qui entre nus comencera la guerre, / tres bien l’achat, ke droiz est qu’il s’en pleingne!». Un conflitto su cui aleggia qualcosa di non detto, l’allusione a un antefatto sottaciuto che fornirebbe la motivazione fittizia del reciproco atteggiarsi dei due facendo presagire l’imminente tragedia: fra loro c’è inimicizia (dato estraneo alla narrazione biblica), un disaccordo che affonda le proprie radici in un anti-tetico rapporto con il Creatore. Eppure Caino non ha ancora visto disprez-zate da Dio – senza giustificazione apparente,23 ma a questa incongruenza l’autore saprà porre rimedio24 – le proprie offerte, perciò non parrebbe
zione della figura di Satana e delle ragioni della sua caduta si veda il sintetico D. Sabbatucci, Satana figlio di Dio, «Abstracta», 36 (1989), pp. 14-21.
21 In merito si veda J. Huizinga, Autunno del medioevo, Firenze, Sansoni, 19898 [traduzione della terza edizione dell’opera, Leipzig, Kröner, 1930], pp. 31-32. Sul concetto di superbia del medioevo cfr. C. Casagrande, S. Vecchio, I sette vizi capitali. Storia dei peccati nel medioevo, Torino, Einaudi, 2000, pp. 3-35.
22 È una delle accezioni dell’a. fr. ban (< francone bann ‘proclama’) da cui bandon deriva, all’origine di un’ampia “famiglia” lessicale variamente acquisita dal linguaggio giuridico e militare del feudalesimo.
23 Il Genesi non dice perché Dio abbia negletto Caino e le sue spighe: l’avversione divina nei suoi confronti insorge infatti solo in seguito, quale reazione al fatto che egli abbia accet-tato di mal grado il rifiuto del Creatore, per quanto incomprensibile. Una spiegazione pos-sibile della preferenza accordata da Dio a Abele è offerta da Pietro Comestore, secondo cui l’offerta di Caino sarebbe stata troppo misera, e ispirata dal peccato dell’avarizia: «munera vero Cain, ex avaritia hominis nata, Deo non placuerunt» (Historia scholastica, «Historia libri Genesis», cap. XVI (P.L. CICVIII, col. 1077).
24 Nel Jeu, infatti, Caino offre deliberatamente spighe di cattiva qualità («Abel: Iert [ton blé] del meillor? / Chaim: Nenil, por voir, / de cel frai jo pain al soir!», vv. 651-652), circo-stanza certo utile a motivare il disprezzo di Dio ma che non trova riscontro in Gn 4, 3: «fac-tum est autem post multos dies ut offerret Cain de fructibus terrae munera Domino».
SONIA MAURA BARILLARI100
esservi nulla che possa dar adito alle preoccupazioni di Abele, espresse in forma esortativa ma sovradeterminate dalla marca forte della negazione, espediente capace di calcare l’evidenza dell’esatto contrario di quanto si afferma: «entre nos […] / n’i soit envie, n’i soit detraction» (vv. 607-608). Un conflitto su cui grava il fatto che Caino è il fratello maggiore, «li ai-nez» (v. 675) e Abele, da buon vassallo, deve obbedirgli («jo ensivrai tes vo-lentez», v. 676) senza tuttavia derogare dall’obbligo di prestargli consilium, come fa nel discorso iniziale a cui la forma metrica – quartine di décasyllabes monorimi – infonde un ritmo lento ed austero.25 E come torna a fare per dissuaderlo dal suo proposito di rifiutare a Dio ciò che gli è dovuto: «creez mon conseil! Aloms offrir / a Dampnedeu, por lui plaisir» (vv. 629-630). In quest’ottica la sua uccisione si mostra ancor più grave proprio in quanto non motivata da alcuna trasgressione al codice feudale: la sorte che attende Caino, vassallo rinnegato e ribelle, sarà inevitabilmente segnata da una pu-nizione dura e irrevocabile.
2. Isoglosse: offerta, dono e contro-dono
Fra i due fratelli, la ragione del contendere sono le offerte da tributare a Dio, offerte denominate dismes, che Abele è lieto di offrire e Caino al-tezzosamente aborre: «disme doner ne me vint onches a gré» (v. 615). E dalla parola disme, ‘decima’, possiamo provare a partire per cogliere il senso profondo di questo brano.26 Essa vi ricorre quattro volte (vv. 603, 615, 657, 712) ed è al centro di una costellazione lessicale che si irradia a coprire uno spettro abbastanza ampio del campo semantico relativo al dono, declinato nella sfera del sacro: fra i sostantivi registriamo don (vv. 604, 636), primices (vv. 604, 712), offrende (vv. 604, 635), sacrifice (vv. 604 653, 701), oblacions (v. 712); fra i predicati doner (vv. 603, 614, 615, 637), offrir (vv. 629, 635, 642, 664, 646, 647, 648), rendre (v. 711). Donare da cui – ma questo viene esplicitato solo in seguito – ci si aspetta una contropartita, a condizione che venga fatto di cuore: «offrez le lui de bon cuer, / si recevras bon luër» (vv. 559-560). La locuzione «de bon cuer»27 chiamata a qualificare le modalità
25 Vv. 591-610. Anche la risposta di Caino è foggiata sullo stesso metro. Sulla funzionalità stilistica dell’utilizzo nel Jeu delle quartine di décasyllabes cfr. J. B. E. Gregory, A note on lines 113-122. Le Mystère d’Adam, in «Modern language notes», 78/5 (1963), pp. 536-537, e E. J. Buckbee, The Jeu d’Adam as Ordo representacionis Evae: truth and dramatic consequences, in «Medioevo ro-manzo», IV (1977), pp. 19-34, a p. 30.
26 Come nota Lynette Muir, il pagamento delle decime era un tema comunemente trat-tato nelle scene dedicate a Caino e Abele presenti nelle rappresentazioni teatrali medievali, tuttavia il Jeu è il solo testo in cui esso sia motivato come un tentativo di riparare al peccato commesso da Adamo e Eva. Muir, Liturgy and drama in the anglo-norman Adam, cit., pp. 86-87.
27 Merita di essere sottolineato come una locuzione simile sia impiegata all’interno di un contesto analogo nel fabliau di Jean Bodel De Brunain la vache au prestre dove tale associazione
LA TEMATICA SOCIO-ECONONICA NEL JEU D’ADAM 101
del dare compare anche poco oltre, ai vv. 599-606, in cui Abele torna ad incalzare il fratello sulla necessità di rendere a Dio quanto gli è dovuto, sottolineando la natura spirituale della ricompensa:28
si servum Deu que li vienge a plaisir. Rendom ses droiz, nen soit riens del tenir. Se de bon cuer le voloms obeïr n’averont nos almes poür de perir. Donum sa disme e tute sa justise, primices, offrendes, dons, sacrifice. Si del tenir nos prent acoveitise Perdu serroms en emfer sen devise!
Esortazione che, fra l’altro, pone in risalto la contrapposizione fra droiz – ciò che è dovuto e il diritto ad esigerlo: accezione che, similmente a justise e raisons (v. 711), perfettamente si attaglia alle decime, di cui il termine può essere considerato sinonimo – e tenir in cui si condensa il concetto di avarizia, di cupidigia (acoveitise), peccato “economico” per antonomasia che lungo tutto il medioevo contese alla superbia il primato nella gerarchia dei vizi capitali29 in accordo con la sentenza paolina secondo cui «radix […] omnium malorum est cupiditas» (I Tim 6, 10).30 Primazia che nella tratta-zione di Pier Lombardo giunge ad essere assegnata ad entrambi, in una reciproca e solidale alternanza in cui è individuato il fondamento primo di ogni agire peccaminoso:31
ex superbia tamen omnia mala oriuntur, et haec, et alia, quia, ut ait Gregorius, «radix cunti mali est superbia». De qua dicitur Eccl 10: «initium omnis peccati, superbia», quae est amor propriae excellentiae […] Similiter et ex cupiditate.
è esplicitata nella predica del prete («[dist] que Dieus au double li rendoit / celui qui le fasoit de cuer»; vv. 8-9), ben recepita dal villano che gli donerà la sua vacca macilenta con l’auspicio – poi realizzatosi – di veder raddoppiato il proprio “capitale”: «qui por Dieu done a escïent, / que Dieus li fet mouteploier» (vv. 12-13). Il testo si legge nell’edizione di Pierre Nardin: Jean Bodel, Fabliaux, Paris, Nizet, 1965, pp. 95-97.
28 A questo proposito rinvio a S. M. Barillari, «Centuplum accipietis…»: la “moralizzazione” delle tematiche folcloriche in un exemplum del XIII secolo, in «L’immagine riflessa», XIII (1990), pp. 55-79; Ead., Donare per Dio. L’azzardo della fede nella nascente economia di mercato, in Vincolare, ricambiare, dominare. Il dono come pratica sociale e tema letterario, a c. di N. Pasero e S. M. Ba-rillari, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2007, pp. 165-184; Ead., «Est Dieus bon doublere»: il dono per Dio e il dono di Dio da Brunain al Jeu de saint Nicholas, in «Medioevo romanzo», XXXII (2008), pp. 241-261.
29 Un’esauriente trattazione in merito è offerta in Casagrande, Vecchio, I sette vizi capi-tali, cit, pp. 96-100.
30 Ma si veda anche Eccl 10, 9-10: «avarum autem nihil est scelestius, hic enim et animam suam venalem habet. Quid superbit terra et cinis? Quoniam in vita sua proiecit intima sua».
31 Si tenga presente che l’associazione cupidigia-superbia era ritenuta alla base stessa del peccato di Adamo: Casagrande, Vecchio, I sette vizi capitali, cit, p. 99.
SONIA MAURA BARILLARI102
Unde Apostolus ait, I Tim: «radix omnium malorum est cupiditas», quia si radix omnium malorum est cupiditas, ergo superbiae […] utrumque recte dictum esse intelligitur, si genera peccatorum singulorum, non singula generum utra-que locutione includi intelligantur; nullum quippe genus peccati est, quo inter-dum ex superbia non proveniat; nullum etiam, quod ex cupiditate aliquando non descendat. Sunt enim nonnulli hominum qui ex cupiditate fiunt superbi, et aliqui ex superbia fiunt cupidi […] patet ergo quod ex superbia aliquando cupiditas, ex cupiditate aliquando superbia oritur, et ideo de utraque recte di-citur quod sit radix omnis mali.32
Un vizio, quello dell’acoveitise, che ben si confà a Caino, descritto come
ricco dal fratello («riches hom es e mult as bestes», v. 655),33 derogando anche in questo ai presupposti dell’etica feudale per cui la ricchezza assolve al ruolo di discriminante sociale proprio nell’esercizio della largesse, estra-nea tanto alla tesaurizzazione dei beni quanto al loro assoggettamento alla logica del profitto.34 E così andando pericolosamente a gravitare nell’orbita della mentalità mercantile che integra questo peccato «del tempo nuovo»35 fra i dispositivi posti in atto per trasformare e sconvolgere le condizioni del potere tradizionale.
Se la contropartita in cui confida Abele è senz’altro estranea allo spiri-to veterotestamentario, essa viene invece contemplata dall’insegnamento evangelico che promette cento volte tanto, anche su questa terra, a chi vor-rà offrire al Signore quanto gli appartiene.36 Una contropartita che si pro-ietta entro lo schema proprio del dono: un atto che non è una prestazione libera e gratuita, né soggiace alle norme che disciplinano la produzione e gli scambi finalizzati all’utile, bensì si configura come un “ibrido” di questi due modi di rapportarsi agli altri,37 recando in sé la nozione di credito,
32 Sententiarum libri quattuor, II, xlii, 9-10 PL CXCII, col. 753-754.33 Si rammenti come tanto la patristica quanto il diritto canonico vedevano nella pro-
prietà privata, e nella ricchezza che da essa consegue, una conseguenza diretta del peccato “originale”.
34 Cfr. Ph. Haugeard, Ruses médiévales de la générosité. Donner, dépenser, dominer dans la littéra-ture épique et romanesque des XIIe et XIIIe siècles, Paris, Champion, 2013, pp. 101-131.
35 Così Huizinga definisce appunto l’avarizia, contrapponendolo al peccato «del tempo antico», l’orgoglio: L’autunno del medioevo, cit., p. 31.
36 Così in Mc 10, 29-30: «rispose Gesù: “In verità vi dico: non c’è nessuno, che abbia lascia-to casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e del vangelo, il quale non riceva ora, nel tempo presente, il centuplo in case, fratelli, sorelle, madri, figli e campi insieme alle persecuzioni, e la vita eterna nel secolo futuro”»; ma similmente in Mt 19, 29 e Lc 18, 29-30. La dialettica Vecchio vs Nuovo Testamento potrebbe riverberarsi allegoricamente nelle figure dei due fratelli che rappresenterebbero – così ritiene Lynnette Muir – rispetti-vamente il popolo cristiano (Abele) e quello ebraico (Caino): Muir, Liturgy and drama, cit., pp. 83 e 85.
37 Cfr. M. Mauss, Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, Torino, Einaudi, 2002 [1950], p. 127.
LA TEMATICA SOCIO-ECONONICA NEL JEU D’ADAM 103
presente nell’aspetto più distintivo del dono, l’attitudine a obbligare nel tempo.38 Ma, dal momento che il donatario è Dio,39 tale “credito” neces-sariamente comporta risvolti del tutto peculiari, le cui implicazioni sono state debitamente approfondite dalla teologia medievale proprio ai fini di emanciparlo da una concezione prettamente “monetaria”.40
Una contropartita che, come si è visto, viene anche inscritta, con i pro-pri corollari etici e giuridici, entro il paradigma dell’istituto della decima, a propria volta organico all’ordinamento feudale che a esso si affida per regolamentare sul piano quantitativo gli obblighi a cui son chiamati ad adempiere gli individui soggetti in ragione dei legami personali sussistenti con il proprio signore.
3. «Non decimas, quae sunt pauperum Dei»
Il tema delle decime, cardine di questo episodio, in verità, e contraria-mente a quanto possa apparire a prima vista, è tutt’altro che avulso dal sog-getto trattato: le fonti patristiche, infatti, unanimemente ne attribuiscono l’istituzione allo stesso Adamo, il quale avrebbe imposto il loro pagamento ai figli per riparare almeno in parte al peccato commesso. Così Ugo di San Vittore:
credimus Deum docuisse Adam cultum divinum, quo recuperaret eius benevo-lentiam, quam amiserat per peccatum transgressionis, et ipse docuit filios suos, dare scilicet decimas et primitias.41
Si tenga inoltre presente che la catechesi della Chiesa medievale era assai severa nei confronti di chi si fosse astenuto dal loro pagamento, invo-cando su di lui la maledizione divina:
qui enim decimam retinuierit, praedam de Dei rebus facit; et si Deo partem
38 Ivi, p. 58-59.39 Offre un’ampia casistica di tale tipologia di tale tipo di dono Natalie Zemon Davis, che
però si focalizza principalmente sulla realtà cinquecentesca. Cfr. N. Zemon Devis, Il dono. Vita familiare e relazioni pubbliche nella Francia del Cinquecento, Milano, Feltrinelli, 2002 [2000], in particolare il cap. 7, I doni e gli dèi.
40 Come ha chiarito la ricerca condotta da Bernard Jussen sul lessico correlato a tale nozione nei testi del XII secolo, la speculazione teologica non presupporrebbe tanto l’asso-ciazione munus - remuneratio (‘remunerazione’, ‘ricambio’) quanto quella munus - cor (esatta-mente come fanno le parole di Abele), mettendo in risalto la retta disposizione di spirito. Cfr. B. Jussen, Gift and heart, countergift and deed: a scholarly pattern of interpretation and tha language of morality in the Middle Age, in Negotiating the gift: premodern figurations of exchange, ed. by G. Algazi, V. Groebner, B. Jussen, Gottingen, Vandenhoeck and Ruprecht, 2003.
41 Ugo di San Vittore, Adnotationes elucidatoriae in Pentateuchon, in PL CLXXV, coll. 29-114, col. 44.
SONIA MAURA BARILLARI104
suam rapiet ipse ei novem auferet, nunc per tempestatem, nunc per siccitatem, nunc per grandinem, nunc per uredinem, nunc per pestilentiam, nunc per iudicum vel militum violentiam, nunc per ignis invasionem, nunc per furum vel latronum direptionem42
recita lo Speculum Ecclesiae di Onorio di Autun sotto la voce «De agricola», e lo fa proprio in un capitolo dedicato alla «Dominica in Septuagesima», ovvero quello stesso tempo liturgico dal cui ufficio sono tratti la lectio e i sette responsori che rispettivamente introducono e scandiscono le prime due sezioni del Jeu.
Ciò non toglie che tale tema rientri a pieno titolo anche in un altro ordi-ne di intenti, forse sottesi alla stesura dell’opera o comunque plausibilmen-te attivati e resi operanti in occasione della sua trascrizione nel secondo quarto del XIII secolo43 nel Sud Est della Francia44 per mano di un copista provenzale:45 a questi l’antigrafo anglonormanno sarebbe potuto giungere mentre regnavano i Plantageneti – forse Giovanni, o Enrico III46 – epoca in cui rapporti fra tale area geografica e l’Inghilterra furono particolar-mente intensi. Territori ancora sconvolti dall’offensiva anti-catara e in cui era ovvio paventare reviviscenze di forme di religiosità condannate come
42 PL CLXXII, coll. 807-1108, col. 866.43 La datazione è stata a lungo controversa: secondo Luzarche la prima parte sarebbe stata
stilata nella seconda metà del XII secolo (opinione condivisa da Foerster), la seconda agli inizi del XIII; Delisle e Dorange indicano come termine post quem la metà del XIII; Marichal e Gachet – basandosi sulla natura del materiale scrittorio – ne fissano definitivamente la data al secondo quarto del XIII. Cfr. Le Mystère d’Adam (Ordo representacionis Ade). Texte complet du manuscrit de Tours publié avec une introduction, des notes et un Glossaire, par P. Aebischer, Droz - Minard, Genève - Paris 1964, p. 14.
44 A corroborare quest’ipotesi interviene il fatto che il codice, frutto dell’assemblaggio di due parti distinte (cc. 1-46, acefale, e 47-229), è redatto su un supporto cartaceo: l’uso della carta in campo librario è infatti, a questa altezza cronologica, del tutto eccezionale per l’Occi-dente cristiano che ne apprende gradualmente le tecniche di fabbricazione, e la consuetudi-ne all’impiego, dagli arabi stanziati nella penisola iberica. D’origine ispano-araba è appunto la carta dei fogli, in fibra di cotone, che compongono il codice di Tours, come confermano l’assenza di vergelle e filigrane nonché la triturazione mediocre dei lunghi filamenti di lino, canapa o stracci a partire dai quali essa è prodotta, infine la patinatura assai accentuata che ha senz’altro favorito la conservazione del manufatto. Il che rende altamente probabile che i due manoscritti da cui è formato siano stati esemplati in area provenzale, a stretto contatto con i territori ancora soggetti alla dominazione musulmana. Cfr. H. Gachet, Six siècles d’hi-stoire du papier, in «Courrier graphique», 14 avril 1938, pp. 3-9, a p. 6.
45 A denunciare l’origine meridionale del copista della prima sezione intervengono ele-menti quali tarzera in luogo di tardera dei vv. 558 e 918 del Jeu, e la rima pan : hahan dei vv. 435-436. Lo stesso può dirsi per l’estensore della seconda sezione che nella Vie de saint George, corregge con coq un precedente gal, espunto e biffato, evidente frutto dell’estemporanea e istintiva traduzione dello scrivente.
46 Cfr. Le Mystère d’Adam. An anglo-norman drama of the twelfth century, ed. by P. Studer, Manchester University Press - Longmans, Green & Co., Manchester - London 1918 p. XXXIV.
LA TEMATICA SOCIO-ECONONICA NEL JEU D’ADAM 105
eretiche ma ancora profondamente radicate nei cuori e nelle coscienze dei più,47 elementi residuali ma pertinaci che era necessario arginare e ricon-durre entro l’alveo del paradigma cristiano. Situazione che motiva e giusti-fica un’intensa azione di catechesi volta per un verso a corroborare la fede degli invasori settentrionali chiamati a ripristinare l’ortodossia, per l’altro a contrastare gli “errori” di chi ancora, più o meno apertamente, aderiva al credo, o alla morale, professati dai “buoni cristiani”.48
E a tali intenti certamente si prestava il Jeu, come e anche più delle altre opere tràdite dal codice che lo contiene, specie nella sua prima parte.49 Intanto per il suo mettere in scena una materia veterotestamentaria,50 e in particolar modo i primi capitoli del Genesi: se invero la dottrina catara traeva fondamento essenzialmente dai Vangeli, e precipuamente da quello di Giovanni,51 era per l’appunto il primo libro dell’Antico Testamento a es-sere rigettato con maggiore risolutezza,52 stigmatizzando la cosmogonia ivi proposta quale menzogna fallace. A essi opponeva una propria storia della creazione che voleva Satana artefice di questo mondo e dei suoi abitanti, seduttore carnale di Eva e suscitatore della concupiscenza dei sensi affinché i corpi si moltiplicassero all’infinito imprigionando senza posa le anime di quegli angeli che si erano ribellati al loro creatore.53 Sotto questo riguar-do, rappresentare l’episodio della caduta, e le sue immediate ma durature conseguenze, soddisfaceva al meglio alla volontà di ribadire la versione or-todossa, o comunque “vulgata”, della creazione dell’uomo,54 e di conserva
47 Rammentiamo che l’indagine svolta a Montaillou da Jacques Fournier per scoprire ed estirpare l’eresia catara data fra 1318 e 1325.
48 Così infatti si designavano i seguaci di quella che gli inquisitori definirono eresia catara.49 Che contiene, oltre al Jeu, un dramma liturgico de Resurrectione (acefalo), 33 inni e canti
quasi tutti consacrati a celebrare la Vergine o la resurrezione e Les quinze signes du Jugement dernier. La seconda parte del manoscritto è costituita essenzialmente da testi di natura agio-grafica.
50 In questo senso il Jeu d’Adam si presenta come un esemplare atipico nel panorama del teatro religioso medievale, latino e vernacolare, in cui predominano soggetti di ispirazione evangelica. Fa eccezione, se si escludono gli Ordines prophetarum (anch’essi tuttavia proiettati sull’avvento redentore del Cristo), il Ludus Danielis (prima metà del XII sec.) che tuttavia potrebbe essere a essi ricondotto. Cfr. D’A. S. Avalle, Il teatro medievale e il Ludus Danielis, Torino, Giappichelli, 1984, p. 135.
51 Per il suo carattere esoterico e in quanto considerato perfuso di influenze dualistiche: cfr. R. Nelli, Dictinnaire du Catharisme et del hérésies méridionales, Toulouse, Privat, 1994 [1968], pp. 124-127; e Id., Les Cathares, Paris, Marabout, 1972, pp. 121-122.
52 Cfr. A. Brenon, Les cathares, Paris, Éditions Albin Michel, 2007, pp. 223-224.53 I tratti essenziali della cosmogonia catara si traggono soprattutto dalla Cena segreta e
dal Libro dei due principi, due fra i pochi testi di provenienza ereticale a noi giunti. Tutti sono pubblicati in traduzione italiana in F. Zambon (a c. di), La cena segreta. Trattati e rituali catari, Milano, Adelphi, 1997. Per una panoramica sintetica si veda J. Duvernoy, La religione dei ca-tari. Fede – dottrine – riti, Roma, Edizioni Mediterranee, 2000 [ed. or.: Touluse, Éditions Privat, 1976], pp. 58-67; e R. Nelli, Le phénomène cathare, Toulouse, Privat, 1964, pp. 27-33.
54 Per inciso, vale la pena ricordare come nei miti catari della creazione dopo l’interdizio-
SONIA MAURA BARILLARI106
scardinare quella dicotomia fra corpo e anima, fra materia e spirito in cui risiedeva il dogma forse più pernicioso, e dirompente, del credo cataro.
Nondimeno, lo stesso può dirsi per l’Ordo prophetarum:55 riconosciuti dai catari come figure storiche a tutti gli effetti, i profeti erano considerati da essi figure radicalmente malvagie,56 espressione delle menzogne contenute nell’Antico Testamento e autentiche «figure diaboliche, emissari del deus iniquus».57 Ed esaltarne l’autorevolezza equivaleva a confermare la loro cen-tralità nella religione cristiana.
Similmente pregnante appare l’enigmatico personaggio di Figura, de-signato esplicitamente come Salvator nella didascalia con cui si apre il te-sto: «tunc veniat Salvator indutus dalmatica et statuantur choram eo Adam, Eva». Benché tale didascalia, come ogni altra, avesse quale unico destinata-rio chi si sarebbe assunto il compito di allestire la rappresentazione, e non il pubblico, ciò non toglie che se pure gli eventuali spettatori non avevano modo di sentire pronunciare la parola Salvator, appellativo canonico del Cristo, potevano tuttavia ugualmente identificare come tale chi lo imper-sonava, o quantomeno recepirne la presenza, grazie alla dalmatica che egli indossava: larga tunica aperta ai lati, con maniche ampie, essa forma una croce ornata di strisce rosse che, secondo la simbologia medievale, avrebbe dovuto ricordare a chi la portava la passione e la morte di Gesù.58
ne – in questo caso diabolica – a mangiare il frutto “proibito”, quest’ultimo non giochi più ruolo alcuno nella vicenda della caduta, in ciò sostituito dal primo atto sessuale e dall’inizia-zione alla lussuria da parte di Satana. Cfr. Zambon, La cena segreta, cit., pp. 118-119; e M. Ro-quebert, La religion cathare. Le Bien, le Mal et le Salut dans l’hérésie, Paris, Perrin, 2009 [edizione riveduta ed ampliata rispetto alla prima del 2001], pp. 162-163.
55 Si tenga presente che esso è introdotto dalla lectio quasi integrale dell’undicesimo ca-pitolo del sermone Contra Judaeos, Paganos et Arianos: circostanza che può aver sollecitato un’assunzione dell’opera in chiave “militante” in considerazione dell’invalsa consuetudine a designare come “ariani” gli adepti della nuova eresia, avendo i catari in comune con gli ariani la negazione della divinità del Cristo. Cfr. Duvernoy, La religione del catari, cit., pp. 257-258. Ma cfr. anche Roquebert, Histoire des Cathares, cit., p. 53 e Zambon, La cena segreta, cit., p. 43.
56 Duvernoy, La religione del catari, p. 33.57 In particolare Abramo, Isacco, Giacobbe e Mosè: cfr. Zambon, La cena segreta, p. 54. Si
tenga presente, fra l’altro, che Nabucodonosor – il profeta che conclude il Jeu quale è giunto fino a noi – è uno dei nomi che i catari attribuivano a Satana. Ibidem.
58 Così infatti la descrive Rabano Mauro nel De clericorum institutione : «haec vestis in mo-dum est crucis facta, et passionis Domini indicium est. Habet quoque et purpureus tramites ipsa tunica, a summo usque ad ima ante ac retro descendens, nec non et per utramque ma-nicam, ut admoneatur minister Domini per habitus sui speciem, cujus muneris particeps est, ut per mysticam oblationem passionis Dominicae commemorationem agat, ut ipse in eo fiat hostia Deo acceptabilis». Rabanus Maurus, De clericorum institutione I, XX (P.L. CVII, coll. 307-308). Non molto diversamente Sicardo, vescovo di Cremona (1155-1215), oltre tre secoli dopo: «laxas manicas addidit, et in sacrificiis portandam instituit. Crucis itaque formam gerit, duas habens lineas, ante et retro, coccineas vel purpureas [...] Sub ala pertusa lateris [latera?] ut ejus vestigia imitetur, qui fuit in latere lancea perforatus. Ad missam et ad annuntiandum evangelium est portanda, ubi Christus praesentatur et praedicatur, quia formam gerit crucis;
LA TEMATICA SOCIO-ECONONICA NEL JEU D’ADAM 107
E mentre da un lato un Creatore denominato Figura,59 e identificato col Salvator in termini sia onomastici che visivi, proiettava sulle vicende dei primi progenitori la certezza della redenzione futura – in perfetto accordo con il tempo liturgico per cui il Jeu è concepito – dall’altro tale inedita sintesi di Padre e Figlio affermava con forza e perspicuità quasi sillogistica la dottrina trinitaria, per la quale la natura divina, ovvero la sua essenza, è una, semplice, individua, in cui sussistono tre Persone.60 Affermazione in aperto contrasto con la cristologia albigese che vedeva nel Figlio uno spirito celeste, un angelo, dunque inferiore al Padre con cui non poteva condivi-dere appieno natura e sostanza.61
In accordo con tale linea interpretativa acquisiscono un deciso rilievo anche altri dettagli del Jeu che non hanno riscontro nel dettato scritturale, come la «lei de manage» (v. 24), il «droiz de mariage» (v. 38) precocemen-te62 quanto puntigliosamente enunciati da Figura prima ad Adamo e poi a Eva nell’Eden che sacralmente accredita un’istituzione, quella del matri-monio, screditata dal catarismo.63
formam vero gerit crucis tum quia Christus pro nobis tulit patibulum crucis». Sicardi cremo-nensis episcopi, De mitrali seu Tractatus de officiis ecclesiasticis summa II, V (P.L. CCXIII, coll. 75-76).
59 Si tenga presente come Cristo sia espressamente definito da san Paolo «figura substan-tiae eius [di Dio]» in Eb 1, 3.
60 Esplicite in merito le affermazioni di sant’Agostino, attento a definire con precisione soprattutto le pertinenze semantiche dei termini in gioco: «alius est quidem Dei Filius, sed non aliud: hoc ut alia persona, non diversa natura» (De anima et eius origine 2, 5, 9); «non di-camus unum eumdemque esse Patrem et Filium et Spiritum Sanctum . . . sed dicamus unam eamdemquem esse naturam Patris et Filii et Spiritus Dancti» (De nuptiis et concupiscientia 2, 23, 28). Ma si veda anche De civitate Dei 11, 10, 1. Per un inquadramento più approfondito del problema terminologico si veda A. Trapè, I termini “natura” e “persona” nella teologia trinitaria di s. Agostino, in «Augustinianum», XIII (1973), pp. 577-587.
61 Cfr. Duvernoy, La religione dei catari, cit., pp. 72-79; Nelli, Le phénomène cathare, cit., pp. 43-48; e Roquebert, La religion cathare, cit., pp. 59-60.
62 Ricordiamo che solo nel 1215, nel corso del Concilio Lateranense IV, la Chiesa cattolica regolamentò la liturgia per il matrimonio e gli aspetti giuridici ad esso relativi. E bisognerà attendere il Concilio di Firenze (1439) perché venisse chiaramente esplicitato che il matri-monio doveva essere considerato dai fedeli come un sacramento. La concomitanza della regolamentazione giuridica e liturgica del matrimonio con la condanna dell’eresia albigese espressa dallo stesso concilio non è ovviamente da ritenersi frutto di casualità.
63 Cfr. Duvernoy, La religione del catari, cit., pp. 160-161; e A. Brenon, Les femmes cathares, Paris, Perrin, 2004 [2002], pp. 102-105. È risaputo che i Perfetti non proibivano ai semplici credenti il matrimonio, che tuttavia non aveva statuto sacramentale. Ciò non toglie che la condanna nei confronti dei rapporti carnali e della procreazione, con il conseguente di-scredito dell’istituzione matrimoniale, fosse individuata da inquisitori e polemisti “ortodossi” quale uno dei tratti distintivi chiamati a identificare in toto i seguaci dell’eresia albigese: così fanno ad esempio Walter Map (De nugis curialium, I, 30; Svaghi di corte, a c. di F. Latella, Parma, Pratiche, 1990, pp. 172-179) e Ralph of Coggeshall (Chronicon anglicanum, ed. by J. Stevenson, London, Longman, 1875, pp. 121-125: «De superstitione publicanorum»). Sulla pratica dell’unione coniugale presso i catari cfr. Nelli, Le phénomène cathare, cit., pp. 92-98;
SONIA MAURA BARILLARI108
A ciò si aggiunga l’accento posto sul lavoro inteso come dura condanna, a petto dell’importanza assegnatagli dai catari in ottemperanza ai precetti apostolici64 che lo fanno interpretare un valido strumento di elevazione morale e spirituale. E, soprattutto, l’insistenza con cui ritorna il tema delle decime nell’episodio qui analizzato, utile a confutare il loro rifiuto di rico-noscere la legittimità di un siffatto istituto,65 apertamente osteggiato quale espressione tangibile dei diritti signorili66 e del sistema economico feudale avallato dalla Chiesa di Roma.67 Tale occorrenza si rivela vieppiù significa-tiva se si considera come la letteratura esegetica istituisse un’equivalenza tipologica fra Caino e, da una parte, la figura dell’ebreo, dall’altra quel-la dell’eretico,68 qui rinsaldata dalla comune predisposizione a concepire un’economia più “fluida”, in cui la tesaurizzazione delle ricchezze prelude a una loro dinamica circolazione.69
Tutti elementi, questi, che se inducono a supporre una ricezione del Jeu in ambiente meridionale “orientata” in chiave di propaganda antiereticale suggeriscono anche, di concerto con altri meno direttamente perspicui ma parimenti rilevanti,70 che una simile finalità potesse essere sottesa anche alla composizione stessa dell’opera, databile attorno alla metà del XII secolo. È noto che i prodromi del dilagare di nuovi e potenti fermenti eterodossi in seno alla Chiesa cristiana assai vicini nei principi al credo dei futuri catari si osservano fin dagli albori dell’anno Mille,71 ma col passare di un secolo
Id., Les Cathares, cit., pp. 17-20.64 In particolare paolini: cfr. Roquebert, Histoire des Cathares, cit., pp. 79-80. Ma si veda
anche Duvernoy, La religione dei catari, cit., pp. 214 e 217-218; e R. Nelli, La vie quotidienne des Cathares du Languedoc au XIIIe siècle, Paris, Hachette, 1969, pp. 121-128.
65 Cfr. Duvernoy, La religione del catari, cit., pp. 224-226; Nelli, La vie quotidienne, cit., pp. 134-136.
66 Sul rifiuto dei catari nei confronti dei valori feudali si veda Nelli, Les Cathares, cit., pp. 13-24.
67 Si tenga presente che le pene comminate dagli inquisitori a quanti erano giudicati ere-tici erano particolarmente dure se la colpa riconosciuta contemplava il mancato pagamento delle decime: Nelli, La vie quotidienne, cit., pp. 164-165.
68 Cfr. F. Saxl, English sculptures of the twelfth century, London, Faber and Faber, 1954, p. 51.69 Sulla liceità del deposito fruttifero, del prestito a interesse e del prestito commerciale
presso le comunità catare, e sulle sue motivazioni teologiche cfr. Nelli, Les Cathares, cit., pp. 20-23; e Id., La vie quotidienne, cit., pp. 113-115.
70 Quali lo spazio concesso a Isaia, di gran lunga eccedente rispetto a quello riservato agli altri profeti, e la decisione di non presentare Eva nell’atto di filare, visti gli stretti legami – concreti e metaforici – che tendevano a collegare le pratiche della filatura e della tessitura con i seguaci della nuova eresia. In merito si veda S. M. Barillari, La scena di pietra. Tradizione materiale e pratiche performative a confronto sulla scorta del Jeu d’Adam, in Atti del convegno Oggetti materiali e pratiche della rappresentazione nel teatro medievale (Genova, 20-22 giugno 2012), cds.
71 Già nel 1022 Ademaro di Chabannes nelle sue Cronache registra che «apud Tolosam inventi sunt manichei, et ipsi destructi, et per diversas Occidentis partes nuntii antichristi exorti, per latibula sese occultare curabant, et quoscumque poterant viros et mulieres subver-tebant». Ademarus Engolismensis, Historiarum libri tres, III 59 (P.L. CXLI, coll. 19-80, coll.
LA TEMATICA SOCIO-ECONONICA NEL JEU D’ADAM 109
le testimonianze si moltiplicano, e gli eretici processati a Anversa, Lovanio, Bruges, Liegi, Utrecht, Colonia, Treviri, Ivoy nelle Ardenne, Tolosa fra 1110 e 1145 professano una fede che lascia trapelare – ovviamente per il trami-te degli inquisitori – «corrispondenze abbastanza precise con le dottrine catare, quali saranno inequivocabilmente attestate a partire dalla seconda metà del XII secolo».72 Tanto che san Bernardo, giunto nel 1145 a Tolosa su richiesta del legato pontificio per contrastare l’apostolato itinerante di Enrico di Losanna, vide i suoi sforzi per estirpare le credenze eterodosse allignate nel Midi in gran parte vanificati dal radicamento di queste ultime a tutti i livelli della scala sociale. E le disposizioni emanate di lì a poco dai concili tenutisi a Reims (1148 e 1157) e a Tours (1163),73 che prevedevano l’imprigionamento e la confisca dei beni degli eretici, escludendoli dal di-ritto d’asilo, se non restarono lettera morta sortirono scarsi risultati.
Neppure l’Inghilterra riuscì a conservarsi totalmente indenne dal “con-tagio”: secondo William di Newburg nel 1160 una trentina di erronei – che egli definisce publicani 74 – furono giudicati e condannati dal concilio di Oxford in quanto rifiutavano il valore di sacramento al battesimo, all’eu-carestia e al matrimonio, pur considerandosi cristiani e praticando i det-tami evangelici.75 Nonostante la mitezza della pena comminata – vennero
71-72). Ma i fatti sono riportati anche da Jean de Ripoll in una lettera all’abate Oliba de Besalù, da André de Fleury nella Vita Gauzlini, da Rodolfo il Glabro negli Historiarum libri quinque (Cronache dell’anno mille), da Paul de Chartres. Lo stesso era avvenuto nel medesimo anno e nel 1019 a Orléans dove dieci canonici imputati di un analogo peccato erano stati arsi sul rogo e un altro, morto da poco, disseppellito per essere rimosso dal cimitero. Le ac-cuse sono quelle convenzionali e stereotipate: adorare il diavolo in forma di ethyope, ingerire polvere di bambini morti in luogo dell’ostia consacrata, compiere atti sacrileghi di natura non specificata ma abominevole. Ma l’attribuire loro credenze manichee, ossia dualistiche, e una spiccata predisposizione al proselitismo, assieme al fatto di identificarli come canonici – perciò litterati, come si addice a un’“hérésie savante” – e di rimarcare che «christianos veros se fallebant» ne fa degli ideali precursori dei boni christiani contro cui si accanirà due secoli dopo Jacques Fournier.
72 Zambon, La cena segreta, cit., pp. 29 e 39. Ma si veda anche Roquebert, Histoire des Cathares, cit., pp. 52-53.
73 Cfr. J.-P. Moreau, Disputes et conflits du christianisme dans l’Empire romain et l’Occident médiéval, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 167. Presieduto dallo stesso Alessandro III, il concilio di Tours inasprisce ulteriormente le disposizioni dei due precedenti, vietando espressamente di ospitare gli eretici e di commerciare con loro: quest’ultima interdizione è particolarmente significativa, considerato come l’“economia” delle comunità catare si basasse principalmente su attività di tipo artigianale.
74 Pubblicani, populicani, poplicani sono fra i molti nomi attribuiti ai catari: cfr. Duver-noy, La religione dei catari, cit., pp. 261-262.
75 Guilelmus Neubrigensis, Historia rerum anglicarum II, 13. (M.G.H Scriptorum XXVII, Hannoverae, Impensis Bibliopolii Hahniani, 1885, pp. 231-232). L’evento è riferito, con toni più sarcastici e faziosi, anche da Walter Map che denomina tali eretici paterini – un altro dei nomi con cui venivano designati i catari (De nugis curialium, I, 30). Cfr. Duvernoy, La religione dei catari, cit., pp. 260-261.
SONIA MAURA BARILLARI110
marchiati a fuoco e banditi dalla città, interdicendo a chiunque di dar loro ospitalità – finirono col morire tutti, vittime del rigore del clima e di un tessuto collettivo ostile o indifferente.
La tempestività con cui fu arginata la propagazione di correnti ereticali oltremanica non dovette essere del tutto avulsa dall’esperienza diretta che Enrico II – promotore del suddetto concilio – e il suo entourage avevano di quanto stava nel contempo avvenendo sul continente, in aree propinque ai domini soggetti alla corona inglese (in particolare i ducati di Guascogna e d’Aquitania). Domini che nelle mire espansionistiche del sovrano avreb-bero dovuto estendersi a comprendere anche il Tolosano, rivendicato in nome della moglie Eleonora. E in effetti lo invade in parte nel 1159, forte dell’alleanza col conte di Barcellona e il visconte di Béziers, ma giunto sotto Tolosa la presenza in città di Luigi VII,76 di cui era vassallo per i feudi fran-cesi, lo fa desistere dall’impresa.77 Ne diventa però formalmente signore alcuni anni più tardi, nel 1173, quando Raimondo V gli presta omaggio riconoscendo la signoria del duca d’Aquitania sulla propria contea. Già dal 1167, del resto, essa era entrata nell’orbita di influenza plantageneta, solu-zione resasi necessaria dopo che il conte aveva ripudiato Costanza, sorella del re di Francia, per sposare la vedova di Raimondo Berengario III, signo-re di Provenza.78 È proprio in questo periodo, nel 1177, che Raimondo scri-ve all’abate di Cîteaux per invocare il suo aiuto – e indirettamente quello della corona francese – nella lotta contro l’eresia che da tempo imperversa-va nelle proprie terre e nella vicina zona albigese: non solo l’incontro che nel 1165 a Lombers aveva contrapposto esponenti dell’ortodossia e seguaci del catarismo non aveva ottenuto nessun effetto, ma questi ultimi subito dopo, nel 1167, giungono addirittura a celebrare una sorta di concilio a Saint-Felix dove affluiscono i più alti rappresentanti delle “chiese” catare.79 Il timore maggiore del conte, al di là di quella del pericolo in cui versava la fede, era l’agente destabilizzante che l’adesione all’eresia rappresentava, cagionando divisione e discordia fra le famiglie, e guadagnando alla pro-pria causa molti dei suoi vassalli e ampie porzioni dell’aristocrazia dei feudi a lui assoggettati.80
76 Cognato oltreché signore dell’allora conte di Tolosa, Raimondo V.77 Non è escluso che le ragioni del suo desistere fossero dettate non tanto dall’etica caval-
leresca quanto dalla preoccupazione per un assedio che si preannunciava lungo e travagliato, mentre le frontiere normanne erano a rischio. Cfr. J. Favier, Les Plantagenêts. Origine et destin d’un empire (XIe-XIVe siècles), Paris, Fayard, 2004, pp. 237-238.
78 Ivi, pp. 244-245. Nel 1186 Raimondo V si rivolgerà però ancora al re di Francia (nel frat-tempo era salito al trono Filippo Augusto) per contrastare la politica aggressiva di Riccardo Cuor di Leone. Ivi, p. 537.
79 Roquebert, Histoire des Cathares, cit., pp. 57-62.80 Ivi, pp. 62-64. L’intervento cistercense ottenne in verità pochi risultati. Appena mag-
giori furono quelli conseguiti da un drappello armato che nel 1181 riuscì a far capitolare il
LA TEMATICA SOCIO-ECONONICA NEL JEU D’ADAM 111
Tale condizione di conflitto religioso, e l’instabilità socio-politica che questo determinava,81 certo ebbe eco e ripercussioni nei territori insulari, in particolar modo nella cerchia di intellettuali di cui amava circondarsi En-rico.82 Delle preoccupazioni che una simile situazione doveva aver suscitato nella curia come negli ambienti ad essa attigui poté forse farsi carico e cassa di risonanza l’anonimo autore del Jeu 83 rivestendo del potere asseverativo delle immagini le argomentazioni speculative di teologi e inquisitori.
castello di Lavaur.81 La fede catara rifiutava infatti la giustizia penale e civile, contestando la gerarchia feu-
dale e, in generale, il potere temporale che traevano fondamento dall’operato demoniaco.82 Rammentiamo come fosse stato Thomas Becket, nel 1159, a condurre l’armata reale
contro Tolosa. E che Gervasio di Tilbury, mentre attorno al 1175 si trovava a Reims ospite di Guglielmo dalle Bianche Mani, aveva denunciato una giovanetta riottosa a concederglisi accusandola di aderire a un’eresia – se prestiamo fede alla testimonianza resa da Ralph of Coggeshall – identificabile con quella catara: «asserunt isti parvulos non baptizandos donec ad intellegibilem perveniant aetatem; astruunt non orandum pro mortuis, non sanctorum suffragia expetenda, nuptias damnant, virginitatem praedicant in operimentum suae turpi-tudinis. Lac et quicquid ex eo conficitur abhorrent, et omne cibum qui ex coitu procreatur. Non credunt ignem purgatorium restare post mortem, sed statim animam a corpore solutam vel ad requiem transire, vel ad damnationem. Nullas sacras Scripturas recipiunt, nisi Evan-gelia et Epistolas canonicas. Rusticani homines sunt, et ideo nec rationibus convincuntur, nec auctoritatibus corriguntur, nec persuasionibus flectuntur. Mori magis eligunt quam ab impiissima secta converti. Aiunt etiam alii qui de secretis eorum investigaverunt, quod isti non credunt Deum res humanas curare, nec aliquam dispositionem vel potentiam in terrenis creaturis exercere; sed apostatam angelum, quem et Luzabel nominant, universae creaturae corporali praesidere, et ad nutum ejus cuncta terrena disponi. Corpus a diabolo dicunt for-mari, animam vero a Deo creari et corporibus infundi; unde fit ut semper quaedam pertinax pugna inter corpus et animam geratur» (Chronicon anglicanum, pp. 121-125).
83 È noto come Enrico II, ben consapevole del ruolo centrale che occupano la comunica-zione e la propaganda nella gestione del potere, sfruttò oculatamente la collaborazione degli intellettuali chiamati a comporre la propria corte a sostegno tanto della sua azione politica quanto dell’ideologia chiamata a legittimarla. In merito si veda M. Aurell, L’empire des Plan-tagenêt, Paris, Perrin, 2004, pp. 71-113; e A. Chauou, L’idéologie plantagenêt. Royauté arthurienne et monarchie politique dans l’espace plantagenêt, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2001, passim.