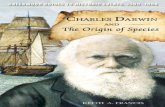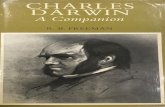Charles Darwin
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Charles Darwin
Charles Darwin
Brunella Danesi
Charles Darwin (1809-1882) nacque a Shrewsbury, da una famiglia alto-borghese; il padre,
Robert, esercitava con successo la professione medica ed era figlio di Erasmus Darwin, medico lui stesso e
una delle figure più rappresentative dell’illuminismo inglese -poeta, filosofo e naturalista, autore fra
l’altro del libro medico-evoluzionista Zoonomia (1794-1796)-; la madre, Susannah era figlia di Josiah
Wedgwood, il fondatore dell’omonima fabbrica di ceramiche, famosa in tutta Europa. Il piccolo Charles,
persa la madre a soli otto anni, fu affidato alle cure delle sorelle più grandi e a nove anni entrò nel college
locale, diretto da Samuel Butler (1774-1839), brillante studioso e appassionato bibliofilo, autore di saggi
e di testi scolastici di geografia di grande successo. La scuola non suscitò il minimo interesse nel giovane
Charles, che così ricorderà quegli anni:
niente è stato più sfavorevole allo sviluppo della mia mente quanto la scuola del dottor Butler, che
era esclusivamente a indirizzo classico e nella quale non s’insegnava nient’altro che un po’ di
storia e geografia antiche. La scuola fu per me assolutamente priva di valore educativo1.
Il ragazzo non mancava però d’interessi; fin da piccolo si appassionò alla chimica e, insieme al
fratello Erasmus, mise in piedi un attrezzato laboratorio, in cui eseguire esperimenti “esplosivi’, tanto
che i suoi compagni gli diedero l’appellativo di Gas; maturò inoltre una non comune passione per la
caccia, la pesca, la raccolta di qualunque materiale riuscisse a trovare durante le sue escursioni all’aria
aperta. Il padre, prendendo atto del suo scarso rendimento scolastico, lo ritirò dal college con due anni di
anticipo e decise di inviarlo a Edimburgo, perché, seguendo la tradizione di famiglia, diventasse medico.
Edimburgo Charles si trattenne per due anni (1826-1827) nella cosmopolita Edimburgo, dove si potevano
incontrare ricercatori, filosofi, scrittori provenienti da tutta Europa; qui socialisti sperimentavano forme
di vita comunitaria; intellettuali si confrontavano sui temi più dibattuti del momento: l’origine della
vita, il rapporto spirito-materia, la formazione delle rocce per via ignea o dai fondali oceanici. Da pochi
anni (1820) era stata fondata la Società Frenologica di Edimburgo cui avevano aderito con entusiasmo
molti medici, convinti che le teorie del neuro anatomico tedesco Franz Joseph Gall (1758-1828) potessero
riuscire a stabilire la personalità e le capacità mentali e morali degli uomini sulla base della morfologia
cranica.
Provvisto di numerose lettere di presentazione fornitegli dal padre, poté accedere alla mensa delle
famiglie più in vista della città e frequentare gli ambienti Whigs cui tutta la sua famiglia apparteneva da
generazioni. Gli Whigs si battevano per l’abolizione della schiavitù, il suffragio allargato, la libera
competizione dei mercati, la possibilità di accesso alle cariche pubbliche da parte di Dissenzienti,
Cattolici ed Ebrei, insomma per tutte quelle cause attraverso cui la borghesia cercava di sottrarre il
potere all’aristocrazia e all’alto clero.
Le lezioni accademiche erano tenute da docenti spesso mediocri, nominati non per particolari
meriti scientifici, ma su base ereditaria o per fedeltà indiscussa al partito Tory, allora al potere; così,
molti studenti preferivano seguire lezioni nelle numerose scuole private, sorte in competizione con
l’università. Charles, comunque, si rese ben presto conto di non amare gli studi medici: aveva orrore delle
lezioni di anatomia svolte sul cadavere, disertava la sala operatoria, dove –in assenza di anestetici-
l’abilità del chirurgo consisteva soprattutto nella rapidità con cui maneggiava bisturi e sega, per
abbreviare il più possibile il trauma al paziente legato al letto e vigile. Charles trovava tediose anche le
lezioni di farmacologia e l’unico corso istituzionale che frequentò assiduamente fu quello di chimica. Così,
anche a Edimburgo, gli interessi di Charles si volsero altrove; s’iscrisse a una serie di lezioni private
tenuta da uno schiavo negro affrancato, John Edmostone, uno dei migliori imbalsamatori del regno, che
gli insegnò tutti i trucchi del mestiere per trattare le pelli dei vertebrati e per conservare inalterati i pesci
1 Autobiografia pag 30
e i fragili invertebrati marini e d’acqua dolce. Il tassidermista e Charles divennero amici e dopo la lezione
John descriveva al giovane allievo la dolorosa vita degli schiavi nelle piantagioni del Sudamerica e anche
le splendide foreste tropicali, facendogli desiderare di poter un giorno vedere quei luoghi. Darwin
frequentò assiduamente il Museo di Storia Naturale della città in cui era presente una ricca collezione di
organismi esotici e s’iscrisse a un corso di Scienze in cui erano previste anche lezioni pratiche, durante le
quali imparò a osservare i materiali al microscopio, preparare i reperti, identificare piante e animali;
lezioni in campagna permettevano agli studenti di orientarsi in campo geologico.
A Edimburgo Charles conobbe il naturalista Robert Edmond Grant (1793-1874) che dopo la
laurea in medicina si era dedicato allo studio della biologia marina e avrebbe in seguito ricoperto la prima
cattedra di anatomia comparata a Londra. La frequentazione con Grant fu fondamentale per la sua
formazione scientifica: grazie a lui imparò a riconoscere e analizzare gli invertebrati marini,
dissezionandoli al microscopio, seguendone le fasi embrionali e larvali, studiandone la distribuzione e il
comportamento; sempre consigliato da Grant, si cimentò nello studio in lingua originale di Histoire
naturelle des animaux sans vertebre di Lamarck, l’opera più moderna ed esaustiva sugli invertebrati.
Grant aveva visitato le principali università europee, era in contatto epistolare con le più importanti
società scientifiche ed era amico e collaboratore di Étienne Geoffroy de Saint-Hillaire. Il naturalista era
un libero pensatore dalle idee radicali, appassionato alle teorie di Erasmus Darwin, Lamarck e Geoffroy
e, quando scoprì che anche i molluschi possedevano un pancreas, pensò di aver trovato una conferma
della teoria dell’amico secondo cui tutti gli animali possedevano un piano di organizzazione simile, segno
dell’ascendenza da un antenato comune, a sua volta originatosi da particelle elementari di vita. Grant,
che aveva preso a benvolere il giovane Charles, forse lusingato di poter frequentare il nipote del grande
Erasmus, lo conduceva con sé lungo le coste scozzesi alla ricerca di celenterati, briozoi e molluschi e
spesso gli parlava con entusiasmo della trasmutazione dei viventi e dei suoi teorici.
Nell’Autobiografia Charles così ricorderà le conversazioni con Grant:
Dichiarò la sua entusiastica ammirazione per Lamarck e per le sue idee sull’evoluzione.
Meravigliato, lo ascoltai in silenzio ma, a quanto oggi posso giudicare, non ne fui molto
colpito. Avevo già letto la Zoonomia di mio nonno, in cui si sostengono opinioni
analoghe, ma anche questa non aveva avuto alcun effetto sul mio pensiero (…)2
Lo stesso dottor Robert aveva suggerito al figlio di leggere l’opera del nonno, che affrontava
anche molti argomenti medici, nella speranza che in Charles si accendesse un po’ di passione per la
professione; il ragazzo, diligentemente, aveva accolto l’invito, ma era rimasto dell’avviso che la pratica
medica non facesse per lui. Conosceva del resto le idee repubblicane del nonno, il suo poco patriottico
entusiasmo per la rivoluzione francese, la sua vita libertina, così lontana dalla rispettabilità borghese cui
invece lo aveva abituato il padre.
A Edimburgo ebbe modo di rendersi personalmente conto di quanto le tesi lamarckiane fossero
considerate eversive; partecipando con una piccola comunicazione sulle larve dei molluschi a una
riunione del club per studenti Plinian Society, poté ascoltare l’intervento di un brillante giovane medico,
William Browne, che sostenne che mente e coscienza sono semplici emanazioni del cervello e che quando
le classi lavoratrici se ne saranno rese pienamente conto, niente potrà trattenerle dall’opporsi alle
ingiustizie di cui sono vittime. L’intervento suscitò un tale scandalo che gli organizzatori lo omisero dal
verbale e si preoccuparono di cancellare anche l’iscrizione di Browne a parlare, malgrado molti studenti
si ribellassero di fronte a questa intollerabile censura; all’esterno dell’Università, vari articoli
stigmatizzarono che la Plinian Society avrebbe dovuto chiudere e che la scuola di medicina formava atei
e materialisti; Coleridge3 stesso, ormai vecchio e malandato, parlò di un intervento atto a promuovere
sollevazioni politiche. Anche fuori delle istituzioni scientifiche, molti radicali facevano leva sulle idee di
trasformazione dei viventi per cambiare profondamente una società basata sul diritto di casta; per loro la
Natura stessa insegnava che il progresso della nazione si sarebbe potuto ottenere solo attraverso una
2 Autobiografia pag 31 3 Samuel Taylor Coleridge (1772 - 1834), è considerato, con il coetaneo William Wordsworth
(1770 - 1850) uno dei fondatori del Romanticismo inglese; la sua opera più nota è The Rhyme of the
Ancient Mariner (La ballata del vecchio marinaio)
sana competizione che spazzasse via tutti i privilegi non basati sul merito. Il pensiero del cittadino
Lamarck, però, era stato messo all’indice nel Regno Unito e i suoi libri circolavano solo in lingua
originale, tanto che Philosophie sarà tradotto in inglese solo nel 1914; paradossalmente fu Charles Lyell
che fece conoscere Lamarck perché nel secondo volume di Principi di Geologia (1833) ne espose i concetti
fondamentali per confutarli; anche per il padre dell’Uniformismo, il pensiero del francese era un
attentato alla religione che avrebbe portato, se condiviso, allo sgretolamento della società costituita. È
da notare, tuttavia, che quando Lyell aveva letto il libro, aveva scritto al geologo Mantell 4:
Ho divorato Lamarck… le sue teorie mi hanno deliziato (lettera di Lyell a Mantell, 2
marzo 1827)
Il giovane Darwin, che per sua natura amava essere benvoluto da tutti, si rese conto di come
fosse rischioso esprimere apertamente il proprio pensiero, soprattutto quando si parlava dell’uomo, ma
capì anche che molti agitatori approfittavano di queste idee per trasformare la società non soltanto a
scapito dell’alto clero e dell’aristocrazia, ma anche dei ceti medio - alti cui la sua famiglia apparteneva.
Il dottor Robert, visti gli scarsi risultati che il figlio stava ottenendo, pensò che l’unica
professione che poteva essere adatta a un gentiluomo amante della natura e della vita all’aria aperta,
fosse quella di pastore; ciò gli avrebbe dato rispettabilità, una certa sicurezza economica e tempo libero
sufficiente per curare le proprie passioni; il ragazzo, che aveva idee vaghe sul proprio futuro, fu
d’accordo. La sede prescelta per l’avvio al sacerdozio fu Cambridge, sebbene il padre fosse un libero
pensatore e sebbene le donne della famiglia avessero abbracciato da tempo la fede unitariana.
Cambridge Cambridge era tenuta saldamente nelle mani del clero anglicano che ne controllava tutte le
istituzioni, soprattutto attraverso la presenza di proctor – veri e propri guardiani della morale- che
vigilavano su studenti e abitanti e commutavano pene severe ai trasgressori.
Il tempo trascorso a Cambridge fu sprecato nel modo più miserevole...5
Questa affermazione non è esatta; anche se Charles frequentava feste e “giovani sportivi, alcuni
dei quali dissoluti e poco intelligenti’, faceva lunghe cavalcate, non rinunciava mai a una battuta di
caccia o alla pesca, gli anni di Cambridge (1828-1831) furono fondamentali per la sua formazione di
naturalista: studiò il Viaggio nelle regioni equinoziali del Nuovo continente di Alexander von Humboldt e
ne rimase talmente affascinato da progettare un viaggio alle Canarie.
La preparazione alla professione di curato di campagna prevedeva studi che Charles non gradiva,
come già aveva verificato al college; trovava insopportabilmente noiosi il greco e il latino e aveva
difficoltà con l’algebra, ma studiò con attenzione e piacere i due testi di William Paley 6 Evidence of
christianity e Moral and political Philosophy, trovando le argomentazioni dell’arcivescovo molto
convincenti e la sua logica stringente; proprio la conoscenza d questi testi gli consentì di superare
dignitosamente l’esame finale.
I suoi interessi maggiori, però, erano altrove: divenne espertissimo nella caccia, cattura e relativa
conservazione degli insetti e, insieme al cugino William Darwin Fox, batté a palmo a palmo le campagne
inglesi alla ricerca di coleotteri, mettendo insieme una collezione invidiabile e intessendo una fitta rete di
relazioni con altri appassionati con cui scambiava il materiale. L’esperienza che aveva maturato con
4 Gideon Mantell (1790 –1852) è stato un geologo e paleontologo britannico. Fu il primo a trovare un fossile
di dinosauro nel 1822: 5 Autobiografia p. 41 6 William Paley (1743-1805): uno dei più noti esponenti del pensiero utilitarista inglese del
diciottesimo secolo. La sua opera Evidences of the Existence and Attributes of the Deity, Collected from the
Appearances of Nature (1802) fu utilizzata per molti anni come saggio divulgativo per spiegare
razionalmente l’esistenza di Dio. Argomenti teleologici di Paley a favore dell’esistenza di Dio: le opere
umane sono il prodotto di un disegno intelligente; l’intero universo, con le sue forme perfettamente
adattate, è simile ad un prodotto umano, per cui deve essere stato concepito da una mente intelligente;
dal momento che è immenso ed estremamente complesso, a fronte dei prodotti dell’uomo, il suo
architetto deve essere immensamente intelligente e dal potere straordinario.
Grant, unita allo studio di numerose guide di sistematica, gli fu molto utile per classificare i suoi
esemplari; strinse con diversi futuri sacerdoti naturalisti legami di amicizia che sarebbero durati per tutta
la vita e in particolare divenne intimo di John Henslow (1796–1861), vicario di Cholsey. Questi
possedeva una solida formazione scientifica; professore di mineralogia a Cambridge, nel 1819 aveva
accompagnato Adam Sedgwick (1785–1873), uno dei fondatori della geologia moderna, in un tour
all’isola di Whight; in seguito aveva spostato i suoi interessi verso la botanica. I due divennero talmente
assidui, che Charles fu presto noto come “l’uomo che passeggia con Henslow”; insieme raccoglievano
piante e minerali e Charles trovava l’andare a erborare altrettanto appassionante che il dar la caccia agli
insetti; così, seguì il corso di Botanica tenuto dall’amico. Non aveva frequentato le lezioni accademiche
di geologia di Sedgwick, ma recuperò il tempo perduto perché Henslow chiese all’amico di impartire
qualche lezione pratica e teorica a Charles; questi fu ben lieto di avere un giovane aiutante e Charles
trovò il vecchio maestro molto autorevole e pieno di fascino. Insieme si recarono nel Galles del Nord,
dove il giovane imparò i trucchi del mestiere e presto fu in grado di condurre autonome rilevazioni
stratigrafiche, utilizzare con sicurezza il clinometro e il martello, tracciare accurate mappe geologiche dei
territori visitati; durante questa escursione, si imbatté anche in ossa fossili di mammifero e vide una ricca
collezione che testimoniava come un tempo la regione fosse stata abitata da una fauna ormai scomparsa.
Fu un apprendistato prezioso che, insieme alla lettura dei Principi di Lyell i cui volumi studiò, freschi di
stampa, durante il viaggio, gli avrebbe permesso di modellare la cornice indispensabile alla sua teoria.
Quando Darwin si imbarcò per il giro del mondo che lo avrebbe tenuto lontano da casa per
cinque anni, era un naturalista di tutto rispetto, addestrato dagli studiosi inglesi più qualificati; era
dotato di non comuni capacità di osservazione, affinate durante le sue numerose escursioni nella
campagna e sulle coste della Gran Bretagna. Era a conoscenza delle rivoluzionarie scoperte della geologia
contemporanea: la delimitazione delle ere geologiche -caratterizzate da una chiara sostituzione nella flora
e nella fauna- lasciava intravedere una possibile progressione interpretabile come un segno di
trasformazione dei viventi; le scoperte e le descrizioni di vertebrati fossili indicavano una divergenza
tassonomica crescente; il rinvenimento di organismi presenti in epoche geologiche successive, aveva
messo in crisi le ipotesi catastrofiste. Gli erano note anche le osservazioni in campo bio-geografico, che
avevano evidenziato variazioni locali in territori contigui, mentre lo studio degli organi rudimentali
aveva fatto vacillare il concetto di perfetta creazione.
Il viaggio 1831-1836 Nel 1829, durante la missione del brigantino Beagle nella Terra del Fuoco, un gruppo di Fuegini
rubò una barca a cinque remi proprio sotto il naso del capitano Fitz-Roy che reagì al furto catturando
alcuni ostaggi da restituire in cambio della scialuppa. Siccome i fueghini preferirono tenersi la lancia e gli
ostaggi, dal canto loro, erano felicissimi della nuova sistemazione, a Fitz-Roy non rimase altra
alternativa che portare gli ostaggi in Inghilterra, nella speranza di poter tornare in Sud America l’anno
successivo, riportando gli indigeni in patria. Nell’estate 1831, il capitano ottenne il comando del Beagle
per una nuova missione esplorativa e si mise alla ricerca di un geologo in grado di fare i rilevamenti
necessari. John Henslow, convinto che per la missione ci fosse bisogno di un naturalista a tutto tondo,
scrisse prima al cognato zoologo Leonard Jenyns 7 che però declinò l’invito; così, il 24 agosto, il
professore scrisse a Darwin:
...Ho deciso che a mio parere sei la persona più qualificata... non perché pensi che tu sia un
naturalista rifinito ma perché sei bravo a collezionare, osservare e porre attenzione su qualunque
cosa degna di essere notata nel campo della Storia Naturale.
Il padre di Charles, convinto che si trattasse di un’impresa folle, non voleva dare il suo consenso,
negando al figlio il denaro necessario alla missione. Lo zio Josiah Wedgwood, chiamato in causa da
Charles per convincere il padre a cambiare opinione, ribatté punto per punto alle obiezioni del dottor
Darwin e in particolare affermò che, essendo Charles un giovane di ampi interessi, senza dubbio avrebbe
7 Leonard Jenyns (1800-1893) fu un eminente zoologo e botanico, che raccolse un gran numero di
esemplari animali e vegetali. Scrisse numerosi saggi scientifici. Al ritorno dal viaggio, Darwin affidò a
Jenyns lo studio e la classificazione dei pesci da lui catturati.
tratto profitto a vedere posti e persone nuove. Alla fine il dottor Darwin cedette e Charles ne fu così felice
che, nella lettera ad Henslow del 5 settembre esordì: Gloria in excelsis è l’inizio più misurato che mi viene
in mente...
Nel poco tempo a disposizione, iniziarono preparativi per la partenza; il costo
dell’equipaggiamento raggiunse le 600 sterline, a cui aggiungere le spese di vitto ed alloggio ammontanti
a 50 sterline l’anno. Darwin portò con sé un piccolo microscopio a bassa risoluzione, varie reti per la
cattura del plancton e di insetti, un martello da geologo, un telescopio, una bussola, dei libri.
Il Beagle salpò il 27 dicembre dalla baia di Plymouth, nel golfo di Biscaglia, ma l’inizio del
viaggio non fu dei migliori per Charles, che così scrive in una lettera al padre datata 8 febbraio - 1 marzo
1832:
Nessuno che sia stato in mare per sole 24 ore ha il diritto di dire che il mal di mare è sgradevole.
Il tormento vero comincia quando si è talmente esausti che basta un piccolo sforzo per avere la
sensazione di venir meno 8
Nel partire, questo vittoriano borghese, di sicura e lontana ascendenza whig, sperava forse di
poter emulare i grandi viaggiatori del passato, soprattutto Alexander von Humboldt, il cui Personal
Narrative fu da lui consultato ripetutamente per tutta la traversata. In patria era stato testimone del
vivace dibattito fra Nettunisti e Plutonisti, fra Continuisti e Catastrofisti, fra chi pensava che anche
l’anima fosse riducibile a pura materia e chi invece riteneva che i viventi dovessero le loro proprietà ad
un indefinito “spirito vitale”. Alla partenza, comunque, nonostante conoscesse bene le ipotesi sulla
trasmutazione della specie formulate dal nonno Erasmo e da Lamarck e le secche -e apparentemente
definitive- obiezioni sollevate da Cuvier, il giovane Charles non aveva dubbi “sulla verità assoluta e
letterale di ogni parola della Bibbia” e sulla correttezza degli argomenti teleologici di William Paley. Il
primo attracco del Beagle fu alle isole di Capo Verde; la nave costeggiò poi la costa orientale del Sud
America, raggiunse la Patagonia, le Falkland e doppiò lo stretto di Magellano; portatasi nell’oceano
Pacifico, fece scalo fra l’altro alle Galapagos, in Polinesia, Nuova Zelanda, l’Australia, agli atolli delle
isole Cocos e alle Mauritius.
Durante la sosta alle isole di Capo Verde, Darwin che ad Edimburgo aveva pensato alla geologia
come a una disciplina noiosa e piena di false teorie, si rese conto di come e quanto un occhio attento
potesse leggere, osservando direttamente la diversa natura e disposizione delle rocce e seguendo le
preziose indicazioni contenute in Principles of geology di Charles Lyell 9, donatogli da Henslow alla
partenza. In Brasile, egli poté addentrarsi nella foresta tropicale, e per un naturalista, come poi scrisse,
“una giornata trascorsa in quei luoghi procura un piacere così profondo da non poter sperare di goderne
altrettanto in futuro”10. Tutto gli apparve nuovo e bellissimo: il groviglio inestricabile dei rampicanti,
acacie e tamarindi dal brillante fogliame blu, svettanti noci di cocco, papaie, banani, piante carnivore,
orchidee, esemplari che si potevano ammirare anche negli orti botanici inglesi, ma quale differenza di
colori, profumi e armonie! Sorpreso da un improvviso temporale tropicale, vide come dopo pochi minuti
l’acqua penetrasse attraverso il fitto intreccio di rami e foglie, scorrendo sui tronchi in piccoli torrenti; il
rumore assordante degli insetti si poteva udire anche dalla nave, mentre nel folto della boscaglia regnava
un silenzio assoluto.
Già nell’agosto del 1832 la raccolta di materiale era diventata talmente consistente, che Darwin
inviò a Henslow alcune casse contenenti rocce, piante tropicali, insetti, animali marini e terrestri, il tutto
numerato, classificato e accuratamente descritto; questa era la prima di molte spedizioni, i cui reperti
sarebbero stati successivamente esaminati da esperti scelti personalmente al suo rientro. Da vero
8 La corrispondenza di Darwin si trova a http:// www.gutenberg.org/etext/2739 More Letters of Charles
Darwin; la traduzione è dell’autrice dell’articolo. In italiano una scelta di lettere è presente nel volume C. Darwin
Lettere Raffaello Cortina, 1999; altre lettere sono in appendice all’Autobiografia 9 C. Lyell (1797-1875) minò la teoria dei cataclismi, mettendo in luce come nelle rocce del passato
si potessero leggere eventi atmosferici e geologici non dissimili da quelli che ancora oggi avvengono; parlò
anche dei fossili come prove cronologiche di gran valore e della “trasmutazione” delle rocce. Darwin
ricevette durante il viaggio i successivi volumi di Principi di Geologia (1831-1833). 10 C. Darwin Viaggio di un naturalista intorno al mondo Einaudi, (pg. 22 e seguenti)
naturalista, non si limitò alla raccolta di materiale, ma condusse brillanti osservazioni etologiche su
uccelli, mammiferi, ragni e insetti; sezionò abilmente animali per verificare il loro tipo di alimentazione,
mise a punto semplici esperimenti per comprendere la fisiologia di numerosi organismi, studiò le
dinamiche ecologiche dei vari ambienti. Il primo incontro con fossili di grandi dimensioni avvenne a
Punta Alta, in Patagonia. Qui Darwin portò alla luce, sepolti nella sabbia, numerosi quadrupedi estinti,
fra cui un Megatherium e prese accuratamente nota dell’ambiente in cui gli esemplari erano stati
rinvenuti, per cui poté risalire alla loro età relativa approssimativa. Il Megatherium, come gli verrà
confermato da Richard Owen11 aveva un piano di organizzazione simile a quello di armadilli, bradipi e
formichieri, ma le sue abitudini di vita erano state profondamente diverse; nel taccuino B, iniziato nel
luglio del 1837 scriverà: “Possiamo considerare i Megatheria, gli armadilli e i bradipi come tutti
discendenti di qualche tipo ancora più antico, alcuni rami del quale si sono seccati” . Nei pressi di Puerto
San Julián, in Patagonia, rinvenne un altro fossile gigantesco, il Macrauchenia patachonica, uno strano
animale simile ad un cammello, ma munito di una corta protuberanze che lo faceva assomigliare ad un
tapiro:
A causa delle conchiglie marine recenti, trovate su uno dei più alti piani a terrazzo, che devono
essere stati modellati e sollevati prima che fosse depositato il fango nel quale l’animale è sepolto, è
certo che deve essere vissuto molto tempo dopo che il mare era abitato dalle attuali conchiglie....
La ricostruzione degli eventi passati gli mostrava per la prima volta - e lo avrebbe mostrato al
mondo intero - che l’America Latina un tempo era stata abitata da numerosi, grandi mammiferi e
Darwin si chiese quali fossero state le cause dell’estinzione. Lo studio geologico della Patagonia e della
Plata indicava solo cambiamenti lenti e graduali, simili a quelli descritti da Lyell nei Principles; non si
poteva pertanto ipotizzare l’avvento di una grande catastrofe e dunque l’ipotesi di Cuvier veniva meno;
neppure imponenti cambiamenti climatici potevano aver determinato l’estinzione, dal momento che
questi giganti erano vissuti quando le grandi glaciazioni erano ormai terminate. Sempre in Patagonia
venne a conoscenza della presenza di due specie di Rhea (nandù), uno di grandi dimensioni, molto
frequente nei pressi di Bahia Blanca e l’altro più piccolo, che i gauchos chiamavano petise, distribuito
più a sud e che Darwin catturò a Port Desire (ma non riconobbe e mangiò, anche se fortunatamente ne
conservò la testa, il piumaggio e le ossa); tornato in Inghilterra, avrebbe affidato l’esame degli uccelli da
lui collezionati a Gould 12, da cui ebbe la conferma che il petise era una specie diversa, denominata, in
onore di Charles, Rhea darwinii. Più avanti lo attendeva un’altra sorprendente scoperta: la presenza di
un grosso mammifero, la volpe delle isole Falkland (Dusicyon australis) –attualmente estinto- di cui non
c’era traccia nel continente antistante; inoltre, molte specie di uccelli erano diverse da quelle presenti nel
vicino continente. Come un’infaticabile formica, Darwin raccoglieva fatti su fatti, affinava le ricerche,
confrontava i reperti e nel tempo libero aggiornava il suo diario. I dati più interessanti li ottenne alle
isole Galapagos, dove si trovò di fronte a un numero di specie incredibilmente elevato: iguane marine e
terrestri, tartarughe giganti, diverse da isola ad isola, sule dai piedi azzurri, 13 specie di fringuelli
(appartenenti, come verificherà Gould, a solo quattro generi diversi), pinguini, unico del genere a vivere
nei pressi dell’equatore, un cormorano, stranamente incapace di volare, un falco, diverse specie di
otarie... Molte di queste specie risultarono endemiche. Inspiegabilmente, però, dato che l’ambiente
avrebbe potuto essere favorevole, non erano presenti rane né rospi, che del resto mancavano anche in
altre isole del Pacifico. Molti problemi si affollarono nella mente di Darwin: per quale motivo gli animali
che popolavano il Sud America sono così diversi da quelle del continente Euroasiatico anche se presenti
in ambienti simili? E ancora, il modello di atti creativi separati poteva rendere ragione di animali viventi
ed estinti con piani di organizzazione simile? Perché nelle isole si trovavano specie endemiche? L’acqua
marina era forse un ostacolo alla diffusione degli anfibi nelle isole? Cominciò ad intuire che l’isolamento
geografico poteva contribuire al differenziamento della specie, promuovendo l’isolamento riproduttivo.
Pochi mesi dopo il suo rientro, dopo aver avuto da Gould anticipazioni sulla classificazione del petise,
scriverà nel suo Taccuino Rosso (1837):
11 Richard Owen (1804 –1892) è stato un biologo e paleontologo britannico. A lui è attribuito il termine
dinosauro 12 John Gould (1804-1881) ornitologo e naturalista, scrisse numerosi libri su uccelli indigeni ed
esotici, illustrati dagli splendidi disegni della moglie Elizabeth Coxen.
Lo stesso tipo di relazione che il nandù comune ha con il petise ..., il guanaco estinto lo ha con
quello recente: nel primo caso la relazione essendo la posizione, nel secondo il tempo
e infine, nel taccuino B scriverà: “Io penso”.
La gestazione Al ritorno dal viaggio, Charles visse per qualche tempo spostandosi fra Cambridge e Londra, alla
ricerca di scienziati affidabili e disponibili a prendere in consegna le sue collezioni di piante e animali per
studiarle e classificarle. Trovò la capitale profondamente cambiata: il Reform Bill, in vigore da quattro
anni, aveva consentito una redistribuzione dei seggi, che favoriva la borghesia a scapito dell’aristocrazia
terriera; i Whigs erano ora al potere e avevano anche istituito la prima New Poor Law che aveva
fortemente ridotto i sussidi per gli indigenti e proibito alle parrocchie di aiutarli. Il governo inglese aveva
abbracciato le tesi esposte dall’economista Thomas Robert Malthus (1766-1834) in Saggio sulla
popolazione e sui suoi effetti sul perfezionamento futuro della società con osservazioni sul pensiero di Godwin,
Condorcet e d'altri autori (1798). L’opera era volta a contrastare le posizioni espresse da molti illuministi
secondo i quali il malessere dei ceti poveri era dovuto alle istituzioni, che non promuovevano una
sufficiente uguaglianza sociale; essi, inoltre, ritenevano che l’incremento demografico poteva essere
arginato solo attraverso un’educazione adeguata rivolta a tutti e in particolare alle donne. Secondo il
pastore di Albury, invece, la miseria era provocata dal fatto che la popolazione umana, se non sottoposta
a freni, tende ad aumentare in proporzione notevolmente superiore all'aumento delle risorse; la
popolazione, infatti, tende a crescere in progressione geometrica, più velocemente della disponibilità delle
risorse, che aumenta in progressione aritmetica. L'incremento demografico, che frena lo sviluppo
economico e crea disagi alla popolazione, può essere ritardato o da eventi straordinari come guerre,
epidemie, carestie o da un rigido controllo della riproduzione, attuato attraverso l’astensione dai rapporti
sessuali cui devono attenersi soprattutto le classi meno abbienti; gli aiuti agli indigenti, invece, fanno
aumentare il loro reddito oltre il livello di mera sopravvivenza, favorendone la riproduzione. I Whigs,
convinti che gli uomini debbano lottare per vivere senza che lo stato crei loro ostacoli, pensarono di
avviare una politica di radicale liberalismo, che avrebbe anche consentito la diminuzione del costo del
lavoro grazie a una feroce competizione.
Solo i vecchi e i malati avevano possibilità di accedere a luoghi di assistenza (le famigerate
workhouses descritte in molti romanzi di Charles Dickens), dove però perdevano le libertà civili ed erano
separati dalle famiglie, per impedir loro di procreare. Gli Whighs costruivano workhouses e i poveri le
incendiavano, appoggiati dai socialisti, conviti che, una volta che le masse popolari avessero assunto il
potere, la vita sarebbe progredita in modo inarrestabile, liberando l’uomo dalle pastoie religiose, dal
matrimonio, dal capitalismo, dal lavoro sottopagato di donne e bambini, che rendeva tanto floride molte
fabbriche, come quella dei Wedgewood, parenti stretti dei Darwin. Anche nella Società Zoologica di
Londra erano in corso profonde trasformazioni; i radicali, capeggiati dal vecchio tutor di Charles, Robert
Grant, chiedevano che le istituzioni scientifiche fossero gestite da specialisti retribuiti e non da ricchi
dilettanti o da sacerdoti e premevano a che lo stesso British Museum fosse riformato sul modello delle
istituzioni francesi; essi lanciavano i loro strali anche contro i “preti di campagna” autodidatti di
Cambridge, cui Charles era legato da profonda amicizia.
A Darwin, rampollo di una ricca famiglia borghese, Grant piaceva sempre meno, tanto che,
malgrado questi si fosse messo a sua disposizione per studiare gli invertebrati marini raccolti durante il
viaggio, il giovane rifiutò. Come tutta la sua famiglia, non amava i radicali sempre a caccia di
rivoluzioni, desiderava poter continuare a godere di privilegi, lavorando in modo autonomo, senza dover
rispondere ad alcuna istituzione; voleva essere libero, se lo avesse ritenuto necessario, di attrezzarsi un
laboratorio, pagando di tasca propria. A Londra fu spesso ospite del fratello Erasmus, la cui casa
accoglieva molti intellettuali e dove si discuteva dei temi caldi del momento, quali il progresso, il libero
mercato, le tesi di Malthus, la liberazione dalle pastoie religiose imposte dalla chiesa anglicana. Qui
conobbe personalmente Charles Lyell e l’ambizioso Tory Richard Owen, che si opponeva con vigore alle
battaglie radicali di Grant e ne stava minando il potere nel campo dell’anatomia comparata, contando
sul pieno appoggio dell’alto clero. Le serate in casa di Erasmus erano animate da personaggi interessanti,
la maggior parte dei quali Dissenzienti, soprattutto Unitariani - come Unitariana era da generazioni la
famiglia Darwin e quella dei cugini Wegwood -, sebbene il padre, molto pragmaticamente, avesse fatto
sottoscrivere ai figli i trentanove articoli della fede anglicana, per consentire loro l’accesso alle università
di Cambridge e di Oxford.
I nonni Erasmus Darwin e Josiah Wedgwood, fra loro intimi amici, erano stati membri influenti
della Lunar Society, frequentata da imprenditori, filosofi, geologi, naturalisti, ingegneri di grande fama,
come ad esempio lo scozzese James Watt, che aveva perfezionato la macchina a vapore di Newcomen;
altro membro di rilievo era stato il chimico Joseph Priestley13, che aveva aiutato il nonno Josiah a
perfezionare le stupende porcellane della sua fabbrica, che così aveva raggiunto una fama internazionale
e aveva introdotto l’Unitarianesimo nel Regno Unito. Questa generazione d’intellettuali aveva diffuso
l'esegesi biblica tedesca che contestualizzava storicamente e socialmente i Libri Sacri. A casa del fratello,
Charles conobbe il padre della macchina differenziale, Babbage 14, uomo dal sapere enciclopedico, che
criticava la visione di un dio perennemente indaffarato nel far miracoli, sostituendola con quella di un
programmatore lungimirante che ha creato ad hoc leggi prevedibili e liberamente indagabili, in
grado di sostituire un determinato organismo con un altro. Le idee di Babbage erano largamente
condivise da molti amici di Darwin. Lyell le trovava “maestose’, Herschel 15 era molto
interessato a quello che, in una lettera a Lyell del 1837, aveva definito il “mistero dei misteri” e,
come l’amico, pensava che l’uomo potesse comprendere quali leggi, dettate da Dio, avessero
consentito il sostituirsi di una specie con un’altra. Lo studioso aveva ipotizzato che la durata di
vita dei patriarchi fosse stata molto più lunga di quella calcolata da James Ussher 16 – secondo
cui la creazione era avvenuta nel 4004 avanti Cristo-; in questo modo sarebbe stato possibile
conciliare la profondità del tempo geologico richiesto da trasformazioni lente e graduali previste
dalla teoria di Lyell, con le Sacre Scritture.
Poco dopo il suo ritorno dal viaggio attorno al mondo, Darwin aveva già maturato l’idea
di trasmutazione del vivente, già abbozzata nel taccuino Rosso, iniziato proprio nel 1836 e
precisata nel taccuino B, in cui compaiono vari schizzi dell’albero della vita; nel 1838, dopo aver
citato la lotta per l’esistenza e fatto esplicito riferimento a Malthus scriveva nel taccuino D:
“Si può dire che esista una forza simile a centinaia di migliaia di cunei che cerca di costringere
ogni tipo di struttura adattata dentro gli spazi presenti in Natura o piuttosto si formi degli spazi,
scalzando gli elementi più deboli” (Notebook D 134e-135e).
Quest’affermazione sarà ripresa, pressoché invariata, nella prima edizione dell’Origine:
La Natura può essere paragonata a una superficie sulla quale sono disposti diecimila affilatissimi cunei, l’uno accanto all’altro e spinti a entrare all’interno da colpi incessanti, talvolta è colpito un cuneo, a volte un altro
(1) 13 Joseph Priestley (1733–1804): teologo, filosofo, chimico ed educatore; apparteneva della Lunar society di
Birmingham che contava fra i suoi membri Josiah Wedgwood, James Watt ed Erasmus Darwin. I suoi
esperimenti sull’aria defloristizzata (l’ossigeno) fornirono dati preziosi a Lavoisier. Nel 1782 pubblicò An
History of the Corruptions of Christianity e nel 1786 An History of Early Opinions concerning Jesus Christ,
compiled from Original Writers; in entrambi i volumi veniva sostenuto che la chiesa in origine era
unitariana e poi era andata incontro a corruzione. Le sue opinioni in fatto di religione e le sue simpatie per
la rivoluzione francese, fecero sì che nel 1791 una folla, aizzata ad arte, distruggesse la sua casa,
costringendolo ad allontanarsi dal paese per trasferirsi negli Stati Uniti. 14 Charles Babbage (1791 - 1871): matematico e filosofo britannico, scienziato proto-informatico che per
primo ebbe l'idea di un calcolatore programmabile. Realizzò la macchina differenziale e progettò la macchina
analitica. 15 John Frederick William Herschel (1792 – 1871): matematico, astronomo, chimico; nel 1833 si recò in Sud
Africa per studiare il cielo dell’emisfero australe. Aiutato dalla moglie, raccolse e disegnò la flora del Capo,
utilizzando la camera lucida, per ottenere disegni di maggior precisione. Durante la sua permanenza in Sud Africa,
fu visitato da Darwin a dal capitano Fitz Roy. 16 Uno dei tentativi più celebri di fornire una datazione delle origini fu quello compiuto dall’arcivescovo
irlandese James Ussher (1581 - 1656) che fissò la creazione alle ore 12 del 23 ottobre del 4004 avanti Cristo. Tale
datazione è stata utilizzata come nota a margine della traduzione ‘autorizzata”di re Giacomo, pubblicata nei paesi
di lingua inglese sino alla seconda metà del Novecento; per i particolari si veda Gould, 2003, Autunno in casa Ussher
(pg. 204-223)
Mantenne, però, il silenzio sulla sua teoria, ma consolidò il suo prestigio scientifico con
numerose pubblicazioni sulla geologia dei paesi visitati, la Zoologia del viaggio sul Beagle,
pubblicato a sue spese e da lui coordinato, comprendente:
Parte 1: Mammiferi fossili, Richard Owen (1838-40)
Parte 2: Mammiferi, George R. Waterhouse, (1838-39)
Parte 3: Uccelli, John Gould (1838-41)
Parte 4: Pesci, Leonard Jenyns (1840-42)
Parte 5: Rettili, Thomas Bell (1842-4), Il Viaggio (Journal of Researches) (1839), La
struttura e distribuzione delle barriere coralline (1842).
Come si può dedurre da questo elenco, Darwin lavorò in questi anni in modo
instancabile. Nel gennaio del 1838 sposò la cugina Emma Wedgwood (1808-1896), cosa che gli
consentì di ampliare il suo già cospicuo patrimonio e di vivere pertanto completamente libero da
preoccupazioni economiche. Emma, che al momento del matrimonio non era più giovanissima e
sembrava destinata a rimanere nubile per accudire la famiglia, si rivelò una compagna preziosa
per Charles. La nipote di Josiah aveva ricevuto un’eccellente educazione; conosceva il francese e
l’italiano, suonava il piano con grazia; in famiglia aveva frequentato Byron, Wordsworth e
Coleridge. Forte, attenta, piena di buon senso, saggia consigliera e serena consolatrice, accudì il
marito con grande abnegazione, assicurandogli una vita familiare tranquilla e mitigando con le
sue attenzioni i fastidiosi disturbi che Darwin aveva cominciato a manifestare al suo ritorno dal
viaggio; di salde fede unitariana, fu tormentata per tutta la vita dal pensiero che molto
probabilmente non avrebbe potuto ricongiungersi con il compagno nella vita futura. I due
ebbero dieci figli, solo quattro dei quali raggiunsero l’età adulta.
La confessione Nel 1842 Charles stilò un primo compendio sulla trasformazione dei viventi (Sketch on
Natural Selection) e nel 1844 terminò un saggio più ampio; i due manoscritti saranno pubblicati
dal figlio Francis solo nel 1909 con il titolo The foundations of the origin of species 17 . Terminato il
secondo lavoro, scrisse una lettera alla moglie, da aprirsi solo dopo la sua morte, in cui la
incaricava di pubblicare la sua fatica, affidandone la revisione a un curatore, scelto fra
personaggi scientifici di sua fiducia. Il saggio del 1844 è suddiviso in dieci capitoli e presenta i
temi essenziali del suo pensiero, gli stessi che saranno ripresi nell’Origine (la presenza di
variazioni negli organismi domestici e allo stato selvatico; incroci; selezione artificiale e naturale;
differenza fra razze e specie; comparsa di nuove specie e loro estinzione; distribuzione geografica
attuale e del passato e sue cause).
Lo stesso anno uscì, anonimo, un libro che suscitò enorme scalpore, Vestiges of the Natural
History of Creation che divenne rapidamente un vero e proprio best seller; fu letto dalla regina
Vittoria e dal principe Alberto, da personaggi politici (William Gladstone, Benjamin Disraeli
Abramo Lincoln), da poeti e filosofi (Alfred Tennyson, Elizabeth Barrett Browning, Arthur
Schopenhauer e John Stuart Mill) e naturalmente da tutta l’intellighenzia scientifica di lingua
inglese. Vestiges era scritto in modo avvincente e mostrava che il suo autore era a conoscenza di
molte scoperte recenti nel campo della geologia, paleontologia ed embriologia. La maggior parte
degli scienziati, forse anche con una punta di malcelata invidia nei confronti dell’ignoto autore
che, sebbene autodidatta, aveva riscosso un successo così travolgente, lo liquidarono come un
insieme di sciocchezze, che d’altra parte non mancavano; vi si affermava, fra l’altro, che
l’ornitorinco, dal momento che possiede il becco come le anatre e ha il pelo, poteva essere
considerato l’anello di passaggio fra uccelli e mammiferi; così Sedgwick prima e poi Thomas
Huxley lo fecero a pezzi.
17 Entrambe le opere sono scaricabili all’indirizzo: http://darwin-
online.org.uk/content/frameset?itemID=F1556&viewtype=text&pageseq=1
Vestiges si apre con l’ipotesi nebulare della formazione del sole, per poi tracciare un
affresco della progressiva evoluzione della vita sulla terra, le cui prime forme si sarebbero
formate per generazione spontanea. Per l’autore, l’evoluzione biologica è un processo
progressivo che ha portato da forme semplici ad altre sempre più complesse, sino alla nascita
dell’uomo, lo scopo ultimo del processo evolutivo. Secondo Robert Chambers, questo il nome
dell’autore di Vestiges, - tutti i viventi percorrono una strada ontogenetica comune, ma poi ogni
embrione imbocca strade diverse e diventa un organismo appartenente a una data classe. Solo
l’uomo percorre l’intera strada evolutiva senza deviazione. Analogamente a quanto si sostiene
ancora oggi nella teoria dell’Intelligent Design, le leggi che hanno portato alla trasformazione dei
viventi sono inconoscibili, perché dettate da un Ente Superiore. Il libro, comunque, ebbe il
merito di far conoscere il problema della trasformazione della specie al grande pubblico. Il fedele
amico di Darwin, J. D. Hooker18, gli scrisse in dicembre, dichiarando che si era divertito molto
nel leggere Vestiges e definendo l’ignoto autore un tizio divertente, ma questi replicò piccato che
non si era dilettato in ugual misura, anche se trovava che l’autore avesse confezionato il suo
lavoro con cura; probabilmente il saggio di Chambers gli fece pensare che se fosse uscito allo
scoperto rischiava di essere confuso con questo geniale dilettante. Nel gennaio del 1844, però, lo
scienziato aveva rivelato il suo segreto al suo confidente:
Dai tempi del mio ritorno mi sono impegnato in un lavoro molto presuntuoso, né conosco
alcuno che non lo definirebbe assai avventato. – Rimasi a tal punto colpito dalla
distribuzione degli organismi alle Galápagos eccetera eccetera e dal carattere dei
mammiferi fossili americani, eccetera eccetera che decisi di raccogliere
indiscriminatamente ogni tipo di fatto potesse in qualsiasi modo riguardare che cosa
siano le specie. – Ho letto montagne di libri di agricoltura e floricoltura e non ho mai
smesso di raccogliere fatti. – Alla fine, si è acceso un barlume di luce, e io sono quasi
convinto (un’opinione opposta a quella che nutrivo all’inizio) che le specie non siano (è
come confessare un omicidio) immutabili. Il cielo mi scampi e liberi dalle insensatezze di
Lamarck di una «tendenza al progresso», di «adattamenti derivanti dalla lenta volontà
degli animali», eccetera – ma le conclusioni a cui sono indotto non sono molto diverse
dalle sue – sebbene i mezzi del cambiamento lo siano completamente – io penso di aver
scoperto (ecco la presunzione!) il semplice modo mediante il quale le specie si adattano
mirabilmente a vari fini. – Ora vi lamenterete pensando fra voi «ecco a qual sorta d’uomo
io scrivo perdendo il mio tempo». – Cinque anni fa avrei pensato anch’io altrettanto.
La lettera esprime chiaramente la preoccupazione e l’orgoglio che lottavano in lui; al
ricco gentiluomo, amico di religiosi e desideroso di mantenere i propri privilegi, la grande idea
appariva criminosa, ma al contempo ne andava orgoglioso; a differenza degli evoluzionisti-
filosofi del passato, riteneva di seguire alla lettera l’insegnamento baconiano, raccogliendo una
miriade sterminata di dati, su cui ancorare il “meccanismo semplice” con cui le specie si
trasformano e a questi si atteneva. I “fatti” non gli mostravano alcuna tendenza al progresso, a
differenza di quanto sosterranno molti suoi sedicenti seguaci.
Nel 1847, Darwin consegnò a Hooker una copia del suo manoscritto e finalmente poté
avere un’opinione sul suo lungo lavoro solitario. L’amico, diligentemente, annotò a margine
dello scritto le cose che condivideva e quelle che apparivano poco chiare.
Il 1845 era stato un anno tragico per tutto il Regno Unito, in particolare per l’Irlanda: la
peronospora aveva distrutto gran parte del raccolto di patate e la farina, a causa dell’aumento
della tassa di importazione sul grano, aveva raggiunto prezzi proibitivi per le classi meno
abbienti. Questa situazione, che portò gravi difficoltà anche all’interno della piccola comunità
18 Joseph Dalton Hooker (1817 –1911) fu botanico ed esploratore inglese . ricoprì la carica di direttore dei
Royal Botanical Gardens di Kew.
che gravitava intorno a Down House, la residenza in cui Darwin si era ritirato con la famiglia a
partire del 1842, confermò lo scienziato nella sua convinzione che solo il libero scambio - con la
relativa abolizione di tasse protezionistiche- e una competizione economica senza vincoli
avrebbero potuto evitare disastri simili. Nel frattempo Richard Owen era diventato l’esponente
di maggior spicco dell’anatomia comparata, tanto da ricevere l’appellativo di “Cuvier inglese”
(anche se lui si reputava superiore). Formatosi come medico all’Università di Edimburgo, dove
era venuto in contatto con la “Naturphilosophie” tedesca, divenendone un devoto seguace,
riteneva che si potesse osservare la presenza in natura di un disegno divino e per questo motivo
era particolarmente caro ai conservatori. Darwin, anche se non lo trovava particolarmente
gradevole, ne ammirava la profonda competenza e si era affidato a lui per lo studio dei fossili di
mammiferi rinvenuti in America meridionale. La fama di Owen si consolidò anche perché
classificò e descrisse i dinosauri –a cui diede il nome-, studiò il Moa, e soprattutto perché distinse
chiaramente gli organi omologhi e quelli analoghi. L’osservazione di omologie nei viventi si
rivelò preziosa per Darwin, perché poteva essere interpretata come una chiara dimostrazione
della parentela esistente fra gli organismi, malgrado Owen fosse convinto che gli archetipi altro
non fossero che vere e proprie idee platoniche, comuni a tutti i membri di un determinato
gruppo di organismi e presenti nella mente di Dio, che preconosce da sempre tutte le
trasformazioni a cui essi sono andati incontro nel tempo.
La teoria di Owen fu esposta nel saggio On the Archetype and Homologies of the Vertebrate
Skeleton (1847); vi si sostiene ad esempio che i centri di ossificazione nei crani di embrioni di
uccelli e mammiferi si ritrovano in posizioni simili e questo non può essere spiegato con
un’interpretazione funzionale-finalistica, ma solo facendo appello, appunto, a un archetipo
comune. Analogamente, da una tipica vertebra ideale, si sono formate tutte le ossa dello
scheletro dei vertebrati, compresa la scatola cranica. La teoria degli archetipi ebbe un
prestigioso seguace anche oltre oceano nel naturalista di origine svizzera Jean Louis Rodolphe
Agassiz (1807 –1873); questi, che aveva compiuto diversi studi sui ghiacciai delle Alpi insieme a
al geologo scozzese Roderick Murchison (1792-1871), era ben presto giunto alla conclusione che
la Svizzera era stata completamente ricoperta dai ghiacci in un passato relativamente recente.
Successivamente, studiando la geologia della Scozia, aveva verificato che anche in quel
territorio esistevano tracce di antiche attività glaciali, presenti del resto –come poté verificare in
spedizioni successive- anche in Inghilterra, nel Galles e in Irlanda. Le sue osservazioni furono
raccolte nel saggio Études sur les glaciers (1840), che naturalmente Darwin lesse e apprezzò,
tanto da inviare al naturalista svizzero una lettera di congratulazioni e una copia del suo
Journal of researches. Recatosi a Boston nel 1846 per un ciclo di conferenze, Agassiz fu convinto
a trattenersi negli Stati Uniti, dove fu nominato docente di zoologia e geologia a Harvard, la
stessa cattedra che ricoprirà, più di un secolo dopo, F. J. Gould. Agassiz era consapevole dei
cambiamenti ambientali a cui era andata incontro la terra – fu infatti il primo a riconoscere
fenomeni di glaciazione nel passato – e vedeva nella sequenza di fossili in strati geologici
successivi un chiaro segno di una progressiva trasformazione; le nuove forme di vita, però, non si
erano formate grazie all’interazione fra ambiente e organismi, bensì a causa di una serie di
creazioni indipendenti. Come per Owen, le omologie riscontrate all’interno di uno stesso gruppo
indicavano gli archetipi presenti nella mente divina. Darwin, dal suo rifugio di Down, da cui si
allontanava raramente e con fastidio, non intervenne mai in questi dibattiti, apparentemente
tutto preso in altre attività: portò a termine il suo lavoro sulla geologia dei paesi visitati durante
il viaggio, rivide il Journal e continuò a intrecciare fitte relazioni epistolari con scienziati,
allevatori e semplici appassionati. Nel 1846 iniziò un poderoso studio sui cirripedi viventi e
fossili, che lo impegnò per ben otto anni. Aveva colto al volo l’osservazione di Hooker che
nessuno ha il diritto di esaminare la questione della specie se lui stesso non ne ha descritte molte.
Forse inizialmente lo scopo di tanto lavoro era solo quello di impratichirsi in descrizioni di tipo
sistematico, ma presto si rese conto di poter andare alla ricerca dell’”archetipo” di questi piccoli
crostacei pressoché sconosciuti; per lui, però, il termine indicava l’antenato comune, l’ignoto
progenitore da cui derivano tutti gli altri. Si mise a studiare le fasi embrionali di numerosi
esemplari, analizzò al microscopio le singole strutture, confrontò specie viventi e fossili, scrisse
lettere a numerosi scienziati o semplici appassionati sparsi nelle più svariate regioni del mondo,
perché gli inviassero esemplari esotici. Infine, a coronamento di tanto lavoro, giunse alla
convinzione che gli individui ermafroditi rappresentano le forme originarie da cui si sono
diversificati gli organismi bisessuati e che in particolare i maschi si sono formati da ermafroditi
che durante il loro sviluppo embrionale hanno perso alcuni organi e ne hanno sviluppati altri.
La variazione di forme, pertanto, è determinata da alterazioni avvenute nel corso
dell’ontogenesi, e, dato che i vari organi sono correlati fra loro, si possono affermare insieme
strutture vantaggiose e altre che sono inutili, a conferma che le variazioni casuali non portano a
organismi perfetti.
Fra il 1851 e il 1854 Darwin diede alle stampe, con il sostegno finanziario della Società
paleontologica, le poderose monografie sui Cirripedi peduncolati e sessili, viventi e fossili. I saggi
erano costati “lacrime e sangue” al suo autore, che quindi non aveva avuto il tempo materiale
per dedicarsi in modo organico alla sua grande idea, ma probabilmente, al di là del desiderio di
accumulare dati inoppugnabili, un altro motivo lo spingeva a tacere, lo stesso che contribuiva a
creargli tutti i disturbi che lo affliggevano da quando era rientrato in patria, o meglio dal
momento in cui gli era balenata per la mente l’idea della trasmutazione. Darwin, secondo molti
suoi biografi, aveva paura; non tanto perché era convinto della trasformazione del vivente, cosa
di cui molti parlavano ormai da molto tempo, introducendo forze vitali, una storia con
direzione, l’essenziale irriducibilità della mente, tutte argomentazioni compatibili con un Dio
cristiano che agiva in accordo con le leggi dell’evoluzione anziché con la creazione, ma perché la
sua era una teoria materialistica, applicata a tutti i fenomeni vitali, mente compresa, una teoria
che poteva essere abbracciata da radicali rivoluzionari, non da un signorotto di campagna,
amico di prelati, lui stesso parroco mancato; eppure, nel taccuino M si legge per esempio:
Platone nel Fedone afferma che le nostre “idee fondamentali” derivano dalla loro
preesistenza nell’anima, non sono derivabili dall’esperienza – leggere scimmie per
preesistenza (1838).
Il 23 aprile del 1851 la famiglia Darwin subì un gravissimo lutto: la figlia decenne, la
dolce e gioiosa Annie, prediletta del padre, morì dopo una dolorosa agonia al quale il padre
assistette impotente. La già vacillante convinzione che esistesse una qualche giustizia morale a
governare il mondo degli uomini, fu radicalmente estirpata dal cuore inconsolabile di Charles:
nessun agente benefico avrebbe potuto sottrarre ai suoi cari una bambina incolpevole e nessuna
consolazione poteva venire dalla lettura del “poeta laureato” tanto amato dalla moglie Emma:
Are God and Nature then at strife, That nature lends such evil dreams? So careful
of the type she seems So careless of the single life. (In Memoriam, Alfred Tennyson, 1850)
Spencer, l’evoluzione, la guerra Nel 1852, usciva, anonimo, sulla rivista radicale “The Leader” Development Hypothesis, di
Herbert Spencer (1820 –1903). L’autore, in questo saggio, inizia ad elaborare una cosmologia
basata sul pensiero di Lamarck e parla esplicitamente di Theory of Evolution. L’articolo si apre
con questa significativa affermazione:
Coloro che con arroganza respingono la teoria dell’evoluzione perché non sostenuta
adeguatamente da fatti, sembrano dimenticare che la loro stessa teoria (della creazione
indipendente di tutte le forme di vita) non è per niente sostenuta da fatti. Come la
maggior parte degli uomini nati con una data convinzione, esigono prove rigorose per
qualunque credenza contraria, ma pensano che la loro non ne richieda alcuna 19
Nelle opere successive, Spencer elabora una filosofia secondo cui nella materia e in tutti i
viventi – uomo compreso- esiste un irrefrenabile impulso verso un continuo miglioramento,
causa stessa dell’evoluzione. La profonda differenza metodologica fra il filosofo e lo scienziato
può essere compresa leggendo il seguente brano tratto dall’Autobiografia:
Trovavo molto interessante la conversazione di Herbert Spencer, ma la persona non mi
era particolarmente simpatica (...) credo che fosse molto egoista. Ogni volta che leggo uno
dei suoi libri provo un’ammirazione entusiastica per il suo talento eccezionale (…)
Tuttavia non credo che la conoscenza delle opere di Spencer abbia avuto qualche influenza
sul mio lavoro. Il metodo deduttivo con cui egli tratta ogni argomento è assolutamente
contrario alla mia mentalità. Le sue conclusioni non mi convincono mai: e ogni volta,
dopo aver letto una sua discussione, mi vado ripetendo: “Ecco un argomento che
richiederebbe sei anni di lavoro.
Le sue generalizzazioni fondamentali (che qualcuno ha paragonato di importanza pari a
quella delle leggi di Newton!), forse sono molto importanti filosoficamente, ma non
sembrano utili dal punto di vista rigorosamente scientifico. Esse hanno il carattere di
definizioni anziché di leggi naturali e non servono a prevedere che cosa accadrà nei vari
casi particolari (...)20.
Darwin lascia chiaramente intendere la sua scarsa simpatia per il filosofo suo
contemporaneo e la profonda distanza metodologica che li separa, eppure i due continueranno a
lungo a essere confusi, soprattutto a partire dalla pubblicazione Principles of biology (1864-1867)
di Spencer, in cui s’insiste sulla profonda analogia fra cambiamento organico e progresso della
società, concetto particolarmente caro ai vittoriani, seguaci del mito delle magnifiche sorti e
progressive dell’Impero. Il termine evolution, coniato da Spencer, non compare mai nella prima
edizione dell’Origine. Darwin parla infatti di teoria della modificazione per selezione naturale o
teoria della discendenza con modificazioni successive o ancora principio della selezione naturale.
Gould (1984) (i) ha cercato di spiegare i motivi che spinsero Darwin a evitare questo termine,
almeno nella prima stesura dell’Origine. Evolution aveva già un significato tecnico in biologia;
gli era stato attribuito nel 1744 dall’anatomico e naturalista svizzero Albrecht von Haller (1708-
1777); egli pensava che tutti i futuri embrioni fossero stati presenti, preformati e in attesa di
svilupparsi, nei testicoli di Adamo o nelle ovaie di Eva, racchiusi negli spermatozoi o nelle uova,
l’uno dentro l’altro come bamboline russe. Von Haller, per definire il fenomeno, aveva utilizzato
il termine evolvere, nel suo significato latino di svolgere, srotolare e dunque, se la teoria del
medico svizzero fosse stata vera, quella della discendenza con modificazione non avrebbe avuto
ragione di essere formulata, giacché tutto era già stato predisposto da un ente superiore.
Evolution, però, nel linguaggio parlato aveva e ha ancora oggi un significato ben diverso,
implica la comparsa, in ordinata successione, di una lunga serie di eventi e soprattutto contiene
in sé il concetto di sviluppo da una stato rudimentale e imperfetto a uno completo e maturo e
quindi è strettamente legato al concetto di progresso. Proprio per questa ragione, Spencer lo
utilizzò ampiamente, convinto che l'evoluzione sia la legge che governa il miglioramento
continuo di tutti i viventi e delle società umane in particolare. Darwin, al contrario, pensava che
non esistessero organismi che presentano strutture inferiori o superiori – vocaboli che egli si
propose di evitare scrupolosamente già durante la stesura dei taccuini -; l’adattamento non
19 L’articolo può essere scaricato all’indirizzo
http://www.victorianweb.org/science/science_texts/spencer_dev_hypothesis.html 20 In Autobiografia, pag 89-91
premia il migliore in assoluto, ma quello più idoneo in quel determinato contesto. Alcuni
organismi si sono formati prima, altri dopo, senza che sia evidente alcun progresso. Gould
termina il suo articolo sottolineando come questa erronea equazione fra evoluzione e progresso,
iniziata in epoca vittoriana, si è perpetuata - per lo meno nel sentire comune- sino ai giorni
nostri. Storicamente fu all’origine degli abusi del darwinismo sociale, che si affermò in epoca
vittoriana, ebbe conseguenze terribili nel secolo successivo e ancora oggi alimenta il razzismo, lo
sfruttamento, la violenza. È pur vero che nelle successive edizioni dell’Origine, e soprattutto
nella sesta, lo scienziato fa più volte uso del termine evolution e di altri termini impiegati da
Spencer in Principles of Biology (1864), in cui il filosofo paragona le sue teorie economiche con
quelle biologiche di Darwin, scrivendo: “Questa sopravvivenza del più adatto che ho qui cercato
di esprimere in termini meccanici, è quella che il signor Darwin ha chiamato “selezione
naturale”, o la preservazione delle razze favorite nella lotta per la vita.” “Survival of the fittest”,
che in italiano verrà spesso tradotto come sopravvivenza del più forte, per Darwin non è altro
che una metafora -ancorché infelice- per indicare il meglio adattato in quel determinato
ambiente particolare. D’altra parte, un vittoriano, sia pure geniale, non poteva rinunciare
completamente alla convinzione che esista anche in natura, come nella società, una qualche
forma di progresso; in un mondo sovraffollato, in cui tutti gli spazi sono occupati, le specie che
riescono a sopravvivere e determinano l’estinzione di altre sono a queste superiori, affermerà più
volte nelle successive edizioni dell’Origine. Darwin, bersagliato da polemiche infinite, cercherà di
accontentare un po’ tutti; preoccupato per le reazioni delle Chiese e dei credenti in genere, a
partire dalla seconda edizione, aggiungerà un “by the Creator” alla sua celebre espressione:
There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally
breathed (by the Creator) into a few forms or into one .
Accentuerà inoltre l’influenza dovuta all’ambiente per i cambiamenti evolutivi. Proprio
subito dopo la pubblicazione di Development Hypothesis, Spencer conobbe Thomas Henry Huxley (1825 –
1895), un promettente autodidatta, che aveva letto con passione di filosofia, scienze, storia e aveva
imparato il tedesco alla perfezione – tanto che molto spesso avrebbe aiutato Darwin a tenersi aggiornato
sulle pubblicazioni scientifiche tedesche -; il giovane si era imbarcato per quattro anni come assistente
chirurgo nella nave Rattlesnake, diretta nell’emisfero australe. Nonostante le difficili condizioni presenti
sulla nave e i pochi strumenti scientifici a disposizione, aveva raccolto e studiato numerosi invertebrati
marini, inviando dettagliati resoconti in patria, dove i suoi articoli erano stati accolti con favore. Huxley
e Spencer divennero molto amici, accumunati forse dal fatto che entrambi avevano avuto un’infanzia e
un’adolescenza difficili, ancora avevano difficoltà a sbarcare il lunario e erano desolatamente soli.
Huxley, desideroso di farsi conoscere, aveva mandato alcuni suoi lavori a Darwin, che li aveva
apprezzati e aveva cercato di aiutare il giovane collega. Quando uscì il primo volume sui cirripedi,
Huxley si complimentò con Darwin e fra i due s’instaurò una salda amicizia che porterà Huxley a essere
ricordato soprattutto come il “mastino di Darwin’. Nel frattempo, anche in Inghilterra fervevano i
preparativi per la guerra di Crimea che vide schierati l’Impero Ottomano, Inghilterra, Francia e Regno
di Sardegna contro la Russia. Si trattò di una carneficina spaventosa, non soltanto per i morti sul campo,
ma soprattutto per le epidemie di colera che colpirono, indifferentemente, entrambi i fronti. Questi
eventi dolorosi fecero riflettere Darwin sull’analogia fra la guerre scatenate dagli uomini e la lotta per la
vita presente in natura; in entrambi i casi, l’invasione poteva venire dal mare che portava da una lato
eserciti a occupare terre altrui, dall’altro semi, uova, piccoli animali aggrappati a tronchi a invadere
nuovi territori, cacciando via la popolazione locale.
Lo scienziato volle verificare la sua ipotesi, mettendo a bagno in acqua salata semi di varie
piante, per esaminare quanto a lungo mantenevano la loro capacità di germinazione e analizzando le
zampe di uccelli migratori per accertare la presenza di spore, semi, uova, piccoli invertebrati.
Alfred Russel Wallace Nella seconda metà dell’Ottocento, un altro personaggio fece la sua apparizione nell’agone
scientifico: Alfred Russel Wallace (1823-1913). Questi aveva ricevuto un’educazione informale e svolto
diverse attività, fra cui quella di agrimensore; nel 1844 divenne maestro presso la scuola di Leicester.
Anche se questo lavoro non lo appassionava, gli lasciava tempo libero per leggere numerosi testi
quali il Personal narrative di Humbaldt, il Viaggio del Beagle di Darwin, il Saggio sul principio di
popolazione di Malthus, i Principi di Lyell, trattati di geografia e di classificazione animale e vegetale. A
Leicester ebbe la fortuna di incontrare Henry Walter Bates 21, che determinò una svolta fondamentale
nella sua vita, alimentando il suo interesse per l’osservazione naturalistica; in particolare, Bates gli
trasmise la sua passione per l’entomologia, tanto che Wallace iniziò una sua raccolta personale; era
affascinato dalla stupefacente varietà di forme e colori degli insetti e, influenzato dalla lettura di
Humboldt e di Darwin, cominciò a sognare di potersi recare lui stesso in quei luoghi esotici alla ricerca di
esemplari rari e sconosciuti. Sempre in questo periodo venne in contatto col mondo dello spiritismo e,
malgrado fosse inizialmente scettico, cambiò presto idea quando si accorse di possedere la capacità di
indurre in altri fenomeni di autosuggestione e ipnosi. Questa scoperta, unita ai successivi interessi per
l’occultismo e il mesmerismo, influenzeranno il suo pensiero, inducendolo a maturare una visione
spiritualista del mondo.
Avendo avuto una formazione autodidatta che lo aveva abituato a fare affidamento sulle sue
osservazioni dirette e non sull’autorità degli altri, per tutta la vita rimarrà convinto che le accuse di
impostura rivolte a più riprese nei confronti di sedicenti maghi – che peraltro erano accolti con grande
favore alle serate della borghesia inglese- fossero dovute a prevenzioni di persone che si erano sottratte
all’osservazione diretta e obiettiva del fenomeno. Del resto, Wallace non era il solo in Europa e oltre
oceano, a riporre la sua fiducia nell’occultismo e a ritenere che di esso potesse essere fornita, in un non
lontano futuro, una spiegazione razionale. Bates e Wallace rimasero in contatto epistolare, si
scambiarono insetti e discutessero di vari argomenti. Entrambi maturarono il desiderio di recarsi in Sud
America e progettarono di pagarsi le spese del viaggio, catturando esemplari da rivendere in patria. Nel
Regno Unito, infatti, imperversava la moda delle collezioni naturalistiche, tanto che a Londra erano nati
numerosi negozi e sale d’asta specializzati nella vendita di esemplari esotici e rari. Mentre pensava al
grande viaggio, Wallace si tenne aggiornato leggendo riviste e saggi scientifici e naturalmente il libro del
momento, Vestiges, rimanendone molto colpito. Wallace si recò anche a Londra, per studiare le ricche
collezioni naturalistiche presenti al British Museum. A differenza di Darwin, che aveva intrapreso il suo
viaggio ancora fermamente convinto sulla fissità della specie, Wallace, quando insieme all’amico salpò da
Liverpool nel 1848, aveva già in mente l’idea di trasformazione dei viventi. I due attraccarono a Parà
(l’attuale Belém) e insieme raccolsero piante e animali nella foresta amazzonica, ma dopo un anno
decisero di separarsi per catturare una maggior quantità di esemplari e, mentre Bates decise di
perlustrare il Rio delle Amazzoni, Wallace si dedicò all’esplorazione del Rio Negro, inviando a più riprese
materiale a un suo agente in patria. Durante il suo rientro, però, la nave su cui viaggiava prese fuoco e
lui perse tutta la cospicua raccolta che aveva con sé e molti dei suoi taccuini. Approdato finalmente a
Londra, pubblicò vari articoli accademici di tipo descrittivo e conobbe molti naturalisti, fra cui lo stesso
Darwin. Nel 1854, nonostante la precedente drammatica esperienza, riprese il mare e si recò a Singapore
e poi nell’arcipelago Malese. Qui fu ospite del Rajah di Sarawak James Brooke ( 1803 –1868), il “Rajah
bianco” che ispirò l’omonimo personaggio del ciclo di Sandokan di Salgari. Da questa sede, nel 1855,
Wallace inviò un articolo On the Law Which has Regulated the Introduction of Species 22, che venne
pubblicato in Annales and Magazine of Natural History; in esso erano raccolte numerose osservazioni
biogeografiche, che gli permisero di formulare quella che sarebbe divenuta nota come “Legge di
Sarawak”:
(2) 21 Henry Walter Bates (1825 –1892) naturalista e esploratore; fu il primo a descrivere il mimetismo. Al suo
ritorno da un viaggio di esplorazione (1859) durato undici anni, riportò 14.000 esemplari (soprattutto
insetti), molti dei quali mai osservati in passato.
22 L’articolo è scaricabile all’indirizzo http://www.wku.edu/~smithch/wallace/S020.htm
Ogni specie ha avuto un'origine coincidente, sia nello spazio sia nel tempo, con una specie
preesistente strettamente affine.
Wallace aveva maturato la sua idea, basandosi sulla diretta osservazione della distribuzione
geografica di piante e animali, aiutato in questo anche dalla sua esperienza di agrimensore, abituato a
tracciare confini e disegnare mappe. L’esploratore aveva notato che, mentre le classi e gli ordini sono
generalmente diffusi in tutto il pianeta, le specie presentano netti confini geografici e frequentemente
specie affini si trovano nella stessa località o in zone contigue, per cui la successione naturale delle specie,
dal punto di vista dell’affinità, diventa anche una successione geografica; anche il ritrovamento di specie
estinte gli aveva mostrato come queste si trovino spesso sepolte nello stesso strato geologico. Darwin,
nella sua affannosa ricerca di “dati certi”, era in contatto epistolare con Wallace, avendogli fra l’altro
richiesto l’invio di animali domestici dei territori da lui visitati; lesse il suo lavoro ma non ne comprese il
significato. Lyell, invece, lo aveva trovato interessante e ne parlò a Darwin che ribadì che a suo
parere non c’era nulla di veramente nuovo. Il primo maggio del 1857, tuttavia, scrisse a
Wallace, informandolo che da ormai venti anni stava cercando di capire “in che modo le specie e
le varietà differiscano le une dalle altre”e, a proposito dell’articolo pubblicato negli Annales, si
congratulò con lui, affermando fra l’altro che le loro idee in proposito erano alquanto simili. Non
è chiaro questo cambiamento di opinione, perché la lettera di Wallace cui Darwin rispondeva è
andata perduta. Probabilmente, lo scienziato voleva solo incoraggiare un giovane collega, non
avendo capito in pieno quanto questi fosse vicino alla verità. Darwin, comunque, era stanco di
mantenere ancora questo pesante segreto e in diverse lettere si confidò con Lyell, Huxley e col
cugino Fox.
Nel 1856 scrisse anche al botanico Asa Gray (1810 –1888), professore di Storia Naturale
all’Università di Harvard, con cui da anni era in rapporto epistolare e che gli aveva fornito
numerose informazioni sulla distribuzione della flora americana. Lyell gli consigliò di smetterla
di tergiversare, di perdere il proprio tempo, accumulando dati sulle varietà di piccioni e altri
animali domestici; doveva pubblicare finalmente qualcosa, stabilire la sua priorità su un lavoro
cui lavorava da anni ma Darwin era ancora incerto. Inaspettatamente, il 18 giugno 1858,
Wallace inviò a Darwin il saggio On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely From the
Original Type in cui esponeva un modello evolutivo molto simile a quello cui Darwin stava
lavorando ormai da venti anni. Nella missiva, l’esploratore chiedeva che il lavoro venisse
inoltrato a Lyell, che doveva giudicare se fosse meritevole di pubblicazione. Lo scienziato fu
sconvolto dalla notizia; immediatamente inviò il manoscritto a Lyell e il 25 giugno scriveva
all’amico:
Non c’è niente nell’abbozzo di Wallace che non sia stato scritto nel mio lavoro del 1844,
letto da Hooker circa dodici anni fa. Circa un anno fa mandai qualcosa di simile ad Asa
Gray, così che posso affermare di non dover niente a Wallace. Sarei molto felice di poter
pubblicare una dozzina di pagine sull’argomento, ma non sono sicuro di poterlo fare
onorevolmente (...) Preferirei bruciare tutto il mio libro piuttosto che lui o chiunque altro
potesse pensare che io mi sono mosso con malafede. Non pensi che il fatto che mi abbia
inviato il suo abbozzo mi leghi le mani?
Gli amici, in particolare Huxley, Hooker e Lyell, lo convinsero altrimenti e il primo luglio
1858 alla Linnean Society di Londra furono letti contemporaneamente il testo di Wallace, la
lettera di Darwin ad Asa Gray, scritta nel 1857, in cui in poche pagine esponeva il suo pensiero,
e parte del saggio del 1844. La comunicazione fu accolta nel più generale disinteresse, tanto che
il bilancio della Linnean Society si chiuse con un resoconto riassuntivo in cui si affermava che
nel 1858 non era successo nulla di particolarmente rilevante.
Charles non aveva preso parte alla riunione, perché impegnato a dare sepoltura
all’ultimo nato, morto di scarlattina, mentre Wallace ricevette la notizia dopo che la
comunicazione era già avvenuta, poiché si trovava ancora all’estero.
La pubblicazione Gli amici spinsero Darwin a porre fine al grosso trattato sull’origine della specie cui stava
lavorando e lo spronarono perché lavorasse a un saggio più agile e breve; Charles si mise a scrivere
alacremente, pur tormentato dai soliti disturbi, e l’anno successivo, in novembre, diede alle stampe On
the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for
Life.
La trepidazione con cui Darwin visse il suo uscire allo scoperto si comprende dalle lettere che
l’autore inviò a scienziati e amici in quell’occasione. Scrisse a Louis Agassiz :
Dal momento che le conclusioni a cui sono giunto differiscono molto dalle vostre, ho pensato che
voi potreste pensare che ve lo mandi per sfida o per bravata’; a Richard Owen: “Temo che ai tuoi
occhi sembrerà un abominio
a Wallace:
Dio sa che cosa penserà il pubblico
a Henslow:
Ho paura che non approverete il vostro allievo, in questo caso. Il libro non mostra appieno la mole
di lavoro che mi è costato (...) voi sapete quanto tenga al vostro giudizio - ma non sono così
irragionevole da aspettarmi che voi lo critichiate in modo dettagliato, spero però che sottolineerete
le parti più deboli. Se voi siete lievemente esitante sulla fissità della specie, allora sono convinto
che lo diventerete maggiormente grazie al processo che ho delineato
all’archeologo ed entomologo John Lubbock:
Non penso di aver mai ammirato libro più di quanto non abbia Natural Theology di Paley (…)
Sono felice che tu abbia ricevuto il libro, penso che tu lo valuti troppo bene. Ti sarei grato per
qualunque critica, non m’interessa quanto diranno le riviste, ma tengo molto all’opinione tua, di
Hooker, Huxley e Lyell
Al cugino Fox:
Penso tu abbia ricevuto il mio noioso libro sulla Specie. Naturalmente io penso che contenga soprattutto verità, ma tu potresti non essere d’accordo con me”.
L’enorme messe di dati presentata nel libro affrontava i seguenti punti:
a. Gli organismi si sono trasformati nel tempo; Tutte le forme viventi sono discese da uno o pochi
antenati comuni attraverso un continuo processo di ramificazioni successive; Ogni specie si riproduce a
un ritmo tale che, se tutta la progenie sopravvivesse, la popolazione aumenterebbe;
b. A parte la presenza di periodiche fluttuazioni, la popolazione rimane numericamente costante;
Le risorse non sono sufficienti per tutti gli organismi che nascono; Esiste fra gli organismi una
concorrenza spietata, una lotta per la vita, intesa anche in senso metaforico (lotta per l’acqua, la luce
ecc.);
c. Gli organismi della stessa specie presentano caratteristiche diverse fra loro; Molte di queste
variazioni sono ereditarie;
d. Alcune caratteristiche “vincenti” in un dato contesto ambientale si trasmettano alla
discendenza, mentre altre scompaiano perché l'individuo che le possiede muore prima di poterle
trasmettere (processo di selezione naturale). Darwin ammette di non conoscere le leggi della variazione
(cap. cinque de L'origine) e parla anche, come già Lamarck, di eredità dei caratteri acquisiti;
e. Le popolazioni si modificano lentamente per adattarsi all’ambiente e l’accumulo di queste
variazioni col tempo porta alla formazione di nuove specie.
L’Origine ebbe un grande successo di pubblico, tanto che le prenotazioni superarono le
disponibilità di 1250 copie e anche le 3000 copie della seconda edizione furono vendute rapidamente. Il
saggio si diffuse negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda, sollevando interesse esattamente come nel vecchio
continente. Le reazioni, però, non furono altrettanto favorevoli.
Critiche, consensi, fraintendimenti La lettura del saggio non fece cambiare parere a molti studiosi, cui Darwin teneva in modo
particolare e lo scienziato ne rimase amareggiato.
Il suo vecchio insegnante di geologia, Sedgwick, fu particolarmente duro:
Ho letto il tuo libro con più pena che piacere (...) Ho ammirato molto alcune parti, altre mi
hanno fatto ridere tanto, altre ancora le ho lette con dispiacere, perché le ritengo totalmente false e
perniciose. Hai abbandonato, dopo un ottimo inizio, il vero metodo induttivista, intraprendendo
un’impresa pazza (…) Molte delle tue vaste conclusioni sono basate su supposizioni che non
possono essere né provate né smentite.
Herschel, convinto da tempo che i cambiamenti delle specie non avvenissero grazie a variazioni
progressive e graduali, ma attraverso una serie di sovrapposizioni che permettevano la coesistenza di
specie nuove con quelle vecchie e che esistesse una “direzione intelligente” dietro il cambiamento, si riferì
alla selezione naturale come alla legge del pasticcio (law of higgledy-piggelty). Henslow scrisse al cognato
Leonard Jenyns – il naturalista, cui era stato inizialmente richiesto di accompagnare Fitz Roy durante il
viaggio sul Beagle- che, sebbene il libro fosse un’eccellente raccolta di fatti e osservazioni, le ipotesi di
Darwin lo spingevano troppo lontano e a lui facevano venire in mente il periodo dell’astronomia
tolemaica, in cui s’introducevano nuovi epicicli tutte le volte che l’interpretazione del cielo presentava
una difficoltà.
Lyell si convinse, almeno in parte, delle idee dell’amico, anche se non condivise mai l’idea che la
selezione naturale fosse il motore più importante della trasformazione delle specie. Comunque, nel suo
taccuino troviamo scritto (maggio 1860):
Darwin ha scritto un lavoro che costituirà un caposaldo nella geologia e nella storia
naturale
l’accettazione pubblica del meccanismo evolutivo, però, avverrà solo nella decima edizione dei
Principi (1867-1868).
Thomas Huxley, che da tempo era diventato intimo amico di Darwin, si schierò al suo fianco e
nel dicembre del 1859 uscì sul Times la prima fra le sue molte recensioni entusiaste sull’Origine. Owen,
palesemente roso dall’invidia, pubblicò anonimamente nel 1860 un astioso articolo su Edinburgh
Review, in cui fra l’altro si chiedeva come mai Darwin non avesse tenuto conto del suo assioma, secondo
cui in natura è presente “un‘azione continua di trasformazione ordinata” e attaccava Hooker e Huxley
per la loro “miope adesione”a un libro che a suo parere rappresentava una sorta di “insulto alla scienza’.
Owen, mettendo il dito nella piaga, insisteva sul fatto che Darwin non sapeva niente di come
avvenisse lo sviluppo e quali leggi governassero l’eredità dei caratteri e quindi la trasformazione e la
divergenza degli organismi avrebbero potuto essere la manifestazione di qualche ignota legge dello
sviluppo; specie simili avrebbero potuto diversificarsi a causa dell’ambiente e non per variazioni casuali.
Per contro, molti scienziati materialisti e radicali appoggiarono Darwin, compreso il suo vecchio
maestro, Grant, che gli dedicò un saggio a testimonianza della sua ammirazione, anche se non entrò nel
merito dei meccanismi evolutivi proposti. La maggior parte del clero anglicano, guidata dal combattivo
vescovo di Oxford Samuel Wilberforce (detto Soapy Sam, Sam il viscido), censurarono il volume e si
adoperarono a che a Darwin non fosse conferito il cavalierato, che era stato sostenuto dallo stesso
principe Alberto, prima della pubblicazione del libro.
In febbraio Thomas Huxley scese in campo con una conferenza tenuta alla Royal Institution dal
titolo Species and Races and their origin; nell’illustrare il pensiero dello scienziato, Huxley, che era
diventato un ottimo oratore, essendo intervenuto più volte anche in pubblici dibattiti per promuovere la
scienza fra i lavoratori, spostava l’attenzione sul tema che Darwin aveva solo sfiorato, l’origine
dell’uomo. L’argomento stava ovviamente molto a cuore al grande pubblico, che invece era scarsamente
interessato alla diversificazione di nandù, fringuelli, o piccioni. Nel suo intervento, il giovane studioso
provocò apertamente la chiesa, difendendo la scienza “schiacciata e mutilata dall’istituzione ecclesiastica
sin dai tempi di Galileo”. Ciò naturalmente fece infuriare il clero e il suo paladino Owen che si
prepararono al contrattacco.
Il 30 giugno del 1860, presso il Museo di Storia Naturale di Oxford, Huxley e Wilberforce – molto
probabilmente istruito sul piano scientifico da Owen - si fronteggiarono con argomentazioni che col
tempo avrebbero acquistato il sapore della leggenda.
Darwin non intervenne mai in pubblici dibattiti; in numerose lettere rimproverò a Huxley la sua
aggressività e cercò di temperare i suoi attacchi, rivolti anche verso quella parte del clero che si mostrava
aperta alle nuove idee; non condivideva la battaglia dell’amico, tesa a trasformare radicalmente le
istituzioni scientifiche attraverso l’assunzione di personale retribuito, ma era per lui giocoforza
appoggiare il suo difensore. Forse, anche la pronta conversione di Huxley al darwinismo era in parte
dovuta al suo fiero antagonismo con Owen, più che a una sincera adesione. Egli nutriva riserve circa il
ruolo della selezione naturale nella formazione di nuove specie, poiché la selezione artificiale non sembra
portare alla formazione di specie, ma solo a varietà che rimangono interfeconde con la specie di origine;
inoltre, ancor prima della pubblicazione, quando lesse il volume in anteprima, dopo essersi profuso in
elogi, criticò due punti della teoria:
Le uniche obiezioni che posso rilevare sono:
1° ti sei messo in una difficoltà inutile adottando senza riserve il motto “Natura non facit
saltus”.
Credo invece che essa debba fare piccoli salti
2° non mi è chiaro il motivo per cui, se le condizioni fisiche esterne sono di poca importanza,
dovrebbe intervenire una variazione
(lettera a Darwin, 23 novembre 1859).
Lo scienziato, nelle successive edizioni, terrà conto di quest’obiezione, ammettendo che a volte la
specie può subire delle stasi o modificazioni improvvise.
Wilberforce continuò a lanciare i suoi rabidi strali contro Darwin, rispolverando vecchie critiche
rivolte a suo tempo a Erasmus e accomunando disinvoltamente nonno e nipote; sostenne sciocchezze
madornali che, però, potevano avere grande presa sul pubblico:
Se le trasmutazioni stessero effettivamente avvenendo, dovremmo tuttora osservarle negli
invertebrati che si riproducono rapidamente; poiché non le vediamo, perché credere che vi siano
varietà di rapa che tendono a diventare uomini?(...) Tutta la creazione è la materializzazione
d’idee che esistono da sempre nella mente dell’Altissimo (...)’.
Nel febbraio del 1860, l’opinione pubblica fu distolta dalle polemiche sull’Origine a causa della
pubblicazione di Essays and Reviews, un manifesto stilato da teologi progressisti, in cui s’interveniva nel
dibattito sulla perfetta creazione, affermando che i miracoli non hanno fondamento razionale; Dio è un
impareggiabile legislatore, per cui i miracoli infrangerebbero l’ordine da Lui stabilito; credere in loro è
pertanto da atei. Il pamphlet, in sostanza, riprendendo le tesi esposte dall’esegesi biblica tedesca,
affermava che la ricerca scientifica non deve né può appellarsi a eventi straordinari. Il pamphlet, che in
due anni vendette 22.000 copie (più di quante avrebbe venduto L’Origine in 20), suscitò enorme scalpore
e infinite discussioni in tutto il paese; fra gli autori figurava anche il matematico reverendo Baden Powell
(1796–giugno 1860) - il cui figlio, Robert Baden-Powell, sarebbe diventato il fondatore degli Scout-.
Powell aveva lodato “il magistrale volume del signor Darwin”e aveva affermato che L’Origine
avrebbe prodotto un grande mutamento di opinione, a favore del grande principio dell’ “auto evoluzione
delle forze della natura”. A Powell era particolarmente caro quest’aforisma: “Il libro dei lavori di Dio è
diverso dal libro della parola di Dio”; purtroppo, proprio quando stava per scendere in campo a difesa del
darwinismo, morì per un attacco di cuore.
Dibattiti infuocati si ebbero anche oltre oceano: a Canterbury Settlement, una sperduta colonia
in Nuova Zelanda, Samuel Butler 23 lesse il saggio, rimanendone entusiasta, tanto da definirsi “uno dei
molti ammiratori del signor Darwin” e nel dicembre del 1862 scrisse un articolo nel giornale Christchurch
Press, Darwin on the origins of species, a dialogue, in cui espose il concetto di trasformazione dei viventi,
controbattendo punto per punto alle obiezioni di un immaginario interlocutore. L’articolo contribuì ad
aprire il dibattito sull’evoluzione anche in quella remota colonia inglese, tanto che ne seguì una replica,
non firmata, Barrel organs (Organini), in cu si sosteneva che le idee errate erano ricorrenti come gli
accordi dei piani meccanici. L’articolo, volto a gettare discredito sull’autore dell’Origine, criticava in
modo becero la teoria affermando fra l’altro: “Abbiamo conosciuto tutto su questa teoria, secondo cui
l’uomo deriverebbe direttamente dalla scimmia e noi avremmo perso la coda, perché ci saremmo seduti
troppo su questa nostra appendice”. L’autore, un vescovo anglicano, formulava una tesi che diventerà
ricorrente da parte di tutti i critici dell’evoluzionista inglese: Darwin non ha detto niente di nuovo,
niente che non sia già stato ipotizzato prima di lui da Monboddo (1714 - 1799) 24, Erasmus Darwin e
Lamarck. Negli Stati Uniti, Agassiz, che per tutta la vita non mutò mai le sue convinzioni, definì la
teoria “un errore scientifico: falsa nei fatti, non scientifica nei metodi e dannosa per il suo orientamento”e
accusò il darwinismo di ateismo. Asa Gray, che avrebbe curato l’edizione americana dell’Origine, accolse
il libro con molto favore e lo recensì nel marzo del 1860 sull’American Journal of Science and Arts,
esponendo i punti essenziali della teoria.
Gray, che era profondamente religioso, cercò di dimostrare che la teoria della selezione naturale
non si contrapponeva al cristianesimo; si poteva, infatti, inferire che il mondo era stato disegnato da una
Mente Ordinatrice; la selezione naturale, che agisce alla cieca su variazioni casuali, non può rendere
ragione di un mondo così ordinato; è Dio che progetta le variazioni buone e utili e su queste agisce la
selezione. Darwin, ringraziando Gray, così gli rispondeva:
Riguardo alla questione teologica, essa mi crea pena. -Sono confuso-, non avevo intenzione di
scrivere come un ateo, ma ammetto che non posso vedere chiaramente come altri la prova di un
disegno. Mi sembra che ci sia troppo dolore nel mondo. Non mi posso persuadere che un Dio
benefico e onnipotente possa aver intenzionalmente creato gli Icneumonidi con la chiara
intenzione che essi si cibino dentro i corpi vivi di bruchi, o che i gatti possano giocare con i topi
(...) D’altro canto, non posso essere soddisfatto, nel vedere questo meraviglioso universo – e
specialmente la natura umana - nel concludere che tutto sia frutto di una forza bruta (...) tutto è
troppo complicato per l’intelletto umano. Un cane potrebbe ugualmente speculare a proposito della
mente di Newton. Lasciamo che ognuno speri e creda in ciò di cui è capace’.
La risposta di Darwin rivela equilibrio e saggezza, anche se il tentativo di vedere nella
trasformazione dei viventi un disegno divino rimane ancora oggi un’invariante nella storia delle idee
evolutive.
Anche lo zoologo Saint George Jackson Mivart (1827–1900), di famiglia anglicana ma
convertitosi al cattolicesimo, cercò di fare un’operazione simile a quella tentata da Gray, pubblicando
Genesis of Species (1871). Mivart, compagno di studi di Thomas Huxley, aveva inizialmente condiviso la
teoria di Darwin ed era entrato nel ristretto circolo dei fedeli amici dello scienziato; successivamente,
soprattutto dopo la pubblicazione dell’Origine dell’uomo (1871), in cui veniva affrontato esplicitamente il
problema dell’uomo, si allontanò dalle posizioni dei suoi vecchi amici. Dapprima sollevò lo scottante
problema della formazione di strutture complesse come l’occhio o l’ala: non è possibile comprendere,
facendo appello a trasformazioni lente e graduali, l'affermarsi di strutture complesse, poiché i supposti
stati intermedi non sarebbero stati di alcuna utilità. Darwin tenne conto di questa e di altre obiezioni di
Mivart, tanto che il settimo capitolo della sesta edizione dell'Origine (1872) è dedicato alla replica alle
critiche sue e di altri scienziati. Mivart, però, giudicava insoddisfacente anche la teoria della selezione
23 Samuel Butler (1835 - 1902): scrittore e saggista, soprattutto famoso per essere l’autore del
racconto Erehwon; intervenne con numerosi saggi, prima per difendere e poi per denigrare l’opera di
Darwin 24 James Burnett, Lord Monboddo (1714 - 1799): giurista e giudice scozzese. Si interessò
all’origine della società e del linguaggio, ma anche di evoluzione; è citato da Erasmus Darwin nella sua
opera Temple of Nature.
naturale e ne proponeva una alternativa. Secondo quella che lui chiamò “genesi specifica’, l’evoluzione è
diretta da una “tendenza interna’. Un organismo appartiene a una specie fissa e determinata, ben
adattata all’ambiente, ma potenzialmente in grado di adattarsi ad altre situazioni, sotto la spinta
dell’ambiente. Quando questo si modifica, l’organismo rapidamente si modifica grazie a una non meglio
precisata forza interiore. Il sogno di Mivart era di costruire una teoria dell’evoluzione in cui scienza e
religione non fossero in contrasto. I vecchi amici criticarono le sue posizioni, accusandolo di tradimento e
egli reagì scagliandosi contro il darwinismo, che a suo avviso, malgrado si fosse presentato inizialmente
come un’ipotesi da verificare, si era trasformato in una nuova fede. In numerosi articoli anonimi sostenne
anche che la teoria minava la moralità, incoraggiava al vizio e metteva in dubbio i sacri vincoli del
matrimonio. Recensendo l’Origine dell’uomo su Quarterly Review, sostenne che il darwinismo poggia su
una metafisica erronea: le differenze fra l’uomo e gli altri animali sono di genere, non di grado; dal
momento che l’uomo possiede l’anima, non può essere considerato alla stregua degli altri viventi. Con
quest’affermazione riprendeva tesi esposte anche da altri e dallo stesso Owen che, ancor prima della
pubblicazione dell’Origine, nel 1857, aveva affermato di aver scoperto che il cervello degli esseri umani
differisce da quello del gorilla perché possiede l’Hippocampus minor, per cui la specie umana doveva
essere collocata in una sotto-classe a parte. Malgrado Huxley avesse dimostrato che tale struttura è
presente in tutte le grandi scimmie e anche nel babbuino, molti continuarono a pensare che si potessero
trovare strutture anatomiche che testimoniassero significative differenze qualitative fra l’uomo e agli
altri animali.
Lo stesso Wallace tradì la teoria che aveva contribuito a formulare; nel 1864 pubblicò su
Anthropological Review il saggio The origin of human races and the antiquity of man deduced from the
theory of “natural selection”. L’articolo precedeva di molto L’origine dell’uomo di Darwin, sebbene fosse
già stato pubblicato Evidence as to Man's Place in Nature (1863) di Huxley. Wallace si dice convinto che
dal momento in cui gli umani iniziarono a modificare il loro ambiente utilizzando strumenti, il fuoco e
l’agricoltura e si organizzarono in gruppi, in cui ciascun individuo collaborava con gli altri, si sottrassero
all’intervento della selezione naturale. Successivamente, sempre più attratto dal mesmerismo e da tutti i
fenomeni paranormali, costruì una teoria dell’evoluzione in cui prendevano spazio entità soprannaturali
e invisibili.
Nell’ultimo capitolo di Contributions to the Theory of Natural Selection (1870), Wallace si dice
convinto che l’azione della selezione naturale non è in grado di spiegare l’origine dell’uomo, per la quale è
necessario l’intervento di una legge divina. Motiva quest’affermazione sostenendo che non è possibile che
il cervello del selvaggio si sia sviluppato per cause naturali; dal momento che la selezione deve portare a
un livello di organizzazione proporzionato ai bisogni di una specie, non c’è alcun motivo per cui i
selvaggi, che hanno basse capacità intellettuali e morali, dovrebbero svilupparle con l’educazione, come
se il loro cervello fosse stato preprogrammato. D’altra parte, nemmeno le facoltà mentali dell’uomo
civilizzato possono essere spiegate dall’azione della selezione naturale, che non avrebbe potuto favorire la
capacità di formare concetti quali quelli di spazio e di tempo, di eternità e infinità, di forma e di numero,
etc. che non avrebbero avuto alcuna funzione per la sopravvivenza dell’uomo primitivo. La selezione
naturale, dunque, è un meccanismo che agisce su tutti i viventi ma non sull’uomo; a partire da quando il
processo di ominazione si è completato, le caratteristiche fisiche hanno perso ogni valore per la sua
sopravvivenza, garantita ora dalla mente, che lo rende capace di dominare la natura.
A Wallace, che applicava il concetto di adattamento in modo rigido, sfuggiva il fatto, più volte
sottolineato dall’autore dell’Origine, che l’organismo è un’entità in cui le varie parti sono fra loro
integrate, per cui la variazione di un certo organo può portare alla formazione di caratteristiche non
idonee in un altro –Darwin a questo proposito parla esplicitamente di principio di “correlazione della
crescita”-. Una certa struttura, poi, può essersi sviluppata per una funzione particolare, ma al contempo
può assumerne anche altre che non sono state selezionate e che possono risultare non adattative. Il
mondo descritto da Darwin non è il mondo perfetto presente nella cosmologia di Panglosso, lo sciocco
precettore creato da Voltaire, convinto che questo è “il migliore dei mondi possibili”. Wallace, certo che
ogni struttura dell’organismo si fosse affermata per una sua immediata utilizzazione, non riusciva ad
applicare il suo concetto di selezione all’uomo, il suo “iperselezionismo” non gli permetteva di capire
come fosse stato possibile l’affermarsi di una struttura come il cervello umano, che è in grado di
comporre musica, poesia, arte. Per Darwin una struttura, affermatasi per un certo scopo contingente,
può assumere col tempo altre funzioni; così, il grosso cervello di Cro-Magnon si può essersi sviluppato per
garantire la sopravvivenza a spauriti piccoli animali bipedi e nudi che si aggiravano nella savana e il cui
unico impellente bisogno era di procurarsi un po’ di cibo, o addirittura può essersi affermato, come
qualcuno sosterrà in seguito, per garantire una migliore termoregolazione, per poi essere utilizzato per
produrre i meravigliosi Lascaux, a comunicare con altri, cantare, scoprire le leggi che governano il
mondo.
Darwin fu sbalordito e costernato dalla deriva di Wallace.
Nel 1869 gli scrisse: Spero che tu non abbia assassinato del tutto il tuo e mio figlio. La lettura di
Contributions, poi, lo lasciò esterrefatto, tanto che scrisse, a margine delle pagine in cui si distruggeva il
concetto di selezione naturale, un desolato NO!
Wallace si trovò in disaccordo con Darwin anche a proposito della selezione sessuale, introdotta
nell’Origine dell’uomo per spiegare alcuni caratteri apparentemente non adattativi, come le livree
sgargianti di alcuni uccelli, i bellissimi disegni presenti sulle ali delle farfalle, le corna imponenti di molti
ungulati. In questo caso la sua convinzione che solo una selezione naturale rigidamente finalizzata fosse il
motore dell’evoluzione, e che essa producesse organismi perfettamente adattati al loro ambiente, lo
portava a non ammettere l’esistenza di strutture non adattative, legate a semplici preferenze estetiche da
parte delle femmine o al vantaggio comparativo di un maschio sull’altro durante le loro reciproche
esibizioni.
Un attacco ancora più pernicioso al darwinismo venne da uno dei fisici più autorevoli del tempo,
lo scozzese William Thomson (1824-1907), futuro Lord Kelvin. Questi, in diversi articoli scritti a partire
dal 1861, affermò che i calcoli di molti geologi, e di Darwin stesso (che, a proposito dell’età della Terra,
avevano ipotizzato un’età di 300 milioni di anni) erano assurdi: una Terra di tal età sarebbe stata un
pianeta invaso dai ghiacci. Il Sole, infatti, secondo Thomson, era una massa liquida incandescente la cui
energia, dovuta al suo collasso gravitazionale, si disperde irreversibilmente nello spazio. Il fisico aveva
calcolato l’energia gravitazionale di un oggetto con massa e raggio uguale a quelli del sole, e diviso il
risultato per il tasso da lui previsto con cui il sole avrebbe dovuto irradiare energia. Ciò lo portava a
stimare un’età del sole di soli trenta milioni di anni: un tempo troppo breve per aver visto il succedersi di
trasformazioni lente e graduali. Darwin era certo che i suoi dati fossero incontrovertibili: doveva esistere
un qualche meccanismo chimico fisico ancora ignoto che ritardava il raffreddamento del Sole. Solo nel
1896 la scoperta da parte del francese Henri Becquerel (1852-1908) dei fenomeni della radioattività
avrebbe aperto le porte alla comprensione dell’origine termonucleare dell’energia del Sole. Anche
Fleeming Jenkin (1833-1885), professore di ingegneria all’università di Edimburgo e futuro socio in affari
di Thompson, si associò alle critiche di lord Kelvin, ma soprattutto, nel 1867, affrontò un altro tema
cruciale cui Darwin aveva dato solo una soluzione parziale, quello dell’ereditarietà. Una delle ipotesi più
largamente condivise, in parte dallo stesso Darwin, affermava che le caratteristiche dei genitori si
mescolerebbero nei figli (eredità per mescolamento).
Molto antica, è un’ipotesi basata su osservazioni comuni: da un bianco e una nera nascono
generalmente figli mulatti, da un animale a collo lungo e uno a collo corto nasce un individuo con una
lunghezza del collo intermedia. Se le cose andassero così, con il passare delle generazioni, anche una
caratteristica ottimale andrebbe incontro a progressiva diluizione sino a scomparire completamente. Dal
momento che il saggio di Mendel, Esperimenti sull’ibridazione delle piante (1866), che lo scienziato aveva
ricevuto, ma probabilmente non letto, restò ignorato sino ai primi del Novecento, l’ipotesi del
mescolamento appariva sensata. A questa obiezione Darwin poteva rispondere solo in modo
insoddisfacente, introducendo l’ipotesi della pangenesi: i gameti riceverebbero da tutto l’organismo
minutissime particelle (gemmule), che contribuirebbero alla trasmissione ereditaria dei caratteri acquisiti
in vita dall’organismo stesso. L’ipotesi, che non aveva nessun riscontro sperimentale, fu quasi subito
falsificata da Francis Galton (1822-1911), il padre della biometria.
Il Mneme - la cultura può essere trasmessa alla prole?
Lo stesso Samuel Butler scese in campo per dare forma a una teoria evolutiva alternativa; già in
Lucubratio Ebria (Pensieri da ubriaco) (1865), quando ancora si proclamava fedele seguace di Darwin,
c’erano i germi di un futuro dissenso:
Si dovrebbe ricordare che gli uomini non sono solamente i figli dei loro genitori, ma sono frutto
delle istituzioni e dello stato delle scienze meccaniche in cui essi sono nati e cresciuti. Queste cose
ci hanno reso quello che siamo. Siamo figli dell’aratro, della spada e della nave; siamo figli
dell’estesa libertà e conoscenza che la pressa tipografica ha diffuso. I nostri antenati aggiunsero
queste cose alle loro membra già esistenti; i nuovi arti furono mantenuti dalla selezione naturale e
incorporati nella società umana; si trasmisero con modificazioni, e da qui deriva la differenza tra
i nostri progenitori e noi stessi. Dalle istituzioni e lo stato della scienza sotto i quali un uomo è
nato si determina se egli avrà gli arti di un selvaggio australiano o quelli di un inglese del
diciannovesimo secolo. Il primo è integrato da poco altro che una coperta e un giavellotto; il
secondo cambia la sua costituzione fisica con i cambiamenti di stagione, con l’età e con l’aumento
o la diminuzione della ricchezza. (...) egli porta un temperino e generalmente un astuccio per le
matite. La sua memoria entra in un taccuino (...).
Nel 1878 Butler pubblicò Life and Habit (Vita e abitudine) e, proprio nel periodo in cui stava
scrivendo il saggio, Francis Darwin, il figlio di Charles, con cui era in rapporti di amicizia, lo informò che
il fisiologo Ewald Hering 25 aveva formulato una teoria psico-fisica dell’ereditarietà, pubblicata nel
saggio La memoria e le energie specifiche del sistema nervoso (1870), secondo cui il protoplasma delle
cellule possiede memoria ed è così in grado in grado di riprodurre ciò che ha prodotto in passato. Gli
stimoli lascerebbero determinate tracce nel protoplasma e, ripetuti regolarmente, determinerebbero un
comportamento che persiste anche quando viene meno lo stimolo, per cui reazioni apprese dalla cellula
possono essere trasmesse alla prole. La trasmissione dei caratteri ereditari è, insomma, il risultato della
memoria preconscia dell’organismo e le acquisizioni culturali si possono trasmettere alla discendenza.
Butler andò oltre Hering, affermando in un’opera successiva, Unconscious Memory (1880), che il
corpo e il cervello del nuovo essere hanno il potere di ricordare o riprodurre eventi o fenomeni
sperimentati centinaia di volte dai loro antenati. Le cellule somatiche (in particolare le fibre nervose)
recherebbero tracce degli stimoli ambientali grazie alla presenza di vibrazioni molecolari specifiche, che
persisterebbero in esse stimolandone la crescita. In quest’opera Butler approda a una sorta di panteismo,
per cui è possibile
Vedere ogni atomo dell’universo come un’entità vivente, in grado di sentire e ricordare anche se in
modo modesto; ciascuno possiede una vita eterna, come eterna è la materia, vita e materia sono
legate insieme indissolubilmente come il corpo e l’anima. Così ognuno potrà vedere dio dovunque.
I saggi di Butler furono accolti dalla comunità scientifica come uno scherzo neppure tanto
divertente e Darwin reagì con la tattica più efficace e offensiva: un silenzio assordante.
Le ragioni di tale reazione furono molteplici. Nonostante Butler si fosse documentato in modo
approfondito sui saggi scientifici contemporanei, quando esprimeva opinioni personali non si
preoccupava di portare la benché minima evidenza sperimentale a sostegno delle sue tesi, procedendo
spregiudicatamente su un terreno in cui l’interpretazione dei fenomeni dovrebbe essere sostenuta da
accurate osservazioni sperimentali. Come dar credito ad affermazioni del tipo: L’uovo (di gallina) pensa
che le penne gli offrano più vantaggi del pelo o della pelle. Se potesse parlare ci direbbe che si potrebbe
facilmente comportare come noi dopo aver preso poche lezioni. Naturalmente si può anche dire che la
comunità scientifica fece quadrato, come spesso succede, di fronte a quella che considerava l’indebita
intrusione di un dilettante. La sua teoria della memoria è stata in qualche modo confermata dalla
genetica contemporanea: che cosa è il DNA se non memoria della specie? Non si può però affermare che
le sue speculazioni abbiano fornito contributi importanti per le successive scoperte. Il suo è il pensiero di
un polemista spregiudicato e beffardo, che agita problemi, solleva obiezioni, ma non offre soluzioni
plausibili. Quanto allo stile, sempre ironico e provocatorio, era il più lontano possibile dal linguaggio
degli ambienti accademici; del resto lui stesso aveva affermato:
(...) Nel lavoro non ho pretese di scientificità, anche in quanto non voglio istruire né tantomeno
desidero essere istruito, mentre è mio desiderio intrattenere e interessare le molte persone che, come
me, non sanno niente di scienza ma si divertono a fantasticare e riflettere (non troppo
profondamente) sui vari fenomeni che li circondano.
25 Il fisiologo tedesco Karl Ewald Konstantin Hering (1834 - 1918) studiò in particolar modo la
percezione dello spazio e la teoria dei colori. Nel saggio Teoria della sensibilità alla luce prende le distanze
da qualsiasi interpretazione di tipo esclusivamente fisico della visione.
L’ipotesi formulata da Hering e Butler, secondo cui anche la cultura umana può essere in qualche
modo trasmessa alla prole, sul piano strettamente biologico sembrò superata dalla scoperta di August
Weissmann (1834-1914) che nel 1883 osserva come, a partire dal cinquantanovesimo giorno di
gestazione, la linea germinativa dell’embrione si separa dalla linea somatica.
In realtà la teoria verrà ripresa agli inizi del Novecento dal neurologo Richard Semon (1859-
1918), allievo di Ernst Haeckel, che in Die Mneme (1904) introdurrà appunto il concetto di Mneme:
ciascun evento agisce sul cervello lasciando una traccia, l’engramma; la materia vivente ha la capacità di
memorizzare le esperienze, di richiamarle e infine di trasmetterle per via biologica. È un concetto che
dovrebbe spiegare le caratteristiche della vita, cioè l’ereditarietà biologica, lo sviluppo embrionale e
l’apprendimento, attraverso un meccanismo di tipo lamarckiano che permetterebbe l’istaurarsi di una
sorta di memoria sociale.
Scienziati di diversa formazione, come lo psicologo della Gestalt Kurt Koffka (1886-1941), il
filosofo e matematico Bertrand Russell (1872-1970), il fisico Erwin Schrödinger, (1887- 1961), il
neuroanatomico John Zachary Young (1907- 1997) apprezzeranno molto questo tentativo e ne saranno
in qualche modo influenzati. Certe sollecitazioni culturali a volte vengono riprese e sfruttate in campi
“altri”: lo storico dell’arte tedesco Aby Warburg -che, per inciso, aveva molto apprezzato L’espressione
delle emozioni di Darwin- tiene conto del saggio sulla Mneme di Semon, e delle teorie di Hering sulla
capacità della materia vivente di memorizzare l’esperienza, per formulare la sua personale idea degli
engrammi dell’esperienza emotiva e del patrimonio ereditario della memoria. Basandosi sulla teoria della
memoria sociale, che trovò confermata dalle analisi compiute sulle forme artistiche del rinascimento
italiano e nordico, Warburg arrivò a concepire la stessa storia della cultura occidentale come uno
straordinario viaggio attraverso un dedalo di immagini e simboli. Nel 1926 progettò un repertorio di
immagini (Atlante Mnemosyne), una sorta di atlante fotografico che avrebbe dovuto testimoniare il
percorso compiuto attraverso i secoli dagli uomini del bacino del Mediterraneo. Il progetto risentì anche
dell’influenza del Darwin dell’Espressione.
Fu infatti in questo testo che lo scienziato inglese riconobbe per primo l’importanza del
documento fotografico come eccellente strumento di studio, in quanto copia fedele e, a differenza del
disegno, non soggetta ad interpretazione. I simboli-engrammi di Warburg divengono formule del pathos,
espressioni di un sentimento o di un’attitudine spirituale che, in quanto riconducibili all’arcaica
emotività del mito, derivano, più o meno consapevolmente, dall’antico. Comunque, il dibattito natura-
cultura (nature versus nurture) circa l’importanza relativa delle caratteristiche innate dell’organismo
(“nature”) rispetto all’esperienza maturata durante la vita (“nurture”) accompagnerà tutto il
Novecento, e in sostanza non è ancora spento.
Butler e Hering erano stati influenzati anche dalla formulazione della teoria cellulare, che aveva
fatto pensare che il protoplasma, considerato la base fisica dei viventi, racchiudesse in sé una sorta di
spirito vitale in grado di spiegare -anche se in modo tautologico- la vita.
Già nel 1868 Huxley, proprio grazie a questa convinzione, era caduto in un errore grossolano;
esaminando un vecchio campione di fango prelevato durante una spedizione oceanografica atlantica del
1858 e successivamente conservato in alcol, aveva descritto una materia trasparente gelatinosa che a suo
parere era una massa di protoplasma e pertanto una possibile dimostrazione della nascita della vita a
partire da materiale inorganico. Lo pseudo-organismo era stato chiamato Bathybius haeckelii, in onore a
Haeckel. Dopo quindici anni, fu appurato che il Bathybius non era un nuovo materiale pre-biologico, ma
semplice solfato di calcio allo stato amorfo.
Darwin è accusato di plagio Butler, ferito dall’assoluta mancanza di reazioni alle sue opere, meditò di prendersi una rivincita;
passò in rassegna tutta la bibliografia evoluzionista del passato e pubblicò Evolution, old and new; or the
theories of Buffon, Dr Erasmus Darwin, and Lamarck, as compared with that of Charles Darwin (1879).
Il poderoso saggio prende in esame il concetto di teleologia a partire da William Paley ed esamina
le concezioni di Buffon, Étienne Geoffroy, Erasmus Darwin, Lamarck, Chambers, Mivart; il volume si
chiude con l’esame dell’Origine, considerata irrilevante rispetto alle opere dei predecessori e la cui teoria
della selezione naturale viene considerata falsa; il saggio lancia inoltre un’accusa infamante per
qualunque scienziato, quella di aver sminuito i meriti dei predecessori, pur essendosi appropriato del loro
lavoro. Effettivamente Darwin non era stato generoso nel riconoscere il valore di quanti lo avevano
preceduto; nella prima stesura dell’Origine non era presente alcun compendio storico, che compare solo a
partire dalla seconda edizione ed è comunque piuttosto scarno e affrettato. È indubbio che Darwin
attribuisse grande valore all’originalità e priorità del suo pensiero - un’umana debolezza in uno scienziato
che al perfezionamento della teoria aveva dedicato la vita - ma è anche vero che non voleva essere
confuso, a ragione, con pensatori che avevano condotto soprattutto speculazioni teoriche senza
apportare significative evidenze sperimentali. Lo scienziato aveva letto i libri del nonno Erasmus, li
aveva studiati a fondo, ma era pervenuto alla conclusione che le prove da lui portate fossero risibili. La
tesi da lui sostenuta era soltanto un’anticipazione del pensiero di Lamarck, che Charles Lyell aveva già
confutato; quanto all’autore di Vestiges, era stato abbondantemente messo in ridicolo da molti scienziati.
La famiglia Darwin fu amareggiata da quest’accusa, ma ancora una volta scelse il silenzio. Seguì una
polemica infinita a proposito del testo di una biografia su Erasmus Darwin, per cui i rapporti fra i due si
chiusero definitivamente. Ancora oggi la tesi di Butler e le sue accuse di plagio piacciono molto ai
creazionisti, che ne hanno riempito pagine e pagine dei loro siti internet.
La lotta per l’esistenza, espressione della borghesia vittoriana L’Origine attrasse anche
l’attenzione di Engels e Marx, che ne furono profondamente colpiti. Circa venti giorni dopo la sua
pubblicazione, Engels scrisse a Marx con toni entusiastici:
Il Darwin che sto leggendo è proprio stupendo. Per un certo aspetto la teleologia non era stata
ancora sgominata, e lo si è fatto ora. E poi non è stato ancora mai fatto un tentativo così
grandioso per dimostrare uno sviluppo storico nella natura, o almeno non così felicemente.
Naturalmente bisogna passar sopra al goffo metodo inglese
Engels a Marx, 11 o 12 dicembre 1859.
Marx rispose all’amico in modo altrettanto favorevole nei confronti di Darwin:
Per quanto svolto grossolanamente all’inglese, ecco qui il libro che contiene i fondamenti
storiconaturali del nostro modo di vedere
Marx a Engels, 19 dicembre 1860
e inviò un messaggio dello stesso tenore al socialista tedesco Fernard Lassalle:
Il libro di Darwin è molto importante e mi è utile come base scientifica per la lotta di classe nella
storia
Sia Marx che Engels, nonostante le critiche rivolte al “goffo metodo inglese” di filosofare, erano
entusiasti del “colpo mortale” inferto da Darwin alla teleologia, e convinti che vi fossero analogie fra la
lotta di classe e la lotta per l’esistenza; non sfuggiva loro il riferimento alle tesi di Malthus, tanto che
Engels, nell’introduzione alla Dialettica della natura, scrisse:
non sapeva quale amara satira scrivesse sugli uomini, e in particolare sui suoi compatrioti,
quando dimostrava che la libera concorrenza, la lotta per l’esistenza, che gli economisti esaltano
come il più alto prodotto storico, sono lo stato normale del regno animale; solo un’organizzazione
cosciente della produzione nella quale si produce e si ripartisce secondo un piano, può sollevare gli
uomini sopra il restante mondo animale sotto l’aspetto sociale di tanto, quanto la produzione in
generale lo ha fatto per l’uomo come specie (...).
Engels, come Marx, era convinto che la stesura dell’Origine fosse stata in qualche modo
influenzata dall’organizzazione borghese della società inglese, il che è certamente vero. Darwin è stato un
figlio del suo tempo; ha però sempre evitato di entrare in settori diversi dalla biologia, come l’etica,
l’economia, la sociologia; tuttavia, fin da subito, pensatori di destra e di sinistra, laici e credenti, hanno
cercato di piegare il suo pensiero all’una o all’altra ideologia.
Marx inviò una copia del Capitale allo scienziato, che ne sfogliò solo alcune pagine e ringraziò con
una lettera cortese e vaga in cui affermava che, sebbene i loro studi fossero diversi, avrebbero entrambi
contribuito ad accrescere la conoscenza dell’umanità. Edward Aveling, compagno della figlia di Marx,
nel 1881 conobbe Darwin, e gli chiese in seguito di potergli dedicare un suo scritto sulle convinzioni
religiose; Darwin declinò l’offerta, affermando fra l’altro:
Mi pare (a torto o a ragione) che le argomentazioni dirette contro la cristianità e il teismo non
producano sul pubblico quasi effetto alcuno e che la libertà di pensiero sia promossa nel modo
migliore dalla graduale illuminazione delle menti umane che fa seguito al progresso della scienza.
Ricezione dell’Origine all’estero
Germania In terra tedesca il darwinismo si diffuse rapidamente, grazie alla traduzione dell’Origine fatta dal
paleontologo Heinrich Georg Bronn (1800-1862), pochi mesi dopo la pubblicazione nel Regno Unito
(1860). La versione di Bronn è “disinvolta”; ricca di note e commenti, presenta un capitolo finale in cui,
in ventisei pagine, il traduttore espone la sua opinione sull’argomento. Come avverrà ancora più
vistosamente in Francia, per Bronn l’evoluzione testimonia uno sviluppo progressivo verso la perfezione;
così, favored fu tradotto con vervollkommnet (perfezionato), struggle for existence con Kampf ums
Dasein, (battaglia per la vita).
Ernst Haeckel (1834-1919), il maggior esponente della zoologia in terra tedesca, lesse
probabilmente l’Origine nella traduzione di Bronn quando si trovava a Iena, dove si era trasferito dopo
essersi laureato in medicina a Berlino, per conseguire il dottorato in zoologia; qui, nel 1862, divenne
professore di anatomia comparata, incarico che mantenne fino alla morte. Lavoratore instancabile, si
occupò di radiolari, poriferi, molluschi, anellidi, da lui classificati e descritti in stupende tavole a colori,
pubblicate nel 1904 col titolo Forme artistiche della natura. S’interessò anche di antropologia, psicologia e
cosmologia, con un atteggiamento più speculativo che sperimentale. Dedicò il suo libro Generelle
Morphologie (1866) al suo insegnante Carl Gegenbaur, a Johann Wolfgang von Goethe, a Jean- Baptiste
de Lamarck e a Darwin; questi ringraziò e si congratulò con l’autore, che lo stesso anno gli fece visita a
Down House.
Ottimo divulgatore, i suoi saggi Il monismo come legame tra religione e scienza (1893) e I problemi
dell’Universo (1899) furono venduti in oltre 400.000 copie e tradotti in 30 lingue. Haeckel propone un
modello evolutivo in cui la teoria del suo mentore è rivisitata e corretta; la vita si è sviluppata secondo
precise linee di progressiva perfezione, grazie all’intervento diretto dell’ambiente che provoca
trasformazioni ereditarie, mentre i processi di selezione hanno un’importanza trascurabile. Amante di
frasi a effetto, coniò numerosi nuovi termini -tanto che Darwin lo pregò di stilare un glossario, in modo
che i suoi testi potessero essere letti più agevolmente- e formulò, fra l’altro, la legge di ricapitolazione,
secondo la quale l’ontogenesi, lo sviluppo embrionale, rappresenta in qualche modo un filmato super
accelerato delle trasformazioni evolutive subite dagli organismi; immagine di grande effetto, che però
aveva ed ha solo labili riscontri sperimentali.
Questa legge esercitò comunque un grande fascino ed ebbe anche un elevato valore euristico,
giacché contribuì alla nascita e allo sviluppo dell’embriologia comparata, anche se già nel momento della
sua formulazione ne fu contestata la validità. Il pensiero dello scienziato tedesco presenta forti
componenti ideologiche ed è affine al darwinismo sociale di Spencer.
Negli ultimi anni della sua vita, Haeckel fondò la Lega monista tedesca, basata su una visione
olista dell’ecologismo, combinata con un atteggiamento sociale con forti componenti nazionaliste. Fu un
fervente sostenitore della teoria poligenista sull’origine delle razze umane, si oppose alla mescolanza
razziale e vide nel popolo tedesco una razza eletta, divenendo un entusiastico sostenitore di programmi di
eugenetica. Fu quindi fra quanti prepararono il terreno al Nazionalsocialismo. Nel saggio Storia della
creazione definì i negri (...) incapaci di una vera cultura e di uno sviluppo mentale superiore(...).
Un’altra delle sue frasi a effetto: La politica non è altro che biologia applicata, divenne
sinistramente famosa perché ripresa più volte a giustificazione del razzismo, del darwinismo sociale, del
nazionalismo più spinto.
Francia La Francia conobbe l’Origine nel 1862 grazie alla traduzione di Clémence-Auguste Royer (1830-
1902); questa, che aveva una formazione autodidatta, conosceva però bene le opere di Lamarck e ne
condivideva le idee evolutive; aveva anche letto e apprezzato Malthus.
Probabilmente la scelta fu dettata dal fatto che aveva accettato l’incarico, mentre altri lo
avevano rifiutato. Il saggio è preceduto da una lunghissima prefazione della traduttrice (60 pagine), che
non si fa scrupolo di esprimere le sue idee personali: entra nel merito delle credenze religiose per
dimostrarne l’inconsistenza e discute l’applicazione della selezione naturale alla specie umana,
dichiarando che, se si applicasse coerentemente questa idea all’uomo, si dovrebbe evitare qualunque
forma di assistenza sociale per favorire la lotta per l’esistenza, come aveva sostenuto Malthus.
L’evoluzione, inoltre, ha per la traduttrice una connotazione di progresso, simile a quella presente
nell’opera di Lamarck.
La Royer, abbracciando con entusiasmo idee eugenetiche, sposta le argomentazioni
squisitamente scientifiche di Darwin sul piano sociale ed economico. Il saggio è infarcito di note
“esplicative”, tanto che Darwin, circa due mesi dopo aver ricevuto la traduzione, scrisse a Joseph
Hooker:
quasi dovunque, nell’Origine, quando io esprimo forti dubbi, lei (la Royer) mette una nota con cui
spiega la difficoltà o afferma che in realtà questa non esiste. È davvero curioso sapere quante
persone presuntuose ci sono al mondo!
Nonostante le proteste di Darwin, anche le successive traduzioni dell’Origine furono affidate alla
Royer, la quale nel 1880 giunse ad affermare:
La teoria della trasformazione dei viventi ha preso il nome di darwinismo (...) ma esisteva già
pressoché completa: Lamarck e Geoffroy Saint- Hilaire ne avevano elaborato tutti gli elementi
necessari (...) la teoria di Lamarck è sostanzialmente identica a quella di Darwin (...).
L’Origine della specie non contiene niente di originale; più che una nuova teoria, è una
confutazione serrata, pressante di tutte le obiezioni rivolte alla teoria di Lamarck.
Così, sia in Francia sia in Germania, il Darwinismo andava identificandosi con il social-
darwinismo, e il modello evolutivo acquistava marcate connotazioni lamarckiane; fu forse questo uno dei
motivi per cui l’Origine fu poco apprezzata in Francia, tanto che eminenti scienziati, come Claude
Bernard e Louis Pasteur, la ignorarono completamente nei loro lavori.
Italia In Italia la traduzione dell’Origine fu pubblicata nel 1864 a cura del naturalista Giovanni
Canestrini (1835-1900), che poi tradusse, insieme con altri, tutte le opere di Darwin. Scienziato dagli
interessi multiformi -è suo un manuale di Apicoltura che ebbe svariate ristampe- si interessò molto
all’antropologia, pubblicando anche, nel 1866, L’Origine dell’uomo, opera che precorre il lavoro di
Darwin e che lo scienziato citò esplicitamente
Bibliografia ragionata
Saggi
G. Barsanti Una lunga pazienza cieca. Storia dell’evoluzionismo Einaudi, Torino, 2005 Barsanti ripercorre la storia dello sviluppo delle idee evolutive -che poi è la storia stessa della
nascita della biologia come scienza- documentando come il termine evoluzione abbia assunto di volta in
volta significati assai diversi: cambiamento, sviluppo, trasformazione, metamorfosi, diversificazione,
complicazione, perfezionamento (ma anche degenerazione o progresso).
Riprendono vita i padri dello studio della natura, con personaggi proto evoluzionisti che hanno
utilizzato idee antievoluzionistiche ed antievoluzionisti che hanno usato idee evoluzionistiche, per
contrastarle. L’autore riesamina criticamente il concetto di progresso, facendo parlare le opere dei
protagonisti. Naturalmente non dimentica la figura di Lamarck, la cui ereditarietà dei caratteri acquisiti
è stata così tanto fraintesa. Sottolinea inoltre come l’Origine delle specie segni la definitiva messa al
bando di qualsiasi spiegazione di stampo teleologico e al contempo abbia aperto la strada ai successivi
studi. Il titolo richiama un brano del critico e scrittore francese Augustin de Saint-Beuve che, a proposito
di Lamarck, afferma:
La sua concezione della natura aveva tanta semplicità, nudità e tanta tristezza. Edificava il
mondo col meno possibile di elementi e di crisi e col massimo di durata. Secondo lui le cose si
andavano facendo da sé, da sole, per continuità, mediante tratti di tempo sufficienti (...) Una
lunga pazienza cieca, questo era il suo Genio dell’Universo.
J. Browne Darwin. L’origine della specie, una biografia Newton Compton, 2007 La Browne (1950) è una delle maggiori esperte della storia della biologia del diciannovesimo
secolo. Ha lavorato come editore associato al progetto dell’Università di Cambridge per raccogliere e
pubblicare l’intera corrispondenza di Darwin e ha scritto una biografia in due volumi sul naturalista:
Charles Darwin: Voyaging (1995) e Charles Darwin: The Power of Place (2002). Questo agile volumetto
descrive la genesi della teoria, racconta come fu inizialmente accolta e mette in luce i motivi che la
rendono ancora oggi così controversa.
P. Casini Darwin e la disputa sulla creazione Il Mulino, 2009 Paolo Casini, già professore di storia della filosofia presso l’Università La Sapienza di Roma,
traccia la storia della interminabile controversia, apertasi sin dal momento della pubblicazione
dell’Origine, sia da parte del clero che da parte di numerosi naturalisti che criticarono le prove portate
dallo scienziato a sostegno della sua teoria. Particolare interesse riveste l’ultimo capitolo, che mette in
luce come le tesi dei creazionisti e quelle dell’Intelligent Design ricalchino, spesso pedissequamente, le
vecchie obiezioni.
Il presente articolo ha utilizzato i seguenti lavori di Charles Darwin:
C. Darwin
Taccuini (1836-1844), a cura di Telmo Pievani, Laterza, 2008
Autobiografia Einaudi, 2006
Lettere Raffaello Cortina, 1999
L’origine dell’uomo e la scelta sessuale Rizzoli, 1982
L’origine della specie (sesta ed.) Boringhieri, 1966
L’origine della specie (prima ed.) BUR, 2009
È tuttavia importante segnalare che moltissime opere del naturalista inglese possono essere
scaricate, tradotte in italiano, dal sito http://www.liberliber.it/biblioteca/d/darwin/index.htm.
Se comunque si preferisce il cartaceo e si vuol leggere l’opera più importante di Darwin, vale a
dire L’Origine, è consigliabile consultare la prima edizione, che è quella che ancora non risente dei
cambiamenti che Darwin apporterà all’opera dopo tutte le critiche che gli erano
piovute addosso.
Per quanto riguarda le opere più recentemente disponibili in traduzione italiana, si segnalano:
C. Darwin Taccuini, a cura di Sandra Herbert, Davide Kohn, Telmo Pievani, Laterza, Bari, 2008 Finalmente, parte dei taccuini di Darwin compaiono anche in edizione italiana. Si tratta della
trascrizione e traduzione dei 3 taccuini (Rosso, B, E) in cui Darwin stilò i suoi appunti. La loro lettura
consente di comprendere l’evoluzione del pensiero del naturalista inglese.
Il taccuino Rosso è pieno di appunti sulle trasformazioni geologiche subite dalle terre da lui
visitate durante il suo viaggio a bordo del Beagle; osservazioni e teorizzazioni che andranno a costituire
la cornice indispensabile alla teoria dell’evoluzione, idea già presente in molti passi del taccuino Rosso,
da cui emerge un Darwin originariamente saltazionista e non gradualista come apparirà nel suo pensiero
maturo. Nel taccuino B appaiono per la prima volta vari schizzi dell’albero della vita, pensieri
riguardanti il nesso fra isolamento geografico e trasmutazione, l’idea che sia privo di senso parlare di
organismi superiori e inferiori. Nel taccuino C lo scienziato concentra la sua attenzione sul problema
dell’eredità dei caratteri e su come questa incida sulla trasformazione dei viventi. Dalla lettura dei
taccuini si evince che già alla fine degli anni Trenta, la teoria dell’evoluzione è ormai completamente
formulata. Opera molto ricca, che ci fa conoscere un Darwin privato e inconsueto.
C. Darwin Autobiografia (1809-1882) a cura di N. Barlow, Einaudi, Torino, 2006 Si tratta di una gradevolissima lettura del Darwin privato, a cui l’articolo ha fatto riferimento
più volte.
Lo scienziato iniziò a stilare questo scritto per lasciare un qualcosa di sé ai propri discendenti e,
partendo dai ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza, dalle memorie del college, di Edimburgo, di
Cambridge, parla delle persone che più lo hanno influenzato, per poi affrontare gli affetti a lui più cari: la
moglie Emma e i figli.
Interessante la parte in cui affronta il suo modo di far scienza, la sua attenzione per i dettagli,
l’empatia e la gentilezza nei confronti degli animali oggetto dei suoi studi. Nora Barlow, con cura e
attenzione, nel 1954 ha curato questa edizione che è completa, senza i tagli voluti dai familiari nella
precedente edizione curata dal figlio Francis. Interessante anche l’appendice, in cui viene presentato il
carteggio fra Samuel Butler e la famiglia Darwin, a proposito di un increscioso fraintendimento.
A. Desmond, J. Moore Vita di Charles Darwin, Boringhieri, 1992 (prima ed. italiana) Poderosa opera di 927 pagine in cui gli autori delineano la vita personale e pubblica di Darwin,
mettendo in particolare in risalto le relazioni fra il lavoro dello scienziato inglese e il contesto economico e
politico in cui presero forma e maturarono. Gli autori seguono le tappe di Darwin, la sua infanzia, il
viaggio che cambiò la sua vita, il matrimonio, la misteriosa malattia che lo accompagnò a partire dal suo
ritorno in patria, le tragedie personali. Si ripercorre la sua formazione scientifica e le tappe che lo
portarono a divenire inizialmente uno stimato geologo, poi un naturalista affermato nel campo dello
studio dei cirripedi ed infine, dopo tanti rinvii e ripensamenti, il padre dell’evoluzionismo. Molto
accurato e ricco di spunti interessanti, si presta anche a una lettura decontestualizzata.
F. Focher L’uomo che gettò nel panico Darwin Boringhieri, 2006 Focher (1957), che lavora presso l’istituto di Genetica molecolare del CNR di Pavia, ci presenta
un personaggio troppo spesso dimenticato e/o sottovalutato, Alfred Russel Wallace (1823-1913), il cui
manoscritto sul processo di speciazione, gettò appunto Darwin nel panico. La figura di questo grande
viaggiatore viene tratteggiata a tutto campo, seguendo le tappe più significative della sua vita; malgrado
un’infanzia e un’adolescenza non facili, il fortunato incontro con Bates diede una svolta significativa alla
sua vita, facendo maturare i suoi interessi per la storia naturale e rendendo possibile il suo sogno di
visitare terre lontane. Wallace è stato un geniale autodidatta, con interessi molteplici in entomologia,
antropologia, geologia, mimetismo, biogeografia evolutiva, politica. Numerosi brani tratti dalle sue opere
sono inseriti in una cornice critica; si possono così conoscere le sue avventure
risalendo il Rio Negro, i suoi interessi etologici, il saggio in cui formula la legge di Sarawak; la sua
attenzione ai caratteri antropologici degli abitanti dei luoghi esotici da lui visitati e molti altri
significativi passi tratti dall’autobiografia e dagli scritti sociali.
S. J. Gould I have landed Codice, Torino, 2009 Certamente, varrebbe la pena di continuare a leggere tutti i libri del grande paleontologo
prematuramente scomparso, che tanto ha contribuito alla divulgazione del pensiero evoluzionista nel
mondo. Nel presente articolo si è fatto riferimento alle seguenti raccolte:
La struttura della teoria dell’evoluzione, Codice, 2003
Otto piccoli porcellini, Il Saggiatore, 2003
Bravo Brontosauro, riflessioni di storia naturale Feltrinelli, 2006
Questa idea della vita, Editori Riuniti, 1984
In questa sua ultima fatica Gould rievoca il nonno materno, Papa Joe, sbarcato dall’Ungheria a
Ellis Island l’11 settembre del 1901; nel 2001 tutta la famiglia avrebbe voluto recarsi al “Golden Gate”,
lo stretto che unisce la baia di San Francisco con l’Oceano Pacifico, per ricordare quest’uomo comune che
col suo duro lavoro e i valori positivi caratteristici di tanti immigrati, ha contribuito a rendere grande e
multietnica l’America e a realizzare il motto e pluribus unum. Per uno strano gioco del caso, quel giorno è
stato invece un giorno di morte, ma “Il rivoletto di una famiglia iniziata l’11 settembre 1901,
moltiplicato per molti milioni di storie simili e comuni sommergerà la malvagità di pochi, messa in atto
l’11 settembre 2001". Questo è l’ultimo messaggio lasciatoci da Gould. Negli altri saggi affronta svariati
temi: valorizza il lavoro di entomologo dello scrittore Nabokov; rievoca la battaglia di Alamo e i suoi
eroi; ricostruisce il lavoro di Humboldt; ci parla di un libro pubblicato nel 1860 da una misconosciuta
naturalista vittoriana, Isabelle Duncan, in cui per la prima volta compare una tavola raffigurante
l’evoluzione della vita sulla Terra; rammenta la figura di Freud; ricostruisce e spiega le figure
rappresentanti la Genesi presenti nel duomo di Venezia; riprende il tema della forte presenza di
movimenti creazionisti in USA.
R. Keynes Casa Darwin, Il male, il bene e l’evoluzione dell’uomo Einaudi, Torino, 2006 Peccato che la casa editrice abbia cambiato il titolo originale Annie’s Box, Darwin, His Daughter,
and Human Evolution, aggiungendo, forse nella speranza di rendere il volume più appetibile il male, il
bene. Keynes ci racconta la vita privata dei Darwin e apre il suo racconto con l’accurata descrizione di un
completo da scrittura della più grande delle figlie di Charles, Annie, che la madre aveva conservato in
ricordo della primogenita morta all’età di soli dieci anni. L’oggetto è stato ritrovato dall’Autore, il cui
bisnonno, George Howard Darwin (1845-1912), era il quinto figlio di Emma e Charles. Il fortuito
ritrovamento ha condotto Keynes a ricercare altro materiale inedito del trisavolo fra i documenti e gli
oggetti sparsi nelle case dei numerosi cugini. Questo ricco materiale ha permesso un’accurata
ricostruzione della vita dei Darwin-Wedgwood, che mette in luce gli stretti legami fra il pensiero dello
scienziato inglese e le sue vicende personali e avanza l’ipotesi inedita che non tanto il viaggio influenzò il
pensatore inglese, quanto le osservazioni naturalistiche condotte nel suo vasto giardino e nelle campagne
circostanti. Ne scaturisce un affresco della vita quotidiana della borghesia vittoriana: a Down House, nel
Kent, a soli 20 km dalla capitale -un viaggio di quattro ore a quei tempi- la famiglia si era trasferita nel
1842 dopo che per i primi 4 anni aveva vissuto nella fumosa e caotica Londra. Qui Darwin poteva fare le
sue passeggiate lungo il suo percorso preferito, il Sand walk, in solitudine o con gli amati figli. Nella casa,
resa accogliente grazie alle numerose migliorie apportate e all’attenzione vigile della moglie, Charles
riceveva i pochi fidati amici o gli ammiratori che, numerosi, venivano in pellegrinaggio a omaggiare il
grande vecchio. Keynes ci descrive le brevi vacanze, i pochi viaggi, i grandi avvenimenti del periodo
come l’esposizione universale di Londra. La parte centrale del saggio è dedicata alla lunga agonia e
successiva morte di Annie, che il padre, combattuto fra la speranza e il timore, descrisse nei suoi rapporti
quotidiani alla moglie lontana. La bambina morì nel 1851 a Malvern, città termale in cui la piccola era
stata portata per seguire la cura idroterapica del dottor Gully, che curava lo stesso Charles. La diagnosi
fu di una non meglio identificata “febbre tifoide” -in realtà si trattò di tubercolosi, i cui sintomi vengono
minuziosamente descritti- una malattia che a quel tempo era diagnosticata con difficoltà e di cui, prima
delle scoperte di Pasteur e di Kock, non si sapeva niente. Infatti, le malattie infettive continuarono
ancora per molti anni a mietere vittime fra i fanciulli, la cui mortalità rimaneva alta in Europa. Alcune
pagine si possono prestare molto bene per uno studio pluridisciplinare sulla vita della società vittoriana e
sulle conoscenze scientifiche del periodo.
A. La Vergata Colpa di Darwin? Razzismo, eugenetica, guerra e altri mali UTET, Torino, 2009
I saggi di La Vergata (1954) sono di estremo interesse per chi si occupa di biologia e in particolare
delle teorie evolutive. La sua raccolta antologica, L’evoluzione biologica da Linneo a Darwin, 1735-1871,
Loescher, Torino, 1979, fu un testo -purtroppo non più ristampato- che permise a molti insegnanti di
scienze naturali di affrontare gli argomenti curricolari in modo completamente nuovo, in quanto permise
loro di comprendere il valore euristico di un’introduzione storica per l’approccio a qualunque argomento.
Il presente volume affronta in modo chiaro e articolato le responsabilità che sono state attribuite
all’autore dell’Origine, analizzandole punto per punto e inquadrando storicamente il problema: avrebbe
giustificato l’egoismo, la sopraffazione, il razzismo, la guerra, l’imperialismo, il colonialismo, il nazismo.
Addirittura c’è qualcuno che gli ha anche attribuito la responsabilità dell’attacco dell’11 settembre.
Tutti questi mali da cui è sopraffatta l’umanità, tuttavia, non avevano bisogno di Darwin per
manifestarsi, anche se hanno trovato nel naturalista inglese uno scudo di cui si sono ampiamente serviti.
Sul sito web della SPI è presente un interessante intervento dell’autore:
http://www.spiweb.it/IT/index.php? option=com_content&task=view&id=395&Itemid=152
N. Nosengo, D. Cipolloni Compagno Darwin Sironi, 2009 In tutto il modo l’evoluzionismo è da sempre il terreno di scontro privilegiato sia sul piano
politico che su quello religioso. Il volume ricostruisce la recezione del pensiero di Darwin sin dalla
pubblicazione dell’Origine; si apre con una citazione da Giorgio Gaber: “Un pacchetto di Malboro è di
destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra.” Il pensiero dello scienziato
inglese, a differenza di quello di molti altri studiosi, ha profonde implicazioni nei più svariati campi,
scientifico, etico, culturale, economico; per questo motivo, esso viene “tirato in ballo” dai laici, dai
cattolici, addirittura dagli islamici; il caso dei creazionisti e quello della teoria del disegno intelligente
negli Stati Uniti sono emblematici. Del resto, molti hanno letto anche il giorno di sangue dell’11
settembre come una conseguenza nefasta della teoria dell’evoluzione. Gli autori prendono anche in esame
la situazione in Italia: essi ricordano -fra l’altro- le vicissitudini della teoria evolutiva per quanto
riguarda il suo insegnamento nella scuola, dove prima è stata depennata, poi dinuovo reintrodotta,
infine tolta di nuovo.
Quammen David, L’evoluzionista riluttante. Il ritratto privato di Charles Darwin e la nascita della teoria dell’evoluzione, Codice, Torino, 2008
Già alla fine degli anni Trenta dell’Ottocento Darwin aveva chiara in mente la sua teoria, la cui
formulazione venne resa pubblica solo nel 1859; quali sono i motivi di tanto ritardo? Quemmen parte
dall’esame dei rapporti fra Darwin e i precedenti pensatori, in particolare il nonno Erasmo e Lamarck
che, secondo Darwin, avevano formulato una teoria nebulosa e soprattutto senza portare dati osservativi
solidi e convincenti; lo scienziato non poteva convincersi dell’esistenza di un inafferrabile “principio
vitale” che sospingeva gli organismi ad evolversi migliorando; aveva da tempo rinunciato all’idea della
scala e il suo modello evolutivo prevedeva un albero che si ramifica copiosamente e i cui rami hanno tutti
pari dignità. Nel 1842 Darwin scrisse un abbozzo di 35 pagine che poi ampliò nel 1844 ed inviò a Joseph
Dalton Hooker nel 1845. Nel frattempo uscì Vestiges e Darwin, secondo Quammen, temette di essere
confuso con quest’opera, piena di inesattezze e complessivamente a suo dire “penosa”. Lo scienziato
aveva bisogno di accumulare dati, di dimostrare a se stesso e agli altri che la sua teoria si basava su fatti,
di essere un esperto in classificazione; fu questo uno dei motivi per cui dedicò tanto tempo allo studio dei
cirripedi, trovando in questi animali dall’apparenza insignificante ulteriori conferme della sua idea e si
dedicò ad ampliare le sue conoscenze sugli animali da allevamento, in particolare i colombi. Solo l’arrivo
della lettera di Wallace convinse Darwin a non dilazionare più.
Siti internet http://en.wikipedia.org/wiki/ Molti dei personaggi e dei fatti citati sono ampiamente
descritti nel sito di wikipedia in inglese.
http://darwin-online.org.uk/ Tutta l’opera del naturalista inglese, sia pubblicata che
inedita, compresi le lettere (a queste è stato fatto riferimento per il presente articolo) e i taccuini,
ma anche una bibliografia internazionale, traduzioni, manoscritti pubblicati, i diari di Emma Darwin, le
recensioni delle opere.
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page Il sito è un’infinita biblioteca che presenta in ordine
alfabetico un’enorme quantità di opere, scritte prevalentemente in
inglese, ordinate alfabeticamente. Si può così scaricare Flatland:a romance of many dimensions di
Abbott, il Discorso sul metodo di Cartesio, in inglese e francese, le opere complete di C. Darwin, On the
genesis of species di Mivart, molte opere di Richard Butler e molto altro ancora.
http://www.victorianweb.org/ Tutto – o quasi- sull’epoca vittoriana.
http://www.anisn.it/matita_ipertesti/evoluzione2009/ Ipertesto sull’evoluzione.
http://www.hevelius.it/webzine/leggi.php?codice=37 Un self opinioned e l’origine della specie
(articolo su Butler di B. Danesi) da cui sono stati tratti alcuni brani.
(1) S. J. Gould 1984, pg 25-29