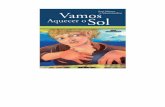Achilleos soma. Una nota iconografica
-
Upload
mondodomani -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Achilleos soma. Una nota iconografica
© Roma 2006, Edizioni Quasar di Severino Tognon srl, via Ajaccio 43, I-00198 Roma; tel. 0684241993, fax 0685833591, email [email protected]
ISSN 1129-5953
Direttore responsabile: Luigi Enrico Rossi
Registrazione Tribunale di Roma n. 146/2000 del 24 marzo 2000
Finito di stampare nel mese di settembre 2006 presso la Arti grafiche La Moderna, via di Tor Cervara 171 - Roma
Questa pubblicazione è stampata con i contributi del Dipartimento di Filologia greca e latina dell’Università di Roma «La Sapienza» e del Di par ti men to di Antichità e tradizione classica dell’Università di Roma «Tor Vergata»
estratto
1 Sull’edificio: Michel-Struck 1906; Chatzidakis, figg. 36-51. Sulle sculture: Steiner 1906; Mango 1963, p. 63 s.; Grabar 1976, pp. 96-99, nr. 81, tavv. LXV-LXX; Maguire 1998.
2 Steiner 1906, pp. 329-331, nr. 6, fig. 2.3 Breve commento in Friederichs-Wolters 1885, p. 180, nr. 439; Zagdoun 1989, pp. 187, 229, nr.
74, tav. 59, fig. 213.4 Friederichs-Wolters 1885, p. 180, nr. 439: «Eine nähere Erklärung zu geben, ist wegen der gros-
sen Verstümmelung des Reliefs unmöglich»; Steiner 1906, p. 330: «Ob uns hier eine bestimmte, mit Namen zu belegende Scene aus Mythologie oder Geschichte vorliegt – wer vermag das zu sa-gen! Es ist wohl nichts weiter, als ein sprechendes Motiv aus einem der Schlachtenbilder, die dem Künstler zur Nachahmung vor Augen standen». Zagdoun 1989, p. 187, dà una descrizione errata della scena, nella quale riconosce un guerriero che si lancia all’inseguimento del suo avversario.
La chiesa della Panagia Gorgoepikoos (c. d. Piccola Metropolis) ad Atene, costruita presumibilmente intorno al 1200, costituisce un caso isolato di reim-piego su vasta scala di sculture di varie epoche in un contesto architettonico bizantino1. Nelle pareti esterne dell’edificio sono infatti murati numerosi ri-lievi, eterogenei per soggetti, cronologia e stile, la cui organizzazione sembra rispondere a un certo desiderio di ordine e simmetria, pur non essendo enu-cleabile un programma iconografico coerente, sicché esemplari greci di età classica si affiancano a pezzi romani, paleocristiani e bizantini.
Fra i materiali antichi si segnala un rilievo (fig. 1), incorporato entro i muri dell’abside, che al di là dell’edizione dello Steiner2, di taglio eminentemente descrittivo, è stato sostanziamente negletto dalla critica3 e che merita invece una rinnovata attenzione soprattutto in rapporto alla singolarità delle scelte icono-grafiche operate, dalle quali, come vedremo, si possono trarre indicazioni utili a decodificare il contenuto della raffigurazione, che sinora è apparso oscuro4. La lastra (alt. m. 0. 52, largh. m. 0. 80), chiusa in basso da un listello che funge da piano di posa delle figure, si direbbe integra sul lato sinistro, mentre il lato de-stro è lacunoso, il che comporta una grave mutilazione della scena, che constava almeno di tre personaggi. A destra si conserva parzialmente un gruppo compo-sto da due figure: un corpo maschile privo di vita pende inerte con le gambe unite, strisciando a terra le dita dei piedi, e viene sorretto da un personaggio incedente verso destra, del quale rimangono la gamba destra arretrata e il brac-cio destro, teso all’indietro all’altezza delle spalle. Tale movimento del braccio
ElEna GhisEllini
Achilleos soma Una nota iconografica
estratto
300 E. Ghisellini
5 Cf. Huber 2001, passim.6 Il frammento, inv. nr. 1154, inedito, è stato studiato da chi scrive per il catalogo delle scul-
ture antiche del Museo di Grottaferrata, di imminente pubblicazione a cura di A. Giuliano. Il volume rientra nell’ambito delle iniziative editoriali promosse dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Millenario della Fondazione dell’Abbazia di S. Nilo a Grottaferrata.
7 La bibliografia sul monumento è vastissima, si ricordano soltanto: Sadurska 1964, pp. 24-37, 1A., tav. I; Simon 1966; Kossatz-Deissmann 1981, p. 191, nr. 894; Salimbene 2002; Valenzuela Montenegro 2004, pp. 26-149, in part. p. 103 s.
implica che il torace fosse girato di prospetto, per cui la salma, contro ogni ve-rosimiglianza, doveva avere la schiena appoggiata sulla sommità del petto del compagno. L’indice della mano destra di quest’ultimo è puntato in direzione di una terza figura, posta nella parte sinistra del pannello, la quale impugna con la mano sinistra uno scudo e una lancia, con la punta rivolta a terra, mentre porta la destra alla testa reclinata in un atteggiamento che, insieme con la leggera in-clinazione in avanti del torso, manifesta profondo dolore5. Il guerriero, imberbe e con i capelli raccolti in un krobylos, è nudo, ad eccezione di una clamide gettata sulla spalla sinistra e scendente ai lati del corpo con le estremità a coda di rondi-ne; corti mantelli sono indossati anche dagli altri due protagonisti.
Del rilievo si può individuare una copia in un frammento (fig. 2), di prove-nienza ignota, custodito nel Museo dell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata6. Il frammento (alt. m. 0. 18, largh. m. 0. 33), di marmo pentelico, è pertinente al settore inferiore destro del fregio e preserva un breve tratto delle gambe acco-state del corpo esanime ed entrambe le gambe, aperte nel passo, della figura che lo sorregge. Rispetto all’esemplare ateniese si osserva una variante nelle proporzioni del morto che, a giudicare dalle dimensioni del segmento super-stite delle gambe, dovevano essere maggiori rispetto a quelle del compagno.
Oltre all’assetto iconografico, i due rilievi condividono l’intonazione for-male, che denuncia un’impronta arcaistica nella prevalente visione di profilo delle immagini, che si stagliano sul fondo con contorni nitidi, nella rigidità delle pose, nella definizione linearistica del modellato, nella stilizzazione ma-nierata dei mantelli, segnati da pieghe a zig-zag e terminanti in lembi a coda di rondine. I raffinati stilemi mutuati dall’arte arcaica appaiono però combi-nati ecletticamente con tratti più recenti, evidenti in particolar modo nell’ac-cenno di spazialità implicito nell’atteggiamento del giovane dolente.
Sebbene la lacunosità di entrambe le sculture non consenta di appurare la loro estensione originaria, è ragionevole supporre che la raffigurazione com-prendesse soltanto i tre personaggi parzialmente conservatisi, che compongo-no un quadro in sé concluso e di immediata lettura: nel corso di una battaglia un guerriero trascina fuori dalla mischia il cadavere di un caduto, mentre un compagno ne lamenta afflitto la sorte. Questa prima, generica lettura si presta tuttavia a un approfondimento che può condurre a una piena comprensione dell’esatto contenuto della scena. La chiave per una plausibile interpretazione è fornita da un dettaglio della Tabula Iliaca del Museo Capitolino7, che nel regi-
estratto
Achilleos soma. Una nota iconografica 301
8 L’evoluzione iconografica del soggetto nel corso dei secoli è analizzata sistematicamente da Kemp-Lindemann 1975, pp. 223-227, ma soprattutto da Kossatz-Deissmann 1981, pp. 185-193, nrr. 860-896, p. 200. La classificazione delle scene in tre gruppi sulla base degli schemi iconografici adottati si deve a Kunze 1950, pp. 151-154.
9 Kylix, Paris, Cabinet des Médailles, inv. nr. 537: Kossatz-Deissmann 1981, p. 190 s., nr. 889.10 Diversa è la situazione in Etruria, ove il tema gode di un certo favore anche in età classica,
principalmente nell’ambito della glittica: Camporeale 1981, p. 208 s., nrr. 136-146.
stro superiore della predella sottostante al pannello centrale ripropone i mo-menti più salienti della Aethiopis di Arctino di Mileto (fig. 3). Dopo la rappre-sentazione della morte di Achille sotto le mura di Troia compare un gruppo di due figure del tutto analogo, sotto il profilo iconografico, a quello effigiato sui nostri rilievi: l’identità del defunto è qui però resa inequivoca dall’iscri-zione ∆Acillevw" sw'ma. Si tratta quindi del trasporto del corpo di Achille, che anche in questo caso appare inclinato in diagonale da sinistra verso destra sì da poggiare la schiena sulla spalla di Aiace, il quale, imbracciando lo scudo con la mano sinistra, muove verso destra con le gambe di tre quarti, il torso di prospetto, la testa volta all’indietro. La puntuale rispondenza dello schema iconografico rende altamente probabile l’identificazione con Achille e Aiace anche del gruppo riprodotto sulle lastre in esame.
Il trasporto del corpo di Achille è uno dei temi epici più cari all’arte arcai ca che, specialmente nel campo della pittura vascolare, ne offre molte-plici rap presentazioni, caratterizzate dall’impiego di tre differenti soluzioni iconogra fi che, a loro volta suscettibili di variazioni8. La redazione più antica (fig. 4), creata già intorno al 700 ca. a. C., prevede che Aiace avanzi verso de-stra in po sizione eretta, tenendo gettato su una spalla il corpo di Achille, dalle propor zio ni gigantesche al punto che le dita dei piedi e delle mani sfiorano il suo lo. I rapporti di misura fra i due protagonisti si fanno più equilibrati nelle scene della prima metà del VI sec. a. C. (fig. 5), che mostrano Aiace nello sche ma della “corsa in ginocchio” con la salma ancora adagiata su una spalla. A partire dal 540 a. C. si afferma una versione più matura (fig. 6), ideata da Exe kias, il quale, con maggiore coerenza naturalistica, ritrae Aiace nell’atto di in cedere con passo greve sotto il peso del cadavere, ora correttamente caricato sul dorso, che si curva in avanti. L’efficacia narrativa e l’intensità drammatica della nuo va formula, in cui l’accentuazione della fatica fisica del Telamonio diviene anche espressione di un’opprimente sofferenza interiore, ne assicura-no il successo fino agli inizi del V sec. a. C., quando Douris, nel tondo di una coppa (fig. 7), effigia Aiace in veduta frontale con il corpo di Achille riverso su una spalla in un audace tentativo di scorcio9. Con gli inizi del V sec. a. C. la documentazione sembra interrompersi, quanto meno nel mondo greco10, per poi riapparire in età ellenistica, quando il tema conosce una discreta fortuna su una serie di gemme che ripetono gli schemi tràditi; rarissime sono le atte-stazioni di epoca romana.
estratto
302 E. Ghisellini
11 Il motivo del corpo di Achille rivolto verso l’alto potrebbe avere tratto spunto dalle raffigu-razioni in cui il cadavere è gettato su una spalla di Aiace in posizione supina (figg. 4, 7): Kossatz-Deissmann 1981, p. 186, nr. 860, p. 191, nrr. 891b, 892b, 895; si veda anche Camporeale 1981, pp. 208-209, nrr. 138-140, 143-144.
12 Kemp-Lindemann 1975, p. 223; Kossatz-Deissmann 1981, p. 186 ad nr. 860, p. 192.
L’iconografia adottata nei rilievi Atene-Grottaferrata e nella Tabula Capito-li na non ha perciò precedenti diretti11, ma sembra piuttosto scaturire dal de-siderio di rivitalizzare le convenzioni vigenti elaborando un nuovo schema, che finisce però per risultare poco convincente, in quanto trasforma il vero-simile trasporto della salma su una spalla o sul dorso in un artificioso e mal-destro trascinamento, privo di ogni plausibilità sul piano del naturalismo. Appartiene invece alla tradizione il motivo della nudità del corpo di Achille, che compare sin dal VII secolo in alternativa alla più frequente raffigurazione del cadavere rivestito da un’armatura completa. La nudità dell’eroe è stata a volte considerata non congruente con il racconto epico12, che non contempla che la salma venga spogliata delle armi, per il cui possesso divamperà fra Aiace e Odisseo la ben nota contesa. In realtà l’assenza delle armi potrebbe rispecchiare la sequenza degli eventi riflessa in Apollodor. Epit. 5. 4, secondo cui Aiace, prima di sollevare Achille, avrebbe consegnato le armi affinché ve-nissero portate alle navi. Prescindendo da un possibile riferimento a tale ver-sione della saga, è bene rilevare che, nella traduzione in immagine del tema, la rappresentazione del corpo nudo o chiuso nell’armatura rientra fra le opzioni espressive dell’artista e si rapporta al messaggio che egli intende trasmettere all’osservatore e alla reazione emotiva che si propone di suscitare. È chiaro in-fatti che l’esibizione del corpo nudo, inerme, talora violato da ferite grondanti di sangue, vale a porre in risalto la condizione umana dell’eroe, la sua fragilità tutta terrena, sollecitando nello spettatore una più commossa partecipazione. Al contrario le armi fulgide che ancora proteggono il corpo evocano le impre-se gloriose di Achille, sono il simbolo parlante della sua stessa natura eroica e nel contempo prefigurano la disputa che si scatenerà per impadronirsene, foriera per Aiace di una tragica sorte.
La volontà di attuare una sorta di compromesso fra dette opzioni espres-sive, ponendo in evidenza la caducità, resa esplicita dalla nudità, e al tem-po stesso l’essenza sovrumana di Achille, potrebbe forse spiegare la variante introdotta nel frammento di Grottaferrata, che conferisce alla salma dimen-sioni maggiori rispetto a quelle di Aiace. La consuetudine di attribuire una grandezza smisurata al corpo del Pelide contraddistingue le scene più antiche (fig. 4), ma viene abbandonata già nel corso dell’età arcaica a vantaggio di un rapporto proporzionale più armonioso. Tuttavia il gigantismo delle dimensio-ni rimane prerogativa della figura di Achille in quanto creatura semidivina, tant’è che Lycophr. 860 lo qualifica come eijnavphcu" e Quint. Smyrn. 3. 386, descrivendo il momento del trasporto, definisce la salma ajpeivrito".
estratto
Achilleos soma. Una nota iconografica 303
13 Le lastre di Atene e di Grottaferrata possono verosimilmente attribuirsi a botteghe ateniesi; benché per entrambe non sia noto il luogo di provenienza, si può supporre che facessero parte dell’arredo di un edificio pubblico o meglio, per lo meno nel caso del frammento criptoferratense, di una ricca dimora privata, così come è documentato per altre classi di rilievi a soggetto epico o mitologico (cfr. Froning 1981, pp. 1 s., 8-32). Le tabule iliache, rinvenute a Roma e dintorni, sono opera di officine urbane; quanto alla destinazione, è controverso se avessero una funzione pratica di sussidio visivo nell’apprendimento dell’epos o non fossero piuttosto finalizzate alla de-corazione di biblioteche o comunque di ambienti riservati ad attività culturali (si veda da ultimo: Valenzuela Montenegro 2004, pp. 298-304, 402-407).
14 In proposito ci si limita a rammentare che il carattere impressionistico delle scene abbozzate sulle tabule iliache ha indotto a ipotizzare una loro derivazione da illustrazioni di volumina di epoca ellenistica: Weitzmann 1959, pp. 34-51; Simon 1966, p. 119; Weitzmann 1970, pp. 36-44. Altri pensano a una dipendenza da un prototipo monumentale (Sadurska 1964, p. 17 s.) ovvero da Bilderbücher, repertori figurativi privi di testo impiegati nelle botteghe artigiane: Schefold 1975; Horsfall 1979, pp. 43-48. Revisione critica della questione in Salimbene 2002, pp. 11-13; Valenzuela Montenegro 2004, pp. 339-346.
15 Od. 5. 308-310; Il. parv. fr. 2 Bern.; Antisth. Ai. 2, Od. 11-12; Apollodor. Epit. 5. 4; schol. Od. 11. 547; schol. Il. 16. 719; Quint. Smyrn. 3. 296 ss. (ma si veda in merito Vian 1959, p. 32). I ruoli di Aiace e Odisseo sono invertiti in: Il. parv. fr. dub. 32 Bern.; schol. Od. 5. 310; Eustath. in Od. 1542. 9. In Soph. Phil. 373 e in Ovid. Met. 13. 284-285, Odisseo si vanta di avere portato in salvo sia il corpo che le armi di Achille.
16 Ad esempio: Kossatz-Deissmann 1981, p. 183, nr. 854a, p. 189, nrr. 875 (?), 878-879, p. 191, nr. 893, p. 191 s., nr. 896.
17 Si è molto discusso se la figura di Odisseo appartenga alla scena del ferimento o a quella del trasporto: considerato che essa si trova esattamente al centro fra le due scene e appare coerente
Il frammento di Grottaferrata può datarsi, su basi stilistiche, agli inizi dell’età augustea; all’età augustea, o comunque alla prima età imperiale, è stata ricon-dotta anche la Tabula Capitolina; l’inquadramento cronologico della lastra ate-niese è problematico, a causa del pessimo stato di conservazione delle superfici e dell’impossibilità di un esame ravvicinato. La nuova soluzione iconografica sembra dunque affermarsi nella seconda metà del I sec. a. C. e riscuote un suc-cesso assai limitato, essendo sinora testimoniata esclusivamente dai tre rilievi qui presi in esame, che peraltro si annoverano fra le più tarde attestazioni del tema, poco amato dall’arte romana. L’apparizione dello schema su monumenti diversi quanto ad ambito di produzione e destinazione13 lascia supporre che esso sia mutuato da un prototipo oggi perduto, sulla cui natura e cronologia è opportuno sospendere il giudizio in mancanza di elementi obiettivi di valutazione14.
Rimane infine da discutere l’identità del personaggio che campeggia nella parte sinistra del rilievo di Atene. Procl. Chrest. 172 Seve. asserisce kai; peri; tou' ptwvmato" [di Achille] genomevnh" ijscura'" mavch" Ai[a" ajnelovmeno" ejpi; ta;" nau'" komivzei, ∆Odussevw" ajpomacomevnou toi'" Trwsivn. Il ruolo decisivo di Odisseo, che fronteggia gli assalitori in difesa di Aiace, è più volte sotto-lineato dagli autori antichi15 e trova riscontro sui monumenti figurati, che lo ritraggono nell’atto di combattere ovvero, più di rado, in atteggiamento statico16. Sulla Tabula Capitolina l’eroe, teso allo spasimo nella lotta, occupa una posizione intermedia fra la scena del ferimento di Achille, caduto a terra e protetto dal grande scudo di Aiace, e la scena del trasporto della salma17.
estratto
304 E. Ghisellini
con entrambe le situazioni illustrate, si può ammettere che lo scultore per brevità abbia omesso di ripeterla, presentandola di fatto come ambivalente.
18 Kossatz-Deissmann 1981, p. 182 s., nrr. 848-850, p. 184, nr. 856.19 Ad esempio: Kossatz-Deissmann 1981, p. 188, nr. 869, p. 188 s., nr. 874.20 Si veda Touchefeu-Meynier 1992, p. 775, nrr. 2-3, 6-7, p. 776, nrr. 10-15, 17, p. 777, nrr. 20,
22-25, p. 778, nr. 26.21 Rimando alle fonti in Touchefeu-Meynier 1992, p. 774.22 Anfora, Monaco, Antikensammlungen, inv. nr. 1415: Kossatz-Deissmann 1981, p. 189, nr. 877;
Touchefeu-Meynier 1992, p. 776, nr. 17.
L’identificazione con Odisseo del guerriero dolente della lastra ateniese urta però contro insormontabili difficoltà di ordine iconografico: questi è infatti connotato come giovane impubere e imberbe, fisionomia che è in insanabile contrasto con l’immagine canonica di Odisseo, sempre effigiato come uomo maturo e barbato.
Quint. Smyrn. 3. 186-386, nel rievocare con enfasi retorica l’aspra battaglia che infuria intorno al cadavere di Achille, ricorda accanto ad Aiace e Odisseo (vv. 321-330) a[lloi / pavnte" oJmw'" ejpimi;x Danaoiv (cf. Od. 24. 36-42). La batta-glia è oggetto di rappresentazione solo raramente18; un richiamo allusivo all’intervento in essa di tutti i Greci può tuttavia cogliersi nelle pitture vasco-lari raffiguranti due anonimi guerrieri che assistono al trasporto del corpo di Achille, affiancando composti il gruppo dei due protagonisti19. Per analogia con tali scene potremmo scorgere nel nostro guerriero un Greco che ha mo-mentaneamente sospeso la lotta e ora, raccolto in se stesso, si abbandona a un disperato cordoglio. Ma il gesto imperioso della mano destra di Aiace, che addita con l’indice il campo di battaglia, immaginato fuori del pannello, vuole forse essere un monito affinché egli riprenda a combattere per vendicare quel-la morte che è causa di tanta angoscia.
Proprio tale gesto, che istituisce un inedito rapporto dialogico tra le due figure, invita a ipotizzare che esistano vincoli profondi fra il guerriero e il gruppo di Achille e Aiace. Elemento distintivo del personaggio pare essere la giovane età, esaltata dalla struttura possente ma acerba delle membra, dal volto imberbe, dal tipo dell’acconciatura: tanta insistenza sull’età giovanile non può non richiamare alla mente Neottolemo, che è sempre ritratto nel fiore degli anni20, visualizzando nell’aspetto un concetto di giovinezza che è implicito nel nome stesso. L’eventualità che si tratti di Neottolemo risulta in contraddizione con il racconto epico a noi tradito, che prevede il suo arrivo a Troia qualche tempo dopo la morte del padre21. Occorre però tenere presente che non bisogna necessariamente aspettarsi una trasposizione letterale del te-sto scritto nel mondo delle immagini, che hanno una vita propria e un proprio linguaggio espressivo: ne è riprova un’anfora attica a figure nere22, sulla qua-le, a sinistra di Aiace con il cadavere di Achille, compare un duello fra Enea e Neottolemo, che il pittore vuole già sul campo al momento dell’uccisione del padre. Come accade nelle pitture vascolari in cui Tetide (?) o il vecchio Fenice
estratto
Achilleos soma. Una nota iconografica 305
23 Ad esempio: Kossatz-Deissmann 1981, p. 187, nr. 866, p. 187 s., nr. 867, p. 188, nrr. 868, 871, p. 188 s., nr. 874, p. 189, nr. 879, p. 190, nrr. 883, 886.
piangono Achille che grava esanime sul dorso di Aiace23, così sul nostro rilie-vo la presenza di Neottolemo straziato dal dolore, con l’alludere ai più intimi affetti familiari, arricchirebbe la scena di una nota di toccante pateticità, atta a stimolare nell’osservatore un intenso coinvolgimento emotivo.
Tra le diverse possibilità che si sono prospettate, l’identificazione con Neottolemo appare quindi la più suggestiva, sebbene sia destinata a rimanere allo stato di ipotesi non suffragata al momento da riscontri probanti.
BiBlioGrafia
G. Camporeale, Achle, in LIMC, I, 1981, pp. 200-214M. Chatzidakis, Athènes byzantines, Athènes s. d.C. Friederichs - P. Wolters, Königliche Museen zu Berlin. Die Gipsabgüsse antiker Bildwerke,
Berlin 1885H. Froning, Marmor-Schmuckreliefs mit griechischen Mythen im 1. Jh. v. Chr. Untersuchungen
zu Chronologie und Funktion, Mainz 1981A. Grabar, Sculptures byzantines du Moyen Age II (XIe-XIVe siècle), Paris 1976N. Horsfall, Stesichorus at Bovillae?, «JHS» 99, 1979, pp. 26-48I. Huber, Die Ikonographie der Trauer in der griechischen Kunst, Mannheim - Möhnesee
2001D. Kemp-Lindemann, Darstellungen des Achilleus in griechischer und römischer Kunst,
Frankfurt 1975A. Kossatz-Deissmann, Achilleus, in LIMC, I, 1981, pp. 37-200E. Kunze, Olympische Forschungen, II, Archaische Schildbänder, Berlin 1950H. Maguire, The Cage of Crosses: Ancient and Medieval Sculptures on the "Little Metropolis"
in Athens, in Rhetorik, Nature and Magic in Byzantine Art, Norfolk 1998, pp. 169-172C. Mango, Antique Statuary and the Byzantine Beholder, «DOP» 17, 1963, pp. 55-75K. Michel - A. Struck, Die mittelbyzantinischen Kirchen Athens, «AM» 31, 1906, pp. 279-
324A. Sadurska, Les tables iliaques, Warszawa 1964C. Salimbene, La Tabula Capitolina, «BMusRom» 16, 2002, pp. 5-33K. Schefold, Buch und Bild im Altertum, in Wort und Bild. Studien zur Gegenwart der
Antike, Basel 1975, pp. 125-128E. Simon, in W. Helbig, Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in
Rom, II, Tübingen 19664, pp. 116-119, nr. 1266 P. Steiner, Antike Skulpturen an der Panagia Gorgoepikoos zu Athen, «AM» 31, 1906, pp.
325-341O. Touchefeu-Meynier, Neoptolemos, in LIMC, VI, 1992, pp. 773-779N. Valenzuela Montenegro, Die Tabulae Iliacae: Mythos und Geschichte im Spiegel einer
Gruppe frühkaiserzeitlicher Miniaturreliefs, Berlin 2004F. Vian, Recherches sur les Posthomerica de Quintus de Smyrne, Paris 1959
estratto
306 E. Ghisellini
K. Weitzmann, Ancient Book Illumination, Cambridge, Mass. 1959K. Weitzmann, Illustrations in Roll and Codex. A Study of the Origin and Method of Text
Illustration, Princeton 1970M.-A. Zagdoun, La sculpture archaïsante dans l’art hellénistique et dans l’art romain du
haut-empire, Paris 1989
Università di Roma “Tor Vergata”
estratto
Achilleos soma. Una nota iconografica 307
Fig. 1. Lastra marmorea. Atene, Chiesa della Panagia Gorgoepikoos (da Ph. lE Bas et WaddinGton, Voyage archéologique en Grèce et en Asie mineure. Monuments figurés, Paris 1847-1877, tav. 7).
Fig. 2. Frammento di rilievo. Grottaferrata, Museo dell’Abbazia di San Nilo.
estratto
308 E. Ghisellini
Fig. 3. Tabula Iliaca: dettaglio. Roma, Museo Capitolino (da o. Jahn-a. MichaElis, Griechische Bilderchroniken, Bonn 1873, tav. I*).
Fig. 4. Cretula. Lemnos, Museo Archeo-lo gico.
Fig. 5. Kylix del Pittore di Phrynos: tondo interno. Città del Vaticano, Musei Va ti ca ni.
estratto
Achilleos soma. Una nota iconografica 309
Fig. 6. Anfora di Exekias: dettaglio. München, Staatliche Anti-ken sammlungen.
Fig. 7. Kylix di Douris: tondo interno. Paris, Cabinet des Médailles.
estratto