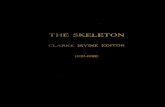215 - Lo studio dei falsi. Diplomi militari falsi o rubati
Transcript of 215 - Lo studio dei falsi. Diplomi militari falsi o rubati
6 - LO STUDIO DEI FALSI 1823
VIII,6,2 - DIPLOMI MILITARI FALSI O RUBATI*
A quanto pare, negli ultimi decenni l’interesse nei confronti dei diplomi militari non è aumentato soltanto da parte degli studiosi, com’è dimostrato dalle numerose ricerche sull’argomento1, ma anche da parte dei falsari. Mi è gradito cogliere l’occasione di questi studi in onore del prof. Piero Meloni, al quale va anche il mio augurio più cordiale, per rendere di pubblica conoscenza alcune informazioni di cui sono
che sarebbero auspicabili. Bisogna riconoscere che si tratta di un lavoro lungo, ingrato e rischioso, che richiede competenze diverse (di epigrafi a e di storia della cultura) non facili da mettere insieme, e che inoltre necessita di un diffi cile equilibrio nel-l’esercizio critico. In primo luogo abbiamo bisogno di conoscere meglio la personalità, le conoscenze ed il modo di procedere dei singoli falsari; quindi di un attento riesame dei documenti che fanno capo ad essi; infi ne di una storia, a tutt’oggi mancante, del fenomeno della falsifi cazione epigrafi ca. Come oggi credo, eventuali riabilitazioni (come pure rinnovate condanne) non dovrebbero costituire il fi ne, ma rientrare tra le conseguenze (più o meno certe) di questo lavoro sempre meno dilazionabile. – Il caso dell’Asquini (personaggio stranamente omesso nel – Il caso dell’Asquini (personaggio stranamente omesso nel – Dizionario Biografi co degli Italiani) mostra che, comunque, di-vergenze di giudizio, anche gravi, alla fi ne possono restare. Questo modesto studioso, che per me fu indubbiamente un falsario, ma non sempre (un altro suo presunto falso è stato ritrovato nel 1974 ed è ora pubblicato con foto in J.B. BRUSIN, Inscriptiones Aquileiae, I, Udine 1991, nr. 193), per una grande esperta in questo genere di cose come Maria Pia Billanovich è invece un falsario punto e basta (M.P. BILLANOVICH, Falsifi cazioni epigrafi che di G. Asquini, in Journ. Warb. Court. Inst., 36, 1973, p. 346; EAD., Il falso epitaffi o aquileiese di Anicia Ulfi na, in Rend. Ist. Lomb., 118, 1974, pp. 530-550). Credo che in buona parte la nostra divergenza di giudizio nasca dalla diversità, sia delle basi della rispettiva ricerca, sia dell’animus con cui essa è condotta. Fondandomi sulla totalità dei testi ‘asquiniani’, io non ho potuto fare a meno di rilevare che i falsi che gli sono stati attribuiti né sono risultati effettivamente tali, né erano poi veramente tutti suoi; e che poi restavano comunque dei casi dubbi. La Billanovich perviene invece alla sua condanna senza remissione portando a fondo l’indagine su alcuni casi specifi ci (le cui conclusioni pe-raltro non sono sempre accettabili) ed ignorando il resto. Anche l’animus di cui ho detto gioca una sua parte. Si prenda il caso di CIL, V 424*. Io ho constatato (pp. 81-84) che la diffusione del testo parte da tale Girolamo Bovio e non dall’Asquini, traendone la conclusione che quest’ultimo non debba quindi essere ritenuto responsabile della sua eventuale (per la Billanovich, forse a ragione, evidente) falsità. Senza alcuna prova, ed anche su larga inverosimiglianza (l’anziano studioso avrebbe dovuto mettere la sua reputazione nelle mani di un ventiseienne), la Billanovich (Falsifi cazioni, pp. 352-354) pensa invece che il testo sia stato creato dall’Asquini e passato al Bosio con l’accordo che questi glielo comunicasse poi per lettera facendo fi nta di averlo trovato lui. La forzatura è evidente. Similmente è senza prove, ma in questo caso con maggiore verosimiglianza, che la Billanovich attribuisce all’Asquini (Falsifi cazioni, pp. 339-352) l’aggiunta fraudolenta sul codice Add. 14049 del British Museum, delle iscrizioni CIL, V 359*-362*, sulle quali anch’io mantenevo dubbi (pp. 81, 167). Infi ne per la Billanovich (Il falso epitaffi o) è assolutamente un falso anche CIL, V 47*, iscrizione sepolcrale della virgo Deo devota Anicia Ulfi na di cui, per la sua coerenza interna, dal punto di vista storico-antiquario al di sopra delle capacità dell’Asquini, io non ho invece escluso l’autenticità (pp. 52-67, 168). C’è anche in questo caso, quanto meno, un eccesso di sicurezza a fronte di prove insuffi cienti vd. in proposito: L. CRACCO RUGGINI, Aquileia e Concordia. Il duplice volto di una società urbana nel IV secolo d.C., in Ant. A. Adr., 29, 1987, pp. 67-69 nt. 22; EAD., Gli Anicii a Roma e in Provincia, in Mél. Éc. Fr. Rome, Moyen Age, 100, 1988, 1, pp. 69-85, in part. 75-84; A. FRASCHETTI, La conversione da Roma pagana a Roma cristiana, Roma-Bari 1999, p. 166 nt. 46; contra, senza tuttavia appro-fondire: CH. PIETRI, Une aristocratie provinciale et la mission chrétienne: l’exemple de la Venetia, in Ant. A. Adr., 22, 1982, p. 116 nt. 1 (= ID., Christiana Res Publica (CEFR, 234), II, Rome 1997, p. 928). A scanso di equivoci, chiarisco che, anche se non sono d’acordo in tutto, ammiro comunque la padronanza con cui la Billanovich si muove nel campo dell’antiquaria e ritengo che ci sia molto da imparare da lei, solo che qualcuno voglia ancora continuare questo tipo di studi.
* Di un sardo con troppi diplomi, Ursaris Tornalis fi lius, e di altri diplomi militari romani, in Sardina antiqua: Studi in onore di Piero Meloni in occasione del suo settantesimo compleanno, Cagliari 1992, pp. 325-340.1 Le nuove acquisizioni, dopo la raccolta speciale in CIL,
XVI (1936, 1955) si trovano riunite, con tutta la bibliografi a pertinente, in M.M. ROXAN, Roman Military Diplomas 1954-1977 (Institute of Archaeology, Occasional Pubblication, 2), London 1978; EAD., Roman Military Diplomas 1978 to 1984(Institute of Archaeology, Occasional Pubblication, 9), Lon-
<325>
1824 VIII - VARIA CUM ARTIS EPIGRAPHICAE DOCTRINA ET USU CONIUNCTA
in possesso circa un traffi co di falsi imbastito intorno a questa classe di documenti, cominciando dal ben noto diploma militare di Ursaris Tornalis f(Ursaris Tornalis f(Ursaris Tornalis f ilius) Sardus2.
Le vicende di questo diploma, ben note, sono state narrate anche di recente3. Trovato nel 1872 in una parte estremamente interna della Sardegna, nella regione del Gocéano e precisamente nella località denominata Charchinazu (Charchinaru, Charchinarzu, Charchinargiu) di Anela, Comune che si trova a m. 446 di altezza nella vallata del Tirso sotto la Punta Masiénnera, esso passò per le mani del pretore di Benetutti, dello Spano che ne diede per primo notizia a stampa nel 18734, del Mommsen che lo vide ancora presso lo Spano nel 1877 e lo pubblicò nel CIL dopo averne già dato notizia in Ephemeris Epi-graphica5, infi ne nel 1878 in quelle del Pais che, ricevutolo in dono dallo Spano, lo inserì nel Museo di Sassari, ove tuttora si conserva.
Si tratta di un diploma di grande importanza. Anzitutto, datato com’è al 22 dicembre del 68, con-tinua a restare tra i documenti più antichi di questo tipo che ci siano pervenuti. In secondo luogo, con altri tre diplomi dipendenti dalla stessa costituzione6, ci illumina sulle misure di smobilitazione prese da Galba nei confronti dei classiari di Miseno, con i quali Nerone, nell’aprile del 68, aveva formato la legione denominata I Adiutrice7. Inoltre, con quelli rilasciati da Vespasiano nel 70 ai classiarii di Raven-na, con cui aveva costituito la legione II Adiutrice8, esso è indicativo della particolare condizione in cui erano venuti a trovarsi questi soldati “considerati legionari quanto a durata di ferma, ma classiari quanto alla formula della dispositio e dell’onomastica. In effetti il loro stato giuridico era rimasto immutato nel passare in nuove formazioni legionarie irregolari, che vennero riconosciute come iustae legiones, e cioè legioni di diritto (‘rechtliche’ non ‘richtige’) nell’imminenza della, o in concomitanza con la promul-gazione delle costituzioni riguardanti congedo e privilegi dei rispettivi veterani”9. La straordinarietà di questa posizione si rifl ette nell’anomalia del rilascio dei diplomi a veterani legionari che ricevevano, insieme all’honesta missio (rilasciata direttamente dall’imperatore invece che dal loro comandante), gli stessi privilegi dei veterani delle fl otte di Miseno e di Ravenna10. Infi ne il diploma è importante anche per il contributo che dà alla conoscenza dell’onomastica sarda11, dell’arruolamento di sardi nell’esercito romano (nel caso specifi co nella fl otta di Miseno)12 e, tramite il luogo di ritrovamento, alla problematica
don 1985. Messe a punto della problematica generale, in Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als Militärdiplome als Mhistorische Quelle, (Passauer historische Forschungen, 2), Köln-Wien 1986 e da parte di ST. LINK, Konzepte der Privile-gierung römischer Veteranen (HABES, 9), Stuttgart 1989. 2 CIL, XVI (1939), 9. 3 A. BONINU, Documenti epigrafi ci della collezione Spano, in Contributi su Giovanni Spano, 1803-1878, Sassari 1979, pp. 105-111. 4 G. SPANO, Memoria sopra l’antica cattedrale di Galtelli e scoperte archeologiche fattesi nell’isola in tutto l’anno 1872, Cagliari 1873, p. 37; ID., Scoperte archeologiche fat-tesi in Sardegna in tutto l’anno 1873, Cagliari 1874, p. 25; ID., Lettera al Conte Carlo Baudi di Vesme intorno ad un diploma militare sardo, in Atti Ac. Torino, 9, 1873-1874, pp. 887-897 con foto. 5 Eph. Epigr., 2, 1875, pp. 454-456 nr. LIX (in base alle pubblicazioni dello Spano e ad informazioni ricevute da Carlo Baudi di Vesme); CIL, X (1883) 7891; CIL, III, Suppl.
3 (1902) p. 1958 nr. VI (visto nel 1877).6 CIL, XVI 7, 8; AE 1985, 770. 7 TAC. Ann., 15, 46.8 TAC. Hist., 3, 50, 3. CIL XVI 10, 11.9 G. FORNI, I diplomi militari dei classiari delle fl otte preto-rie (inclusi quelli dei classiari-legionari), in Heer, cit. (nt. 1), p. 297.10 J.C. MANN, The Development of Auxiliary and Fleet Di-plomas, in Epigr. Stud., 9, 1972, pp. 233 sg.; FORNI, art. cit. (nt. 9), pp. 297 sg.11 Sull’onomastica della provincia: J.R. ROWLAND JR., Ono-masticon Sardorum Romanorum, in Beitr. Nam., n.s., 8, 1, 1973, pp. 81-118; aggiunte: ID., ibid., 10, 2, 1975, p. 172; 12, 3, 1977, pp. 286-287; 12, 4, 1977, p. 420; vd. anche ID., Onomastic Remarks on Roman Sardinia, in Names, 21, 2, 1973, pp. 82-102; il tutto insieme con le osservazioni e le precisazioni di A. MASTINO, in Quad. Sard. Stor., 3, 1983, pp. 191-194.12 G. SOTGIU, Sardi nelle legioni e nella fl otta romana, in
<326>
6 - LO STUDIO DEI FALSI 1825
del rientro in patria dei veterani e dei luoghi prescelti per insediarsi13, quindi anche alla storia, a tutt’oggi poco conosciuta, del popolamento della valle del Tirso in età romana14.
A più riprese nel 1966 ebbi modo di vedere a Roma la prima tavoletta di un diploma militare che si asseriva trovata tra un cumulo di sassi in un campo, circa a 100 metri da via della Giustiniana, all’al-tezza dell’ottavo chilometro, e che era offerta in vendita al prezzo di duecentomila lire15. In una di tali occasioni riuscii anche a misurarla, pesarla ed a farne fotografare le due facce (fi gg. 1-2). La lamina di bronzo misurata sugli assi centrali era alta cm 16,7, larga cm 13,85, spessa cm 0,35. Il peso era di gr. 542. La superfi cie risultava coperta da una patina verdastra piuttosto resistente con alcune macchie chiare e parecchie altre brune.
La scrittura non destava sospetti: ben incisa e chiaramente leggibile nella faccia interna, tranne nella parte centrale delle due ultime righe, richiedeva invece qualche sforzo di lettura, per la maggior corrosione, sulla faccia esterna. Comunque il testo si poteva leggere per intero e, dalla trascrizione, risul-tava essere identico (anche nell’impaginazione, nelle abbreviazioni e negli errori) a quello del diploma sardo.
Il dubbio che potesse trattarsi appunto di una tavoletta, trafugata, di quel diploma fu dissolto dal-l’allora Soprintendente alle Antichità per le Province di Sassari e Nuoro, Prof. Ercole Contu, al quale mi rivolsi per informazioni. Il diploma si conservava ancora integro nel Museo (fi gg. 3-4)16. La tavoletta offerta in vendita a Roma era dunque un falso.
Interessante a questo punto un attento confronto tra i due esemplari. Le misure della prima tavoletta dell’originale, prese sempre sugli assi centrali, erano di cm 17 x 14,2, dunque di qualche millimetro superiori al falso romano. Inferiore invece lo spessore e, corrispondentemente, il peso: gr. 42017. Se si considera che, a fronte di queste differenze, dal confronto delle foto i documenti risultano assolutamente
Athenaeum, n.s., 39, 1961, pp. 78-97; R.J. ROWLAND JR., Sardinians in the Roman Empire, in Ant. Soc., 5, 1974, pp. 223-229 (in part. pp. 222-225); Y. LE BOHEC, La Sardaigne et l’armée romaine sous le Haut-Empire, Sassari 1990, in part. pp. 46, 86, 120.13 M.-TH. RAEPSAET-CHARLIER, Le lieu d’installation des vétérans auxiliaires romains d’après les diplomes militai-res, in Ant. Class, 47, 1978, pp. 557-565; M.M. ROXAN, The Distribution of Roman Military Diplomas, in Epigr. Stud., 12, 1981, pp. 265-286; H.-J. KELLNER, Die Möglichkeit von Rückschlüssen aus der Fundstatistik, in Heer, cit. (nt. 1), pp. 241-248.14 Per un quadro dei ritrovamenti ed insediamenti romani in Sardegna: R.J. ROWLAND JR., I ritrovamenti romani in Sar-degna (Studia archaeologica, 28), Roma 1981 (per Anela, p. 13); ID., Addenda to Rowland, I ritrovamenti romani in Sar-degna, Columbia 1982; ID., The Countryside of Roman Sar-dinia, in Studies in Sardinian Archaeology, Ann Arbor 1984, pp. 285-390 (per il Gocéano, p. 291); il tutto con le osser-vazioni ed integrazioni di A. MASTINO, in Quad. Sard. Stor., 3, 1983, pp. 201-214. Specifi camente sulla distribuzione del materiale epigrafi co nell’isola: A. SECHI, Cultura scritta e territorio nella Sardegna romana, in L’Africa romana, 7, 1990, pp. 641-654. Nuove scoperte in località Charchinazu
(non registrate negli studi precedenti) che fanno ipotizzare l’esistenza in loco di un centro di produzione di pesi di te-laio, embrici e recipienti di vario tipo, sono segnalate da BO-NINU, art. cit. (nt. 3). Ampio aggiornamento bibliografi co: C. VISMARA, Gli studi degli ultimi anni sulla Sardegna romana (1977-1987), in 1977-1987), in 1977-1987 Journ. Rom. Arch, 2, 1989, pp. 71-92. Nuo-vi contributi panoramici sull’archeologia dell’isola sono an-nunciati in ANRW, 2, 12, 4, da parte di Rowland (inventario ANRW, 2, 12, 4, da parte di Rowland (inventario ANRWtipologico scoperte), Angiolillo (mosaico, pitture, stucchi) e Saletti (scultura).15 Me lo fece vedere, con richiesta di un parere, Luigi Capo-grossi Colognesi, allora assistente presso la cattedra di Isti-tuzioni di Diritto Romano della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma.16 La foto che riproduco è quella che mi è stata mandata dalla Soprintendenza in quell’occasione ricavandola da una vecchia lastra. Già a quel tempo tuttavia le tavolette non era-no più tenute insieme dai legamenti in “fi lo a più doppi di rame inargentato” che c’erano al momento della scoperta e che si vedono ancora nelle fotografi e. Per foto più recenti, posteriori al restauro, LE BOHEC, op. cit. (nt. 12), tavv. X-XI.17 Ho preso le misure del diploma di Sassari da un calco car-taceo dell’originale mandatomi dal Prof. Contu. A lui devo anche l’indicazione del peso (l’altra tavoletta pesa gr. 3l5).
<327>
1826 VIII - VARIA CUM ARTIS EPIGRAPHICAE DOCTRINA ET USU CONIUNCTA
identici tra loro, non solo per quanto concerne il testo, ma anche nella scrittura, la | conseguenza che s’impone è che la tavoletta romana è stata tratta mediante calco (di qui i millimetri di differenza) dalla corrispondente dell’originale sassarese. La copia ottenuta è stata quindi invecchiata mediante tratta-mento con acidi ed altri trucchi del mestiere, non troppo smaliziati peraltro, se hanno lasciato ancora sostanzialmente leggibile la parte più compromettente del diploma, quella con il nome del titolare, per l’appunto Ursaris Tornalis f(Ursaris Tornalis f(Ursaris Tornalis f ilius), Sardus. Si può anche intravedere il momento in cui la falsifi cazione ha preso l’avvio. Come seppi dal Prof. Contu, in qualche momento anteriore al 1966 il diploma del Mu-seo di Sassari fu mandato a Firenze, per restauro, nel noto laboratorio di Bruno Bearzi. Nessun calco era autorizzato. Sembra probabile che, ciò nonostante, non si sa da chi, uno ne sia stato fatto.
Non so che fi ne abbia fatto l’esemplare che ho avuto tra le mani. Comunque non era diffi cile preve-dere che in giro ve ne fossero altri. Un paio d’anni dopo Ivan Di Stefano Manzella, nelle sue fruttuose frequentazioni delle collezioni private e dei negozi d’antiquariato romani18, ne trovava uno presso un anti-quario di via Margutta il cui negozio, denominato “Il Faunetto”, oggi più non esiste. Dagli appunti volanti che ne trasse e che in seguito mi passò, mi par lecito concludere che si trattasse di altra copia della stessa tavoletta. Il testo e le misure corrispondono, ma le condizioni di leggibilità sembrano esser state differen-ti. Evidentemente il trattamento d’invecchiamento rese di diffi cile lettura altre parti della lamina.
Ancora qualche anno dopo, precisamente il 9 gennaio del 1971, la collega della Soprintendenza Ar-cheologica di Roma Elisa Lissi Caronna m’inviava in visione la foto di una tavoletta di diploma militare (fi gg. 5-6) che le era stata presentata come parte di una collezione privata romana19, affi nché esprimessi un parere sulla sua autenticità ed il suo valore. Inutile dire che si trattava ancora una volta di una copia della prima tavola del diploma di Ursaris. Certamente diversa dalle precedenti perché, ancora una volta, come risulta dalle foto, le condizioni di leggibilità e conservazione risultano diverse. Si noti, fra l’altro, la frattura dello spigolo inferiore sinistro, rispetto alla faccia esterna, che non si riscontra in nessun altro degli esemplari considerati.
Così il nostro sardo, Ursaris fi glio di Tornalis che, per conquistare un diploma, o meglio ciò che esso attestava (cittadinanza per lui e per i fi gli e conubium), si sobbarcò ad un lungo servizio militare, prima nella fl otta di Miseno e poi nella Legio I Adiutrix, più di 1900 anni dopo si trova ad averne non meno di quattro.
Caso del resto non unico. Colgo l’occasione per arricchire di ulteriori particolari un’altra storia di falsi concernenti questo tipo di documenti. | Nel 1939 Andreas Alföldi pubblicava come autentica la prima tavola di un diploma militare di età domizianea venduta al Museo Nazionale Ungherese da per-sona che aveva dichiarato di averla trovata nel Danubio presso Nicopol in Bulgaria20. Ad un più attento esame, il diploma, che appariva rilasciato all’ausiliare Gorius Stibi f(Gorius Stibi f(Gorius Stibi f ilius) Dacus, risultava però un’evi-dente falsifi cazione ricavata, con sostituzione del nome e qualche altra lieve alterazione, dalla fotografi a di un diploma, pubblicato nel 1927, conservato nel Museo di Sofi a e rilasciato dallo stesso Domiziano all’ausiliare Bithus Seuthi f(Seuthi f(Seuthi f ilius) Bessus21.
18 Vd. la cospicua serie di materiali pubblicata in Rend. Ac. Linc., ser. 8, 26, 1971, pp. 751-768 e in Epigraphica, 34, 1972, pp. 105-130; 36, 1974, pp. 223-225; 37, 1975, pp. 5-16; 38, 1976, pp. 17-25.19 Si trattava di una non meglio precisata collezione Astorri sulla quale né lei né io a tanti anni di distanza siamo in grado di dare migliori informazioni.20 A. ALFÖLDI, Dacians on the Southern Bank of the Da-
nube, in Journ. Rom. Stud., 29, 1939, pp. 28-31, tavv. II-III.21 Sul diploma di Sofi a: I. WELKOW, Neues Militärdiplom von Domitian, in Bull. Inst. Arch. Bulg., 4, 1926-27, pp. 69-80, fi gg. 31-34 (in bulgaro con riassunto tedesco), inde CIL, XVI 35. La falsità del diploma di Budapest fu riconosciuta da H. Nesselhauf e dichiarata in CIL XVI, Suppl. (1955) p. 216.
<328>
<329>
6 - LO STUDIO DEI FALSI 1827
Due foto di un altro esemplare dello stesso falso capitavano poco dopo il 1955 nelle mani di Ida Calabi Limentani che ne rendeva pubblica una (quella della faccia esterna) con un opportuno corredo di osservazioni22. La foto mostrava senza dubbio una tavoletta diversa, non nel testo, ma nello stato di conservazione, da quella acquistata dal Museo di Budapest. Dall’originale del Museo di Sofi a, o me-glio dalla sua fotografi a, dunque erano stati ricavati, con la stessa alterazione, almeno due esemplari falsi.
Alla stessa conclusione si giunge anche attraverso l’esame della foto dell’altra faccia (quella inter-na), non pubblicata a suo tempo dalla Prof.ssa Calabi Limentani, che tuttavia è stata così gentile da man-darmela insieme con qualche ulteriore informazione (fi g. 7). Chiara la derivazione da una stessa matrice tanto del diploma di Budapest quanto di questo, ma assolutamente diverso lo stato di conservazione, evidentemente per il differente processo d’invecchiamento cui i due esemplari sono stati sottoposti.
Dove si trovasse il diploma riprodotto nelle foto non si era potuto appurare. Queste si trovavano in proprietà di un collezionista di monete amico di famiglia della Prof.ssa Calabi Limentani, ed a lei erano state consegnate dopo la morte di questi. Credo ora di poterne stabilire la provenienza.
Nel febbraio del 1967 Fausto Zevi, avendo saputo del mio interesse per questa storia di diplomi falsi, m’inviò le negative di alcune foto di un diploma scattate circa sei anni prima a Roma in casa di un privato occasionalmente commerciante in antichità. Gli pareva, egli mi scrisse, che la tavoletta fotogra-fata avesse qualcosa a che fare con il diploma Alföldi e quello Calabi. Così era, in effetti. Ora che le ho stampate (fi gg. 8-9), le negative si rivelano tratte senza dubbio dallo stesso esemplare riprodotto nelle foto Calabi. L’identità è evidente e non ha bisogno di commenti.
Dunque almeno all’inizio degli anni 60 il diploma Calabi si trovava sul mercato antiquario romano. Il collezionista milanese poté facilmente venirne a conoscenza, almeno fotografi camente, in occasione di contatti con questo ambiente in ragione della sua raccolta numismatica. Non so poi se debba consi-derarsi del tutto casuale il fatto che il detentore del diploma romano (che si è visto essere altra copia del falso di Budapest) fosse un ungherese trapiantato a Roma nel corso dell’ultima guerra mondiale. In ogni caso è chiaro che, eseguito il falso in più copie e collocatane una a Budapest, si cercò di sistemarne almeno un’altra all’estero attraverso il commercio antiquario. È da notare che anche in questo caso la limitata perizia grafi ca e l’ingenuità del falsario (che ha bensì avuto cura di cambiare il nome fi gurante nel suo modello senza però rendersi conto che le misure che riproduceva dalla foto peccavano notevol-mente per difetto rispetto all’originale ed in generale rispetto ai diplomi autentici contemporanei)23, non ha impedito un discreto successo dell’operazione.
Insieme con le foto di cui si è detto, il collezionista milanese, amico della famiglia Calabi, conserva-va anche un frammento di diploma. Venutane in possesso, I. Calabi Limentani si accorse subito ch’esso corrispondeva esattamente, fi n nei minimi dettagli, al quarto destro superiore della prima tabella del diploma rilasciato da Marco Aurelio e Lucio Vero il 21 luglio 164 d. C., trovato nel marzo 1936 a poca distanza da Palatovo in Bulgaria, acquistato dal Museo di Plovdiv e pubblicato dal Detschew24. Logico che si chiedesse se per caso non si trattava di un pezzo di quello stesso diploma, trafugato dal Museo di Plovdiv o non si aveva, anche in questo caso, a che fare con un falso25. La direzione del Museo di Plo-
22 I. CALABI LIMENTANI, Due diplomi militari, falsi o rubati?, in Atti III Congr. Intern. Ep. Gr. Lat., Roma 1957, Roma 1959, pp. 81-82, tav. XV.23 Il diploma di Budapest misura mm. 118 x 94 laddove l’originale di Sofi a è di mm. 188 x 148. Lo Zevi ricorda che anche l’esemplare da lui visto e fotografato era molto
piccolo.24 D. DETSCHEW, Ein neues Militardiplom aus Dacia Poro-lissensis, in Klio, 30, 1937, pp. 187-199 con 2 tavv., indeCIL, XVI 185.25 CALABI LIMENTANI, art. cit. (nt. 22), pp. 81-82.
<330>
1828 VIII - VARIA CUM ARTIS EPIGRAPHICAE DOCTRINA ET USU CONIUNCTA
vdiv da lei interpellata rispondeva che il diploma si trovava ancora là senza tuttavia precisare se ancora in tutte le sue cinque parti26. Dunque la questione restava aperta. Suscitava in ogni caso sospetto trovare il frammento in qualche modo associato, tramite le foto prima considerate, con un falso.
Con grande liberalità e nello spirito della più aperta collaborazione, la Prof.ssa Calabi Limentani mi ha fatto pervenire di recente questo frammento e tutto il carteggio messo insieme al riguardo, invitan-domi a riprendere l’inchiesta. La visione del pezzo, che ho fatto fotografare (fi gg. 10-11), confermava in pieno le osservazioni della collega sulla sua assoluta identità con il corrispondente frammento del Museo di Plovdiv, quale risulta dalle descrizioni e dalle foto che ne sono state date. Si prospettavano tre possibilità teoriche:
a) si trattava in effetti dello stesso pezzo, rubato; b) avevamo un calco fedelissimo dello stesso;c) come nel caso del diploma di Budapest, avevamo a che fare con un diploma falso eseguito in più
esemplari, uno dei quali acquistato dal Museo di Plovdiv.L’ultima eventualità poteva essere tranquillamente esclusa. Basti questo: il diploma contiene dati
che l’eventuale falsifi catore non poteva attingere da altra fonte e che sono stati confermati da non so-spette scoperte posteriori27.
Grazie alla cortesia del Prof. Velizar Velkov, al quale mi sono rivolto per nuove ed inequivoche informazioni sul diploma di Plovdiv, siamo in grado di orientarci risolutamente anche rispetto alle altre due possibilità. Con lettera in data 5 marzo 1991 egli mi scrive: “Maintenant on a constaté que le frag-ment en question manque de la collection du Musée, et donc l’original a été volé (!)”. Come pare, non v’è necessità di pensare, in questo caso, ad un falso ottenuto mediante calco (ipotesi b). Il pezzo, già pervenuto nelle mani della Prof.ssa Calabi Limentani ed ora nelle mie, può ben essere una parte, rubata, dell’originale di Plovdiv (ipotesi a). Il Prof. Velkov mi comunica che altri ammanchi si erano registrati nel Museo, tra cui uno riguardante una serie di monete molto rare e di grande valore, che erano in segui-to andate a fi nire al Metropolitan Museum di New York. Il frammento milanese era conservato in una bustina che portava sovrastampato il nome di un noto commerciante in monete di Londra. Ma questo può essere dovuto semplicemente al riutilizzo di questa bustina da parte del nostro collezionista. Il pezzo poté essere acquistato, senza conoscere la sua storia anteriore, sia a Londra, sia in Italia, forse a Roma, provenienza, come si è visto, delle foto dell’altro diploma. Con il pieno consenso della Prof.ssa Calabi Limentani, esso tornerà naturalmente al Museo d’origine.
Anche questa vicenda, come quella dei falsi realizzati con tecniche diverse e con maggiore o minore perizia, di cui si è parlato prima, mostra come i diplomi militari abbiano sul commercio antiquario una presenza tale da meritare una segnalazione anche in sede scientifi ca ed è ciò che ci si è qui proposto di fare28.
26 Lettera 1 agosto 1957 (prot. 446).27 Ad esempio il nome del procuratore-governatore della Da-cia Porolissensis all’epoca, Sempronius Ingenuus, ignoto per l’avanti e poi conosciuto da ulteriori scoperte: B.E. THOMAS-
SON, Laterculi praesidum, I, Göteborg 1984, col. 153 nr. 30.28 Il mio più vivo ringraziamento a tutti i colleghi ed amici citati nel testo senza il cui apporto di materiali e d’informa-zioni questo articolo non avrebbe potuto essere scritto.
<331>
6 - LO STUDIO DEI FALSI 1829
1 - Roma, commercio antiquario: prima tavoletta di diploma militare falso, faccia esterna (Foto O. Savio).
1830 VIII - VARIA CUM ARTIS EPIGRAPHICAE DOCTRINA ET USU CONIUNCTA
2 - Roma, commercio antiquario: prima tavoletta di diploma militare falso, faccia interna (Foto O. Savio).
6 - LO STUDIO DEI FALSI 1831
3 - Sassari, Museo archeologico: diploma militare di Ursaris, facce esterne (Foto Dachena).
4 - Sassari, Museo archeologico: diploma militare di Ursaris, facce interne (Foto Dachena).
1832 VIII - VARIA CUM ARTIS EPIGRAPHICAE DOCTRINA ET USU CONIUNCTA
5 - Roma, proprietà privata: prima tavoletta di diploma militare falso, faccia esterna.
6 - LO STUDIO DEI FALSI 1833
6 - Roma, proprietà privata: prima tavoletta di diploma militare falso, faccia interna.
1834 VIII - VARIA CUM ARTIS EPIGRAPHICAE DOCTRINA ET USU CONIUNCTA
8 - Roma, proprietà privata: prima tavoletta di diploma militare falso, faccia esterna (Foto F. Zevi).
7 - Milano: prima tavoletta di diploma militare falso, faccia interna, in foto posseduta da privato collezionista (dono I. Calabi Limentani).
6 - LO STUDIO DEI FALSI 1835
9 - Roma, proprietà privata: prima tavoletta di diploma mi-litare falso, faccia interna (Foto F. Zevi).
10 - Milano, proprietà privata: frammento di prima tavo-letta di diploma militare da Palatovo, faccia esterna (Foto D. Pivato).
11 - Milano, proprietà privata: frammento di prima tavoletta di diploma militare da Palatovo, faccia interna.