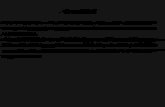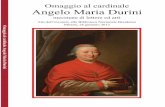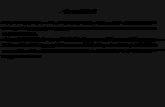Marcello A. Farinelli Per molto tempo la storia del fascismo è ...
(2011) Leggevamo e studiavamo molto”. Alberto e Giorgio de Chirico alla Braidense (1907-1910)
Transcript of (2011) Leggevamo e studiavamo molto”. Alberto e Giorgio de Chirico alla Braidense (1907-1910)
11 «leggevamo e studiavamo molto»: alberto e giorgio de chirico alla braidense (1907-1910)
Il lavoro compiuto con Alessandro Tinterri per la curatela delle Opere pubblicate da Adelphi nella collana “La Nave Argo”, e svolto nel Fondo Savinio dell’Archivio Contemporaneo A. Bonsanti del Gabinetto G.P. Vieusseux di Firenze, ci ha permesso di ricostruire la formazione di Alberto Savinio, verificandone la straordinaria versatilità intellettuale e mettendo meglio a fuoco il contributo essenziale che diede nella fondazione della poetica metafisica.
È un fatto ormai assodato che per capire la nascita della metafisica – non solo pittorica ma anche letteraria – si debba arretrare nel tempo rispetto a quella che anni fa ho chiamato “officina ferrarese”, e approfondire il tessuto culturale e filosofico della formazione di Alberto e Giorgio de Chirico attraverso un’analisi specifica dei documenti che si sono conservati: appunti di lettura, note critiche, elenchi di termini, improvvisi letterari del quadriennio cruciale 1907-1910. Se infatti il primo contatto è del settembre 1906 (una visita di pochi giorni dell’Esposizione Universale di Milano al Parco Sempione, di cui resta a Giorgio e ad Alberto il ricordo di Previati e Segantini) è dalla metà di luglio del 1907 che, grazie alle ricerche di Gerd Roos, possiamo datare più precisamente il periodo milanese di Savinio, che viene raggiunto dal fratello verso la fine di maggio del 1909.
Il 17 ottobre 1907 in un’intervista sul “Corriere della Sera” Tito Ricordi consacra «un giovinetto di quindici anni, un certo di [sic!] Chirico nato in Grecia da genitori italiani, che vive ora a Milano, ed è uno dei più strani talenti musicali che abbia mai conosciuto». Due giorni dopo appare quella che in gergo giornalistico si chiama “la ripresa”, sotto forma di intervista alla madre. È il 19 ottobre 1907 e Gemma Cervetto dichiara:
Noi siamo a Milano da tre mesi con questo scopo. In Grecia, non era possibile pensare ad un
avvenire artistico per mio figlio […]. È necessario il giudizio di Milano perché Alberto possa
cominciare la sua carriera di artista. Se ci riuscisse a dar l’opera altrove, sarebbe come non data. È
Milano che dà il battesimo agli ingegni musicali.
[…]
Io insegnai ad Alberto i primi elementi del pianoforte. Egli aveva allora dieci anni. Lo mandai
poi al conservatorio, dove studiò con intensità e riuscì a suonare come un virtuoso. Il professor
Sacerdoti, che lo aveva in grande amore, mi diceva sempre: ‘È un peccato che questo ragazzo
rimanga qui, in Atene’ allora mi decisi a lasciare la Grecia, e dissi ai miei figli: ‘se fra due anni non
sarete riusciti a far qualche cosa, ritorneremo ad Atene’. Essi hanno mantenuto la parola: Giorgio
studia e si fa onore, Alberto ha composto un’opera.
«LEGGEVAMo E STUDIAVAMo MoLTo»: ALBERTo E GIoRGIo DE ChIRICo ALLA BRAIDENSE (1907-1910)
Paola Italia
ATTI METAFISICA.indd 11 16/06/11 17.05
12 paola italia
La loro prima residenza è in via Principe Umberto (oggi via Turati), dove Alberto e la madre vivono qualche mese. Poi, tra fine 1907 e inizio 1908 si trasferiscono in via oriani, a cui è legato un altro ricordo ‘musicale’: «Via oriani ora si chiama via Boito». E il nome di Boito torna, proprio in questo biennio 1907-1908, legato agli spettacoli teatrali che in quel momento a Milano calcavano le scene: il 21 dicembre 1907 il Crepuscolo degli Dei diretto da Toscanini e il Mefistofele di Arrigo Boito e Pellèas et Mélisande di Debussy (a cui Alberto assiste con Tito Ricordi).
Il trasferimento in via Petrarca viene collocato tra il 1907 e il 1908, ma è probabile che Savinio nella rievocazione successiva anticipi di un anno ciò che i documenti collocano invece più tardi:
Tra il 1907 e il 1908 [in realtà nel 1909], da San Michele a San Michele, abitai in via Petrarca
l’ultimo piano di una casa nuova, ma di stile rinascimentale e lombardesco. Può influire su l’opera
di un poeta l’abitare in via Petrarca? Da me non lo so, perché in quel tempo non lavoravo di poesia,
per meglio dire non scrivevo in versi […]. Eppure era molto petrarchesca quella via: petrarchesca a
meriggio, quando ai tavolini di un’osteriola di fronte a casa mia, posati sul marciapiede, venivano
a desinare i muratori, la bustina di giornale in testa, e il misterioso vento del meriggio sollevava le
tovaglie; petrarchesca nelle prime e ancor pàniche ore del pomeriggio, quando le domestiche, dalla
parte delle cucine, rigovernavano i piatti e cantavano le gioie e i tormenti dell’amore; petrarchesca
nei morbidi pomeriggi d’autunno, quando gli organetti venivano a fare stazione nella via dedicata
al poeta, e lentamente, malinconicamente, gli sgranavano il duetto fra Manrico e Azucena;
petrarchesca soprattutto nel cielo lombardo, così puro e profondo, di cui il mio occhio adolescente
esplorava da quell’ultimo piano l’oceano vasto, i continenti mutevoli, le isole passeggere.
Un biennio di incubazione, che emerge con linee più definite nel 1909, anno cruciale per la formazione culturale dei fratelli, che muovono i primi passi immersi nella fervida temperie culturale della Milano di quegli anni: nel gennaio-marzo 1909 viene messo in scena il Boris Godunov di Mussorskij, l’Elettra di Strauss e la Fedra di D’Annunzio, il 24 febbraio 1909 Virgilio Talli: Come le foglie, andato in scena al Teatro Manzoni, nel maggio 1909 La buona figliola, rappresentato tra l’aprile e il maggio 1909 sempre al Teatro Manzoni (dramma giocoso in tre atti di Piccinni su Libretto di Goldoni).
Se di un’“officina milanese” si tratta, è certo che essa ha nella Biblioteca Braidense il suo cantiere aperto. Nel maggio-giugno del 1909 Savinio viene raggiunto dal fratello a Milano, dove rimane fino al 25 gennaio 1910: in questi mesi le attività dei fratelli si fondono, sia sotto il versante della pittura che sotto quello dello studio e della scrittura. Le lezioni di latino dal maestro Domenico Fava, autore di un fortunato volumetto di Sinonimi latini ad uso delle scuole classiche pubblicato da hoepli proprio nel 1910, verranno immortalate in Ascolto il tuo cuore, città:
Quel mio professore era una delle stupidità più belle, più rotonde, più perfette che io abbia mai
conosciuto. Era una stupidità corazzata, inespugnabile. Le cose più strane, più inquietanti, più
insidiose lo lasciavano indifferente, non traversavano il nimbo della sua oscurità. Non le vedeva,
non le sentiva, non le sospettava neppure. Fuori dagli ablativi assoluti non capiva nulla, e anche
gli ablativi assoluti li capiva a modo suo, che non è quello che può trasformare anche un ablativo
assoluto in istrumento di intelligenza. C’è tra gli ufficiosi della coltura classica un’aria di famiglia,
e a capostipite di costoro vedo giganteggiare la figura del mio professore di latino. Veggo la sua
ATTI METAFISICA.indd 12 16/06/11 17.05
13 «leggevamo e studiavamo molto»: alberto e giorgio de chirico alla braidense (1907-1910)
faccia àtona come la pianta di un piede, il suo sguardo che non zampilla, ma cola giù dagli occhi
come un filo d’acqua da un rubinetto stanco.
Dello studio del latino ci sono rimasti alcuni brani di traduzione dal De Bello Gallico e dalla Germania di Tacito. Si tratta di esercizi di carattere soprattutto scolastico, in cui però vediamo prendere forma per la prima volta il metodo di lavoro di Savinio, che ricopia i passi più significativi dei testi studiati, costituendo una sorta di antologia personale. Dal De bello gallico, ad esempio, è ripresa solo una breve parte del libro primo, un esercizio di tipo strettamente scolastico, come gli appunti trascritti e ricopiati (figg. 1, 2, 3), spesso anche ricalcati fisicamente nel secondo periodo di formazione italiana di Savinio e di de Chirico, l’“officina ferrarese”. Credo si possa affermare con certezza la doppia stesura di questi testi: gli appunti che figurano su fogli sciolti si presentano come i più arcaici e riflettono gli studi del 1909, ma vengono ripresi nel 1915 a Ferrara, quando Savinio riapre il cantiere linguistico e letterario, per completare le vistose lacune scolastiche della sua formazione, e in parte riutilizza i materiali “milanesi”, in parte adopera i moduli militari prestampati dati in dotazione a Villa Seminario.
Accanto agli studi latini si pongono due letture note da tempo, le Argonautiche di Apollonio Rodio tradotte dal Flangini e il Morgante Maggiore del Pulci. Gli appunti lessicali qui riportati (fig. 4) inseriscono la citazione dalle Argonautiche, qui in corsivo, in una serie di altri termini in ordine sparso:
aliosso: osso del tallone col quale giocavano i ragazziarmilla: bracialetto [sic] dei guerrieri romanicommessura: commettituraazzurrigno (la ben concatenata nave)mozioneonustostamefuso
2. Appunti di latino (ACB, Sc. 49)1. Appunti di latino (ACB, Sc. 49) 3. Appunti di latino (ACB, Sc. 49)
ATTI METAFISICA.indd 13 16/06/11 17.05
14 paola italia
ardiglione: ferretto della fibbia, puntalela Titania Diva (la luna)Rodio Arg. Pag. 209. verso 80 cant. IVlapillotrojaIppotadetabe: tabido: consunzione, infettoequabile: gualemergocòmere: ornare
La diversa grafia e il diverso ductus della pagina riflettono i due diversi momenti della stesura del testo. Inizialmente Savinio annota i termini e i versi di cui ignora il significato o che vuole conservare a futura memoria, in un secondo momento (con diversa penna) ne cerca la definizione sui dizionari, e la annota a fianco del termine registrato, compilando una sorta di vocabolario personale arricchito di osservazioni, citazioni, fonti, che rimanda alla sezione di appunti più importante per la ricostruzione della formazione di Savinio in questo cruciale quadriennio milanese. Mi riferisco alle carte formato computisteria che recano elenchi lessicali in ordine quasi sempre alfabetico, di cui ho dato anticipazione nel Pellegrino appassionato, e che qui vorrei presentare, anche visivamente, in una ricostruzione più approfondita.
A prima vista si tratta di elenchi, ma dovremmo chiamarli piuttosto atlanti lessicali perché uniscono all’interesse linguistico e a un indubbio scopo di documentazione (Savinio trascrive
4. Appunti dalle Argonautiche (ACB, Sc. 49) 5. Appunti di lingua (bufolo-ciolla) (ACB, Sc. 49)
ATTI METAFISICA.indd 14 16/06/11 17.05
15 «leggevamo e studiavamo molto»: alberto e giorgio de chirico alla braidense (1907-1910)
solo termini fuori dall’uso, spesso contrassegnati nel Tommaseo-Bellini o nel Tramater dalla croce utilizzata per indicare un lemma ormai scomparso) anche richiami decisivi alle opere che sono il lievito della formazione letteraria dei due artisti.
Vediamo una pagina tipo (lettere b/c) con lemmi particolari, afferenti all’ambito dell’insulto, della beffa (fig. 5):
bufolo: uomo goffo, per ingiuriabulima: frotta confusain bulima: alla rinfusaburugliare: fischiare, mugliare, di razzo gittato con forzabuscalfana: cavallaccio magrobuzinieri, busineri: sonatore di buccinebuzzone: strumento antico da fiatobuzzichiello: piccolo romorecachinno: scrosci di risa, strepito nel riderecalameggiare: sonàr lo zuffolo.Calcagnare: scappare, spronare.Caleffo: burla, beffacamozza: donna abietta e sudiciacapripane: agg. e sost. dal dio Pane e da Capracapripede: che à i piedi di capracarnonia: carne soda e fresca di personacarnure: escrescenza carnosacasside: elmo, celatacatto: stromento bellico degl’antichicazzalbagio: uccello acquaticocetera: sorta di scudoceterare: sonar la ceteraceterato: armato di ceterachicchirlèra: burla, beffa.Chiocca: colpo, percossa, bussachioccare: dar delle bussecianfrona: donna sciattafobonchiare: sono sordo, Ciccarecinfolare: fischiare, di serpicinolissa: rabbia caninaciolla: donna sciatta.Salinoso: salino
Alcuni termini, come si può vedere dalla fig. 5, sono accompagnati da segni a matita come cerchi, croci o simboli indicanti I°, II° o III°, che ci permettono di ricavare ulteriori gruppi all’interno dell’elenco (anche se la corrispondenza non è sistematica). In molti casi (ma non in tutti), alla croce dell’autore corrisponde quella del dizionario Tommaseo-Bellini, che classifica il termine come
ATTI METAFISICA.indd 15 16/06/11 17.05
16 paola italia
fuori d’uso (molti termini segnati dal vocabolario come «morti» però, non sono contrassegnati da croce sul manoscritto). Vista l’estensione del lavoro (si tratta di alcune centinaia di termini), daremo qui solo alcuni campioni significativi.
La prima categoria (I°: attiva solo dalla lettera «B» in poi) riunisce termini riguardanti la sfera dell’insulto (soprattutto verso la donna), dell’ingiuria, della beffa (figg. 9, 10, 11). Alcuni di questi sono poi ricopiati su fogli a parte, che riguardano esclusivamente il tema Le beffe ed i beffati (figg. 15, 16, 17) come indica una postilla a lapis e sono per lo più contrassegnati, come si è detto, da una croce:
amaiare: abbassar gli orecchi + bagatelluzza: dim. di bagatella - buajucca [?]: bagatella + bazzecola: inezia
+ bufolo: òmo goffo
+ chicchirlerà: beffa + ciuffole: bagatelle, baie cornacchiamenti: cicalìo vano cornacchiaia: cicalìo noioso corneggiare: cozzare colle corna! bergolare: cicalare, chiaccherarebergolinare: cortellare, far restar minchione. + bèrgolo: minchione, sciocco.berleffe. + scazzata: ciancia, baiascoccoveggiare: civettare, burlarea scoppiacorpo: a crepapellescrepazzare: scoppiare, crepare+ taccolata: ciancia
10. Appunti di lingua (dolcemele-gherbel-lire) (ACB, Sc. 49)
9. Appunti di lingua (cruore-dolcefrizzan-te) (ACB, Sc. 49)
11. Appunti di lingua (ghiringhellare-in-domo) (ACB, Sc. 49)
ATTI METAFISICA.indd 16 16/06/11 17.05
17 «leggevamo e studiavamo molto»: alberto e giorgio de chirico alla braidense (1907-1910)
La seconda categoria (II°) riguarda invece il combattimento, lo scontro, il ferimento, l’uccisione, un ambito semantico che invece, a partire dalla lettera «G», è contrassegnato dal numero III°, mentre il II° circoscrive termini zoologici e botanici.
Molte delle definizioni sono parafrasate, ma alcune sono puntualmente ricopiate dalla fonte che credo possa a buon titolo essere identificata in un dizionario ottocentesco, presente ovviamente nella Biblioteca Braidense, molto diffuso nel primo ottocento, il Dizionario della Lingua Italiana di Paolo Costa e Francesco Cardinali (Bologna, 1821), su cui, a suo tempo, aveva esercitato la sua acribia linguistica con note e postille pari a quelle depositate sul Vocabolario della Crusca, lo stesso Vincenzo Monti. Che il dizionario sia proprio questo lo mostra non solo il lemmario (che è condiviso con quello della Crusca e del Tommaseo-Bellini), ma la glossa, la definizione, che spesso viene puntualmente ripresa dal solerte lessicografo (figg. 6, 7, 8). A ogni lemma segue quasi sempre la corrispondente definizione, o un sinonimo, privi, tuttavia, di esempi d’autore (anche nei rari casi in cui questo sia identificabile). Per bulima, ad esempio, il Costa Cardinali offre la definizione di «frotta confusa», per calameggiare: «sonar lo zufolo», chioccare viene indicato come «voce bassa» per «dare altrui delle busse», e così di seguito.
Possiamo prendere, a titolo di esempio, alcuni lemmi della pagina relativa alla lettera “s”, (fig. 12) molto produttiva nel settore delle neoformazioni prefissali intensive o oppositive:
Sonniferoso sonniglioso sonnacchioso agg. sonnocchioso sonnoglioso
Tutti registrati in CC
soppiano: sottovoce CC: Diciamo Di soppiano, posto avverbialm. E vale lo stesso che Sottovoce.
soppozzare: affogare, sommergere CC: Affogare, sommergere
soprasberga: cotta d'arme CC: Sopravvesta chesi porta sopra l'usbergo
sobrasbergato: agg. vestito soprasberga CC: Vestito di soprasberga
spanciata: colpo con la pancia. “Spanciarsi dalle risa”, sbellicarsi
CC (con croce): colpo dato con la pancia
16. Appunti di lingua (La beffa e i beffati) (ACB, Sc. 49)
15. Appunti di lingua (La beffa e i beffati) (ACB, Sc. 49)
17. Appunti di lingua (La beffa e i beffati) (ACB, Sc. 49)
ATTI METAFISICA.indd 17 16/06/11 17.05
18 paola italia
Altri termini invece sembrano derivati dall’autore per analogia. Spantoso, per “maraviglioso”, non è registrato dai dizionari, ma tra le accezioni di spanto, la Crusca veronese (IV impressione), riporta anche «Spanto, vale anche Pomposo, Magnifico, Eccedente. Lat. mirificus, lautus, splendidus».
Lo stesso procedimento di ricerca linguistica si può vedere in atto per solluchero, da cui Savinio trae, per derivazione e procedimento analogico, tutta la famiglia corrispondente (trovandone parziale corrispondenza nel Costa Cardinali, che registra solo sollucheramento e sollucherare):
solluchèro: andare in – smammolarsi dalla giojaSollucheramento: sollùchero. voglia. desiderio ardenteSollucherare, andar, mandare in sollùcheroSollucherata: manifestazione esterna di commozioneSollucherone: chi va in sollùchero
Ci troviamo di fronte a un lavoro di documentazione lessicale di notevole estensione, che non solo fornisce un vastissimo materiale di arricchimento linguistico, ma che è possibile legare a un progetto artistico preciso, il Poema fantastico, un’opera musicale che attraversò vari stadi di lavorazione tra l’autunno 1907 e l’estate 1909 e sulla quale abbiamo preziose informazioni nel programma di un concerto che Savinio aveva previsto di eseguire al Teatro Alla Pergola di Firenze nel gennaio del 1911 e che invece fu tenuto a Monaco (si veda in questo volume il saggio di Gregorio Nardi). Il Poema Fantastico, secondo le ricostruzioni più attendibili, ripercorreva l’esperienza letteraria/musicale di Savinio in forma mitica e ironico autobiografica, proponendosi, come poi la pittura metafisica di de Chirico, come il racconto per metafore, largamente autobiografico, di un itinerario intellettuale.
Così esso viene ricordato da Giorgio de Chirico nelle sue Memorie, con un esplicito riferimento allo stile composito del Pulci:
Mio fratello […] aveva ultimato un lungo melodramma dal titolo Poema fantastico che era qualcosa
come l’oberon di Weber, ma si riferiva a una mitologia e ad una preistoria elleniche, fortemente
condite di spirito burlesco, nello stile del Pulci e di Rabelais.
È molto probabile, che proprio in funzione della stesura delle parti cantate del melodramma (fig. 13), Savinio trascrivesse una serie di termini arcaici caduti fuori dall’uso: voci rare, preziose, assolutamente non trasparenti, che risultano registrate dai vocabolari storici che abbiamo citato oppure, come ho già avuto modo di notare, toscanismi presenti nel dizionario dell’uso toscano compilato da Pietro Fanfani, ma che vengono scelti non tanto perché presentavano una maggiore adesione alla lingua toscana, e garantivano la “comunicabilità” della lingua, ma per la ragione
7. Costa-Cardinali, v. calameggiare6. Costa-Cardinali, v. bulima 8. Costa-Cardinali, v. chioccare
ATTI METAFISICA.indd 18 16/06/11 17.05
19 «leggevamo e studiavamo molto»: alberto e giorgio de chirico alla braidense (1907-1910)
opposta, per la loro rarità e una “patente” di toscanità che sconfinava nel vernacolo. Si tratta infatti di una selezione precisa, che ritaglia fondamentalmente temi bellici (il campo semantico degli scontri, battaglie, ferimenti, uccisioni) e burleschi (i temi della beffa e dei beffati). Lo conferma una carta (fig. 14), conservata insieme a queste e come esse di tipo computisteria, recante alcuni termini riportati nelle serie lessicali ‘tematiche’ sotto il titolo generale: Per la scena dell’ira faunica:
Camozza.ciollagalluzia.gialdranacianfronacornacchiuzza.
coincidenti (tranne «ciolla» e imperfettamente «cornacchiuzza») con quelli presenti nel ‘vocabolario d’autore’, e poi contrassegnati dal simbolo I° (gruppo della beffa): «camozza: donna abietta e sudicia», «galluzia: donna smorfiosa», «cianfrona: donna sciatta», «cornacchiaia: ciacolio noioso». Come si è già visto, nel programma di sala del Concerto tenuto a Monaco dal Poema fantastico – riprodotto da Roos e Baldacci – troviamo il titolo: La danza dei faunetti, che potrebbe rimandare a questa «scena dell’ira faunica» dove possiamo immaginare che venissero rivolti a delle donne gli ingiuriosi epiteti trascelti dal repertorio di arcaismi che Savinio aveva scovato compulsando i vocabolari.
13. Appunti di lingua per il Poema fantastico (ACB, Sc. 49)
14. Appunti di lingua per il Poema fantastico (ACB, Sc. 49)
ATTI METAFISICA.indd 19 16/06/11 17.05
20 paola italia
In un’altra carta Savinio va anche oltre; non riporta solo il termine trovato nel vocabolario, ma l’intera locuzione, e non utilizza solo il Costa Cardinali, ma anche un’altra fonte, ancora più interessante perché finora completamente sconosciuta, il manuale di Letteratura italiana dell’Ambrosoli, pubblicato a Milano da Fontana nel 1831-1832 [fig. 18], da cui annota modi di dire e locuzioni dai Discorsi degli animali di Agnolo Firenzuola, un autore a lui particolarmente caro (nella colonna di sinistra la trascrizione di Savinio, in quella di destra il luogo corrispondente dell’Ambrosoli):
Locuzioni
Altre locuzioni, invece, provengono dalla diretta lettura di Leopardi: i Paralipomeni della Batracomiomachia di Omero, il Manuale di Epitteto, e, dalle Operette morali, il Dialogo di Plotino e Porfirio.
tirar via alla distesa Narrato ch’ebbe alla distesa il tutto, La tregua, il novo prence e lo statuto, lI brutto inganno dei nemici, e il brutto Galoppar dell’esercito barbuto, Addimandò se la vergogna e il lutto Ove il popol de’ topi era caduto Sgombro sarebbe per la man de’ molti Collegati da lui testè raccolti. Leopardi, Paralipomeni della Batracomiomachia di Omero, l. 23
tenersi da qualche cosa: aversi in istima
Se tu vuoi far profitto, comporta pazientemente di esser tenuto pazzo e stolido per cagione delle cose di fuori. Anzi se egli ci avrà di quelli che ti stimino uomo da qualche cosa, diffidati di te medesimo. Perché tu déi sapere che egli non si può in un medesimo tempo conservare l'animo tuo disposto e ordinato secondo natura, e provvedere alle cose esterne; ma colui che ha cura dell'una di queste parti, di necessità dee trascurare l'altra. Leopardi, Manuale di Epitteto
Siamo usati di vivere: (Leopardi) abbiamo l'abitudine di vivere trascorrere a lagrime smoderate
E perché anche non vorremo noi avere alcuna considerazione degli amici; dei congiunti di sangue; dei figliuoli, dei fratelli, dei genitori, della moglie; delle persone familiari e domestiche, colle quali siamo usati di vivere da gran tempo […] Né lasciarsi vincere dalla pietà e dal cordoglio in guisa, che egline sia perturbato, che dava a terra, che ceda e che venga meno come vile, che si trascorra a lagrime smoderate. Leopardi, Operette morali, Dialogo di Plotino e Porfirio
ora che gli anni cominciano a farmi somma addosso era per morirsi di fame venne alla volta sua: verso di lui contò loro come passasse la cosa (come andavano le cose) la quale, quando fosse vera (qualora fosse vera) All'universal di quegli uomini (alla generalità di quegli uomini) mettersi coccoloni; farsi sulle calcagna
Stavasi un uccel d'acqua entro a un lago molto grande, posto nella più alta cima del dilettevole monte Grisciavola, intorno al quale nella sua gioventù a suo senno si era saziato di pesce; ma poiché gli anni gli avevano fatto somma addosso, a gran pena potendosi mettere nell'acqua per pescare, era per morirsi di fame. E standosi così di mala voglia, venne alla volta sua un gambero, e dissegli: Buon dì, fratello; e che vuol dire che tu stai così maninconioso? […] Udendo il gambero così mala novella, subito se n'andò a ritrovare pesci del lago, e contò loro come passava la cosa […] “Fratello, egli ci è stata racconta per tua parte una mala novella, la quale quando fosse vera, le persone nostra sarebbono in grandissimo pericolo. […] Parve all'universal di quei pesci il consiglio assai buono. […] Quando egli si metteva coccoloni nell'acqua. “nota 1 Coccoloni. Spiegasi Seduto sulle calcagna” (Agnolo Firenzuola, Discorsi degli animali, in Ambrosoli, Manuale, pp. 387-389)
ATTI METAFISICA.indd 20 16/06/11 17.05
21 «leggevamo e studiavamo molto»: alberto e giorgio de chirico alla braidense (1907-1910)
Il nome di Leopardi costituisce un vero e proprio filo rosso – si potrebbe parlare di una “funzione Leopardi” - nella formazione dei due fratelli, e sarà ripreso, come mostrano le carte del Fondo Savinio, nel 1917 a Ferrara come “manuale di studio” della lingua italiana, quella lingua che era stata brutalmente condannata da Papini nel rifiutare a Savinio il primo articolo presentato alla “Voce”, La realtà dorata, per lesa maestà della grammatica italiana e filogallismo:
Buono e giusto tutto quanto lei dice sul mio articolo. Sono ringhioso e inflessibile, non però con
coloro che amo e stimo. Sin d’ora Lo considero come la mia buona guida in lingua italiana. Le
dò facoltà di sfrondare i miei scritti; tanto più che quei periodi che Lei critica sono, anche a parer
mio, i meno importanti. – Altro che disabituato dall’italiano! Io, italiano, non ho mai scritto nella
mia lingua! Quei periodi che Le paiono più francesi che italiani, sono appunto delle note scritte in
francesse e tradotte con sommo fastidio. Non lo dica a De Robertis; lo inciti a publicarmi, almeno in
Febbraio (17 gennaio 1916).
A questa imponente documentazione ora possiamo aggiungere un ulteriore tassello emerso solo da poco, grazie agli scavi nei libri del prestito effettuati in Braidense. Gli elenchi di letture documentabili riguardano il biennio 1909-1910, ma naturalmente non possiamo escludere né che certi volumi siano stati acquistati in contemporanea, né che siano stati letti in sede. Le informazioni che abbiamo, in altre parole, non sono sufficienti per trarne considerazioni sicure dal punto di vista cronologico, ma solo per suffragare ulteriormente dei dati che abbiamo sulla base di altre fonti, e costituiscono solo un punto di partenza di ulteriori, più approfondite ricerche.Alcuni libri figurano dati in prestito ad Andrea de Chirico (domiciliato in via Petrarca 13) altri a de Chirico senza indicazione del nome (riferito genericamente ai due fratelli), mentre non compare esplicitamente il nome di Giorgio de Chirico. L’ultimo volume, preso in prestito il 24 gennaio figura restituito il 15 febbraio (restituzione che poté avvenire anche per via postale o per interposta persona, dal momento che il 26 gennaio Alberto risulta già a Firenze).
Questi i volumi presi in prestito da Andrea de Chirico:
8 settembre 1909 Tirteo – Carmi 8 settembre 1909 Boito – Nerone 8 settembre 1909 Vico – Principi di scienza nuova 18 ottobre 1909 Apollonio Rodio – Argonautiche (restituito il 10 gennaio) 9 dicembre 1909 Rostand – Cyrano de Bergerac
tirar via alla distesa Narrato ch’ebbe alla distesa il tutto, La tregua, il novo prence e lo statuto, lI brutto inganno dei nemici, e il brutto Galoppar dell’esercito barbuto, Addimandò se la vergogna e il lutto Ove il popol de’ topi era caduto Sgombro sarebbe per la man de’ molti Collegati da lui testè raccolti. Leopardi, Paralipomeni della Batracomiomachia di Omero, l. 23
tenersi da qualche cosa: aversi in istima
Se tu vuoi far profitto, comporta pazientemente di esser tenuto pazzo e stolido per cagione delle cose di fuori. Anzi se egli ci avrà di quelli che ti stimino uomo da qualche cosa, diffidati di te medesimo. Perché tu déi sapere che egli non si può in un medesimo tempo conservare l'animo tuo disposto e ordinato secondo natura, e provvedere alle cose esterne; ma colui che ha cura dell'una di queste parti, di necessità dee trascurare l'altra. Leopardi, Manuale di Epitteto
Siamo usati di vivere: (Leopardi) abbiamo l'abitudine di vivere trascorrere a lagrime smoderate
E perché anche non vorremo noi avere alcuna considerazione degli amici; dei congiunti di sangue; dei figliuoli, dei fratelli, dei genitori, della moglie; delle persone familiari e domestiche, colle quali siamo usati di vivere da gran tempo […] Né lasciarsi vincere dalla pietà e dal cordoglio in guisa, che egline sia perturbato, che dava a terra, che ceda e che venga meno come vile, che si trascorra a lagrime smoderate. Leopardi, Operette morali, Dialogo di Plotino e Porfirio
ATTI METAFISICA.indd 21 16/06/11 17.05
22 paola italia
9 dicembre 1909 Voltaire – Oeuvres complètes
22 dicembre 1909 Pulci – Il Morgante maggiore
10 gennaio 1910 “Journal des savants” degli anni 1892 e 1908 10 gennaio 1910 Salomon Reynach – Les origines des Aryens
24 gennaio 1910 M. Maeterlink – Théatre, vol. I e III
Questi invece i volumi presi in prestito genericamente da “de Chirico”:
10 settembre 1909 Anatole France – Thais 24 settembre 1909 Anatole France – La vie de Jeanne d’Arc 24 settembre 1909 Histoire de la vie de Fr. Bacone 24 settembre 1909 hegel – Filosofia 10 novembre 1909 Esiodo – Teogonia 10 novembre 1909 Pluche – Concorde de la géographie [1765]
Da questi nuovi materiali abbiamo alcune conferme (come le Argonautiche di Apollonio Rodio e il già citato Morgante maggiore del Pulci) e molti elementi di novità, che polarizzano le letture di questo periodo intorno a tre direttrici, diverse e intrecciate fra loro:
1. letture di formazione linguistica e letteraria (Carmi di Tirteo, Cyrano de Bergerac, Morgante di Pulci, Argonautiche di Apollonio Rodio).
2. letture di formazione filosofica, che iniziano da Vico, Voltaire, hegel, Bacone, si incrociano con la lettura di Nietzsche, nell’estate 1909, e continueranno negli anni successivi a dare linfa alla produzione pittorica e letteraria di de Chirico e Savinio (da Weininger a Schopenhauer).
3. letture funzionali alle opere musicali composte e/o progettate (Nerone di Boito, teatro di Maeterlink e le biografie per il Poema Fantastico).
Tra questi titoli ne spicca uno che ci rimette sulle tracce di Leopardi, anche se non esplicitamente: la Teogonia di Esiodo. Testo affine a Savinio e de Chirico per il magistero sapienziale che ricopre nella storia della letteratura greca e per quella volontà di inserire la propria storia individuale nella storia del mondo e di fare della propria autobiografia una mitologia assoluta.
I primi 72 vv. della Teogonia (parte delle Opere e i giorni), ovvero la Titanomachia, vengono tradotti da Leopardi, all’età di diciannove anni, in endecasillabi sciolti e pubblicati sullo “Spettatore italiano” il 1 giugno 1817. Qui troviamo passaggi già metafisici come i vv. 9-10: «nascosti da molte nebbie andavano le muse notturne», oppure la dichiarazione dei poeti di saper dire «molte menzogne simili al vero» (v. 27), da cui si conferma ancora una volta come Leopardi sia maestro di lingua e stile, ma anche collettore di entrambe le direttrici, artistica e filosofica, dell’arte metafisica. Un’arte in cui la ricerca sui testi letterari e la loro trascrizione e traduzione in un nuovo linguaggio letterario e musicale, e in senso più ampio artistico, diventa un’indagine generale per gettare le basi di una nuova “teoria estetica” applicabile a tutte le arti.
ATTI METAFISICA.indd 22 16/06/11 17.05
23 «leggevamo e studiavamo molto»: alberto e giorgio de chirico alla braidense (1907-1910)
Nota bibliografica
Le carte di Savinio sono custodite presso l’Archivio Contemporaneo A. Bonsanti del Gabinetto G.P. Vieusseux di Firenze (qui siglato ACB). Ringrazio la Direzione dell’Archivio e Angelica e Ruggero Savinio per avermi permesso di studiare e pubblicare gli appunti qui presentati.
Nella collana “La Nave Argo” sono usciti finora Hermaphrodito e altri romanzi [Opere I], a cura di Alessandro Tinterri (1996), Casa La vita e altri racconti [Opere II], a cura di Alessandro Tinterri e Paola Italia (1999) e Scritti dispersi (1943-1952) [Opere III], a cura di Paola Italia, Introduzione di Alessandro Tinterri (2004) ed è attualmente in preparazione il volume di Saggi e viaggi [Opere IV].
La ricostruzione della prima formazione dei fratelli de Chirico si legge in Gerd Roos, The Most Profound Music Ever Written (1909-1911) – on the early collaboration between Alberto Savinio e Giorgio de Chirico, in Alberto Savinio, catalogo della mostra, New York, Paolo Baldacci Gallery, aprile giugno 1995, Paolo Baldacci, New York-Milano, 1995, pp. 49-68 e in Giorgio de Chirico e Alberto Savinio: ricordi e documenti, Monaco-Milano-Firenze 1906-1911, Edizioni Bora, Bologna, 1999.
La più aggiornata discussione e ricostruzione dei contenuti del Poema Fantastico nelle sue varie elaborazioni tra il 1907 e il 1910 si trova nel saggio di Gregorio Nardi, qui alle pp. 57-78.
La citazione da Ascolto il tuo cuore, città è tratta dall’edizione Adelphi, Milano, 1984 (20095); la definizione della “funzione Milano” nella narrativa di Savinio e della genesi del testo omaggio alla capitale lombarda, Ascolto il tuo cuore, città, è stata svolta da Giulia Munaretto nella tesi specialistica discussa all’Università di Siena nell’a.a. 2008-2009: Una città personaggio. Storia di Ascolto il tuo cuore, città di Alberto Savinio.
ho ricostruito le letture e il contesto culturale dell’“officina ferrarese” nell’omonimo capitolo del Pellegrino appassionato. Savinio scrittore 1915-1925, Palermo, Sellerio, 2004.
Il rinvenimento dei documenti sulle letture di de Chirico e Savinio alla Braidense è stato possibile grazie alla disponibilità della Dott.ssa Donata Falchetti, che qui ringraziamo.
Sulle ipotesi relative al soggiorno milanese e al trasferimento fiorentino di Giorgio e Alberto de Chirico rimando al saggio di Paolo Baldacci, qui alle pp. 25-55.
L’edizione critica della traduzione leopardiana della Titanomachia di Esiodo è stata pubblicata nel 2005, a cura di Paolo Mazzocchini, presso Salerno (Testi e documenti di letteratura e di lingua, XXV).
ATTI METAFISICA.indd 23 16/06/11 17.05