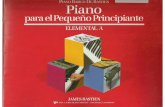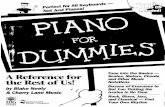Piano dell'opera
Transcript of Piano dell'opera
Piano dell'opera:
STORIA D'ITALIA Voi. I
476-1250
STORIA D'ITALIA Voi. II
1250-1600
STORIA D'ITALIA Voi. I l i
1600-1789
STORIA D'ITALIA Voi. IV
1789-1831
STORIA D'ITALIA Voi. V
1831-1861
STORIA D'ITALIA Voi. VI
1861-1919
STORIA D'ITALIA Voi. VII
1919-1936
STORIA D'ITALIA Voi. Vi l i
1936-1943
STORIA D'ITALIA Voi. IX
1943-1948
STORIA D'ITALIA Voi. X
1948-1965
STORIA D'ITALIA Voi. XI
1965-1993
STORIA D'ITALIA Voi. XII
1993-1997
I N D R O M O N T A N E L L I
STORIA D'ITALIA 178911831
INDRO MONTANELLI
L'ITALIA GIACOBINA E CARBONARA Dal 1789 al 1831
STORIA D'ITALIA Voi. IV
E D I Z I O N E PER O G G I pubblicata su licenza di RCS Libri S.p.A., Milano
© 2006 RCS Libri S.p.A., Milano
I n d r o Montanel l i Eltalia giacobina e carbonara
© 1969 Rizzoli Edi tore , Milano © 1998 RCS Libri S.p.A., Milano
Progetto grafico Studio Wise
Coordinamento redazionale: Elvira M o d u g n o
Fotocomposizione: Corapos 90 S.r.L, Milano
Allegato a OGGI di questa settimana NON VENDIBILE SEPARATAMENTE
Direttore responsabile: Pino Belleri RCS Periodici S.p.A. Via Rizzoli 2 - 20132 Milano
Registrazione Tribunale di Milano n. 145 del 12/7/1948
Tutti i diritti di copyright sono riservati
La Rivoluzione francese prima, la grande avventura napoleonica poi avevano sconvolto e distrutto l'ordine che faceva sopravvivere quegli Stati, staterelli, regni e ducati in cui era
frammentata la penisola. LItalia, come scrisse Stendhal, aveva riassaporato, almeno per quanto riguarda i suoi uomini più illuminati, quel gusto per la libertà che avrebbe segnato la nascita di quel Risorgimento che, tra mille incertezze e tentennamenti, avrebbe portato alla nascita dell'Italia unita, ultima a raggiungere questo traguardo tra gli Stati europei. In questi anni si assiste, infatti, al sorgere confuso e contraddittorio degli ideali risorgimentali. Confuso e contraddittorio perché ancora oggi è difficile individuare con precisione chi volle in realtà questa unità: Casa Savoia ?, i generosi idealisti mazziniani?, le potenze straniere?, la volontà corale di un popolo ? E proprio questo l'argomento principale che viene affrontato in questo libro. La libertà fu perseguita con il sostegno della volontà popolare o le masse rimasero indifferenti o perfino avverse (come nella tragedia della Rivoluzione napoletana del 1799) agli ideali di giustizia e libertà importati d'Oltralpe?
Lltalia napoleonica e repubblicana, quella borbonica del Regno delle Due Sicilie, dello Stato pontificio, del Piemonte sabaudo, dei ducati e granducati e quella dei giacobini e dei carbonari rivivono in modo superbo in questa smagliante ricostruzione che va alla radice degli eterni vizi italiani: l'incostanza nelle scelte, degli alleati, il timore di agire e di scendere in campo, le speranze e i sogni scambiati per realtà, la pavidità degli intellettuali, il cinismo e l'indifferenza di ampi strati delle diverse classi sociali, chiuse in un miope egoismo teso a difendere i propri interessi particolari.
INDRO MONTANELLI (Fucecchio 1909 - Milano 2001) è stato il più grande giornalista italiano del Novecento. Laureato in legge e in
scienze politiche, inviato speciale del «Corriere della Sera», fondatore del «Giornale nuovo» nel 1974 e della «Voce» nel 1994, è tornato nel 1995 al «Corriere» come editorialista. Ha scritto migliaia di articoli e oltre c inquanta libri. Tra i suoi ultimi successi, tutti pubblicati da Rizzoli, ricordiamo: Le stanze (1998), Eltalia del Novecento (con Mario Cervi, 1998), La stecca nel coro (1999), Eltalia del Millennio (con Mario Cervi, 2000), Le nuove stanze (2001).
AVVERTENZA
Nel presentare L'Italia del Set tecento, avevo avvertito il lettore che probabilmente non avrei potuto essere puntuale alla solita scadenza natalizia. E così infatti sarebbe stato, se avessi insistito nella mia idea di dedicare al Risorgimento due volumi. Viceversa, via via che proseguivo nella stesura, vii sono accorto che di volumi ce ne volevano almeno tre. Fermando il primo al 1831, ho potuto arrivare in tempo all'appuntamento.
Qualcuno troverà arbitraria la scelta di questa data. Ma, a, parte il fatto che arbitrarie sono tutte le scelte, mi è parso che questa un suo fondamento lo abbia, e io ho cercato di riassumerlo nel titolo: L'Italia giacobina e carbonara. Che non è ancora quella del Risorgimento, ma è quella che lo prepara.
E un periodo estremamente complesso, specie il primo ventennio napoleonico. E debbo dire che la più grande difficoltà l'ho incontrata appunto nell'annodare ifili delle vicende di cui esso è gremito, in modo che il lettore possa seguirli senza eccessivo sforzo. Credo che siano in pochi ad avere un'idea chiara di quella specie di balletto che Napoleone impose al nostro Paese, facendone e disfacendone gli Stati, fondendoli, dividendoli, trasformandoli da Principati in Repubbliche e da Repubbliche in Regni. Non so se questo libro aiuterà a capirne un po' meglio le «figure». Ma questo è uno dei miei obbiettivi. Ealtro è naturalmente la ricostruzione e l'analisi dei fermenti politici, sociali, culturali che la conquista francese lasciò. E qui si entra in una materia che, anche per la sua vicinanza all'epoca attuale, si presta alle più svariate interpretazioni e quindi alle più accese polemiche. Io ho cercato di non parteggiare. Se vi sia riuscito, non lo so. So soltanto che me lo sono proposto anche col sacrificio di certe mie pregiudiziali. Io vedo nel Risorgimento e in tut-
to quello che lo preparò l'unica cosa nobile e bella che l'Italia abbia fatto negli ultimi quattrocento anni, e non mi sembra di dir poco. Ma ho voluto pormi di fronte ad esso in una posizione spassionatamente critica, denunziandone anche i difetti e le inadempienze. Qualcuno, per esempio, troverà forse un po' impietose le mie riserve sulla Carboneria e i suoi uomini, compresi quelli che subirono il martirio della forca e dello Spielberg. Ma io penso che fra le tante cose che oggi contro il Risorgimento congiurano e ne offuscano gli splendidi valori, ci sia anche l'immagine statuaria che per un secolo ci si è sforzati di dargli. Di ridimensionamenti ne sono già stati fatti molti, perfin troppi, ma di solito con intenzioni che solo per eufemismo si possono chiamare ambigue. Il mio è quello di un uomo che conserva integra la religione del Risorgimento e considera bastardi gl'italiani che non la condividono. Questo tuttavia non m'impedisce di vederne e di farne vedere i limiti. Ce ne furono, purtroppo. E proprio nel periodo d'incubazione che costituisce la materia di questo libro, mi sono sforzato di cercarne i motivi.
Come il lettore vede, sono rimasto solo a proseguire questo ciclo storico. Il mio amico e collaboratore Gervaso ha «messo bottega» per conto suo, ed era logico: ormai ne ha la maturità e la capacità, come si appresta a dimostrare. Gli auguro il più grande successo.
Un'ultima cosa. Mi hanno sempre rimproverato di non aver fornito in questi libri una bibliografia ragionata e argomentata delle opere consultate. Io pensavo - e continuo a pensare - che il vasto pubblico a cui mi rivolgo, non essendo di specialisti, non la esiga. Comunque, stavolta gli ho dato molti più ragguagli del solito, ma sempre rifiutandomi di sommergerlo sotto un diluvio di monografie specifiche, che del resto non sono state scritte per esso, e fra le quali non è verisimile ch'esso intenda ingolfarsi.
Ecco tutto. E ora la parola, come sempre, al lettore. I.M.
Ottobre 1971
CAPITOLO PRIMO
IL C O N Q U I S T A T O R E
L'ultimo capi tolo de L'Italia del Settecento e r a ded ica to alla Francia. Ed è dalla Francia che anche questo vo lume deve p r e n d e r le mosse perché la storia del nostro Paese si fa più a Parigi che a Torino, o a Roma, o a Napoli. L'influsso che la rivoluzione francese esercitò sull'Italia fu d a p p r i m a soltanto ideologico e limitato a quella sparu ta pattuglia d'intellettuali ch ' e rano gli unici in g rado d ' in tenderne i motivi; e di questo pa r le remo più tardi. Ma dal '96 in poi le idee si presenta rono sotto forma di baionet te che misero a soqquadro l'assetto polit ico della penisola r iba l t andone il vecchio equilibr io e lasciandovi, anche d o p o il loro r i t i ro, quei ferment i che di lì a poco avrebbero dato avvio ai moti risorgimentali. Ecco p e r c h é i l quasi ven t enna l e domin io francese fu, p e r l'Italia, di decisiva importanza.
Abbiamo lasciato i rivoluzionari di Parigi al m o m e n t o in cui la loro ghigliottina si abbatteva sul collo del re Luigi XVI e di sua moglie, l 'austriaca Maria Antonietta. Più che dei nemici, essi e r ano rimasti vitt ime degli amici. I nobili fuggiti o l t re f ront iera p e r raccogliere aiuti e r i e n t r a r e in pa t r ia a capo di u n a spedizione punitiva, dicevano di farlo in n o m e del Re, un fratello del quale militava nelle loro file. L'Impera to re d'Austria Leopo ldo , fratello della Regina, e il Re di Prussia, ol tre a p res ta re larga ospitalità a questi fuorusciti, minacciavano d ' i nvade re la Francia se ques ta avesse tor to un capello ai suoi Sovrani. Nell ' interno del Paese, e soprattu t to in Vandea , c ' e rano forti resis tenze al n u o v o reg ime , che si manifestavano con u n a sanguinosa guerriglia. Il Re e la Regina e r a n o n a t u r a l m e n t e sospettati di s tare al giuoco
9
dei nemici di d e n t r o e di fuori. Ma forse a p reg iud ica re la loro sorte n o n fu tanto l'accusa - d 'a l t ronde provata - d'intelligenza coi ribelli, quan to il fatto che la rivoluzione aveva bisogno, come tutte le rivoluzioni, di creare nel popolo u n a psicosi di persecuzione p e r ristabilirne l 'unità. I l d e p u t a t o C o u t h o n lo disse ai suoi elettori: «Per consolidarci ci vuole u n a guerra». II regicidio la r endeva inevitabile e obbligava anche i francesi che lo contes tavano a str ingersi in to rno al nuovo regime.
Fu infatti la Francia a p r e n d e r e l'iniziativa scendendo in campo contro Austria e Prussia. Le d u e Potenze raccolsero la sfida pe rché i fuorusciti assicuravano loro che si sarebbe trattato di u n a passeggiata militare. Invece i d u e eserciti fur o n o fermati a Valmy dall 'artiglieria francese, e più ancora dalla nebbia. Sebbene n o n si trattasse di u n a vera e p ropr ia vittoria, essa fu presenta ta come tale dal governo rivoluzionario e suscitò nel Paese un 'onda ta di patriott ismo che sommerse le opposizioni . Fu in questa surr iscaldata atmosfera che l'Assemblea Nazionale, la quale aveva fin allora esercitato il po te re , si sciolse pe r cedere il posto a una Convenzione, cioè a un Par lamento incaricato di redigere la nuova Costituzione. In esso n o n c 'e rano dei veri e p r o p r i «partiti» nel senso m o d e r n o della parola. Tutti e r ano convinti rivoluzionari e accesi nazionalisti, che volevano la gue r r a a oltranza, e n o n si con ten ta rono di quella difensiva coronata a Valmy. Manda rono il loro esercito a invadere il Belgio, tu t tora possedimento austriaco, la Renania, Nizza e la Savoia, dove fur o n o bandi t i dei plebisciti più o m e n o truccati che sancirono l 'annessione alla Francia. Così la rivoluzione cominciò a traboccare fuori del Paese.
Fu sulla sorte del Re e della Regina che la Convenzione si divise. Fin allora essa era stata domina ta dal g r u p p o dei «Girondini», piuttosto modera t i anche perché rappresentavano gl ' interessi d i u n a classe bo rghese , che n o n voleva spingere la rivoluzione a misure es t reme. Cont ro di essi stava la fazione massimalista dei «Giacobini» o «Montagnardi»
10
che, sebbene anch'essi di estrazione borghese (in tut to quel pa r l amen to n o n c 'erano che d u e popolani) , s i at teggiavano a in terpre t i del proletar iato - i cosiddetti «Sanculotti», cioè gli sbracati - e dei suoi violenti umor i . In mezzo c'era la «palude», cioè gl ' indecisi . F u r o n o cos toro che , lasc iandosene t ravolgere, d i ede ro ai Giacobini la maggioranza necessaria a s t rappare la condanna a mor te .
Sia il Re, ai pr imi del ' 93 , che la Regina, nell 'ot tobre, aff rontarono la ghigliottina con molta dignità. Ma il loro sangue scatenò la violenta reazione di tutta l 'Europa monarchi ca che vedeva in quel l 'episodio la fine del pr inc ip io di sovrani tà pe r diritto divino, su cui tutte le sue dinastie si reggevano. Si formò una coalizione cui ade r i rono anche il Piemonte , lo Stato pontificio e il Regno di Napoli. I vincitori di Valmy furono a loro volta sconfitti e il loro Genera le , Du-mouriez , passò al nemico.
C o m e s e m p r e accade in ques te circostanze, i l per icolo diede ancora più forza agli estremisti che scatenarono un 'ondata di te r rore . Essi redassero u n a Costituzione di contenuto spiccatamente socialista. Ma gli stessi autori si resero conto che la sua applicazione avrebbe provocato la rivolta, e vi r inunziarono pe r concentrarsi unicamente sul problema più urgente: la difesa nazionale. A essa fu preposto un «Comitato di salute pubblica» che, per difendere insieme il Paese dall 'invasione esterna e la rivoluzione dalla dissidenza interna, dovet te r i cor re re alle misure più es t reme. I l g r a n d e pro tagonista di questa fase violenta fu Robespierre che pe r parecchi mesi non diede riposo alla ghigliottina, avviandovi anche i suoi vecchi amici e gli uomini più prestigiosi del regime come Danton, forse il più g rande cervello politico del momento. Alla fine sotto la ghigliottina finì anche lui (1794): un po ' perché anche i suoi complici e collaboratori si sentivano minacciati dal suo crescente satrapismo, un po ' perché di terrore n o n c'era più bisogno: gl'istituti rivoluzionari e rano rinsaldati , e gli eserciti nemici costret t i a subire l'iniziativa di quello francese, forte di 300.000 uomini . Nel '95 la coalizio-
11
ne si e ra sfasciata p e r il r i t iro di Olanda , Spagna e Prussia. In campo restavano solo l ' Inghil terra che pe r il m o m e n t o si limitava a sorvegliare i mari , e l'Austria.
Anche con queste Potenze la pace era a por ta ta di mano . Il p o m o della discordia era soprat tut to il Belgio, che i francesi avevano s t rappa to all 'Austria. Ma questa sembrava disposta a r inunziarvi in cambio di qualche compenso sul Reno , e già pe r questo si e r ano allacciate trattative sotto banco. A Parigi il governo, che allora si chiamava «Direttorio», era or ientato verso la distensione. Con l 'annessione del Belgio, di Nizza e della Savoia, la Francia aveva raggiunto le cosidde t t e «frontiere natura l i» , e po teva cons ide r a r s ene paga . Furono i militari che si opposero a qualsiasi revisione in Renania. Con le vittorie il loro peso era cresciuto, ed essi lo facevano sentire. La diplomazia inglese che n o n voleva le basi navali be lghe a disposizione della flotta francese ne a p p r o fittò pe r r i lanciare la coalizione a t t i randovi la Russia. Così, alla fine del '95, la parola fu di nuovo alle armi .
Sia la Francia che i suoi avversari e r a n o convint i che la campagna si sarebbe svolta in Germania , e lì cominciarono ad ammassare le loro forze. Ma il Direttorio incluse nel suo p iano anche u n a manovra di diversione in Italia che obbligasse l'Austria a dislocarvi par te del suo esercito. Per questo compi to secondar io fu prescel to un Gene ra l e d i a p p e n a ventisette anni : Napoleone Bonapar te .
Non ci sognamo di r icostruirne la storia e la personalità, illus t ra te in migliaia di biografie e in cent inaia di d r a m m i e di film. Napoleone è una delle poche figure, di cui tutti sanno a lmeno le cose essenziali: ch 'era nato in Corsica da una famiglia di o r ig ine toscana, c h ' e r a cap i t ano di ar t igl ier ia q u a n d o scoppiò la rivoluzione di cui si mise subito al servizio, che si e ra dis t into r e p r i m e n d o sp ie t a t amen te coi suoi cannoni i moti controrivoluzionari di Tolone, che doveva la r ap id i t à della sua c a r r i e r a all 'amicizia di Robesp i e r r e , la quale poi gli e ra costata il «siluramento».
12
A r ipor tar lo a galla e rano stati un po ' gli avvenimenti politici, un po ' gl ' intrighi d'alcova. Dopo la l iquidazione di Robesp ie r re , i cont ror ivoluz ionar i avevano rialzato la cresta. Anche a Parigi ci furono dei moti , e pe r schiacciarli nessuno aveva le carte più in regola di Napo leone che già in questo g e n e r e di operaz ion i aveva da to p rova dei suoi talenti . Li confermò a m m u c c h i a n d o sui selciati di Parigi t recento cadaveri , e pe r di più en t rò nelle grazie di u n o dei più potenti m e m b r i del Direttorio, Barras , sposandone l 'amante, Giusepp ina Beauha rna i s , vedova d ' u n al tro Genera l e , che da b u o n a moglie francese aveva l 'abi tudine di t rad i re i p rop r i marit i , ma anche di aiutarli nella carr iera . Q u a n t o essa abbia influito nella n o m i n a del Bonapa r t e a c o m a n d a n t e del c o r p o di spediz ione des t ina to all ' I talia, n o n si sa. Ma che v'influì, sembra accertato.
Era il marzo del 1796. Ques to corpo di spedizione e ra composto di 30.000 uo
mini , che a veri e p r o p r i soldati somigliavano poco. E rano ancora di quelli che il governo r ivoluzionario, con le casse vuote, aveva spedito sulle frontiere p e r pa r a r e l 'aggressione con l 'ordine di ar rangiars i , cioè di man tene r s i da soli sulle r isorse dei t e r r i to r i occupat i . Versavano in tali condiz ioni che gli storici francesi h a n n o dedicato add i r i t t u ra dei libri alla descrizione delle loro dilapidate uniformi e dei loro modi inselvatichiti. Vivevano di r ap ine come u n ' o r d a barbar i ca, e Alfieri li chiamò «un pidocchiume».
Bonapar te n o n si lasciò sgomentare dall 'aspetto di questi miserabili «capelloni» in stracci e ciocie, q u a n d o il 2 marzo ne assunse a Nizza il comando , sebbene anche a lui il Direttor io avesse de t to di a r rang ia r s i sia pe r i r i forn iment i che pe r la «cinquina». Sapeva che pe r questo poteva contare sull 'eccezionali qual i tà organizzat ive d i un suo c o m p a e s a n o còrso, Saliceti, che lo aveva accompagnato , anzi che lo aveva p recedu to in qualità di «Commissario». I Commissari e rano agent i di fiducia che il governo rivoluzionario metteva alle calcagna dei capi mili tari con compi t i vari d i p r o p a g a n d a
13
fra le t r u p p e , di consulenza politica, ma soprat tu t to di sorveglianza: molti ufficiali e r ano di sent iment i monarchic i , e talvolta sabotavano gli o rd in i o passavano al nemico, come aveva fatto Dumour i ez . Ma fra B o n a p a r t e e Saliceti i r a p por t i n o n e rano questi. Legati da u n a vecchia amicizia di famiglia, avevano en t rambi fatto pa r te del clan di Robespierre , si e r ano rec iprocamente aiutati nei t rambust i della rivoluzione e nei repentagl i delle «purghe», insomma erano , da buoni còrsi, «compari».
Ment re Saliceti sfamava quel l 'orda con implacabili requisizioni e l 'equipaggiava con t ra t t ando sulla p rop r i a responsabilità un pres t i to con le b a n c h e di Genova , N a p o l e o n e metteva a p u n t o il suo p iano, senza tener il m e n o m o conto degli ordini ricevuti. N o n era affatto disposto a fare il compr imar io dei suoi colleghi Hoche e Moreau , prepos t i all 'esercito che operava in Germania . Pur al comando di quelle scalcagnate forze, la c a m p a g n a era ben deciso a risolverla lui, d iven tandone il protagonista . In cuor suo aveva già disobbedito, e seguiterà a farlo senza esitazioni, me t t endo reg o l a r m e n t e i l Di re t tor io di f ronte al fatto c o m p i u t o : ma compiuto con la vittoria.
Il t e r r eno lo aveva già coscienziosamente studiato all'Istit u to Topograf ico d i Parigi . O r a s tudiava, sui r a p p o r t i de i suoi in fo rmator i , lo s ch i e r amen to nemico p e r t rova re i l p u n t o più favorevole a r o m p e r n e il fronte. Questo schieram e n t o d isponeva di 60.000 uomini , i l d o p p i o dei suoi. Ma metà e rano austriaci, metà piemontesi , che collaboravano al solito modo , cioè diffidando gli uni degli altri. Il p u n t o debole era la loro saldatura, cioè la loro mancanza di saldatura. Costeggiando il colle di Cadibona fra le Alpi e il mare , ci si poteva insinuare t ra loro e affrontarli separa tamente .
Il 28 m a r z o B o n a p a r t e lanciò ai suoi soldati i l famoso p roc lama : «Voi siete n u d i e affamati. . . Io voglio c o n d u r v i nelle più fertili p i anure del m o n d o . Vi t roverete gloria, onore , ricchezza...» Queste sono le parole registrate all 'anagrafe della Storia. In real tà p a r e che l 'ult ima frase suonasse: «Vi
14
t rove re t e glor ia e p r eda» , che s ' in tonava mol to megl io ai sent imenti di quegli uomini . C o m u n q u e , fu in questo senso ch'essi in te rp re ta rono l 'appello.
Ma d i p roc lami , N a p o l e o n e ne f irmò c o n t e m p o r a n e a men te anche un altro, in cui c'era probabi lmente lo zampino di Saliceti, alle popolazioni piemontesi : «Il Governo della Repubblica saprà r iconoscere in ogni m o m e n t o i popol i che sono pron t i a scuotere, con u n o sforzo generoso, il giogo della tirannia!...»
La politica del Bonapa r t e nel nos t ro Paese n o n riuscirà più a liberarsi da questa contraddizione, e pe r vent 'anni gl'italiani n o n s a p r a n n o se Napo leone li scuote dai gioghi o li tratta da p reda .
CAPITOLO SECONDO
LA PREDA
La comparsa di Napo leone rimescolava tut to l'assetto degli Stati italiani, che da mezzo secolo n o n aveva più subito t raumi. Richiamiamolo r ap idamen te alla memor ia del lettore.
I Savoia regnavano sul Piemonte e la Sardegna. La Lomba rd i a e ra u n a provincia austr iaca. Genova serbava la sua autonomia . Il Veneto faceva Repubblica con Venezia e il suo res iduo strascico di «dipendenze» istriane e da lmate fino a Corfù. A sud del Po sopravvivevano i vecchi Ducati di Parma e Piacenza sotto i Borbone , e di Modena e Reggio sotto gli Este, senz 'al t ro avvenire che il loro passato. Poi cominciavano le «Legazioni» (Ferrara, Bologna ecc.), p u n t a avanzata degl i Stati pontifici che ing lobavano R o m a g n a , Marche, Umbr ia e Lazio. La Toscana faceva ancora Granduca to sotto la dinast ia dei L o r e n a , ma con l 'eccezione di Lucca, Repubblica ind ipenden te . Dall 'Abruzzo in giù era tut to Regno delle Due Sicilie, o Reame come si chiamava pe r an tonomasia, sotto la dinastia dei Borbone di Napoli .
II deus ex machina, lo Stato-guida di questa costellazione era l'Austria, d i re t tamente p a d r o n a della Lombardia , indirettam e n t e della Toscana p e r c h é i l G r a n d u c a appa r t eneva alla stessa casa del l ' Imperatore di Vienna, anzi era suo fratello, e del Reame, che la regina Maria Carolina, a sua volta zia dell ' Impera tore , aveva sottratto all 'influenza dei Borbone spagnoli, cui suo mari to Ferd inando appar teneva, pe r metterla sotto quella degli Asburgo-Lorena. Questo groviglio dinastico è piut tos to complicato, lo sapp iamo. Ma chi voglia meglio informarsene p u ò rifarsi alla nostra Italia del Settecento, dove ne abbiamo ritessuto più dettagliatamente la t rama.
17
Era u n a tipica s is temazione da ancien regime, in cui gli Stati venivano considerati pa t r imonio personale dei vari titolari, che ogni tanto addir i t tura se li barat tavano come fattor ie . In essi n o n c 'era pos to p e r altr i p ro tagonis t i che i l Principe, laico o ecclesiastico che fosse. Anche là dove vigeva un regime repubbl icano - come a Venezia, a Genova e a Lucca - , i l potere s ' incarnava in un piccolo g r u p p o di uomini o di famiglie che lo esercitavano come loro esclusivo monopolio. Il po te re era tut to, e tutto era del potere . Anche la cu l tu ra e ra r imasta legata al suo ca r ro , e la massa, ol t re a n o n avere s t rument i pe r esprimersi (istituti rappresentat ivi , part i t i politici, giornali) , n o n aveva n e m m e n o la coscienza di sé e un alfabeto con cui formarsela e manifestarla.
Ma qui occor re u n a breve p a n o r a m i c a della s i tuazione sociale perché fu p ropr io su di essa che l'esercito rivoluzionario di Napoleone , a differenza di tutti gli altri invasori che nei secoli lo avevano preceduto , agì da e lemento catalizzatore c reando , in con t rappos to al Principe, un nuovo interlocutore: la pubblica opinione. Che questa fosse più ostile che favorevole ai nuov i venu t i , con ta poco. Ciò che conta è ch'essi la evocarono e la ch iamarono nel giuoco politico.
«L'opinione dei milanesi nello spazio di un mese è cambiata ed un avvenimento [la rivoluzione francese}, che dappr inc ip io fu accolto con ammiraz ione e con giubilo, poco d o p o si r igua rdò con dileggio e come una pubblica sciagura» scriveva con amarezza Pietro Verri nei suoi Pensieri sulla rivoluzione. La sua diagnosi era sostanzialmente esatta, e n o n si applicava soltanto a Milano. In tut ta Italia, all'iniziale onda ta d 'entusiasmo per le g rand i notizie che g iungevano da Parigi, ne era seguita u n a di sbigot t imento . Ed è facile r i cos t ru i rne i motivi.
La r ivoluzione francese, m a l g r a d o cer te sue v e n a t u r e proletarie e socialiste, era un fatto essenzialmente borghese. Ma in Italia di borghesia ce n 'era poca e di poco peso. Quella che si e ra formata nell 'età comuna le del Tre e del Qua t -
18
t rocen to si e ra sbriciolata sotto i regimi spagnol i e con t ro riformisti che avevano res taurato un tipo di società feudale. La scoper ta del l 'America che aveva spos ta to i traffici dal Medi te r raneo all'Atlantico e l'inflazione dovuta all 'alluvione del l 'oro e del l ' a rgento amer icani avevano rovinato i nostr i ceti industriali e mercantili . E la Contror i forma li aveva mor a l m e n t e scredi tat i r i p r i s t i nando i valori del s angue e del r ango al di sopra di quelli economici e culturali. Ment re nell 'Europa r iformata l ' imprendi tore p r endeva i l sopravvento sul nobi le , i m p o n e n d o i suoi valori - il lavoro e il r i spar mio -, in Spagna e in Italia era il nobile ter r iero e reddi t iero che p rendeva il sopravvento sul l ' imprendi tore facendo dell'ozio e del fasto un criterio di distinzione sociale.
Nel Settecento un po ' di ceto med io s i e ra r i formato, ma n o n d a p p e r t u t t o e n o n in m o d o omogeneo . Come abbiamo det to nel volume dedicato a questo secolo, solo in Lombar dia si poteva par la re di un capitalismo industr iale . A dargli avvìo e r a n o stati quei fittavoli che, d o p o aver esercitato le loro capaci tà i m p r e n d i t o r i a l i nel la cascina - c h ' e r a a n c h e u n a piccola industr ia di t rasformazione - , avevano impiantato fabbriche e manifa t ture in città. N o n esager iamone la p o r t a t a . Que l l a l o m b a r d a e r a a n c o r a u n a società d i t ipo spagnolesco, cioè domina ta dall 'aristocrazia e dai suoi interessi e privilegi. Però accanto ad essa s'era formato un ceto borghese , che cresceva in p roporz ione alla sua forza economica.
Di ques to ceto ce n ' e r a a n c h e in Toscana, ma aveva tut t 'a l tre origini e att i tudini. Qu i e rano gli stessi terr ier i che, spintivi dalle i l luminate r iforme di Pietro Leopoldo , si erano fatti imprendi tor i , ma r i m a n e n d o terrieri . La fattoria toscana era diventata, pe r quei tempi , un model lo d ' impresa agricola, ma n o n ne varcava i limiti. A differenza della cascina l ombarda , n o n svi luppava indus t r ie di t rasformazione . Era la cabina di c o m a n d o di un «padrone» che i l c o m a n d o lo esercitava di persona , impegnandos i nelle sue t e r re , migl iorandole , ce rcando di cavarne i l massimo, ma anche in-
19
vestendovi tutti gli utili che ne traeva. Fabbriche in città n o n ne impiantava. Anzi, m e n t r e in Lombard i a l ' imprend i to re spremeva la te r ra pe r fondare la manifat tura in città, in Toscana il professionista, l 'artigiano e il mercan te arricchiti in città investivano il loro capitale in te r ra e acquistavano mentalità e costume di terrieri .
Ogn i r eg ione i n somma aveva un suo t ipo d i borghesia . In Piemonte la formavano i funzionari dello Stato. A Roma, i notai e impiegati della Curia. Nel Sud, gli avvocati. E oltre alla povertà dei suoi ranghi e dei suoi conti in banca, anche questa diversità di formazione, e quindi anche di vocazioni, cont r ibuiva alla sua debolezza. L ' imprend i to re mi lanese aveva poco in c o m u n e col «paglietta » napo le t ano e quest i col bot tegaio f iorentino. Ma a ostacolare la nascita fra loro di u n a coscienza di classe e di u n a c o m u n i t à d ' in teress i e d ' intenti c 'erano anche altre d u e circostanze.
La p r ima e ra il pol icentr ismo italiano. L'elaborazione di un pens i e ro o di un m o v i m e n t o è facile là dove u n a sola città è in g r a d o di dec idere p e r l ' intera nazione. In queste condizioni, grazie ai suoi lunghi secoli di storia unitaria, era la Francia. Parigi aveva dato e dava a tut ta la borghesia francese u n o s tampo omogeneo , il pun to d ' incontro, il costume, il l inguaggio. Tut to era nato lì, e tut to lì si decideva. In Italia questo mancava. La nobiltà aveva i suoi centr i di po te re nelle varie Corti . Il clero lo aveva nella Curia. La borghesia non lo aveva.
L'altro mot ivo di debolezza e ra i l suo i so lamento . In Francia e in Inghi l ter ra essa attingeva la sua forza alle classi popolar i con cui aveva instaurato dei rappor t i di cul tura. In questi paesi, grazie alla diffusione dell'alfabeto, l 'intellettuale si e ra scosso di dosso la d i p e n d e n z a dal p o t e n t e che un t e m p o lo f inanziava pe r tener lo asservito al suo ca r ro . Or mai gli bastavano i diritti d 'au tore , cioè i provent i che gli venivano dalla vendita delle sue opere . Da allora si e ra abituato a p a r l a r e al «pubblico», e il pubbl ico si e ra ab i tua to ad ascoltarlo. Così si e ra formata quella meravigliosa uni tà di
20
l inguaggio che in Francia fa tu t t ' uno fra l ingua scritta e lingua parlata. E così i valori ideali della borghesia - la libertà, la giustizia, il p rog res so - e r a n o d iventa t i p a t r i m o n i o del popo lo , che p e r essi salì sulle ba r r i ca te e li fece t r ionfare . Che in segui to la borghes ia li abbia t radi t i o sacrificati ai p rop r i egoismi, è un altro discorso, che r iguarda il poi. Alla vigilia e al m o m e n t o della r ivoluzione, borghesia e popolo furono insieme perché già da un pezzo lo e rano , grazie alla cultura.
In Italia queste condizioni mancavano totalmente. Ol t re ad essere pochi , e te rogene i e poveri , i borghesi e r ano soli. Un colloquio con le masse n o n avevano mai p o t u t o istaurar lo perché ne mancava lo s t rumento fondamentale : l'alfabeto. La Chiesa, che aveva il monopol io dell ' istruzione scolastica, n o n aveva sentito il bisogno di diffonderlo, da quando il Concilio di T ren to aveva fo rma lmen te r ibadi to che il c r eden t e n o n aveva affatto i l dovere , anzi n o n aveva n e m m e n o il dirit to di leggere e d ' in te rpre tare le Sacre Scritture. Di esse si era perfino proibita la t raduzione in l ingua italiana a p p u n t o pe r r iservare al p re te il compito di decifrarle. Il Verbo doveva restare un'esclusiva di casta, e la cul tura si era adegua ta al sistema. Essa e ra diventata un circolo chiuso e asfittico di «iniziati» che si par lavano solo t ra loro nell 'ambito delle «Accademie» finanziate dal po t en t e . «A che scopo scrivere libri se n o n ho più a chi dedicarli?» diceva Frugoni , caduto in disgrazia presso i suoi protet tor i . Infatti, anche se li avesse scritti, n o n avrebbe avuto di che pubblicarli pe rché alle spese di s tampa e ra d 'uso che provvedesse il destinatario della dedica - di solito un Principe o un Cardinale -, non essendoci un pubblico in g rado di acquistarli.
Era ques ta m a n c a n z a d i u n a cu l tu ra m e d i a (che quel la accademica anco r oggi segui ta s t u p i d a m e n t e a spreg iare) che isolava la borghesia, le impediva di allacciare il dialogo con le classi popo la r i e di suscitarvi un ' eco . Verri lo aveva capito. «Se n o n s'illumina p r ima la plebe - aveva scritto nei suoi Pensieri -, s'ella n o n costringe poi i nobili a piegarsi, u n a
21
rivoluzione non p u ò da noi cagionare che rapine e saccheggi.» Ma ques ta i l luminaz ione n o n s i po teva o p e r a r e d ' u n trat to, g i rando l ' in terrut tore . Francia e Inghi l te r ra ci avevano messo più di d u e secoli: i d u e secoli che noi avevamo impiegato a fare della cul tura un'esclusiva di pochi, anzi di pochissimi: u n a mafia al servizio di quel la del p o t e r e . Fra la cul tura e il popolo n o n c'era più in c o m u n e neanche la lingua. Ment re in Francia si scriveva quella di Voltaire, in Italia si scriveva quella di Vico. Il lettore le met ta a confronto.
Per le gambe di un intellettuale così condizionato, l'Illuminismo rappresentava il passo più lungo. Esso gli pe rmet teva di assumere un'et ichetta «progressiva», ma al r iparo da qua lunque accusa di eversione. Gl'illuministi n o n e rano dei rivoluzionari. Non volevano affatto dis t ruggere l 'ordine costituito. Sia il Verri , q u a n d o reclamava il riassetto mone ta rio in Lombard ia , che il Beccaria, q u a n d o chiedeva l'abolizione della p e n a di mor te , collaboravano col po tere , e pensavano più a inserirvisi che a sovvert ir lo. E r a n o i n somma dei «moderati» avanti lettera, né altro potevano essere pe r i motivi che abbiamo det to : e rano pochi, e r ano soli, non potevano contare su nessun appoggio popolare , e quindi il potere restava l 'unico loro sostegno e l 'unico loro interlocutor e . Il lo ro g io rna le , II Caffè di Milano, n o n si r ivolgeva al pubblico (che n o n c'era), ma ai pad ron i del vapore (austriaci), p e r spinger l i a p r e n d e r e le mi su re ch 'esso r i teneva le più efficaci pe r l ' a m m o d e r n a m e n t o , e qu ind i p e r il po tenziamento, del «sistema». Era una collaborazione che, anche q u a n d o assumeva toni di critica vivace, n o n diventava mai contestazione. Non poteva diventarlo perché gliene mancava la fondamenta le a r m a di r icatto: l 'appello alla pubblica opinione.
Ecco perché la rivoluzione francese aveva suscitato quell e d u e o n d a t e d i sen t iment i con t r add i t t o r i . Dappr inc ip io l 'opin ione borghese che , in mancanza d i quel la popo l a r e , e ra l 'unica a potersi qualificare «opinione», vide nei fatti di Parigi i l c o r o n a m e n t o del sogno illuministico di un po t e r e
22
che l iquidava le sue b a r d a t u r e feudali pe r darsi un assetto più funzionale e m o d e r n o , basato sulla libertà e la giustizia. Alfieri innalzò un inno a Parigi sbastigliata, e perf ino un poeta t imido e t imora to come Ippol i to P i n d e m o n t e le ded icò un poema.
Ma q u a n d o cominciarono ad arr ivare le notizie delle barricate, del sangue, del Re fatto pr igioniero, dei pret i costrett i a l l ' ab iura , la cu l tu ra i tal iana inor r id ì . N o n a v e n d o mai servito il popolo, ma solo il potere , nel m o m e n t o del pericolo si sentiva più solidale col po te re che col popolo . Ancorata c o m ' e r a a u n a t rad iz ione cor t ig iana , cosa avrebbe fatto il g iorno in cui le Corti fossero venute a mancarle? Principi e Prelati e r ano la sua unica clientela. Poeti, letterati, scultori, pittori, architetti n o n avevano mai lavorato che pe r loro. Far causa c o m u n e col p o p o l o n o n e r a n e a n c h e un salto nel buio, ma un salto nel vuoto perché i l popolo n o n c'era. C'era soltanto u n a plebe analfabeta, in s t ragrande maggioranza contadina e quindi refrattaria a esigenze di modern i t à e di progresso.
Infatti, p r ima che le a rmate francesi si affacciassero sulle Alpi, veri e p rop r i contraccolpi rivoluzionari in Italia n o n ce ne furono . In P iemonte si manifestò qualche agitazione di proletar iato scontento che inviò u n a petizione al Re perché riducesse gli abusi dei nobili e addossasse anche a loro u n a par te del peso fiscale. «Non vogliamo esser piemontesi , siam francesi!» dicevano i sottoscrittori. Un analogo gr ido - «Vu-l imme fa' come li francise!» - r iecheggiò in Basilicata, dove fu bandi to u n o sciopero di contr ibuent i . Ma è inutile cercar di maggiora re , come fanno certi nostri storici, il significato di questi episodietti. Sotto di essi covava soltanto il solito spirito pro tes ta tar io delle masse italiane, capaci di tumul t i , al massimo di rivolte, ma n o n di rivoluzioni. Per r ivoluzione, esse in tendevano l'evasione fiscale.
Ma le cose c a m b i a r o n o q u a n d o , o l t re che con le idee , la Francia bussò alle p o r t e d ' I tal ia coi suoi soldati. Come ab-
23
biamo già det to, essa n o n si contentò di respingere a Valmy il p r imo tentativo d'invasione compiuto da Austria e Prussia per res taurare a Parigi il vecchio regime. I suoi eserciti passa rono all'offensiva, invasero il Belgio e la Renania , e con un colpo di mano occuparono la Savoia e Nizza.
Quest i successi n o n r imasero senza effetti. Ma qui bisogna in tenderci fuori di ogni facile retorica e mitologia. L'Italia era abituata a far da «premio del vincitore» còme diceva Voltaire. Fin dai tempi di Carlo VI I I , cioè da quasi tre secoli, ogni invasore ci aveva sempre t rovato u n a «quinta colonna» p r o n t a a secondar lo un po ' p e r accapar ra r s i u n a compartecipazione agli utili della vittoria, un po ' nella speranza che il p a d r o n e nuovo fosse migl iore e p iù generoso - o più raggirabile - di quello vecchio. Fin d 'allora infatti i veri «partiti» italiani e r ano stati quello francese, quello spagnolo e quel lo aus t r iaco. N e s s u n o di essi aveva u n a base ideologica, né poteva averla pe r ché queste t re Potenze incarnavano lo stesso tipo di regime, basato sull'assolutismo e sui privilegi di casta.
Stavolta la cosa e ra diversa . Nella «quinta colonna» di s impatizzanti della Francia, forse c 'era qua lcuno che su di essa p u n t a v a p e r i l solito des ider io di t rovars i dalla p a r t e del vincitore. Ma c 'erano anche quelli che a tale scelta e rano stati indotti da altri e più nobili motivi. Essi sentivano, o speravano, che un' invasione francese n o n si sarebbe risolta solt an to nel solito cambio d i p a d r o n e , ma avrebbe sconvolto tut to l'assetto italiano. Si trattava solo di u n a sparuta minoranza d'intellettuali. Ma c'era. E la sua presenza documentava l ' incr inatura , des t inata a t rasformarsi con lo svi luppo degli avvenimenti in ro t tura , che si era verificata nel fronte della cosiddetta intellighenzia italiana.
P rònuba dello scisma fu soprat tut to la Massoneria. Lungo tut to il Settecento essa era rimasta divisa in varie corrent i ideologiche, ma n o n c'è dubb io che ad avervi i l sopravvento e r a n o quelle i l luminist iche: t an t ' è vero che vi e r a n o iscritti dei sacerdoti , degli ufficiali, dei funzionari , perf ino
24
dei Sovrani. Non aveva nessuna uni tà organizzativa, seguiva riti diversi, e forse il suo successo era dovuto più che alt ro agli oscuri simboli e alle complicate liturgie, che davano agl'iniziati il brivido del mistero. Ma a par t i re dall '89 le logge francesi si t r a s fo rmarono in centra l i r ivo luz ionar ie , il contagio su quelle i tal iane fu immedia to , e a l t re t t an to immedia ta fu la reazione dei governi. Da tollerate e in qualche caso addi r i t tura incoraggiate e prote t te , le logge si t rovarono perseguitate. E ciò pose i loro aderent i di fronte all'alternativa: o r i en t ra re ne l l 'o rd ine accet tando quello costituito, o saltare il fosso sposando la causa rivoluzionaria. Scegliere la p r i m a s t r ada significava c o n f e r m a r e la p r o p r i a fiducia nelle capacità evolutive e riformistiche del vecchio regime: e questa era la posizione «moderata». Scegliere la seconda significava scendere col vecchio reg ime in u n a lotta a ol tranza: e questa era la posizione democrat ica o giacobina.
I p iù scelsero la p r ima n o n solo pe rché era la m e n o scom o d a e rischiosa, ma anche la più congeniale alla tradizione cort igiana e conformista del pens iero italiano. Un alibi tuttavia lo avevano, di cui n o n si poteva contestare la fondatezza: che rivoluzione - essi dicevano r iecheggiando il Verri -si p u ò fare senza le masse , e dove sono in Italia le masse p ron t e a raccogliere un messaggio rivoluzionario? Il seguito degli avvenimenti avrebbe dimostra to anche t roppo la validità di questa obbiezione.
Coloro che scelsero la seconda strada, i «giacobini», avevano della s i tuazione un ' idea mol to p iù astrat ta , che stava p e r avviarli alle p iù cocenti delusioni . N o n misu ravano la p r o p r i a sol i tudine e r i p o n e v a n o nella Francia u n a f iducia che sarebbe stata la rgamente t radi ta . Ma u n a cosa avevano capito, la cosa fondamentale : che le s t ru t ture degli Stati tradizionali n o n e r a n o r i formabil i dal d i d e n t r o . Bisognava spazzarli via, tutti , con un 'az ione violenta, dal basso: il che c o m p o r t a v a u n a visione, come oggi s i d i r ebbe , «globale», cioè nazionale, del p rob lema italiano.
I debut t i di questa nuova forza fu rono , com 'e ra logico,
25
infelici. Il processo di chiarificazione ideologica si o p e r ò lentamente attraverso dibattiti spesso oziosi e confusi. E i pr imi assaggi di azione politica, p r i m a del l 'a r r ivo di Napo leone , r ive la rono l ' immatur i t à e spesso anche la fragilità m o r a l e dei loro autori . Ci limitiamo agli episodi salienti.
Era fatale che il «via» venisse dal P iemonte , lo Stato più vicino alla Francia e più d i re t tamente esposto alla minaccia dei suoi eserciti. Qui la scelta era peren tor ia e n o n si poteva l imi tare al p i ano ideologico: o con la pa t r i a p i emon te se o con la Francia r ivoluzionar ia , anche se nemica . Le logge masson iche di Alba, Asti, Vercelli, Nova ra d i v e n t a r o n o i centr i di un vero e p r o p r i o complot to . I congiura t i si p r o ponevano , q u a n d o l'esercito francese avesse preso l'offensiva, d ' impadroni rs i con un colpo di m a n o della cittadella di Torino, sequestrare il Re e proc lamare la Repubblica.
Dubi t iamo molto che ci sa rebbero riusciti pe rché , come poi si vide, i cospiratori n o n avevano nessun seguito nel popolo e tanto m e n o nelle t r u p p e . C o m u n q u e , la polizia n o n gli det te il t e m p o di tentare . Uno dei capi, il Barolo, cedet te sotto g l ' in ter rogator i e rivelò il p iano e i nomi dei partecipant i . Alcuni r iuscirono a fuggire e a riparare ol t ralpe. Gli altri finirono in galera e d u e sulla forca.
Analoga sorte sub i rono i loro confratelli di Napol i . Anche qui, secondo il model lo francese, a lcune logge si e r ano trasformate in clubs sotto la regia di un abate, il Je rocades , e di un nobile, il Lauberg . Ques to è abbastanza significativo: d imostra la pover tà e debolezza della borghesia meridionale, costretta a cedere alla nobiltà e al clero anche l'iniziativa rivoluzionaria. I clubs poi si fusero in u n a «Società Patriottica» che cercò di svolgere ope ra di proselitismo fra le masse popolari , ma senza sortire altro risultato che quello di scatena re i furori della polizia. La repress ione fu du ra . Il ministro Medici che tentò di addolcirla ci rimise il posto e finì in galera anche lui. Anche qui molti arrestat i d e n u n z i a r o n o i p rop r i compagni , tre dei quali salirono il patibolo. U n o solo, De MeOj d iede prova fino in fondo di stoico coraggio.
26
Di conat i ce ne furono altri , qua e là. A Bologna lo studen te Zamboni , che aveva fatto il suo apprendis ta to rivoluzionario a Marsiglia, cercò di reclutare adept i pe r un ' insurrezione, e anzi si dice che la coccarda ch'egli distribuì come distintivo sia stata il p r imo tricolore. In realtà si trattava invece d ' un bicolore, bianco e rosso. Il g iorno stabilito pe r la rivolta n o n si presentò che u n o s tudente di teologia, De Ro-landis, che poi venne impiccato, m e n t r e Zamboni si suicidava in carcere.
Ma forse l 'episodio più saliente, pe rché il p iù indicativo degli umor i popolari , fu quello che si svolse a Roma, nel '93 . Il papa Pio VI era stato esplicito nella condanna del regime r ivoluzionario, e la sua polizia l 'aveva t rado t ta nel l ' a r res to di d u e artisti del la scuola francese. Parigi aveva spedi to a Roma un suo emissario, il giornalista Basseville, a chiedere spiegazioni e a svolgere ope ra di p ropaganda . Come p r ima cosa egli reclamò la sostituzione dello s temma repubblicano a quello monarchico nella sede dell 'ambasciata. La Curia si oppose , e la Francia minacciò rappresagl ie . Stavolta n o n ci fu bisogno di r icorrere alla polizia per d i sperdere il piccolo g r u p p o d'intellettuali che si e ra raccolto in to rno a Basseville. Il popol ino infuriato i r r u p p e nella residenza del francese e lo linciò. Il poeta Monti ne fu entusiasta e sciolse un inno ai massacratori , la Bassvilliana, che a n d ò a ruba: ne furono s tampate e vendute cento edizioni.
N o n c o m p r e n d i a m o p r o p r i o come certi storici possano par la re di un «movimento di vaste proporzioni». Non lo era né po teva esserlo p e r i motivi che abb iamo de t to . Esso emerse come forza politica o p e r a n t e solo q u a n d o po tè appoggiarsi sulle baionette francesi, che furono insieme la sua fortuna e la sua disgrazia. Ma la sua impor tanza n o n sta nel n u m e r o dei seguaci, e n e m m e n o nelle imprese in cui si misurò. Sta nel compito di provocazione che assolse. Di fronte alla sua minaccia, i vari Stati i taliani a b b a n d o n a r o n o ogni p r o g r a m m a di r i forma e b a d a r o n o soltanto a d i fendere le loro ant iquate s t ru t ture con gli appara t i polizieschi. E que-
27
sto obbligò molti uomin i di formazione il luminista e di att egg iament i m o d e r a t i a r o m p e r l a col vecchio r eg ime e a passare sulle posizioni democrat iche.
Ma questo lo vedremo più tardi . Per ora torn iamo a Napoleone, che alla testa dei suoi «capelloni» discendeva il colle di Cadibona. Qual i forze organizzate trovava di fronte a sé?
CAPITOLO TERZO
LA C O N Q U I S T A
La geograf ia c o n d a n n a v a i l P i emonte a subi re p e r p r i m o l'invasione. La storia di questo Stato veniva data da studiare ai giovani diplomatici francesi come il più perfetto modello del doppio giuoco. Per secoli i suoi Duchi e Re si e rano barcamenati p r ima t ra Francia e Spagna, e poi t ra Francia e Austria passando disinvoltamente da un campo all 'altro secondo le convenienze del m o m e n t o . Da un pezzo il loro sogno era la Lombardia . E al Re in carica, Vittorio Amedeo I I I , si e ra p resen ta to i l des t ro di accaparrarsela , q u a n d o , nel '93 , la Francia rivoluzionaria gliel'aveva offerta come p remio di un 'a l leanza con t ro l 'Austria. I l suo avo Emanue le Filiberto p r o b a b i l m e n t e n o n avrebbe esitato. Ma Vit tor io A m e d e o n o n e ra tagliato nella stessa stoffa. O che n o n credesse alla forza della Francia, o che n o n volesse pat teggiare con gli uomini che avevano tagliato la testa al p ropr io Re, declinò l'offerta. E questa r inunzia gli era costata Nizza e la Savoia, che i francesi si e rano affrettati a incamerare .
Aveva cercato di r i farsene lanc iando i l p roge t to di u n a Lega antifrancese fra tutti gli Stati italiani. Ciò gli avrebbe da to fra di essi un r a n g o di capofila, ma a p p u n t o perciò i l tentativo fallì. Esso era diret to ch ia ramente cont ro l'Austria, ma t roppo chiaramente : nessuno Stato italiano era disposto a giuocarsi i favori di quella g r ande potenza pe r a m o r e del piccolo Piemonte: m e n o di tutti i Lorena austriaci di Toscana e i Borbone austriacizzati di Napoli.
La Lega n o n s i fo rmò n e m m e n o o r a che N a p o l e o n e compariva sulle Alpi. Gli Stati italiani ne affrontarono la minaccia più disuniti del solito, e o g n u n o di essi agì pe r conto
29
suo. Na tura lmente e r ano tutti dalla pa r te dei coalizzati, con cui Napoli si schierò a p e r t a m e n t e d ich ia rando alla Francia u n a g u e r r a , sia p u r e sol tanto platonica. Gli altri lo fecero coper tamente cercando di n o n compromet ters i t roppo . Ma per il Piemonte, vie di mezzo n o n ce n ' e rano . Esso si trovava fra i d u e eserciti che stavano pe r affrontarsi. Doveva scegliere. Ma la scelta era pregiudicata dal l 'a t teggiamento che aveva già assunto. L'Austria, che lo sapeva, p romet teva ben poco oltre la resti tuzione, in caso di vittoria, di Nizza e della Savoia, che del resto sarebbe venu ta au tomat icamente . Ma u n a garanz ia al suo Re la forniva: la difesa a o l t ranza del principio dinastico e della monarchia assoluta pe r diritto divino su cui essa stessa si reggeva, e di cui la Francia era invece la negazione.
Perciò Vittorio Amedeo aveva aper to le por te all'esercito aus t r iaco che accor reva dalla L o m b a r d i a e ad esso aveva unito il suo.
Il p r imo era comanda to dal maresciallo Beaulieu e disponeva di 30.000 uomini ; il secondo, di forza pressappoco equivalente, dal maresciallo Colli. T r u p p e eccellenti, le u n e e le altre, ma con d u e difetti: l 'abi tudine alla g u e r r a di posizione , che ne rendeva i movimenti lenti e impacciati; e la mancanza di coordinazione. Abituati ai rovesciamenti di fronte, i piemontesi consideravano gli alleati come potenziali nemici, e a n c h e stavolta avevano r if iutato u n a col laborazione completa.
N a p o l e o n e forse lo sapeva, e c o m u n q u e agì come se lo sapesse. In grave svantaggio numer ico , n o n gli restava che l 'arma della rapidi tà pe r attaccare separa tamente gli avversari e colpirli u n o alla volta. In tre giorni - p r ima a Monte-no t t e , poi a Millesimo, po i a Dego -, r u p p e il f ronte di Beaulieu e ci ficcò un cuneo che lo isolava da Colli. Poi attaccò ques t 'u l t imo aggi randolo sulle ali e sbaragl iandolo a Mondovì. Senza più contatti con l'alleato, i piemontesi erano alla mercé del nemico e si affrettarono a chiedere l 'armi-
30
stizio. Napoleone n o n rispose pe r u n a sett imana, quan to gli bas tò p e r r a g g i u n g e r e Cherasco a 50 km da Tor ino . Di l ì de t tò le sue condizioni, r inviando alla diplomazia di Parigi il negozia to di pace . A lui p r e m e v a n o solo il Col di T e n d a pe r garantirsi le comunicazioni con la Francia e le piazzeforti di Tortona, Alessandria e Cuneo . E se le assicurò.
Beaulieu si e ra at testato sulla riva set tentr ionale del Po, convin to che l 'avversario avrebbe cercato di a t t raversa r lo p e r i r r o m p e r e su Milano. Napo leone ne fece solo f inta lasciando un repar to a costruire ponti di barche. Col grosso, a marce forzate, costeggiando la riva mer id ionale del fiume, si avventò su Piacenza. Vi arrivò in 36 ore , e il Po lo passò lì, p r e n d e n d o lo schieramento avversario a rovescio. Beaulieu gli fece fronte sull 'Adda. Ma Napoleone riuscì a forzare anche il pon te di Lodi, e da quel m o m e n t o fu p a d r o n e di Milano, già investita dal suo genera le Masséna. A Sant 'EIena, r i c o r d a n d o quelle gesta, scrisse: «Fu la sera di Lodi che io mi sono c redu to un u o m o super iore e nacque in me la scintilla dell 'alta ambizione...»
L'ingresso a Milano, il 16 maggio (del '96) fu il suo p r imo g rande trionfo. Ma glielo amareggiò un dispaccio del Direttorio che gl ' ingiungeva di t ra t tare quella città come te r ra di conquista met tendola a sacco in m o d o che si r iducesse a un peso pe r l'Austria q u a n d o gliela si fosse restituita in cambio di qualche provincia tedesca. Era d u n q u e chiaro che la posta del giuoco, per il Direttorio, restava ancora la Germania , che lì si voleva la soluzione della guer ra , e che la campagna d ' I ta l ia e r a cons idera ta un semplice diversivo. Lui, Bonapar te , doveva pensare soltanto a spingersi con le sue colonne verso il Sud della penisola i m p o n e n d o taglie, es torcendo tributi, facendo insomma bott ino pe r contr ibuire alle spese di gue r r a in Germania . Alla sistemazione dei terr i tor i occupati non doveva badare : tanto, dovevano servire solo come articoli di scambio ai negoziati di pace.
Vedremo più tardi come Napoleone si compor tò nei confronti delle province conquis ta te e delle loro popolazioni .
31
Ora seguiamo fino in fondo la sua azione militare. Il nemico bat tuto, in attesa di rinforzi, si e ra asserragliato a Mantova, u n a città-fortezza resa inespugnabile dagli acquitrini che la c i rcondano. Napoleone vi pose assedio, ma senza logorare le sue forze con attacchi impossibili. Bastava già la malaria a decimargliele.
Dal T i ro lo scendeva un n u o v o eserci to aus t r iaco d i 60.000 uomini , guidati da Wùrmser . Avanzava su t re colonne . Napoleone lasciò che quella del comandan t e entrasse a Mantova, e batté le altre due , l 'una a Salò, l 'altra a Lonato : ancora u n a volta aveva compensa to l ' inferiorità n u m e r i c a con la r ap id i t à dei mov imen t i . W ù r m s e r par t ì a l soccorso dei suoi luogotenent i , ma t roppo tardi : a Castiglione fu travolto anche lui.
Ridiscese poco d o p o alla testa di altri 40.000 uomin i , e stavolta imboccò la valle del Brenta . Bonapa r t e lo contra t taccò a Bassano schiacciandolo con t ro l 'Adige. W ù r m s e r riuscì ad at traversare il fiume, ma con le ossa rotte, e dovette nuovamente r inchiudersi a Mantova.
In suo aiuto, l'Austria spedì un terzo esercito al comando de l l ' unghe re se Alvinczy. Era il p iù debole - 30.000 uomi ni -, e p p u r e fu l 'unico che ad Arcole riuscì a t ene r testa a Napoleone . La t rappola che questi gli aveva teso n o n scattò, e Alvinczy, sebbene respinto , po tè rit irarsi ol tre il Bren ta e poi risalire in Ti ro lo , dove si mise alla testa di un 'a l t ra armata, di 45.000 uomini , con cui r i tentò l 'avventura. Ma non aveva capi to la s trategia di B o n a p a r t e , m e n t r e B o n a p a r t e aveva capito la sua. Gli espert i considerano quella di Rivoli u n a battaglia da manua le . Cer to , fu risolutiva. Dei qua t t ro eserciti scagliati in questa fase dall 'Austria pe r r iconquistare l'Italia, non restavano che i brandell i asserragliati a Mantova e r idot t i o r m a i alla fame. La città-fortezza si a r rese . In sette mesi, dal luglio del '96 al febbraio del '97, Napoleone aveva p ros t r a to l 'Austr ia e umil ia to i suoi rivali Moreau e Hoche , che la loro campagna di Germania non riuscivano a risolverla.
32
Napoleone n o n r inunziò a farlo no ta re al Diret torio nel dargli l 'annunzio delle sue vittorie e nel comunicargli la sua intenzione di marc iare su Vienna: che in German ia - diceva - i suoi colleghi r i p r e n d e s s e r o p u r e la loro offensiva: il nemico e ra costretto ad accorrere sul suo fronte. Il compri mar io era diventato protagonista, e imponeva le p ropr ie direttive ai protagonist i diventati comprimar i .
I l suo p i ano sembrava folle. Da Vienna lo s epa ravano 800 chilometri quasi tutti di montagna , e pe r di più si trovava di fronte il più g r ande generale austriaco, l 'arciduca Carlo d'Asburgo, quello che aveva inchiodato Hoche e Moreau sul Reno. Ma Napoleone era ormai deciso a giuocare il tutto pe r tut to . P rocedendo con u n a spericolata manovra lungo le valli, senza curars i dei n idi di resistenza sparpagl ia t i sulle al ture, at traversò il Brennero , raggiunse Klagenfurt, e si affacciò sul colle del Semmer ing che domina il bacino dan u b i a n o . Ma invece d ' inves t i re Vienna con un ' az ione d i guer ra , la investì con un 'azione di pace scrivendo all 'arciduca Carlo u n a lettera in cui, coi commossi accenti che sapeva t rovare q u a n d o gli conveniva, lo invitava a collaborare con lui pe r p o r r e f ine all ' inutile massacro. Aveva p a u r a n o n di un contra t tacco austr iaco, sebbene si trovasse in u n a posizione s t ra teg icamente rischiosissima, isolato nel cuo re del terr i tor io nemico e senza comunicazioni con le retrovie; ma che Parigi lo precedesse. Voleva esser lui il protagonista anche della pace.
Gli riuscì anche questa. Il 7 aprile (del '97) i p lenipotenziari austr iaci s i p r e s e n t a r o n o al suo q u a r t i e r gene ra l e di Leoben . Dovet tero res tare stupiti dalla rapid i tà con cui, al par i delle manovre , Bonapar te condusse i negoziati. Al termine di sette giorni li concluse bruscamente a p r e n d o la porta della sala in cui si svolgeva la conferenza e a n n u n z i a n d o agli ufficiali raccolti nel l 'ant icamera: «Gli accordi pe r la pace sono firmati. Viva la Repubblica! Viva l ' Imperatore!»
Il Di re t tor io si t rovava di f ronte al fatto c o m p i u t o , ma compiu to in m o d o tale che n o n poteva rifiutarlo. La Fran-
33
eia infatti ot teneva ciò che con quella gue r r a aveva voluto: il Belgio e la riva sinistra del Reno , compresa Magonza . Ma Napo leone le consegnava su un pia t to d ' a rgen to , a m o ' di personale donativo, anche la Lombard ia . L'Austria ci aveva r inunziato in cambio di Venezia con tut te le sue d ipendenze venete e istriane, che la Francia stessa s ' impegnava a consegnarle alla conclusione del trat tato di pace.
Per n o n d a r e t e m p o alla d ip lomazia d i r ime t t e r e in discussione il suo opera to , Napoleone procedet te immediatam e n t e alla l iquidazione della Sereniss ima. Ques t a n o n gli aveva offerto nessun p re tes to p e r c h é in quel la g u e r r a e ra r imasta scrupolosamente neut ra le , e anzi aveva lasciato occ u p a r e un l embo del suo t e r r i to r io dal le t r u p p e francesi. Ma Bonapar te non era u o m o da scoraggiarsi pe r così poco; e i pretesti , q u a n d o gli facevano comodo , sapeva anche inventarli. Due giorni d o p o la firma dell 'accordo, inviò al doge Manin u n a lettera insultante, piena di accuse e di minacce ingiungendogl i di soppr imere l 'Inquisizione e il Senato, e agl'inviati della Repubblica fece u n a delle sue solite scenate a freddo. Poi, a secondare i suoi disegni, sopraggiunsero le «Pasque veronesi».
Questo episodio n o n è mai stato chiarito, e a p p u n t o perciò si presta ai peggiori sospetti. A Verona, dove si e r ano disinvoltamente istallate, le guarnigioni francesi avevano commesso soprusi e angher ie che avevano attirato su di loro l'odio della popolazione. Ma a farlo esplodere fu un b a n d o di chiamata alle armi , affisso sui mur i e firmato da un ufficiale di Napo leone . Risultò più ta rd i che i l b a n d o e ra falso. Ma p e r c h é l'ufficiale lo aveva r e d a t t o e lanciato? Le c a m p a n e sonarono a s tormo, i popolani accorsero armat i di schioppi e di forche, e il p o g r o m costò la vita a una sessantina di francesi. Napoleone li maggiorò a quat t rocento, disse che il loro, sangue n o n poteva essere lavato che col sangue, e ingiunse alla città l ' ist i tuzione di un gove rno r app re sen t a t i vo sotto supervisione francese.
Il Gran Consiglio si r iunì pe r l 'ultima volta l'I 1 maggio. I
34
suoi m e m b r i por tavano le loro uni formi di pa ra ta col parruccone e la toga strascicante. Della passata grandezza n o n gli restava altro. Le proposte di resistenza a oltranza furono scarse e prive di convinzione. L'atto di decesso fu firmato, e nella notte fra il 15 e il 16 un Commissario francese venne a p r e n d e r e possesso della città, in attesa di consegnar la agli austriaci che non avevano perso t empo ad annet ters i l 'Istria e la Dalmazia fino alle Bocche di C a t t a r e
L'ultimo atto di questa t ragedia si svolse il 17 o t tobre di quello stesso a n n o '97, q u a n d o il trat tato di pace fu definitivamente firmato a Campoformio. La diplomazia aveva portato poche variant i alle clausole di Napo leone . Quel le che r iguardavano la Germania non c' interessano. Per l'Italia, Io Stato Veneto cessava di esistere e d iventava u n a semplice provincia austr iaca. Ma, del suo te r r i to r io , i l l embo che si s t ende a ovest del l 'Adige veniva annesso alla L o m b a r d i a francese, che ora si chiamava Cisalpina. L' indomani le t r up pe aus t r iache fecero il loro ingresso a Venezia, e il do lo re spezzò il cuore del vecchio doge Manin che, dicono, cadde a t e r ra fulminato.
Con un t ra t to di p e n n a , quat tordic i secoli di Storia e di gloria e rano stati cancellati.
CAPITOLO QUARTO
L'ITALIA REPUBBLICANA: PRIMA FASE
È pe r il comodo del lettore e pe r meglio aiutarlo a or ientarsi nel groviglio degli avvenimenti che abbiamo preferi to seguire la travolgente cavalcata di Napoleone dal colle di Ca-d ibona a Leoben senz ' a t t a rda rc i sulla sua az ione polit ica nelle t e r r e conquis ta te . Ma o ra b isogna t o r n a r e sui nost r i passi a p p u n t o pe r vedere da vicino la sua ope ra di riassetto. Per capirla, bisognerà tuttavia t ener sempre presente i suoi complessi r appor t i col Diret torio. E il Diret torio n o n aveva u n a volontà univoca. In esso convivevano uomini di diverse tendenze che, pe r semplificare, possiamo r iassumere in d u e f i loni: quello dei realisti, che nella gue r ra vedevano un mezzo pe r consolidare il r eg ime e accrescere la potenza, la ricchezza, il prestigio della Francia; e quello degl ' ideòlogi che nella gue r ra vedevano u n o s t rumento pe r r ed imere i l mondo conver tendolo ai princìpi della rivoluzione.
Q u e s t e d u e t e n d e n z e convivevano a n c h e nel l 'eserci to che aveva valicato le Alpi, e s ' incarnavano r i spet t ivamente in Napoleone e Saliceti. Non vennero in conflitto perché l'omer tà còrsa fu più forte di esse e riuscì s empre a conciliarle. Saliceti, che avrebbe dovu to fare i l r a p p r e s e n t a n t e del Diret torio presso Napoleone pe r controllarlo, fu in realtà l'avvocato di Napo leone presso i l Diret tor io . Ma a p p u n t o p e r questo egli potè esercitare u n a notevole influenza sul Generale. Forse anzi, oltre che dalla vecchia amicizia la collaborazione fra questi d u e uomini fu concimata dalla loro complementar ie tà . Oppor tun i s ta freddo fino al cinismo, unicamente p reoccupa to della g randezza della Francia e più ancora di quella sua propr ia , Napoleone non vedeva che la vittoria
36
e la conquista: pe r lui l'Italia era soltanto un campo di battaglia e u n a fonte di gloria e di po te re . Per Saliceti, che ai princìpi ci credeva, sebbene n o n fosse pe r nulla un astratto do t t r i na r io , l ' I talia e r a un p o p o l o da l iberare . La politica napo leon ica in Italia fu un po ' i l c o m p r o m e s s o fra ques te due esigenze. Vediamolo nei fatti.
Pr ima che l 'esercito imboccasse la via delle Alpi, Saliceti aveva avuto molti contatt i coi r ivoluzionari italiani esuli in Francia. A Nizza ce n ' e r ano un paio di centinaia, scampati alle p u r g h e della polizia piemontese e napoletana, e raccolti in torno a un giornale, il Monitore italiano: Essi avevano convinto Saliceti che l'Italia era p iena di r ivoluzionari p ron t i a met ters i al servizio di Napo leone , se quest i avesse t ra t ta to con loro. Napoleone l i ricevette, ma ne rimase poco persuaso: n o n sol tanto p e r c h é gli p a r v e r o delle teste esagi tate e confuse, ma anche perché par lavano di un'Italia uni ta sotto «il simbolo l iberatore p ianta to in Campidoglio». Era logico che in questi uomini l 'ideale di democrazia si fosse sposato con quello de l l ' ind ipendenza nazionale, facendo di «giacobino» un s inonimo di «patriota» (e infatti i d u e termini , d 'ora in poi , n o n s i d i s t i n g u e r a n n o p iù l ' uno dal l 'a l t ro) . Ma questo a Napoleone n o n interessava. Egli in tendeva servirsi di questi uomini , n o n servirli. In tendeva insomma farne dei «collaborazionisti». Per questo aveva lanciato il proclama alle popolazioni invitandole a scuotere il giogo della t irannia. Voleva che gli facessero da «quinta colonna» nella fase della lotta. Ma impegni n o n ne prese .
Q u a n d o , d o p o la vittoria sugli aust ro-piemontes i , en t rò ad Alba e vi trovò u n a specie di governo provvisorio rivoluzionario che in un proclama invitava le popolazioni del Piem o n t e e L o m b a r d i a a costituirsi in u n a Repubblica alleata della Francia, lo lasciò fare. Ma n o n fu, con esso che t ra t tò . Trat tò coi poter i costituiti, cioè col re Vittorio Amedeo I I I . E Napoleone , d o p o ch 'ebbe o t tenu to da lui ciò che desiderava, cioè le piazzeforti, a b b a n d o n ò i r ivoluzionari alla sua mercé.
37
I l Diret torio n o n trovò nulla da ridirvi anche pe rché in quel m o m e n t o la fazione degl ' ideologi era in crisi pe r la scoper ta di un complot to estremista capeggiato da u n o dei loro , Babeuf, che voleva r i lanciare u n a rivoluzione più radi cale. Di questo complot to , u n o dei capi p iù in vista era un esule i tal iano, B u o n a r r o t i , c h ' e r a stato in stret t i r a p p o r t i con Saliceti. Sicché anche costui ne usciva compromesso . E ora, pe r riqualificarsi, non gli restava che applicare con zelo le consegne del Dire t tor io , di un Diret tor io s empre più in balìa dei fautori della «ragion di Stato» e s e m p r e più d u r o nei confronti delle t e r re conquistate. « Imponete e riscuotete tributi con r igore e rapidi tà - ingiungeva nelle sue istruzioni -, E nei pr imi moment i della vittoria che il vinto paga senza discutere.» Parigi considerava l'Italia u n a p r e d a e ne voleva il saccheggio. E Saliceti, sia p u r e controvoglia, doveva seguirne le direttive.
Cercava di farlo in coerenza coi pr incìpi della rivoluzione , cioè co lpendo soprat tu t to i beni della Chiesa e dei nobili. Ma ciò n o n bastava a saziare l 'appeti to del Direttorio. Bisognava r e n d e r e la spoliazione più razionale es tendendola all 'unico vero inesauribile tesoro del Paese: quello artistico. «Questa campagna deve un i re alla gloria dei trofei militari la bellezza delle ar t i benef iche e consolatrici» diceva un ' i s truzione del 7 maggio '96. E pe r r e n d e r e sistematica questa consolazione, giunse da Parigi un 'apposi ta commissione di espert i , che fece piazza puli ta di q u a n t o c 'era di meglio nelle chiese, nei musei , nelle p inacoteche , nelle abitazioni private. In tutti gli armistizi che Napo leone via via firmava con gli Stati italiani c 'era u n a clausola che legittimava questa razzia. M o d e n a dove t t e ve r sa re vent i capolavor i d i Guerc ino , Reni e Carracci ; altri vent i Pa rma fra cui i suoi splendidi Correggio . I convogli che t raspor tavano in Francia il tesoro italiano si a l lungavano sempre più. Ma alla ruberìa in serie e legalizzata, si aggiungevano quelle spicciole dovu te all 'iniziativa pr iva ta di ufficiali e funzionari . Ci fur o n o rivolte, di cui la più violenta scoppiò a Pavia, dove i
38
popolani , d o p o aver ammazzato un po ' di francesi, s i misero con loro in concor renza di saccheggio. Lo stesso N a p o leone alla fine se ne p reoccupò e impar t ì o rd in i severi, anche di fucilazione, c o n t r o le r u b e r ì e dei soldat i , del tu t to d iment ico di essere stato lui a indicargli l 'Italia come u n a «preda» . Ma i l fatto è che o r a nel la sua m e n t e a n d a v a n o m a t u r a n d o idee diverse da quelle con cui aveva varcato le Alpi. Non che si fosse affezionato all 'Italia, come qualcuno dice, pe rché gli si e ra risvegliata «la voce del sangue». Non e ra u o m o da sent i re questi r ichiami . Ma n o n cons iderava più l 'Italia come un semplice campo di battaglia. La conside r ava i l p iedes ta l lo del la sua p e r s o n a l e p o t e n z a . Perciò aveva deciso, cont ro i l Diret torio, di n o n p iù farne ogget to di ba ra t to . E questo g l ' imponeva di dar le un 'organizzazione politica.
Ques t 'opera , come oggi si direbbe, di «ristrutturazione», a t t raversò varie fasi, tu t te condiz iona te dai suoi cangevoli r a p p o r t i con Parigi . In u n a delle sue p r i m e re lazioni dal P i emon te , scriveva al Di re t to r io : «Il popo lo è fiacco. Da q u a n d o s iamo en t ra t i in Italia, n o n c'è stato a lcun movimento in favore della libertà». L'atteggiamento dei lombardi n o n fu tale da fargli cambiai" pa re re . A Milano le notizie dell 'avanzata francese non avevano provocato nessun disordine. Il personaggio del giorno, pe r i milanesi, non era Napoleone , ma il castrato Crescentini , che alla Scala aveva ripor ta to un clamoroso successo in Giulietta e Romeo. Tutti erano convint i che i l viceré aus t r iaco , a rc iduca F e r d i n a n d o , stesse t ra t t ando u n a pace separata, e n e m m e n o q u a n d o invece part ì , il 7 maggio, ci fu ombra di panico.
Egli aveva lasciato il po te re a u n a Giunta di notabili che band ì pubbl iche p regh ie re e l 'esposizione del Santo Sacramento , ma non ebbe bisogno di r icorrere a misure repressive p e r ass icurare l ' o rd ine . Un cer to Salvador, cui Saliceti aveva affidato il compi to di organizzare manifestazioni popolari , n o n incontrò ostilità, ma neanche consensi. L'Austria non aveva lasciato brut t i r icordi: la sua amministrazione era
39
stata esemplare e il suo r iformismo aveva consenti to, come già abbiamo de t to nell'Italia del Settecento, la formazione di u n a classe media abbastanza affezionata al potere che l'aveva evocata e chiamata a collaborare. Neanche gl'intellettuali e r ano su posizioni eversive: lo stesso Verri che p e r dispetto ora faceva il giacobino, in realtà era un illuminista della più bell 'acqua, cioè un modera to .
Ancora più modera t i e r ano gli uomin i della Giunta. Essi decisero di m a n d a r e un 'ambascer ia a Napo leone , che frattanto correva a perdifiato lungo la sponda mer idionale del Po pe r p r e n d e r e gli austriaci alle spalle. E a guidar la fu designato Melzi d 'Eri l un po ' p e r c h é par lava i l francese alla perfezione, un po ' p e r c h é sembrava l ' uomo più indicato a cattivarsi le grazie del conquistatore, e infatti lo era.
Que l p r imo incontro fu utilissimo a en t rambi . Melzi disse al Generale che un p u r o e semplice t rapianto degl'istituti francesi in Italia sarebbe stato un e r ro re pe r la diversità delle condizioni economiche e sociali fra i d u e Paesi. E il Genera le , che in fondo n ' e r a già pe r suaso , disse a Melzi che la sorte della Lombard ia era nelle mani dei lombardi : se essi si mos t ravano degni de l l ' ind ipendenza , nessuno avrebbe più po tu to togliergliela. Era un a m m o n i m e n t o , ma forse anche u n a speranza.
Melzi to rnò r incuora to a Milano, già occupata dalle avanguard ie del genera le Masséna. I francesi e r ano stati accolti piut tosto f reddamente . Ma q u a n d o vi giunse Napoleone, la città si scaldò di entusiasmo. Ci furono para te , serate di gala all 'opera, alberi della libertà piantati in tut te le piazze. Molto vi contr ibuì il magnet i smo che sprigionava quel conquistatore di ventisette anni , così diverso dalla compassata solenni tà degli Arciduchi e dei Marescialli austriaci. Ma tu t to questo era soltanto epidermico.
Per i l m o m e n t o , Napo leone n o n era in g rado di affrontare p rob lemi politici. Sapeva che il nemico stava p e r ridis c e n d e r e in forze da l T i ro lo p e r socco r r e re Mantova , ed e ra a ques to che doveva anzi tu t to b a d a r e . I l po ' di t e m p o
40
che gli avanzava preferì dedicarlo a un rego lamento di conti, sia p u r e m o m e n t a n e o , con gli Stati italiani che potevano infastidirlo da tergo. Il più minaccioso era quello Pontificio n o n pe r ché le sue forze r appresen tas se ro un pericolo, ma p e r c h é esso aveva spalancato il p o r t o di Civitavecchia alle navi inglesi che vi stavano ammassando un corpo di spedizione.
B o n a p a r t e p r e s e l e sue p r ecauz ion i f acendo o c c u p a r e Bologna e Ferrara , e il Papa si affrettò a ch iedere la mediazione dello spagnolo Azara. Ques te furono le trattative più l unghe e difficili, anche pe rché con la Spagna il Diret torio voleva m a n t e n e r e buon i r appor t i , e Azara e ra un negoziatore scaltro e paziente . Bonapa r t e , che invece aveva fretta, ebbe con lui scenate terr ibi l i , in u n a delle quali s t r appò a morsi un d o c u m e n t o . Probabi lmente e r ano collere f inte , e lo spagno lo lo capì . Visto che n o n riusciva a i m p a u r i r l o , N a p o l e o n e fece occupare anche i l p o r t o di Ancona. Azara si rese conto che, se cont inuava a tergiversare , quel Generale pigliatutto avrebbe fatto dello Stato pontificio ciò che a morsi aveva fatto del documen to , e accettò le ul t ime condizioni: la San ta Sede cedeva Ancona , Bo logna e Fe r r a r a , s ' impegnava alla più s tret ta neutra l i tà , e versava venti milioni d ' indenni tà , nonché cento ope re d 'ar te e c inquecento manoscri t t i .
Men t re si svolgevano queste trattative, Bonapa r t e aveva già reciso altri nodi r i ducendo il Ducato di Modena e Reggio sotto il suo vassallaggio. Il Duca in carica, Ercole Rinaldo d'Este, n o n era u o m o da emergenze. Firmato il diktat che gl ' imponeva il solito tr ibuto in dena ro e quadr i d 'autore , lasciò il po te re a u n a reggenza e si ritirò a Treviso, dove poco d o p o mor ì . O r a tu t ta la Padania era nelle man i del Bonapar te salvo il Ducato di Parma e Piacenza ch'egli dovette rispe t ta re p e r le solite cons ideraz ioni d ip lomat iche : i l duca F e r d i n a n d o a p p a r t e n e v a alla dinast ia borbonica del Re di Spagna , d i cui e r a anche cogna to . B o n a p a r t e , che con la Spagna n o n voleva complicazioni, lasciò questo Principe in-
41
nocuo e bacchet tone sul t rono a recitare i suoi salmi e a suona re i suoi orologi a cucù.
Un 'a l t ra p e n d e n z a aveva l iquidato col Regno di Napol i che aveva m a n d a t o un co rpo di spedizione a combat te re a fianco degl i austr iaci . I l P r inc ipe B e l m o n t e Pignatel l i e ra venuto a chiedere l'armistizio, e Napoleone s'era divertito a farlo c o r r e r e di q u a e di là p e r esserne r a g g i u n t o . Anche Napoli appa r t eneva a u n a dinastia Borbone , anzi il suo Re era fratello di quello di Spagna. Ma si odiavano, e ancora di più si odiavano le d u e Regine, che contavano più dei rispettivi mariti . Bonapar te , cui pe r il m o m e n t o stava a cuore soltanto il ritiro di Napoli dalla guer ra , si contentò di poco, lasciando il compito del regolamento definitivo al Direttorio, che infatti si most rò molto più esigente.
Con Genova, tu t to era stato sistemato con l ' ingiunzione alla città di r ichiamare i giacobini bandi t i , di esiliare gli austriacanti e di ch iudere il por to alle navi inglesi. Di Venezia, abbiamo già anticipato la sorte, saldata poi a Campoformio. Restava la Toscana. Sebbene fratello de l l ' Impera to re d'Austria, i l g r a n d u c a F e r d i n a n d o aveva d ich ia ra to la p r o p r i a neutral i tà fin dal p r imo giorno della guer ra , e l'aveva scrupolosamente osservata. Ma Livorno n o n aveva rispettato la consegna anche perché era pra t icamente in m a n o agl'inglesi che vi facevano ciò che volevano. Bonapar te vi accorse pe r r i ch iamar la alla r ag ione , e a Pistoia lo r agg iunse il p r i m o ministro Manfredini pe r invitarlo, a n o m e del Granduca , a Firenze. Bonapar te a n d ò a p ranzo da Ferd inando che lo accolse con g rand i onor i e ne ricevette tut te le assicurazioni. Più tardi Napoleone scrisse nel suo Memoriale: «Fui estremamente soddisfatto dell 'Arciduca (voleva dire il Granduca) che mi mostrò le cose di questa antica e impor tan te capitale, fatte pe r risvegliare la mia attenzione». Ma l ' indomani di quella visita, nel d a r n e conto al Diret tor io, scrisse: «Ho visto la Venere dei Medici che manca al nos t ro Museo e u n a collezione di cere che non sarebbe indifferente di possedere...»
Così Bonapa r t e , approf i t t ando della t regua , aveva sbri-
42
gato le faccende della penisola , che o r a e r a tu t t a alla sua mercé. Poi, con la calata di Wùrmse r dal Ti ra lo , la gue r r a lo aveva r ichiamato in servizio di Generale , e lo aveva condotto di vittoria in vittoria fino a Leoben. Q u a n d o to rnò ad occupars i delle cose d'Italia, tut to era cambiato, a cominciare da lui.
CAPITOLO QUINTO
LA CISALPINA
Di r i torno dalla folgorante campagna in Austria, Bonapar te stabilì i l suo qua r t i e r gene ra l e ne l palazzo di Mombel lo a d u e passi da Milano, e lo t ras formò in u n a vera e p r o p r i a Reggia. Giuseppina lo aveva raggiunto . Napoleone l 'amava d ispera tamente , ma aveva dovuto lasciarla l ' indomani delle nozze, e la sua passione l'aveva sfogata in lettere torrentizie vergate nelle pause di quella lunga corsa d ie t ro i l nemico . O r a voleva p r e m i a r l a di quel la l u n g a at tesa - di cui d 'alt r o n d e essa si e ra a b b o n d a n t e m e n t e consolata - m e t t e n d o l'Italia ai suoi piedi. Da secoli avvezzi a sciogliere inni, i poeti della penisola n o n si fecero p rega re pe r incensarla. Dame e gent i luomini venivano a farle r iverenza. Il Papa le aveva manda to u n a collana di preziosi cammei .
Tut to questo n o n era molto repubbl icano né democrat i co, ma ormai Napoleone poteva consentirselo. Era stato lui n o n soltanto a vincere la guer ra , ma anche a impor r e la sua pace. Il Direttorio aveva dovuto a r renders i a tut te le sue esigenze , compresa quel la di p o r t a r e la sua a r m a t a a 80.000 uomini sottoposti a un t ra t tamento di privilegio - come cinquina, gratificazioni, onorificenze - che ne faceva un corpo pre tor iano .
La situazione politica in Francia accelerò questo processo. Le elezioni di quel la p r i m a v e r a ('97) avevano da to la maggioranza ai monarchici . Per d i fendere le istituzioni re pubblicane e se stesso, il Direttorio aveva bisogno dei Generali, ma non sapeva di quali f idarsi . Da q u a n d o Saliceti e ra r imasto coinvolto nell'affare Babeuf-Buonarrot i , i suoi r ap por t i n o n godevano più molto credito. Pur senza r ichiamar-
44
lo, gli avevano m a n d a t o di rincalzo un al tro Commissar io , Gar rau . La sua relazione fu rassicurante: sui sentimenti repubbl ican i de l l ' a rma ta d ' I ta l ia , diceva, s i po teva con ta re . Ma aggiungeva profet icamente: «Un giorno, d o p o aver conquistato l 'Europa, essa conquisterà la Francia».
Della profezia, i l Diret torio n o n e ra in condizione di tene r conto. Aveva bisogno, subito, di gente sicura. Si rivolse a Napoleone , e questi spedì a Parigi il suo luogotenente Au-gereau, un caporalaccio r u d e e spavaldo, che n o n andò pe r il sottile. Il regime fu salvato da lui, cioè da Bonapar te , che così ne d ivenne ancora di più credi tore, e ne approfit tò pe r da re all'Italia l'assetto più confacente ai suoi disegni.
Le cose, da q u a n d o le aveva lasciate pe r inseguire i l ne mico fino a Leoben, si e rano messe in moto da sole. La reazione politica dell 'Emilia al l 'occupazione francese era stata mol to p iù vivace che in Lombard ia . Già nell 'agosto del '96 quell i d i Reggio ne avevano approf i t t a to p e r p roc lamars i ind ipendent i da Modena, del cui Ducato avevano f in allora fatto par te in posizione subalterna, e costituirsi in Repubblica. Ga r rau era stato ben lieto di riconoscerla, anche perché questo gli offriva il pre tes to di p roc lamare decadu to il Ducato anche a Modena, che seguì l 'esempio di Reggio. Le d u e città s tabi l i rono subito r a p p o r t i con Bologna e Fe r ra ra , e tu t t ' e qua t t ro decisero d ' ind i re un congresso, che s i t e n n e in o t tobre . Fu proc lamata l 'un ione in u n a sola Repubbl ica che si chiamò Cispadana e bandì l ' a r ruolamento di 3.000 uomini in u n a Legione italiana.
L'episodio era di modes te proporz ioni , ma di g r a n d e significato. Per la p r ima volta italiani di Stati diversi e fra loro t radizionalmente ostili si r iconoscevano fratelli e si attribuivano un'et ichetta nazionale. E pe r la p r ima volta essi agivano in n o m e della volontà popo la re e come suoi «delegati». Il lettore la p r e n d a con cautela. Questi congressisti, tutti aristocratici e borghesi, di popolare n o n avevano che la pre te sa di esserlo, in quan to alla loro elezione n o n avevano partecipato che i ceti da cui provenivano. Ma pe r la p r ima volta
45
i l loro p o t e r e n o n der ivava da u n a «investitura» dal l 'a l to. Bene o male, e r ano dei «rappresentanti».
Due mesi d o p o indissero un nuovo congresso a Reggio, ed espressero il voto che i l ombard i si un issero a loro p e r «formare un solo popo lo , u n a sola famiglia». I l ombard i , ch ' e rano lì come invitati, mescolarono le loro acclamazioni a quel le dei p a d r o n i di casa. Ci fu rono p iant i , abbracci , ins o m m a un po ' di m e l o d r a m m a all ' italiana. Ma ci fu anche un fremito di autentico entusiasmo.
I lombardi avevano dato la loro adesione perché anche a Milano le cose in quei mesi e rano molto cambiate. Essa e ra diventata il rifugio e il luogo di raccolta degli esuli di tu t te le altre part i d'Italia. Costoro avevano fondato il Giornale dei patrioti e il Termometro politico dove si dibat tevano i problemi del m o m e n t o . N o n siamo riusciti ad a p p u r a r n e la «tiratura», cioè il n u m e r o di copie ch'essi vendevano. Doveva essere molto scarsa perché la massa della popolazione era analfabeta e m u r a t a da secoli nella sua indifferenza. La discussione restava limitata a quella piccola minoranza d'intellettuali, ma pe r la p r ima volta si svolgeva l iberamente fra italiani di d iverse p r o v e n i e n z e reg ional i e ideologiche e su problemi che n o n e rano più quelli del dio Pan e delle pastorelle d 'Arcadia, ma quelli politici e economici della società attuale. Il giacobino Ranza polemizzava col modera to Gioia, i l napo le t ano L a u b e r g col r o m a n o L'Aurora. E rano cattivi giornalisti, impacciati da u n a sintassi macchinosa, retorici e declamatori . Ma grazie a loro Milano era diventata un laborator io d ' idee e di p rog rammi , in cui si venivano del ineando i g randi filoni del pensiero risorgimentale.
Tut to ques to aveva avuto il suo riflesso anche sul p iano politico. Aiutato da Saliceti, un nuovo g r u p p o radicale aveva sostituito quel lo m o d e r a t o alla testa della municipal i tà . Proveniva dalla Società popolare fondata da Salvador, sebbene ne facessero pa r t e anche dei p re t i e alcuni nobili come Visconti, Serbelloni e Porro . Esso fece sfoggio di una tale intolleranza che anche il Verri si trovò a disagio e il Melzi p re -
46
ferì ritirarsi disgustato nelle sue te r re . Però o t t enne da Bon a p a r t e la cost i tuzione di un vero e p r o p r i o gove rno , sia p u r e condizionato, che si chiamò Amministrazione Generale della Lombardia . Nell 'ottobre del '96, men t r e Napoleone infliggeva colpi risolutivi agli eserciti austriaci, essa istituì e reclutò anche un p ropr io esercito di 3.500 uomini , la Legione lombarda, e gli assegnò la bandie ra bianca, rossa e verde . Era nato il tricolore.
Ecco p e r c h é u n a de legaz ione d i Milano e ra a n d a t a a l congresso di Reggio e aveva sottoscritto con tanto entusiasmo le sue del iberazioni . Esse mi r avano alla fusione della Lombard ia e dell 'Emilia in un unico Stato che, sia p u r e sotto il controllo francese, facesse da polo di at trazione di tut to il resto della penisola. Forse a Napoleone l 'idea non dispiacque , ma la considerò p rema tu ra . In quel m o m e n t o non era ancora in g rado di sfidare ape r t amen te il Direttorio che gli r accomandava di «non d a r e corda al pat r io t t i smo degl ' i taliani», e pe r di p iù n o n voleva esasperare il Papa r e n d e n d o irrevocabi le la mut i laz ione dei suoi Stati. P iombato anche lui a Reggio il 9 gennaio , disse che il congresso n o n poteva p r e n d e r e decisioni: p r ima ci voleva un governo, e p r ima del governo ci voleva una Costituzione.
Era u n a buona scusa, ma che n o n poteva arres tare i l naturale sviluppo della situazione. Il congresso si piegò al veto, ma decise di riunirsi nuovamente in gennaio a Modena, dove si t rasformò in Costituente. Stavolta vi presero par te anche i delegati di Massa e Ca r ra ra e di Imola, che nel f ra t tempo si e r a n o un i t e motu proprio alla C i spadana . Il m o v i m e n t o uni tar io dilagava a chiazza d'olio.
O r a , a Mombel lo , N a p o l e o n e p r e n d e v a at to di ques ta realtà. E ormai libero di agire a testa sua, proc lamò ufficialm e n t e una Repubblica cisalpina che comprendeva , oltre alla Lombardia , le province ex-venete di Bergamo e Brescia, la Valtellina e tutta la Cispadana. Prese pe rò le sue precauzioni i m p o n e n d o a questo embr ione d'Italia u n a Costituzione
47
quasi identica a quella francese, che accentrava tut to il potere esecutivo nelle mani di un Direttorio, di cui egli si riservava di nomina re i component i . Voleva uomini maneggevoli, e aveva capito che i giacobini o «democratici», come anche si chiamavano, n o n lo e rano .
Costoro avevano perso i loro migliori avvocati: Saliceti e G a r r a u . Saliceti, lo abb iamo già de t to , sebbene avesse i l compi to di sorvegliare Bonapa r t e , lo aveva s e m p r e seconda to in tu t to e perc iò eserci tava su di lui u n a g r a n d e influenza. Ma Napoleone lo ascoltava come amico, non come Commissar io . Col Commissa r io si t rovava spesso ai ferr i corti pe r ché n o n ne riconosceva le funzioni. Ques to aveva gettato un ' ombra sulla loro amicizia, che tuttavia era abbastanza forte e profonda pe r resistere alla prova.
Ben più d u r o fu lo scontro con G a r r a u , un cont ro l lore inflessibile e b e n deciso a esercitare i suoi poter i . Anche lui a p p a r t e n e v a alla vecchia gua rd i a di Robesp ie r re , e le sue idee repubbl icane e democra t iche lo por tavano a simpatizzare p iù coi r ivoluzionari italiani che coi general i francesi, di cui scoprì e denunc iò le ruber ìe . I suoi r appor t i n o n ott enne ro risultati pe rché p rop r io allora l 'esercito era diventato, grazie ai suoi successi, intoccabile. Ma questo n o n disa rmò Gar rau , che scrisse al Diret torio: «Le vittorie dell 'esercito servono a immunizzare i colpevoli». Napoleone , che n o n aveva il sarcasmo leggero, lo chiamava «il gobbo velenoso», e gobbo infatti e r a G a r r a u , ma sol tanto nel fisico. Moralmente era dri t to come una lama.
Il contrasto si era acuito a tal pun to che alla fine il Direttorio aveva manda to a inchiestare un suo fiduciario, Clarke. Ma questi giunse quando Bonaparte stava già r ipor tando vittorie su vittorie, e il r appor to fu favorevole a lui. Vi si diceva che, anche se l'onestà di Garrau era al di sopra di ogni sospetto, il Commissariato creava nei comandi un pericoloso dual ismo che andava a tutto: scapito dell'efficienza. Sia p u r e a malincuore, il Direttorio si era uniformato al responso, e alla fine di quell 'anno aveva soppresso i Commissari agli eserciti.
48
O r a Napoleone era definit ivamente libero di regolare le cose i taliane a suo p iac imento , e lo fece senza lasciarsi impacciare da pregiudiziali ideologiche. Con la Cisalpina egli aveva già crea to un e m b r i o n e di Nazione , che contava t re milioni e mezzo di abitanti nel l 'area più ricca e svi luppata della penisola. Ma questa nazione egli la concepiva e la voleva napoleonica, non italiana. E fu questo che lo mise in conflitto coi patrioti di estrazione democratica.
Per t u t to l ' anno '97 , cos toro ce rca rono di e s t e n d e r e i l moto uni ta r io al P iemonte accendendovi focolai rivoluzionari . La polizia del re Carlo Emanuele IV, da poco successo al p a d r e Vittorio Amedeo, fu spietata nonostante la mitezza del Sovrano . U n a sul l 'a l t ra un cen t ina io d i teste c a d d e r o sotto il fuoco dei plotoni di esecuzione. I rivoluzionari lombard i spe ra rono che Bonapar te avrebbe colto quel pretesto p e r d ich iarare decadu ta la dinastia sabauda, i s taurare u n a repubblica anche in Piemonte e fonderla con la Cisalpina. E invece lo v ide ro se rba re un a t t e g g i a m e n t o favorevole nei confronti di Carlo Emanue le e anzi spingere il Direttorio a ratificare le clausole dell 'armistizio di Cherasco.
Ma il colpo più grosso ai loro sogni lo inferse il trattato di Campoformio, che consegnava Venezia all'Austria. I patrioti veneti avevano già stabilito r appor t i con quelli milanesi pe r p reparare la fusione fra i due Stati. Suppliche e appelli firmati da migliaia di cittadini furono mandat i a Bonaparte. Questi se ne servì per minacciare l'Austria e indurla a ratificare al più presto le clausole dell'armistizio di Leoben. Poi abbandonò la gloriosa Repubblica alla sorte ch'egli stesso le aveva assegnata.
La reaz ione fu grossa e provocò , nel fronte patr iot t ico, u n a spaccatura irrimediabile. L'ala più intransigente e risoluta perse ogni fiducia nella Francia e nei poter i costituiti in genera le . Nei mesi p receden t i il dibatt i to svoltosi sui giornali e nei circoli milanesi aveva già lasciato affiorare questa tendenza estremista. Il Galdi aveva pubblicato un saggio intitolato Antimoderatismo, che affidava la redenz ione dell ' I talia n o n più a un «liberatore», ma a u n a rivoluzione popola-
49
re cont ro t roni , altari e privilegi. L'idillio dei «patrioti» con la Francia era finito. Respinti all 'opposizione e sottoposti alla censura che soppr imeva anche i loro giornali , costoro si de t t e ro alla lotta clandest ina. La loro ideologia era ancora nebulosa e incerta, divisa fra t endenze uni tar ie e t endenze federaliste. C'era chi dava il passo alla cosiddetta istanza nazionale e chi a quella sociale. Ma ciò che ormai era acquisito era la ro t tu ra fra l'ala modera ta e quella democrat ica e rivoluzionaria. Le r ivedremo all 'opera, l 'una cont ro l'altra, nel Risorgimento, che cercò di conciliarle, e qualche volta ci riuscì. Ma n o n sempre , e quasi mai del tut to.
A questo p u n t o in t e rvenne un fatto nuovo . Napo leone , d o p o aver messo in ginocchio l'Austria, decise di fare altrett an to con l ' Ingh i l t e r ra . N e s s u n o sap rà mai se vi si risolse p e r d a r e alla Francia u n a definitiva pace , o p e r r i lanciare u n a gue r ra che o rmai languiva. Pur d o m i n a n d o i mar i , l 'Inghi l terra era rimasta sola, e la sua diplomazia n o n riusciva a t rovare delle potenze terrestr i disposte a sfidare nuovamente quel la francese. Forse p r i m a o poi sa rebbe scesa a u n a t ransazione, ed e ra p r o p r i o ciò che Napo leone paventava . Per d iventare Napo leone , egli aveva bisogno della gue r r a . Espose e impose al Direttorio un p iano temerar io : n o n pot e n d o colpire quel l ' i r r iducibi le nemico sul m a r e e sul suo p r o p r i o te r r i to r io , lo avrebbe colpito nelle sue basi navali d'Africa t raghet tandovi un esercito. Forse fu un dialogo tra mariuoli , che cercavano di gabbarsi l 'un l 'altro. Il Direttorio era p ron to a r imetterci anche un 'a rmata , p u r di liberarsi di Napo leone e della sua p r e p o t e n t e tutela. E Napo leone era p r o n t o a c o r r e r e i l r ischio p u r di r a g g i u n g e r e i l suo t ragua rdo : i l po te re sup remo . All'Italia aveva dato l 'ultimo ritocco, impadronendos i con un 'operaz ione del tut to indolore anche di Genova, ma senza fonderla con la Cisalpina. Come successore designò, con pieni poter i militari e civili, un luogotenente di tut ta fiducia: il suo capo di Stato Maggiore Berthier. E il 17 novembre del '97 part ì da Mombello incontro alla sua nuova avventura.
CAPITOLO SESTO
IL '98
Nel passargli le consegne, Napo leone aveva raccomanda to a Ber thier di «sorvegliare il Papa e tener a guinzaglio Napoli», cioè di fare in m o d o che la si tuazione in Italia restasse qual era. Ber thier n o n chiedeva di meglio. Non privo di capacità, ma cinico e spregiudicato , donnaio lo e sibarita, e ra ben contento di godersi in pace la sua privilegiata posizione di proconsole e le grazie della duchessa Visconti, sua amante. Ma n o n aveva abbastanza autori tà e prestigio pe r sfidare gli ordin i del Direttorio, che cont inuava a pensa re all'Italia come a u n a te r ra di saccheggio.
A forn i re pre tes t i di aggress ione fu lo Stato pontificio, che n o n aveva abbandona to il suo a t teggiamento ostile alla Francia anche p e r rag ion i d i poli t ica in t e rna . Per q u a n t o scarsi e isolati, a Roma i circoli intellettuali d' ispirazione giacobina e r a n o in f e rmen to e facevano g r u p p o i n t o r n o agli emissari di Parigi. Fra questi c'era, in qualità di ambasciatore , Giuseppe Bonapar te , fratello di Napoleone, che cercava di ba rcamenar s i a t t e n u a n d o i contrast i . Ma c ' e rano anche t re Genera l i in incogni to che invece sp ingevano in senso d iamet ra lmente opposto . U n o di essi, Duphot , si t rovò coinvolto in u n a manifestazione di patr iot i . Se fosse stato lui a aizzarla, come poi dissero i pontifici, o se invece cercasse di placarla, come invece sostenne Parigi, n o n si è mai saputo . Fatto sta che la polizia, spa rando sui dimostrant i , uccise anche lui. Dopo qualche esitazione, Giuseppe respinse le scuse del governo e lasciò Roma. Il Diret torio, in p r e d a a un soprassa l to di r ivoluz ionar i smo anticlericale, ing iunse a Berthier di marciare sulla città.
51
Data la consis tenza del l 'eserci to pontificio, n o n fu che una passeggiata militare che raggiunse i suoi obbiettivi senza in toppo. Secondo gli ordin i ricevuti, Berthier n o n doveva usare violenza al Papa. Doveva aspet tare che a scacciarlo fossero i patrioti romani , ma questi si g u a r d a r o n o bene dal farlo, impauri t i dal minaccioso at teggiamento del popolino. Nel febbraio (del '98), Berthier scriveva a Napoleone , intento a p r e p a r a r e la sua spedizione in Africa: «In questa città non ho trovato che costernazione. Nessuna traccia di spirito l iber tar io . N o n un pa t r io ta è v e n u t o a visitarmi». Ci volle del bello e del b u o n o pe r raccogliere, i n to rno a un albero della libertà, qualche centinaio di volenterosi e pe r far eleggere un governo provvisorio formato di sette Consoli.
Be r th i e r lo incaricò di e l abora re u n a Cost i tuz ione sul modello di quella francese. I Consoli si misero al lavoro, ma non pr ima di aver provveduto a dotarsi di una ruti lante divisa all'altezza del loro titolo. Fra di essi c'era qualche u o m o di valore, come l 'archeologo Ennio Qui r ino Visconti, ma il factotum e ra un tale Angelucci di profess ione ginecologo - che allora era soltanto la versione maschile della levatrice - cui, secondo Hér io t , Sa rdou si sarebbe ispirato p e r il personaggio di Angelotti nella Tosca. Questi patrioti tuttavia si affrettarono a dichiarare che, p u r spogliato di ogni potere temporale , il Papa avrebbe conservato quello spirituale e seguitato a godere di tutti i privilegi connessi al suo alto magistero. Non volevano r inunziare all 'unica industr ia di Roma: la Chiesa.
Ma questo contrastava con gli ordini ricevuti da Berthier che, non t enendo alcun conto di quella decisione, ingiunse al Papa di lasciare la città en t ro t re giorni . Pio VI era quel Braschi , g r an s ignore r inasc imenta le e nepot is ta , che da giovane aveva saputo far fronte a ogni emergenza. Ma ora, a ot tant 'anni e dopo ventitré di Soglio, n o n era più in g rado di lo t tare . Se ne a n d ò in p u n t a di p iedi , ma con mol ta dignità. E il suo orgoglio fu messo a d u r a prova dai rifiuti che incont rarono le sue d o m a n d e d'asilo. Per quanto si fregias-
52
sero della qualifica di «cattolici», né l ' Impera tore d'Austria, né il Re di Napoli accettarono di ospitarlo. Solo il Granduca di Toscana gli permise di accasarsi a Siena, ma col divieto di avvicinarsi a Firenze.
Seguiamo ancora pe r un m o m e n t o i l suo patetico vagabondaggio . Da Siena lo scacciò un te r remoto che distrusse il monas tero in cui s'era rifugiato. Il Granduca gli consentì di trasferirsi nella Certosa di Firenze, ma sempre vietandogli di e n t r a r e in città. Q u a n d o anche lui s i t rovò nei guai coi francesi, il Papa, pe r n o n aggravarli con la sua presenza, si t rasferì a Pa rma . Era mezzo paral izzato e c o m p l e t a m e n t e solo perché anche suo nipote, il duca Braschi, era stato rimpatr iato d 'autori tà . Ma a Parma il Duca n o n lo volle, e il veg l ia rdo dove t te piegarsi a l l 'u l t ima umil iaz ione: ch i ede re ospitalità a coloro stessi che l 'avevano scacciato. Gliela concessero. Senza seguito e quasi in stato d'incoscienza, si mise in viaggio pe r le Alpi, e dovunque al suo passaggio la gente si ammassava , lo copr iva di fiori e s ' inginocchiava d imos t r a n d o q u a n t o c o n t r o p r o d u c e n t e sia l 'anticlericalismo q u a n d o diventa persecuzione. Da Briangon dove fu accolto come «il cit tadino Papa» fu trasferito p r ima a Grenoble, poi a Valenza, e anche di lì s tavano pe r r imuover lo , q u a n d o la mor te sopravvenne a met tere fine al suo calvario. Il giornale ufficiale scrisse: «Questa fine met te il sigillo alla gloriosa filosofia dei t empi moderni» . I delitti delle rivoluzioni n o n devono sgomentare . Sgomenta la loro stupidità.
A Roma il nuovo governo brancolava nel vuoto, sopraffatto dalle difficoltà sopra t tu t to economiche . Ber th ie r e ra stato subito raggiunto dal g rande «esattore» Haller che, non t rovando più nulla da spremere nella Cisalpina, veniva a saccheggiare l 'Urbe pe r rifornire non solo il Direttorio sempre a corto di quattr ini , ma anche le p ropr ie tasche. Il Vaticano fu svuotato perfino dei suoi mobili. Gli stessi ufficiali francesi ne furono così disgustati che lanciarono un appello ai romani pe r scolparsene. Il popol ino , vedendol i divisi, insorse al grido di «Viva il Papa!» E i francesi, per venirne a capo, do-
53
vettero accantonare i p ropr i dissensi. Ma questi r imasero nel fondo e resero ancor più intricata e precaria la posizione di quel governo improvvisato, senza sostegno popolare , e privo di uomini autorevoli e competent i . Solo Visconti cercava di po r r e r iparo al caos politico e alla bancarot ta economica; ma n o n poteva nulla cont ro il di lagante ladroneccio francese e ind igeno . Ad esso r isa lgono molte fo r tune r o m a n e , come quella dei banchier i Torlonia. Un ingegner A r m a n n i fece i soldi i m p i a n t a n d o u n a fabbrica di acido solforico rifornita col p iombo grattato dalle bare dei defunti.
L'accorto Ber th ie r aveva prefer i to lavarsene le man i ed era anda to a Parigi con la scusa di riferire. Al suo posto erano stati nomina t i p r i m a Masséna, cont ro cui c 'era stato da pa r t e degli altri Genera l i un mezzo pronunciamiento p e r la sua durezza, e poi Saint-Cyr, che invano cercava di met tere un po ' d 'o rd ine in quel caos. I l suo collega B r u n e scriveva: «Tutti, di qualsiasi par t i to e opin ione , concordano nel d i re che mai, in nessuna epoca e in nessun luogo, la ruber ia ha raggiunto le vette d ' impudenza che tocca nella Repubblica Romana». Lo stesso ga lan tuomo Visconti ne fu alla fine imbrattato, o fu accusato di esserlo, e di poco evitò l 'arresto.
Le cose e rano a questo p u n t o q u a n d o sopravvennero nuove complicazioni internazional i . A Campoformio , l 'Austria aveva avuto col Veneto i l suo p r e m i o di consolazione, ma n o n se ne contentava. Ora che i francesi es tendevano la loro occupazione in Italia, essa reclamava u n a compartecipazione agli utili: le Legazioni. Il Direttorio non ne volle sapere, e la delusione acuì in Vienna il des ider io di rivincita. Riallacciò l 'al leanza con l ' Ingh i l t e r ra , r imas ta sola in c a m p o contro la Francia, e vi attrasse la Russia. Questa nuova coalizione era abbastanza forte pe r infondere speranze agli Stati italiani che ancora non e rano stati occupati dai francesi, ma se ne sentivano alla mercé . Parigi se ne rese conto e, p r ima che la pa ro la fosse di n u o v o res t i tu i ta alla spada , p rese le sue precauzioni, cominciando dal Piemonte.
54
Abbiamo lasciato questo Stato al t rat tato di Cherasco del '96, che p ra t i camen te lo r iduceva a vassallo della Francia, ma consentendogl i di m a n t e n e r e i l suo reg ime. Bonapa r t e aveva negoziato con Vittorio Amedeo, e aveva lasciato al suo successore Carlo Emanuele IV m a n o libera nella repressione dei patrioti . Si contentava della sua soggezione. Non così i l Di re t tor io , che p e r mesi aveva t rasc inato le t ra t ta t ive di pace, e le aveva firmate solo al m o m e n t o di Campoformio, e controvogl ia . Car lo E m a n u e l e e r a un u o m o t imido , p io e indeciso, che di suo n o n avrebbe osato nulla contro i francesi. Ma a p p u n t o il suo debole cara t te re lo r endeva succubo di u n a Cor te reaz ionar ia e velleitaria, e sopra t tu t to di suo fratello Vittorio Emanue le , dest inato più ta rd i a succedergli-
Furono pe rò soprat tut to i patrioti lombardi che spinsero il Direttorio ad annul la re quella pace. D'accordo con quelli locali, essi t en tarono un' incursione in Piemonte pe r istaurarvi la Repubblica e fonderla con la Cisalpina. I francesi li lasciarono mor i re sotto la fucileria delle regie t r u p p e pe rché n o n volevano affatto la fusione di quei d u e Stati che avrebbero costituito un centro di potere difficilmente controllabile. Ma comprese ro che i l Re n o n era in g r a d o di garantir l i contro questo pericolo e gl ' imposero di consegnar loro prima la cit tadella di Tor ino e poi tut t i i suoi Stati. I nvano la Corte istigò Carlo Felice a u n a resistenza a oltranza, d 'altronde impossibile. I l Re par t ì di not te con la Regina senz'aver neanche il coraggio di portarsi dietro i gioielli della corona. D a p p r i m a si rifugiò a Firenze, dove a n d ò a visitare l 'altro gran fuggiasco, il Papa, e dove fu visitato da Vittorio Alfieri. «Ecco il vostro t i ranno» disse b o n a r i a m e n t e al poeta , che cont ro i t i ranni aveva tanto declamato. Alfieri si commosse alla vista del suo ex-sovrano «infelicissimo e abbandonato». Quel l ' incontro rinfocolò in lui i furori antifrancesi che p ro prio allora aveva esalato nel Misogallo. Nel suo at teggiamento si r iassumevano molto bene gli umor i della cul tura italiana, avversa a l vecchio r eg ime , ma ancora p iù spaur i ta da
55
quello nuovo. Perfino in questo campione delle più smoderate passioni, l'Italia modera ta faceva sentire la sua voce.
A Tor ino fu p roc l ama ta la Repubbl ica subalp ina . E ne p a r l e r e m o d o p o . Per o ra ved iamo i l segui to del l ' az ione francese.
Ci si r improve ra di far t r o p p o posto, in questa nost ra Storia, al capriccio degli uomini . Ma noi ci chiediamo che cosa, se n o n il capriccio, p u ò spiegare la marcia su Roma dell 'esercito napole tano. Che i francesi a Roma rappresentassero u n a minaccia anche pe r Napoli, è evidente. Ma è al tret tanto evidente che a p p u n t o pe r questo i napole tani n o n avevano nessun interesse a provocarl i , visto ch'essi pe r il m o m e n t o avevano altro a cui pensare .
Na tura lmente anche a Napoli si sapeva dell 'alleanza che, nel l 'assenza di N a p o l e o n e , s i a n d a v a abbozzando t ra Austria, Russia e Inghi l te r ra pe r u n a r ipresa delle ostilità. Ma la da ta n o n e ra stata decisa, e il gabinet to di Vienna aveva espresso la sua intenzione di n o n precipitarla. In parole povere, aveva det to ai napole tani che, se si muovevano , lo facevano a loro rischio e per icolo. E p p u r e essi si l anc iarono ugua lmente , da soli, in quell 'avventura, che n o n la ragione, ma solo le passioni possono giustificare.
Ne Eltalia del Settecento abbiamo già dato il q u a d r o della Corte di Napoli, delle sue divisioni, dei suoi intrighi, e n o n vogl iamo r ipe terc i . Ma ne r i ch iamiamo alla m e n t e i l sommario. A palazzo reale c 'erano in quel m o m e n t o d u e partit i : quel lo del re F e r d i n a n d o e del suo min is t ro degli es ter i , Gallo, che volevano u n a politica di compromesso e d'attesa; e quello della regina Maria Carol ina e del suo factotum Ac-ton, che volevano la guer ra . La gue r r a l 'avevano già fatta e p e r d u t a nel '96, q u a n d o avevano manda to un corpo di spedizione in aiuto degli austro-piemontesi , che poi si era a r re so sotto le m u r a di Mantova. Napoleone , che allora n o n voleva spingere le p ropr i e conquiste verso il Sud della penisola, aveva concesso la pace a condizioni n o n gravose.
56
Ferdinando, cui stava a cuore solo la p ropr ia tranquillità, e ra ben deciso a r i spe t ta r le . Maria Carol ina spiava invece l'occasione della rivincita. Essa era u n a Asburgo, non soltanto sorella della Maria Antoniet ta che i francesi avevano decapitato, ma anche m a d r e d i un 'a l t ra Maria Antoniet ta anda ta sposa a l l ' Impera to re d 'Austria, Francesco che, p r ima di d iventare suo gene ro , e ra già suo n ipote . Quest i legami d i famiglia con tavano mol to in u n a politica d o m i n a t a dagl ' interessi dinastici come quella delle m o n a r c h i e assolute del Settecento. E a Napoli c 'era chi sapeva sfruttarli: l 'ambasciatore inglese, Hamil ton, e più ancora sua moglie Emma, a m a n t e de l l ' ammirag l io Nelson, i l g r a n d e an tagonis ta di Napoleone .
Napoleone si trovava in quel m o m e n t o in Egitto, dov 'era riuscito a r ipor ta re brillanti vittorie. Ma ad Abukir, alle foci del Nilo, la flotta che ve lo aveva t rasporta to era stata imbottigliata e dis t rut ta da quella di Nelson. Abi lmente mon ta t a dalla p ropaganda , la notizia sollevò gli entusiasmi di Napoli, che d iventarono addi r i t tu ra deliranti nella p r imavera di quel l ' anno '98, q u a n d o Nelson, di r i to rno dalla sua impresa, gettò le ancore nella r ada pe r godersi il p r emio del suo trionfo nell'alcova di Emma.
Ques t a e ra già u n a violazione dei pat t i s t ipulati con la Francia che vietavano l'ospitalità alle navi inglesi. Ma a ciò si agg iunsero atti ch ia ramen te provocatori . La città si p a r ò a festa pe r accogliere l 'Ammiraglio, e Lady Hami l ton l 'attraversò su u n a berlina scoperta su cui sventolava una bandiera con le pa ro le «Nelson e la Vittoria» r i camate in p ie t r e preziose. L'ospite fu sommerso di don i dalla Regina, e a tal p u n t o r imase contagiato dal generale entusiasmo che, a u n a g rande rivista militare inscenata in suo onore , dichiarò che quelle e rano «le migliori t r u p p e d 'Europa».
F e r d i n a n d o , a cui n o n m a n c a v a un ce r to b u o n senso, cercò d ' imbrigl iare questi ott imismi. Ma, come al solito, fu travolto dalla moglie . In maggio consent ì a firmare un 'a l leanza offensiva e difensiva con Vienna, ch ia ramente rivol-
57
ta cont ro la Francia. In g iugno lanciò un 'energica protes ta c o n t r o l 'occupaz ione francese di Malta, su cui Napol i r i vendicava u n a platonica sovranità. E infine consentì all'ingaggio , p ropos tog l i da Mar ia Caro l ina e da Acton, d i un genera le aust r iaco, Mack, quale c o m a n d a n t e in capo dell 'esercito. Mack era un g rande storico militare. Di ogni battaglia comba t tu ta nel corso dei secoli sapeva citare luogo, data, disposizione dei repar t i , nomi degli ufficiali. Ma n o n ne aveva mai vinta una . Per di più n o n parlava u n a parola d ' i ta l iano. E forse p e r ques to gl ' i taliani lo p r e se ro pe r un genio.
Fu in questo clima di bellicosi entusiasmi che m a t u r ò la decisione. Ferd inando credet te che, pe r tenersi al r iparo dai pericoli della gue r r a , bastasse non dichiararla . Alla fine di novembre annunciò in un proclama che si considerava e voleva res ta re amico dei francesi, ma che r i teneva i m p e g n o d ' o n o r e res t i tu i re Roma «al suo legi t t imo sovrano», senza pe rò precisare se tale considerasse il Papa o se stesso. Nella storia della diplomazia - scrisse il più g rande storico di allora, Cuoco - n o n si era mai vista u n a simile dichiarazione.
L'esercito di Mack, forte di 50.000 uomini , n o n incontrò altro ostacolo che le piogge, ma bastarono a r idur lo in brandelli. Quel la che e n t r ò a R o m a e ra u n a specie di a r m a t a Brancaleone, che si det te subito al saccheggio. Fe rd inando venne a passarla in rivista, e dichiarò «liberata» la Città Eterna senza fare il min imo accenno al Papa.
I francesi avevano evacuato l 'Urbe il g io rno p r i m a fra gl'insulti e gli sberleffi della popolazione, seguiti da tutti gli esponenti del regime repubbl icano che si sentivano in pericolo di vita. Bisognava r iunire le scarse guarnigioni sparpagliate nello Stato pontificio che n o n assommavano a più di 12.000 uomini . Al loro comando era Championne t , forse il miglior generale francese, a lmeno sul p iano morale : p r o d e soldato, s inceramente repubbl icano, onesto e m a g n a n i m o . Torna to alla controffensiva, ma lg rado l 'inferiorità numer i ca, inflisse alle avanguardie di Mack un paio di disfatte che,
58
sebbene parziali, bastarono a seminare il panico in tutto l'esercito. N o n fu u n a r i t i rata. Fu u n a fuga indecorosa al «si salvi, chi può». E il più trafelato appar iva Fe rd inando , che pe r n o n farsi r iconoscere aveva scambiato la p ropr ia divisa con quella di un suo aiutante, e non faceva che r ipetere alla scorta: «Restatemi accanto, n o n lasciatemi solo!» Era talm e n t e fuori d i s enno che p r o p r i o allora, nel m o m e n t o in cui l'aveva persa, dichiarò la guer ra ai francesi perché - disse - «gli avevano opposto resistenza».
Arr ivato col fiato mozzo a Napol i , lanciò al suo popo lo un proclama che lo invitava a battersi «per il vostro pad re e Re che espone per voi la vita, che è p ron to a sacrificarla per la vostra difesa e pe r conservare a voi quan to avete di più caro: la rel igione, l 'onore delle vostre mogli e delle vostre sorelle...» Q u a n t o fosse p ron to a espor re la vita, lo dimostrò imbarcandosi pe r Palermo con la Regina, il seguito e i bagagli sulla nave ammirag l ia di Nelson. «E in pochissimi dì -v e n n e , vide e fuggì» scrisse un pasqu ino locale. Ma con quell 'appello alle mogli e alle sorelle, era riuscito a toccare il cuore dei suoi sudditi. Molto migliore del suo esercito, il popolo corse alle armi e scatenò u n a guerriglia, che sorprese e un po ' offese Championne t , convinto di essere atteso in festa da u n a città smaniosa di libertà e di repubblica. A Capua dovette fermarsi. E forse avrebbe r inunziato a en t ra re a Napoli - come del resto gli sugger iva il Di re t tor io , restìo a sparpagliare ancora di più le sue t r u p p e nella penisola, alla vigilia di u n a r ipresa delle ostilità con l 'Austria -, se al governo della città ci fosse stato qualcuno capace di organizzare e sfruttare la resistenza popolare .
Ma Fe rd inando aveva commesso anche l ' e r rore di designare a questo compito, col titolo di Reggente, l 'uomo meno adat to: il Principe Pignatelli. Costui, invece di chiamare in aiuto la flotta tut tora all 'ancora, la fece affondare. Eppoi, p u r d i o t tenere una t r egua di d u e mesi, concluse un armistizio con cui consentiva ai francesi di occupare tutte le piazzeforti in torno alla città e s ' impegnava a versargli un ' inden-
59
nità di cui n o n disponeva, perché il Re si e ra por ta to via tutto il tesoro.
In quei d u e mesi la città assediata fu p r e d a dell 'anarchia, di cui fecero le spese i «giacobini», accusati d'intelligenza col nemico. Ad aizzare cont ro di loro la furia popo la re furono sopra t tu t to i barb ier i , che ai giacobini r i m p r o v e r a v a n o di aver in t rodot to la m o d a dei capelli corti al posto della par rucca, campo dei loro virtuosismi e fonte dei loro guadagni . Ma l'etichetta di giacobino veniva applicata anche a chi n o n lo era, perché o g n u n o aveva il suo da l iquidare o da dep re dare .
Tuttavia questa caccia al l 'uomo mise i giacobini veri nella necessità di agire. A metà gennaio essi s ' impadroni rono con un colpo di mano dei Forti di Sant 'Elmo e di Castel Nuovo, e con le loro artiglierie cominciarono a bat tere le s t rade su cui avanzavano i francesi. Ma ci vollero tre giorni e quat t romila mort i , p e r r i d u r r e alla rag ione i «lazzaroni». L'ultima loro impresa resistenzialista fu il totale saccheggio del palazzo del loro «padre e Re», in n o m e del quale si e r ano così vigorosamente e gra tu i tamente battuti .
Championne t seppe conquistarseli con un gesto accorto. En t ra to in città sulla fine del genna io (del '99), si recò immedia tamente a r e n d e r e omaggio a San Genna ro che, lungi dal serbargli il broncio, reciprocò la cortesia improvvisando fuori t e m p o il solito miracolo . «San G e n n a r o è d iven ta to giacobbino» disse, sorpresa e un po ' scandalizzata, la gente . E pe r il momen to , fu pace.
CAPITOLO SETTIMO
I B O R B O N E A PALERMO
Per Ferd inando e Maria Carolina, q u a n d o sulla fine del '98 vi g iunsero a b o r d o della nave ammiragl ia di Nelson, la Sicilia era u n a t e r r a del tut to sconosciuta: in qua ran t ' ann i di Regno n o n ci avevano mai messo piede. Di essa n o n sapevano che ciò che ne riferivano i Viceré nei loro rappor t i , ammesso che li leggessero.
Si t r a t t ava de l res to di un ' i so la mis ter iosa a n c h e p e r i suoi abitanti pe rché la mancanza di s t rade ne rendeva inaccessibili molte par t i specie del l ' in terno, e i g rand i p ropr ie tari ter r ier i che se ne spart ivano la fetta maggiore avevano un concet to così assoluto della loro sovrani tà che nei loro feudi n o n ammet t evano interferenze del po t e r e centrale e si so t t r aevano per f ino ai cens iment i . N o n si conosceva n e m m e n o l ' a m m o n t a r e della popolaz ione , ma s i p r e s u m e che si aggirasse sul mi l ione e mezzo . Pa l e rmo , coi suoi 200.000 abitanti, era la città più popolosa d'Italia d o p o Napoli, ma anche quella in cui il contrasto fra lusso e miseria era il p iù sfacciato.
Alla base del la s i tuazione politica ed economica stava quel la sociale. U n a specie di «Libro d 'oro» s t ampa to p r o pr io in quegli anni definiva orgogliosamente la Sicilia come «la t e r ra dei nobili» pe r il fatto che ce n ' e rano di p iù che in qualsiasi altra regione della penisola: 142 principi, 788 marchesi, 1.500 fra duchi e baroni . Questa moltiplicazione e ra dovuta a un fatto molto semplice e che di nobile aveva poco: siccome nessun sistema fiscale era mai riuscito a funzionare , invece d ' imporgli u n a tassa, al ricco si vendeva un blasone. Na tura lmente la vecchia nobiltà, quella del sangue, le
61
cui dinastie più antiche risalivano ai Normann i , reagivano a questa inflazione m a g g i o r a n d o i p r o p r i titoli pe r differenziarli da quelli nuovi . I l marchese di Geraci aveva coniato per sé quello - di p u r a fantasia - di «Primo Signore pe r grazia di Dio nel l 'una e nell 'altra Sicilia, p r imo Conte d'Italia e Principe del Sacro Romano Impero». Non è che un piccolo scampolo della gara che divampava fra questi nobili pe r accaparrars i , nel l 'ambito della stessa casta, delle posizioni di «vertice». E ques to accan imento aveva il suo p e r c h é nel la s t ru t tura feudale della società, che faceva del r ango la condizione del po te re e del po te re la condizione della ricchezza. Un po ' per la sua posizione geografica, un po ' per l'ininterrot to p redomin io spagnolo, la Sicilia era rimasta complet a m e n t e es t ranea al r i n n o v a m e n t o d ' idee e al r i formismo economico po r t a t i da l l ' I l lumin ismo. «In nessun sito del m o n d o un titolo è più pregia to che in Sicilia» scriveva Colletta che p u r e , come n a p o l e t a n o , n o n veniva cer to da un paese democratico.
Non tutti i titolati, che si chiamavano gener icamente «baroni», e rano ricchi. Di quelli nuovi, alcuni si e r ano rovinati pe r diventarlo, altri s ' indebitavano fino al collo pe r tenere il passo di quelli che li sovrastavano. E questa era a p p u n t o la dannazione loro e della loro categoria. Nell'Italia del Nord i q u a d r i del l 'ar is tocrazia s i a l largavano p e r l ' immissione di nuovi e lement i borghes i distintisi in qua lche m o d o , p e r esempio nel servizio di Stato, come in P iemonte . E quest i innesti si r ivelavano benefici alla stessa casta pe rché la r insanguavano economicamen te e vi po r t avano idee p iù mod e r n e . Fu grazie a questa osmosi che i nobili acquis tarono un certo spirito d ' in t rapresa , cioè fu la borghesia che convertì la nobiltà alla p ropr ia mentalità imprendi tor ia le: lo abbiamo visto ne L'Italia del Settecento.
In Sicilia - come in S p a g n a - avveniva e s a t t a m e n t e il contrar io : il borghese imblasonato si convertiva alla mentalità r edd i t i e ra e parass i tar ia del l 'ar is tocrazia del s angue e ne adottava, maggiorandol i , tutti i vizi: la smodata passione
del fasto c o m e segno di po tenza , l ' a r roganza , l ' esagera to concetto delle p ropr i e prerogat ive , i l morboso at taccamento alle a p p a r e n z e e alle «precedenze»: i n somma tutt i quei carat teri che ancora, a duecen t ' ann i di distanza, caratterizzano i l nobile siciliano d i m o s t r a n d o q u a n t o quel la società sia r imas ta immobi le e pietrif icata a n c h e in ques t i u l t imi d u e secoli che d o v u n q u e a l t rove ne h a n n o visto i l to ta le sconvolgimento.
Le cifre par lano chiaro. Dei 360 villaggi della Sicilia, 280 vivevano in regime di signoria feudale, cioè sottoposti a un ba rone che vi si comportava da sovrano assoluto. Gli abitanti - quasi tutti contadini - e rano pra t icamente dei servi della gleba, t enu t i a p r e s t a r e corvées, cioè g io rna te di lavoro gratuito, e inabilitati a cambiare domicilio. Non che lo proibisse la legge, ma lo proibiva il b a i o n e , che sulle o r m e del fuggiasco sguinzagliava la p ropr ia personale polizia, lo portava davant i al p rop r io t r ibunale e lo gettava nelle p rop r i e prigioni.
I l let tore n o n si faccia un q u a d r o t r o p p o n e r o di questa situazione. Molto spesso essa era mitigata dal cara t tere del feudatar io che, lungi dal l 'abusare dei p r o p r i diritti, o ch 'egli cons iderava tali, li esercitava con pa t r ia rca le bonomia . Ciò che n o n a m m e t t e v a e ra che gli venissero contesta t i . Molte volte si e r ano provati a farlo sia i Viceré spagnoli che i funzionar i p i emontes i nel b reve p e r i o d o in cui la Sicilia aveva fatto par te del Regno dei Savoia. Ma la resistenza era stata irriducibile e aveva tr ionfato anche sul p iano giuridico, q u a n d o un avvocato palermitano, Di Napoli, riuscì a far accettare dal t r ibunale di Stato il principio che il feudo - si t rat tasse di u n a fattoria, o di un villaggio, o di u n a in te ra provincia - e ra p ropr ie tà privata del feudatar io, in quan to come tali Ruggero il N o r m a n n o (figuriamoci!) li aveva considerati e distribuiti ai suoi subalterni, che lo avevano aiutato a conquistare la Sicilia.
Ques ta causa r imase famosa negli annal i siciliani perché nel suo piccolo riassumeva tutti gli aspetti più tipici e salien-
63
ti della situazione isolana. Anzitutto, l 'onnipotenza dei baroni e la loro solidarietà q u a n d o e rano in giuoco i titoli del loro potere . Essi passavano la vita e d renavano i loro pat r imoni a contenders i un palmo di terra , un at tr ibuto nobiliare e la p r ecedenza in u n a cer imonia . Ma q u a n d o si t ra t tava di difendere la loro ind ipendenza dal po te re centrale, si chiudevano a testuggine in un fronte comune , impar t endo dall'alto della loro casta l 'esempio della riottosità e del l 'omertà.
Secondo , l ' impossibili tà da p a r t e della Giustizia di sott rars i alla sugges t ione e alle press ioni ambienta l i . I magistrati siciliani giuravano fedeltà al Re, ma a un Re che se ne stava a Madr id o a Napoli. Probabilmente a inclinare la loro bilancia in favore dei baroni non era tanto il sent imento della p ropr i a indifesa solitudine di fronte alle loro milizie private, q u a n t o i l r icat to di un mal in teso «patr iot t ismo». Per c o m u n e convincimento, l 'at tentato al dirit to del ba rone diventava l 'attentato alle «libertà» siciliane. Il suddito (perché di «cittadino» non si poteva parlare) o il villaggio che voleva sottrarsi alla soggezione feudale e scuotersi di dosso la servitù della gleba pe r mettersi sotto la protezione della legge dello Stato commet teva un gesto di fellonìa p e r c h é faceva combutta con u n o straniero (il Re) contro un siciliano (il barone).
Ques to convincimento si e ra formato in secoli di d ipendenza coloniale. I l t r a t t a m e n t o r icevuto lo giustificava in par te , ma solo in par te . La Spagna n o n aveva sfruttato, come qualcuno dice, la Sicilia; al contrario, ci aveva rimesso di suo. Ma n o n aveva min imamente tentato di a m m o d e r n a r n e le s t ru t ture anche perché quel tipo di società feudale corrispondeva al suo. Essa preferì lasciare le cose come stavano, il che accrebbe nelle plebi siciliane la totale sfiducia nei poteri dello Stato. Q u a n d o al domin io spagnolo si sostituirono , d o p o i l fugace in te rmezzo p i emon te se , p r i m a quel lo dell'Austria e poi quello dei Borbone di Napoli, questo processo era o rma i irreversibile. I nuovi p a d r o n i t e n t a r o n o a più r iprese di r i d u r r e l 'onnipotenza baronale , come vedre-
64
mo a propos i to di Caracciolo, ma si t rovarono di fronte al m u r o di u n a resistenza massiccia. Gli oppress i facevano combu t t a con gli oppresso r i in n o m e delle minacciate «libertà» siciliane, che in pratica e rano la libertà del ba rone di tenere il contadino in schiavitù. Il patriott ismo siciliano - in q u a l u n q u e forma si manifesti, separat is ta o au tonomis ta -n o n è mai stato che questo e seguita ad esserlo anche oggi: la trincea del privilegio e l'alibi, da par te di ch iunque detenga il potere , del diritto di abusarne .
Anche gl 'intellettuali ne e rano complici. La cul tura siciliana era «area depressa» rispetto a quella italiana, che a sua volta era «area depressa» r ispetto a quella eu ropea . L'analfabetismo dilagava. L'Università di Messina era stata chiusa e quella di Catania distrut ta da un t e r remoto sulla fine del Seicento. Pa le rmo cercò d i approf i t t a rne pe r c r ea rne u n a sua propr ia , ma dovette r inunziarvi pe r l 'opposizione di Catania, dove alla fine furono istituite tre scuole di Stato, ma riservate agli aristocratici. Così il circolo si era chiuso. Avendo anche il monopol io della cultura, l 'aristocrazia non aveva più nulla da temere pe r i suoi privilegi. Per i pochi talenti che riuscivano ugua lmente a svilupparsi, n o n c'era scampo: o emigrare come fecero per esempio l 'architetto Juva ra e il musicista Scarlatti, o mettersi al servizio del potere .
L'avvocato Di Napoli che aveva fatto trionfare in t r ibunale il pr incipio dell 'assoluta sovranità feudale incarnava app u n t o ques to t ipo d ' in te l le t tuale a l soldo dei ba ron i . N o n c'è da biasimarlo. Aveva studiato dai preti , che certo non gli avevano dato da leggere le ope re degl 'Illuministi . Ma anche se le avesse lette e avesse voluto farsi b a n d i t o r e dei loro princìpi, a chi si sarebbe rivolto? Non parl iamo dell ' interno dell 'isola, asso lu tamente impene t rab i le e so rdo a qualsiasi «messaggio» sociale. Ma nella stessa Palermo, che sapessero leggere e scrivere e quindi fossero in grado di capire, c'erano sol tanto i ba ron i - e n o n tut t i - e i Mons ignor i , i quali avevano in m a n o le chiavi di qualsiasi p romoz ione economica e sociale. Infatti Di Napol i g u a d a g n ò un mucchio di
65
qua t t r in i , e d o p o m o r t o ebbe anche l 'onore d i un m o n u men to per il servigio reso ai padron i . Altri che si distinsero in queste forme di collaborazionismo ebbero in p remio il titolo nobiliare. Le c ronache n o n regis t rano nomi d'intellettuali che denunziassero quest 'avvilente condizione e p roponessero r imedi radicali. Forse ce ne furono, ma n o n ebbero n e a n c h e il t e m p o di espr imers i . Gli unici che r iusc i rono a farlo furono quelli che s eppe ro m a n t e n e r e le loro critiche en t ro i limiti della più stretta p rudenza . Il più audace fu Di Blasi che giunse a chiedere un ' imposta progressiva sul reddito, ma in un l inguaggio da giurista assolutamente incomprensibile alle masse. Natale mise in discussione la pena di mor te , ma avallò la tor tura . L'economista Sergio p r o p u g n ò le dot t r ine liberiste, ma tenendosi sull 'astratto. Più che voci siciliane, e rano echi del riformismo napole tano, che si spen-gevano sul m u r o della generale ignoranza.
Sia p u r lent issimo, qua lche m u t a m e n t o tut tavia avveniva anche sotto la crosta di questa società pietrificata. La Sicilia, come tutt i i paesi a r eg ime feudale, viveva quasi esclusivam e n t e di agricoltura. Non tut to era latifondo. C 'e rano anche dei feudi modesti , i cui titolari non avevano altro lusso che il blasone e n o n campavano molto meglio dei contadini , di cui condividevano anche il livello intellettuale. Tuttavia la fetta più grossa era quella riparti ta t ra alcune diecine di famiglie, le cui p r o p r i e t à r a g g i u n g e v a n o d imens ion i da Texas, come quella del pr incipe Butera che, secondo Mack Smith, ne ricavava il dieci pe r cento dell ' intero reddi to siciliano.
Questa ingiusta redistr ibuzione avrebbe anche po tu to essere u n a fortuna - come lo era per esempio in Lombard ia e in Toscana - perché consentiva l 'accumulo di capitale, che a sua volta poteva consentire gl 'investimenti e quindi il decollo industriale dell'isola. Ma il terr iero siciliano n o n aveva la mentali tà imprendi tor ia le di quello lombardo . Per lui la ricchezza n o n era s t r u m e n t o di al tra e più g r a n d e ricchezza,
66
ma solo di po te re e di fasto. Invece di r is iedere sulla terra , r isiedeva in città, un icamente inteso ai suoi impegn i di com a n d o e di rappresentanza .
Ques to p r o d u c e v a d u e conseguenze . L a p r i m a e ra u n cont inuo drenaggio del reddi to dalla sua vera e unica fonte - l ' agr icol tura - alla città col conseguen te i m p o v e r i m e n t o della campagna e dei suoi abitanti. La seconda era la formazione di u n a nuova categoria sociale: il r appresen tan te in loco del p a d r o n e assenteista, il gabellotto.
In Sicilia n o n c'era mezzadria . I l reg ime prevalente era quello dell'affitto, che dappr incipio era stato a breve termine: in genere , un anno . Ma alla fine i p a d r o n i si e r ano accorti che il breve termine invogliava il contadino a praticare un 'agricol tura di rapina, intesa più a saccheggiare che a coltivare i campi . Così si e r a n o in t rodot t i t e rmini più lunghi , dai t re ann i in su, che st imolavano a u n o sfrut tamento più razionale. Ques to p e r ò aveva ancora più bisogno della supervis ione del p a d r o n e che, oltre a ignora re tut to di agricol tura , spesso n o n sapeva n e m m e n o dove fossero le sue t e r r e . Perciò prefer iva da re l ' intero lat ifondo in appa l to a qua l cuno che gli garant isse un cer to r edd i t o e se ne compensasse intascando il di più.
Nella storia dell 'isola, l 'avvento di questo nuovo personaggio r a p p r e s e n t a un fatto fondamenta le . Come tu t te le società a s t ru t tura feudale, la Sicilia non conosceva che d u e classi: il p a d r o n e e il servo. A differenza di tutte le altre città d ' E u r o p a , quelle siciliane n o n e r a n o riuscite a sv i luppare un vero e p ropr io ceto medio con una sua coscienza di classe. Vita mercant i le e art igiana ce n 'era poca. E quella poca ruotava, come la cultura, in torno al potere , cioè alla nobiltà, cui forniva u n a docile clientela. Per esempio, tutto il mercato del g rano , che rappresen tava la principale risorsa dell'isola, era in mano a pochi grossisti, che ne facevano quel che volevano, spesso provocando coi loro incettamenti delle carestie artificiali pe r far rialzare i prezzi. Ma tut to ciò avveniva col beneplacito del potere , di cui questo racket era solida-
le e complice. La città era insomma soltanto un centro milit a re e amminis t ra t ivo, n o n c h é il luogo di r i t rovo della nobiltà e la palestra dei suoi lussi e lustri e piaceri. A Palermo Goethe scoprì che sulle s t rade veniva lasciato lo sterco pe r fornire un soffice tappeto alle carrozze.dei nobili e nessuno se ne lamentava. Del resto, bastava gua rda re l 'architet tura: ciò che n o n era palazzo, era tugur io .
In Sicilia - e questo spiega molte cose -, la classe media si sv i luppò in c a m p a g n a , e il suo p r o t o t i p o fu a p p u n t o il gabel lo t to . E ra d i solito un e x - c o n t a d i n o segnalatosi agli occhi del p a d r o n e p e r par t icolar i capacità, o p p u r e un ca-pe ronzo lo di quel le squadracce di cui il b a r o n e si serviva come di milizie private. C o m u n q u e , un analfabeta, ma che aveva dato prove di zelo e di energia: un «duro», insomma. E tale infatti si rivelò. La sua comparsa n o n migliorò di certo le condizioni dei contadini , anzi le peggiorò . Anche per ché quasi s empre lontano, i l ba rone era molto più tollerante e bonar io : il Gattopardo n o n è un frutto della fantasia di Lampedusa .
Il gabellotto aveva ben altri artigli. Egli si mise n o n in posizione di contrasto, ma di concorrenza col p a d r o n e . Come suo vicario ne esercitava i diritti, ma por tandol i al sopruso sistematico. In tanto , essendo dei loro, conosceva molto meglio i contadini e le loro malizie. Eppoi , doveva sfogare u n a lunga fame di dena ro e di autorità. C'è chi dice che la mafia n o n fu che il sindacato dei gabellotti, la loro segreta associazione di m u t u o soccorso pe r tenere in soggezione i contadini e in r ispet to i p ropr ie ta r i . Non vogliamo adden t r a rc i in questo problema che ancora suscita polemiche a n o n finire. Probabi lmente la mafia è più antica (Titone dice che risale add i r i t tu ra ai saraceni) e a provocar la fu la p ro lunga ta assenza di qualsiasi po te re centrale: una specie di rozzo autogoverno esercitato da privati . Ma n o n c'è dubbio che i gabellotti se l 'accaparrarono e le d iedero i quadr i .
Altrettanto indubitabile è che furono loro a precosti tuire i caratteri della borghesia siciliana, anche q u a n d o questa co-
68
minciò a svilupparsi nelle città, pe r il semplice motivo che i gabellotti furono i pr imi non-nobili che po te rono da re ai loro figli un ' is t ruzione e farne degli avvocati, dei medici, dei professori, dei magistrat i , ma s empre nel q u a d r o di quella società feudale , di cui essi avevano m u t u a t o dai b a r o n i la mentali tà e i vizi. Non pe r nulla la borghesia siciliana ha del t i tolo accademico la stessa cupid ig ia che i l b a r o n e mos t ra del titolo nobiliare. Non pe r nulla, da q u a n d o ha assunto i l po te re , lo esercita con gli stessi criteri corporativi . Non pe r nulla essa ostenta lo stesso at taccamento al privilegio, e pe r d i fender lo innalza il vessillo del patr iot t ismo siciliano cont ro le in te r fe renze del lo Stato. I n s o m m a è u n a borghes ia che, pe r un vizio d 'origine, n o n ha potu to né saputo svolgere la funzione economica e cul tura le delle a l t re borghes ie italiane. Gli uomini d'iniziativa e di talento ch'essa p roduce con meravigliosa fertilità sono tu t tora costretti a emigrare .
Verso la fine del secolo c 'erano stati d u e tentativi di riscossa. Del p r i m o fu protagonis ta , nel ' 73 , la plebe di Palermo, rido t t a alla fame da un raccolto a n d a t o male e forse a n c h e dalle speculazioni dei soliti grossisti. Ma p r o p r i o il suo and a m e n t o d imos t rò quale re te di omer tà , consapevoli o inconscie, i ba ron i avevano saputo tessere. Essi detestavano il viceré Fogliani pe r qualche sua t imida manifestazione di democrazia. Trattava con garbo anche la gente di «ceto ignobile», come scriveva con o r r o r e i l Villabianca, cioè di umi le condizione, e aveva tentato d ' impor re u n a piccola tassa sui consumi di lusso, che na tura lmente colpiva i ricchi. E p p u r e , q u a n d o venne la carestia, la plebe se la rifece con lui e lo costrinse alla fuga. La città r imase in balìa degl ' insor t i che si avventarono, è vero, anche contro i baroni ; ma, privi com'er a n o d ' idee e di capi, non seppero sfruttare il successo. Ad emergere in quel t rambusto furono le «maestranze», cioè le corporaz ion i di arti e mestier i , unica forza popo l a r e organizzata. Ma essa dimostrò subito il suo fondo conservatore, ch 'era poi il motivo pe r cui le autori tà l 'avevano sempre fa-
69
vorita. Le «maestranze» e r a n o complici dei monopo l i per ché e rano un monopol io anch'esse. Nessuno poteva ot tenere un pos to di lavoro qualificato senza i i pe rmesso della «maestranza» che diffìcilmente lo concedeva p e r r i d u r r e l'offerta di m a n o d o p e r a e tenere aiti i salari. Essa non difendeva i diritti del lavoratore, ma soltanto i privilegi dei suoi consociati , e p e r ques to e ra r iconosciuta e p ro te t t a come p a r t e di un «sistema» che a p p u n t o sui privilegi s i basava, p rendeva ufficialmente par te alle cerimonie, e spesso assolveva compiti di polizia ausiliaria.
Q u a n d o i ribelli si fu rono impadron i t i di Pa le rmo e rimasero in balìa di se stessi, furono le maestranze che presero la direzione di tut to perché e rano le uniche che sapessero far funzionare i servizi. Ma i negozianti e gli artigiani che ne componevano il grosso si resero subito conto che, senza i baroni , andavano incontro al fallimento perché i baroni erano l 'unica loro clientela (quando si dice i baroni s ' intende, è logico, anche gl ' impiegati, i clienti, i famigli dei baroni) . Essi in t rodussero qualche r i forma t imidamente giustizialista, ma soffocarono nel sangue la rivolta e r ichiamarono i nobili forse sperando di o t tenere , in r icompensa del servigio, u n a maggiore partecipazione al potere . Ma furono presto delusi. Una volta che po te rono d isporre delle forze militari mandate di rincalzo da Napoli, i baroni r ipresero in m a n o la situazione.
Il secondo tentativo fu fatto dal viceré Domenico Caracciolo. Era un marchese napo le tano , ma nato in Spagna da m a d r e spagnola, e formatosi a Parigi e a L o n d r a , cioè alia scuola del l ' i l luminismo francese e del l iberalismo inglese. Già a Napoli si sentiva spaesato: la considerava un avanzo di Medio Evo. Pr ima di accet tare il governo della Sicilia, che sapeva ancora più a r re t ra ta , esitò un anno . I l personaggio era di rilievo in tut to: nei difetti non meno che nelle qualità. Era intell igente, colto, onesto e coraggioso. Ma le sue idee liberali si sposavano male a un t e m p e r a m e n t o autor i tar io , impaziente e talvolta perfino insolente. Era libero da tut to,
70
ma n o n dai p reg iudiz i , e con t ro i nobili siciliani ne aveva molti: li considerava dei parassiti p repoten t i e intesi solo all'esteriorità. In u n a parola, li disprezzava ed era deciso a rid u r n e la protervia.
Ma i baroni avevano, pe r difendere i p ropr i privilegi, un istituto di cui e rano riusciti a fare la band ie ra del patriottismo siciliano: il Par lamento. Nel mito popolare esso passava pe r la t r incea delle «libertà» isolane nei confronti delle Potenze s t ran ie re che avevano via via d o m i n a t o la Sicilia. In realtà n o n era affatto così. Mai o quasi mai il Par lamento siciliano si era trovato in conflitto politico col p a d r o n e di turno . Le un i che sue bat tagl ie e r a n o s e m p r e state d i o r d i n e amministrat ivo e fiscale e si r iducevano a questo: impedi re le in ter ferenze del po te re cent ra le nelle sfere che i ba ron i consideravano di loro competenza e soprat tut to nella r ipartizione degli utili e degli oneri .
Esso era diviso, come quello prer ivoluzionario francese, in tre Camere o «bracci»: quello dei nobili, quello del clero, e quello delle città «demaniali», cioè poste sotto la giurisdizione del Re, e n o n di qualche ba rone . Era un Par lamento peripatetico, perché si r iuniva ora a Palermo, ora a Catania, ora a Messina, e in nessuna di queste t re città aveva u n a sede fissa: a volte teneva le sue sessioni in palazzo reale, a volte in cattedrale, a volte anche in case private.
I l suo compi to p iù i m p o r t a n t e e ra quel lo di stabilire l ' ammonta re dei «donativi», e questa parola rappresentava i l trofeo di u n a delle sue p iù grosse, ma anche più inutili , vit torie. I «donativi» e r ano in real tà i contr ibut i che la Potenza occupante esigeva dalla Sicilia. Ma i baroni n o n li avevano mai accettati come tali. Li ch iamavano «donativi» come se si trattasse di un regalo, il che forniva loro buon i argoment i p e r d imos t r a r e con quan ta tenacia e successo difendevano la dignità dell'isola. Però li pagavano, o per meglio d i re li facevano paga i e pe rché il meccanismo era questo: un Comitato pa r l amenta re imponeva a ciascuna città o villaggio la sua quota, ma la r ipart izione di questa quota fra
71
i singoli contr ibuenti era affidata al feudatario locale o a u n a commissione di «notabili», e o g n u n o capisce cosa succedeva. Siccome in Sicilia po te re e ricchezza e rano sempre concentrati nelle stesse mani in quan to l 'uno era fonte dell 'altra e viceversa, a fare le spese di questo sistema fiscale era il povero impotente .
I l Pa r l amen to n o n ostacolò Caracciolo, q u a n d o quest i decise di s o p p r i m e r e l ' Inquisizione: anche il «braccio» del clero approvò, perché quel t r ibunale faceva concorrenza ai suoi. P u r t r o p p o tale soppress ione ne c o m p o r t ò un 'a l t ra : quella del l ' immenso archivio in cui e rano compendia t i tutti i casi della Sicilia. La o rd inò il Re forse su pressione delle famiglie più in vista dell'isola, tu t te più o m e n o interessate a d isperdere le tracce di tanti delitti, soprusi e malversazioni. Ci vollero d u e giorni pe r consumare nel fuoco tut te quelle carte, e pe r la Storia fu u n a perdi ta grave.
Ma le cose cambia rono q u a n d o il Viceré attaccò il sistema dei privilegi alla base, cioè inva l idando il ve rde t to che aveva dato la vittoria a Di Napoli nella famosa causa sui diritti feudali. Il feudatar io, egli disse, n o n era che un «delegato» del Re, con cui pe r t an to non poteva metters i in concorrenza. Il Re non gli aveva mai dato facoltà di ar res tare e g iud icare i suoi vassalli p e r c h é ciò spet tava u n i c a m e n t e a lui, né tanto m e n o di a rmare u n a milizia personale.
Incoraggiato da questo battagliero at teggiamento, il terzo «braccio», quello delle città demaniali , presentò al Viceré la richiesta di un «catasto» delle p ropr i e t à feudali in m o d o che anche queste fossero soggette a u n a quota dei «donativi». Caracciolo, che probabi lmente aveva sollecitato la p ro posta, la fece sua, e i ba ron i sen t i rono che lì si giuocava la part i ta decisiva. Fin allora mai nessun Viceré era arrivato a tanto. Anche quelli che coi baroni si e rano trovati in conflitto non lo avevano mai spinto al p u n t o di aizzare cont ro di essi al tre forze sociali. Avevano sempre prefer i to in ul t ima istanza appoggiarsi a loro e comprarsene la complicità riconoscendoli come unici legittimi r appresen tan t i della Sicilia
72
e lasciandogliela in appa l to . Ques to e ra il tacito pa t to che pe r secoli aveva regolato i r appor t i della nobiltà siciliana col p a d r o n e di t u r n o e le aveva consentito di fare dell'isola u n a sua clientela. Caracciolo vi contravveniva c r eando un conflitto d ' interessi e di classi che r o m p e v a il circolo del l 'omertà . La richiesta delle città demanial i dimostrava che non tutta la Sicilia era dei baroni e pe r i baroni . Dimostrava che combat tere le «libertà» dei baroni n o n significava a t tentare a quella della Sicilia. Dimostrava che in Sicilia c 'erano delle forze interessate a r i du r r e la protervia dei baroni .
Pu r t roppo , fu Caracciolo stesso ad annul la re gli effetti di quel p r imo successo. Egli e ra capace di tener testa a tut to e a tutti, ma n o n alla p ropr ia lingua. Aveva perfet tamente capito che questo famoso Par lamento siciliano, s trombazzato dai suoi esaltatori come il gemello e anzi il modello di quello inglese, lungi dal r app resen ta re u n o s t rumento del p ro gresso, rappresentava la trincea del privilegio. Ma commise l ' e r rore di dirlo ape r t amen te , offendendo un mito che, sia p u r e a to r to , e ra p e n e t r a t o nella coscienza siciliana. N o n volle sentire di «donativi»; li chiamò «contributi» quali effett ivamente erano, e anche questo ferì il suscettibile nominalismo isolano.
Ma lo sbaglio più grosso lo commise q u a n d o pre tese di sopp r imere o a lmeno r i d u r r e le feste di Santa Rosalia, pat rona della città. Aveva ragione pe rché il costo di quelle feste, che si svolgevano in luglio, ma si r ipe tevano anche in gennaio e in ot tobre, incideva paurosamente sul bilancio di una città che non aveva di che provvedere neanche ai servizi p iù elementar i . Ma il popolo vi era così attaccato che minacciò la rivolta. «O festa o testa» scrissero sulla por ta di casa del Viceré, il quale dovette r imangiarsi l 'ordine e uscì da quella sconfìtta gravemente discreditato.
La delus ione lo esacerbò. Da b u o n illuminista, egli n o n credeva nelle libertà democrat iche , e anche pe r questo era tanto avverso al Par lamento . Ma era convinto che un assolut ismo efficiente e giustizialista avrebbe avuto l ' appoggio
delle masse. E invece o ra doveva convincers i che n o n e ra così: le masse p re fe r ivano le l umina r i e e i mor t a r e t t i p e r Santa Rosalia alle scuole e agli ospedali. Tentò di smantellare i monopol i a cominciare da quelli delle «maestranze» ord inando loro di aprirsi a tutti i lavoratori, e u r tò contro u n a insormontabi le resistenza passiva. Fece costruire un cimitero pe r impedi re l ' inumazione nelle chiese dove si sviluppavano fetori insopportabi l i . Ma la gente seguitò a seppell ire in chiesa i suoi mort i , istigata da pret i e becchini che su quest 'uso facevano lauti affari. N o n suscitò consensi popo la r i n e m m e n o la tassa imposta sulle carrozze pe r f inanziare la pavimentazione delle s t rade. La tassa n o n colpiva che i ricchi e sarebbe anda ta a beneficio anche dei poveri . Ma i poveri vi r imasero indifferenti.
Nessuno saprà mai se le masse siciliane r imasero sorde alle r i forme di Caracciolo p e r incomprens ione o pe r sfiducia nelle sue capacità di realizzarle. C o m u n q u e il suo insuccesso d imos t rava che la col lusione fra aristocrazia e p lebe era a tutta prova e non lasciava spazio a forze riformistiche. I baroni , che alla Cor te di Napoli avevano i loro avvocati e complici, da t empo la bersagliavano di p reghie re e minacce pe rché li liberasse dei «villani e spregevoli modi del governan te Caracciolo», cont ro cui n o n si stancavano di diffondere calunnie . Mobil i tarono perf ino i l p a d r e di re Ferd inando , Carlo I I I di Spagna. Ma forse fu lo stesso Caracciolo a sollecitare, pe r stanchezza e delusione, il p rop r io r ichiamo. Ques to n o n s i risolse tut tavia in un «si luramento» p e r c h é Caracciolo venne anzi nomina to Primo Ministro con facoltà di designare il p ropr io successore a Palermo.
Lo scelse nella pe r sona del pr incipe di Caramanico , uomo fornito di u n a personali tà meno incisiva, ma anche meno angolosa, e anche lui intriso di cul tura francese e d ' idee illuministe. Caramanico non r innegò i l p r o g r a m m a del p redecessore; si limitò a smussarne le p u n t e , e questo gli consentì di r a g g i u n g e r e qua lche r isul ta to . Fece ratif icare i l principio che il feudo era un' investi tura da par te del Re, cui
74
quindi restava sottomesso, e con un miracolo di diplomazia o t tenne dal Par lamento l 'adesione di massima al catasto e a u n a più equa ripart izione degli oner i f iscal i . La rivoluzione francese e il rimescolio che provocò impedì la realizzazione di questi proget t i . Ma la loro esigenza era ormai riconosciuta e accettata.
La nobile, anche se malaccorta , bat taglia di Caracciolo, di cui Caramanico era stato il cont inuatore , n o n aveva raggiunto g rand i risultati. La Sicilia restava pra t icamente qual era da secoli: u n a foresta pietrificata, una giungla di privilegi e di monopol i , dove chi n o n e ra oppresso era oppressore , e viceversa. Però l ' impegno dei d u e Viceré e i loro r ap por t i e r ano serviti a lmeno a questo: a far capire alla Cor te di Napoli, la quale della Sicilia non si e ra mai ricordata, che la Sicilia c'era ed era così.
Questo aveva la sua importanza, ora che l'isola diventava i l rifugio di un Re, che in q u a r a n t a n n i di r egno n o n aveva mai n e m m e n o sentito il bisogno di andar la a vedere .
«Tutto qui mi r i p u g n a . I pre t i sono corrot t i , il popo lo selvaggio, la nobiltà infida» scriveva in u n a delle sue centomila lettere la regina Carolina, subito d o p o lo sbarco. Duran te la t raversa ta da Napol i , aveva sofferto un t r e m e n d o mal d i m a r e e l 'ul t imo na to le era mor to t ra le braccia. Pur senza conoscerla, aveva s e m p r e detes ta to la Sicilia, e il fatiscente palazzo Colli in cui l 'avevano alloggiata n o n era certo il p iù indicato p e r fargliela a m a r e . Ma sopra t tu t to sentiva che i l suo ascendente sul Re, e quindi la sua influenza politica, era in declino: «Non mi si consulta, neanche mi si ascolta, e sono terr ibi lmente infelice».
F e r d i n a n d o aveva s e m p r e mal soppor t a to i l suo cattivo carat tere , ma in politica si fidava del suo giudizio, considerandola degna figlia di Maria Teresa, e pra t icamente le aveva lasciato fare tut to quello che voleva. Le aveva consenti to di r o m p e r e il pat to di famiglia che legava i Borbone di Napoli a quelli di Spagna pe r trasferirli nell 'orbita dell'Austria,
75
di l iqu idare il suo migl ior min is t ro , Tanucci , e di fare del suo favorito Acton il vero factotum del Regno. Ma ora aveva di che r impianger lo . Era stata lei a tirarsi addosso i francesi con quella disgraziata gue r r a preventiva e ad affidare il com a n d o dell 'esercito a Mack, che n o n aveva certo dimostrato g r a n genio s trategico. F e r d i n a n d o i n s o m m a n o n s i f idava più di lei e sembrava deciso a imbrigliarne il forsennato attivismo. Per questo poteva contare sull 'aiuto di Acton che, da q u a n d o aveva smesso di essere il favorito della Regina, e ra diventato il favorito suo.
Maria Carol ina si e ra s empre imposta con gl ' intr ighi di Cor te in cui era maestra , ma la Corte era r imasta a Napoli . Gli unici amici che l 'avevano seguita fin lì e rano l'ambasciato r e inglese H a m i l t o n e sua mogl ie E m m a , coi qual i n o n aveva segreti. Gli Hamil ton e rano u n a strana coppia, in cui la mogl ie valeva, o a l m e n o contava, mol to più del mar i t o pe r via dei suoi legami con Nelson, l 'eroe nazionale inglese. E m m a si mos t rava nel la vita un 'a t t r i ce mol to migl iore di q u a n t o fosse stata sul palcoscenico, d o n d e proveniva . Da quan to se ne p u ò capire, e ra u n a mi tomane frigida, che sapeva recitare anche la passione, q u a n d o serviva all'ambizione . Come dominava il mar i to e l ' amante , così dominava la Regina fingendo u n a partecipazione senza riserve sia ai suoi entus iasmi che alle sue indignazioni . Le t resche di ques te d u e d o n n e esercitarono un peso nefasto sulla politica estera ed i n t e rna dei Bo rbone in ques to p e r i o d o , ma n o n s i p u ò negare che lo abbiano esercitato.
Dal canto loro, i siciliani avevano accolto i fuggiaschi con un calore in cui tuttavia n o n c'era ombra né di patriott ismo né di devozione a u n a dinastia, che n o n si e ra mai curata di loro. C'era solo la contentezza di essersi liberati da u n a posizione subal terna nei confronti di Napoli , di vedere Palermo promossa a capitale con la sua Corte e le cerimonie, le feste e i rituali di cui sempre le Corti si c i rcondano; e la speranza, da p a r t e dei ba ron i , d ' i r re t i re il Re e di farne il loro s t rumento .
76
Ma queste attese e rano anda te deluse. Ferd inando suscitava pa recch ie s impat ie p e r la sua cordial i tà e b o n o m i a . Aveva affidato a pr incipi siciliani d u e impor tan t i dicasteri , t rat tava tutti con affabilità, e si e ra affrettato a trasferirsi in u n a villa sul m a r e pe r sottrarsi alla moglie. Ma, con un appannagg io r idot to al lumicino, aveva bandi to un regime di austerità, e come al solito si sfogava a caccia e a pesca.
La Regina invece si e ra fatta subito de tes tare pe r la sua a r roganza e petulanza. Essa n o n nascondeva il suo disprezzo pe r i siciliani, anzi l 'ostentava con insigne malaccortezza, n o n par lava che di Napol i , e aveva formato u n a specie di «governo-ombra», fatto di adula tor i e di avventur ier i , p e r organizzare la riconquista.
Vedremo più tardi quale nefasta influenza vi esercitò. Per ora r ip rend iamo il filo degli avvenimenti .
CAPITOLO OTTAVO
LA REPUBBLICA PARTENOPEA
Abbiamo lasciato Napoli nel m o m e n t o in cui C h a m p i o n n e t vi en t rava . «La r ivoluzione è fatta - scrisse a Parigi -: un monarca di meno , u n a repubblica di più.» Infatti la Repubblica era già stata proclamata, e alla sua presidenza era stato designato quell 'ex-fuoruscito Lauberg , che abbiamo già incontrato a Milano fra i più irrequieti esponent i della sinistra democratica.
N o n fu u n a scelta fo r tuna ta . L a u b e r g n o n aveva nul la pe r piacere ai napoletani : né il n o m e che denunciava la sua origine tedesca, né il passato. Il popolo n o n lo considerava dei suoi perché era nobile, i nobili lo consideravano traditore pe r le sue idee, i preti lo consideravano apostata pe rché aveva det to messa e poi aveva gettato la tonaca alle ort iche pe r sposarsi. Per di più, aveva un cara t tere in t rans igente e violento, che l'esilio aveva reso ancora più aspro. «Cosa possiamo aspettarci da voi che avete t radi to anche Cristo?» gli disse la Principessa di Belmonte.
Ma il governo era composto da uomini seri e appassionati, forse anche t roppo appassionati per essere dei buoni politici. Fra loro brillavano il giurista Mario Pagano, incaricato di e laborare la Costituzione, e Vincenzo Russo, un giovane ascetico do t t r ina r io , incapace di d i s t inguere fra u top ia e realtà, ma coraggioso e devoto alia causa.
Erano dei sognatori . Ma solo dei sognatori potevano tentare, in un Paese come quello, un esper imento come quello. La Costituzione fu il solito documen to accademico, ricalcato sul modello francese, che non fece né male né bene perché r imase solo u n a d ichiaraz ione di b u o n e in tenzioni . Ma fu
78
sul piano dei problemi concreti che si vide insieme la buona fede e l ' inesperienza di questi improvvisati governanti . Essi esclusero dai pubblici uffici tutti coloro che avevano collabora to col «tiranno». Il t i r anno era un Re che aveva regna to pe r vari decenni . E l 'epurazione quindi - come diceva gius t amen te Cuoco - , co lpendo coloro che avevano servito i l Re, colpiva coloro che avevano servito il Paese.
A questa p r ima misura, che na tura lmente non potè essere applicata ma irr i tò la pubblica op in ione , ne segui un'altra più logica, ma altret tanto difficile: lo smantel lamento del sistema feudale. Esso era incompatibi le con la democrazia, ma la sua l iquidazione ledeva vasti interessi, che andavano affrontati g r a d u a l m e n t e . I l p r i m o passo, l 'abolizione del maggiorascato, n o n incontrò forti contrasti . Ma q u a n d o fu annunzia ta una riforma agraria che distruggeva i latifondi e tutti i privilegi che vi e rano connessi, le resistenze s'irrigidirono e la battaglia si fece aspra.
A condur la sul p iano propagandist ico fu soprat tut to u n a donna , Eleonora De Fonseca Pimentel , editrice e direttr ice del giornale // monitore. Romana di origine portoghese, essa e r a v e n u t a a Napol i da sposa, c 'era r imas ta da vedova, e aveva tentato di lanciarvi un salotto intellettuale. Pu r t roppo la società napo l e t ana n o n consent iva quei ma t r imon i fra mondan i t à e cul tura che facevano la fortuna e lo sp lendore della società francese. Eleonora aveva invano cercato di fare t ra esse da ponte , e forse era stato propr io questo insuccesso a inasprirla contro un regime che lo rendeva impossibile. S'iscrisse alla massoneria, e di li scivolò nei circoli giacobini di cui d ivenne la ninfa Egeria. Era stata anche arrestata e, a quanto pare , solo per sbaglio rilasciata. // monitore se lo scriveva quasi tutto da sé, c imentandosi in qualsiasi a rgomento di politica, di economia, di le t tera tura , di cos tume. La sua prosa arzigogolata e piena di svolazzi n o n rivela né originalità né profondi tà di pens ie ro . Forse nel suo i m p e g n o era mescolata anche u n a certa dose di femminile vanità: le piaceva essere la Madame Rolland di Napoli. Ma alcune cose le
79
vide con più chiarezza degli uomini : pe r esempio l'inutilità di s t ampare libri e opuscoli di p ropedeu t ica rivoluzionaria in u n a l ingua i tal iana che le masse n o n conoscevano. Era u n a sognatr ice anch'essa, ma i l risveglio seppe affrontarlo con ammirevole dignità.
Per il nuovo regime, u n o dei più grossi incagli era la situazione economica. Come al solito, i francesi avevano imposto un forte t r ibuto pe r i l man ten imen to delle loro t ruppe , e il governo n o n sapeva dove at t ingerlo pe rché il Re si era por ta to via la cassa. Championne t , che voleva aiutare la Repubblica, ma doveva anche accontentare l 'esigente Direttor io , consigliò a L a u b e r g di m a n d a r e u n a d e p u t a z i o n e a Parigi pe r spiegare la situazione e o t tenere facilitazioni. Gli ambasciatori par t i rono, ma a mezza strada furono raggiunti dalla notizia del s i luramento del loro prote t tore .
Championne t era caduto pe r un basso intrigo ordi to t ra un Commissar io ch'egli aveva al lontanato pe r le sue ruberie, Faypoult, e il generale Macdonald che aspirava a p ren dere il suo posto. Costoro lo avevano denunzia to al Direttorio come venduto agl'italiani: un'accusa che, a p p e n a arrivato a Parigi, lo por tò davanti al t r ibunale militare e poi in galera. In seguito fu riabilitato, ma t roppo tardi: subito dopo , morì di c repacuore .
Così la Repubblica perse il suo più valido punte l lo p ro prio nel momento in cui ne aveva più bisogno: l'Austria era scesa in g u e r r a e i suoi eserciti si appres tavano a r iconquistare l'Italia. A Parigi gli ambasciatori furono accolti malissimo e b ruscamen te congedat i . R ien t r ando a Napoli , vi t rovarono una situazione in rapido de te r ioramento . Sebbene il fronte italiano fosse ancora calmo, i francesi r agg ruppavano le loro t r u p p e sparpagliate nella penisola. Macdonald, p re vedendo di essere r ichiamato al nord , aveva abbandona to la città nelle man i di Faypoult, il p iù avido e infame di tutti i ladroni che quell 'esercito si era por ta to al seguito.
Ma c'era di peggio. La r ipresa delle ostilità aveva rianimato i sentimenti filo-borbonici del popolino. Nella capitale
80
si accendevano congiure. La più celebre fu quella che prese il nome di u n a donna , destinata - del tut to e r roneamen te -a p r e n d e r e posto accanto a Eleonora nella martirologia re pubblicana: Luisa Sanfelice. Questa signora era una testolina sventata che, andata sposa a un u o m o non m e n o sventato di lei, aveva dilapidato in mondan i t à e galanterie il patrimon io di famiglia, pe r castigo e ra stata in te rna ta anche in un convento , e o ra viveva, d 'accordo col mar i to , facendosi m a n t e n e r e dai suoi amant i . U n o di essi, un cer to Baccher, convinto monarchico, aveva annoda to un complot to pe r impadronirs i del forte di Sant 'Elmo e di là dare il via alla rivolta. Se ne confidò con Luisa. Ouesta se ne confidò con un al-tro suo amante , che a sua volta se ne confidò con lo storico Vincenzo Cuoco. E costui la indusse a denunz ia re la tresca, anzi pa re che redigesse di suo p u g n o la delazione. Baccher fu messo a m o r t e , e Luisa si t rovò p romossa a G iovanna d'Arco della Repubblica pa r tenopea .
Ma la minaccia più g rande veniva dalle province dell'int e rno , dove il nuovo reg ime n o n era ancora riuscito ad affermarsi . C o m e negli Stati pontifici, anche qui la legge la de t t avano i br igant i che si t r inceravano d ie t ro l'alibi della fedeltà al t rono e all 'altare. Michele Pezza det to Fra Diavolo terrorizzava Itri e i suoi d in torn i con gesta in cui è diffìcile r iconoscere il fantasioso e cavalleresco protagonis ta dell 'opera lirica che a lui s'ispira e ne por ta il nome. In realtà era u n o scellerato mozzates te , e lo r imase anche d o p o che re Ferd inando l'ebbe nominato colonnello come il suo compare M a m m o n e che, a d i re di Colletta, usava pe r boccali i teschi delle sue vittime.
Questo miscuglio di spirito protestatario contro qualsiasi novità e di uzzolo di saccheggio si chiamava sanfedismo perché p r e t e n d e v a d ' ispirarsi alla Santa Fede, e forse n o n sarebbe a p p r o d a t o a nulla di conclusivo, se ad a s sumerne le r ed in i n o n fosse sop ravvenu to un n u o v o pe r sonagg io d i ben altro prestigio e statura. Fabrizio Ruffo era un Principe calabrese d iven ta to Card ina l e grazie alla p ro t ez ione di
81
Pio VI, che ne aveva fatto il suo tesoriere. Stando a certe voci, il tesoro di cui si e ra più preoccupa to era quello suo. Ci dev'essere qualcosa di vero pe rché a un certo p u n t o la carica gli fu tolta, sebbene vi avesse dato prove eccellenti. Torna to a Napol i , e ra d iven ta to , grazie al suo n o m e , alla sua presenza, ai suoi modi di g ran signore, u n a delle f igure più in vista della Corte, senza tuttavia scadere al r ango di cortigiano. Non si pe rdeva in intrighi e pettegolezzi. Le sue parole contavano anche perché ne pronunciava poche. Q u a n do il Re e la Regina par t i rono pe r Palermo, egli li seguì, ma controvoglia, pe rché quella fuga gli sembrava un disonore , e lo era. Infatti n o n ci r imase che pochi giorni . Alla fine di genna io disse alla Regina che sarebbe to rna to in Calabria, ch 'era quasi pe r intero feudo della sua famiglia, pe r accendervi la rivolta, ma n o n chiese aiuti né di uomin i né di den a r o . Attraversò lo s tret to con ot to servitori . E ai p r imi di febbraio aveva già ai suoi o r d i n i un piccolo eserci to , che ogni giorno s'ingrossava di nuove reclute.
La storiografia r i sorgimentale ha d ip in to a fosche t inte questo brigante porporato, p r e sen tando lo come un Fra ' Diavolo maggiora to . Ma n o n è così. Inca rnaz ione del vecchio r eg ime con tu t te le sue ot tusi tà e ingiustizie, Ruffo lottava pe r u n a causa che n o n meri ta simpatie e che la Storia aveva già condanna to . Ma l ' uomo n o n e ra da bu t t a r via, come si vedrà al t e rmine della sua impresa. Cer tamente i contadini calabresi gli corsero incon t ro affascinati dal suo n o m e , famosissimo nella contrada, e dalle sue seriche vesti cardinalizie che non smise mai. Ma egli seppe organizzarli e t r a d u r r e in spirito di crociata le loro torbide smanie di rapina. Da vero prelato cattolico, senza illusioni sulla u m a n a na tura , patteggiò con tutti, anche coi p iù infami e sanguinar i briganti , p u r di at t rar l i dalla sua pa r te . E q u a n d o n o n potè evitarli, finse di n o n vederne i delitti, i soprusi, le ruber ie . Ma riuscì a t e n e r e in p u g n o fino in fondo la sua o rda , e a c o n d u r l a dove voleva.
Ingigant i ta dalla leggenda, l'eco delle sue gesta arr ivò a
82
Napoli in un m o m e n t o par t icolarmente delicato. I francesi, che n o n avevano n e m m e n o riconosciuto la Repubblica, avevano p rovoca to u n a crisi di gove rno e a r r e s t a to lo stesso Lauberg che poi, rilasciato, r iprese la via dell'esilio. Ma i napoletani tenevano testa alle loro p repo tenze . Non si facevano illusioni. Anch'essi sapevano che Macdona ld con le sue t r u p p e era in procinto di abbandonar l i pe r n o n farsi tagliar fuori dagli austriaci già penetra t i in Lombardia . Ma, a differ enza dei lo ro colleghi cisalpini fuggiti al segui to dei loro pro te t tor i , e r ano decisi a res tare e a lottare fino all 'ult imo. Le loro leggi con t ro i l sistema feudale cadevano nel vuoto pe r mancanza di s t rument i con cui applicarle; ma essi continuavano a emanar le , e Eleonora Pimentel a esaltarle nel suo giornale . Per c o r r e r d ie t ro al loro sogni di pa l ingenesi sociale, avevano dimenticato di organizzare i servizi necessari a m a n d a r e avanti la barca. Non avevano n e m m e n o u n a polizia efficiente. E p p u r e , r iuscirono a levare t re corpi di spedizione da lanciare cont ro l'Armata cristiana della Santa Fede, come ormai si chiamavano le bande di Ruffo. Costui si t rovò di fronte a un avversario del suo stesso calibro: il duca Cara-fa, e la guerrigl ia diventò g u e r r a aper ta , a lmeno finché Ca-rafa potè d i spor re anche di un r epa r to francese. Ma ai primi di apri le questo venne r ichiamato: Macdonald aveva ricevuto l 'ordine di risalire verso Genova, a b b a n d o n a n d o Napoli al suo destino.
La popolazione ne aveva avuto sentore, ed era inquieta. Tutti capivano che il ritiro dei francesi avrebbe dato il via alle forze monarch iche e reazionarie che avevano seguitato a t r a m a r e ne l l 'ombra . Per ca lmare gli animi e nascondere le sue intenzioni, Macdonald si presentò alla festa di San Genna ro pe r assistere al consueto miracolo. Ma stavolta il Santo si most rò reni tente , e la folla ne fu p ro fondamente turbata, vedendovi un segno di cattivo augur io . «Allora - dice il memorialista francese Thiébaul t , p resen te alla scena - il capo del gove rno , livido, si avvicinò al ca rd ina le Zur lo , gli conficcò nel costato la canna della pistola e gli soffiò nell 'orec-
83
chio: "Se il miracolo n o n avviene immedia tamente , siete un u o m o morto!" I l Cardinale ne fu ta lmente at terr i to che n o n riuscì ad azionare il trucco - se trucco c'era -, e a quan to pare ne incaricò uno dei suoi accoliti. C o m u n q u e , il sangue si mise a bollire, e la Repubblica pa r t enopea si riaccreditò agli occhi dei suoi sudditi.»
Tre giorni d o p o i francesi cominciarono a evacuare Napoli , lasciando solo u n a g u a r n i g i o n e d i pochi u o m i n i nel forte di Sant 'Elmo. La Repubblica fu sola. Ma qui a p p u n t o si vide in che legno e rano intagliati i suoi uomini . Alcuni capi br igant i le offersero i p r o p r i servigi p e r f e rmare Ruffo. Ma il governo rispose che n o n scendeva a pat t i col deli t to. N o n scendeva a patt i con nulla e con nessuno. Fino in fondo rimase fedele a se stesso.
Per n o n farne p e r d e r e il filo al lettore, seguiamone la vicenda fino all 'epilogo.
L'emergenza p o r t ò alla ribalta un al tro protagonis ta : l 'ammiragl io Caracciolo. Anche lui, come Ruffo, aveva seguito di malavoglia e con un senso di vergogna i sovrani a Palermo. Ma anche lui n o n c'era r imasto che pochi giorni. Come ufficiale, si sentiva umiliato n o n soltanto da quella fuga, ma anche dalla diffidenza che la Regina nutr iva pe r lui e dal disprezzo che Nelson ostentava pe r la fiotta napole tana . Non e ra un democra t i co , ma e ra un pa t r io t a e un u o m o orgoglioso. Con la scusa di r ego la re i suoi affari pr ivat i , si fece d a r e il p e r m e s s o di t o r n a r e a Napol i , dove fu accolto con grandi onor i e invitato a collaborare con la Repubblica. Per un pezzo aveva rifiutato. Ma q u a n d o u n a flottiglia comanda ta da Nelson sbarcò a Procida e se ne i m p a d r o n ì , lanciò un proc lama in cui accusava gl'inglesi di aver provocato la rovina dei sovrani obbligandoli alla fuga e assunse il comando delle navi scampate all 'affondamento ord ina to da Pigna-telli. C o n quelle carcasse affrontò i vascelli br i tannic i e ripor tò anche qualche successo, ma n o n riuscì a impedi re che anche Capri e Ischia cadessero in m a n o al nemico. O r a Na-
84
poli e ra chiusa sia dal la p a r t e del m a r e che dal la p a r t e di t e r ra , dove Ruffo seguitava ad avanzare , affiancato dai re par t i del l 'eserci to rego la re che i l Re gli aveva m a n d a t o di rincalzo.
In città, b e n lavorat i dalla p r o p a g a n d a monarch ica , i «lazzaroni» scesero pe r strada, e la caccia al giacobino ricominciò. Sugli o r ror i che vennero perpet ra t i , le testimonianze sono unanimi . Ruffo, che si e ra fermato, chiese al Re d'intervenire con un messaggio pe r far cessare il massacro. Rispose la Regina: «Il ve rmina io r ivoluzionar io dev 'essere estirpato». Allora i l Card ina le , a g e n d o d'iniziativa, m a n d ò degli emissari a t ra t tare un armistizio con gli esponent i repubblicani asserragliati in Castel Nuovo e in Castel del l 'O-vo. Essi n o n potevano ormai o p p o r r e più nessuna resistenza. E quindi è chiaro che il Cardinale voleva soltanto offrir loro u n o scampo.
La resa fu firmata il 23 giugno, recava l'avallo dell 'ammiraglio inglese Foote, del genera le francese Méjean comandan te della piccola guarn ig ione r imasta a Sant 'Elmo, e degli ambasciatori russo e turco . Ai repubbl icani si garant iva la vita e la libertà a Napoli, o p p u r e il permesso d' imbarcarsi pe r Tolone. Ma l ' indomani , accompagnato dagli Hamil ton, sopragg iunse con la sua nave Nelson, cui la Regina aveva raccomanda to di «trattare i napole tan i come gli abitanti di u n a città inglese in rivolta». Fece u n a scenata a Ruffo accusandolo di aver abusato dei suoi poter i , ma il Cardinale gli t e n n e testa. E m o r a l m e n t e , da quel lo scontro , uscì meglio dell 'Ammiraglio che, q u a n d o non faceva l 'ammiraglio, faceva soltanto delle sciocchezze.
Forse l'inglese si sarebbe arreso, se ad aizzarlo n o n ci fosse stata Emma , che si sentiva investita della pa r t e di vendicatrice affidatale dalla Regina. Non si sa se essa abbia messo lo z a m p i n o a n c h e nel p r o d i t o r i o c o m p r o m e s s o , p r o p o s t o da suo mar i to , che decise la sorte di quegli sventurat i . Ma, da ta l 'assoluta null i tà de l l ' uomo, è p iù che probabi le . Hamilton scrisse a Ruffo che Nelson accettava la capitolazione.
85
Ruffo l ' interpretò come un riconoscimento delle condizioni, e ne informò i repubblicani , che consegnarono la loro fortezza e t raghet ta rono sulle navi che dovevano portarli a Tolone. Le navi vennero immedia tamente sequestrate ed essi gettati nelle stive: Nelson aveva in terpre ta to la loro resa come resa a discrezione.
A i naugu ra r e il massacro fu Caracciolo. Ruffo gli offrì il destro di sottrarvisi con la fuga. Ma l 'Ammiraglio, forse diff idando di lui, r ifiutò, venne ca t tu ra to , condo t to a b o r d o della nave di Nelson e giudicato pe r direttissima da u n a corte marziale inglese. Il processo fu u n a semplice formalità e si concluse, secondo le istruzioni del Re, con la c o n d a n n a a morte . L'infelice venne impiccato sul posto, e il suo cadavere gettato in mare . E m m a Hamil ton, dicono, volle assistere all 'esecuzione da una barca pe r po te rne riferire tutti i dettagli alla sua diletta amica Maria Carolina.
Per un pezzo la forca non ebbe requie . Secondo Cuoco, che la scansò pe r miracolo, le vittime furono centodicianno-ve, fra le quali tutti gli uomini migliori della Repubblica: Pagano, Cirillo, Ciaja eccetera. Ma Cuoco non contava tutti coloro che vennero trucidati alla spicciolata dalla plebaglia. Fu una delle più orribili e ignobili feste di sangue che si fossero mai viste. I giustiziandi venivano condotti al patibolo eret to sulla pubblica piazza fra d u e file di folla esul tante e insultante, eppoi sospesi con la corda al collo a un cavo oscillante in m o d o che la loro agonia durasse più a lungo. Tutti morirono con g rande coraggio e dignità. Ma forse lo spettacolo di p iù g r a n d e fermezza e nobiltà lo fornì Eleonora Pimen-tel, le cui ult ime parole furono un verso di Virgilio. Invano Ruffo invocò u n a pa ro la di c lemenza da pa r t e del Re. Sul patibolo salì anche un ragazzo di sedici anni , Filippo Marini, reo di aver decapitato la statua di re Carlo, padre di Ferd inando . E infine fu la volta di Luisa Sanfelice. Essa riuscì a guadagna re qualche mese fingendosi incinta, e in suo aiuto si mosse anche la mogl ie del Pr inc ipe Ered i ta r io . Ques ta aveva avuto p r o p r i o di quei t empi un bambino , e q u a n d o
86
Ferd inando venne a vederlo, trovò nella culla una supplica. Ma accortosi che si trattava della Sanfelice, la gettò via stizzito insieme alla c rea tura che aveva preso tra le braccia. E così anche questa povera d o n n a fu avviata a un martir io assolu tamente sproporzionato non solo alle sue colpe, ma anche alla sua statura.
Carafa teneva ancora le sue posizioni a Pescara. Per venire a capo della sua resistenza, anche con lui si r icorse a un inganno , ch 'ebbe pe r protagonista u n o dei più scellerati briganti abruzzesi, Pronio . Anche questo episodio n o n è stato mai messo del tutto in chiaro. Il pat to era che Carafa avrebbe abbandona to Pescara con la garanzia di un pacifico ritiro delle sue t r u p p e verso n o r d pe r r iunirs i a quel le francesi. Concluso l 'accordo, pranzava con Pronio, q u a n d o la polver ie ra della cit tadella saltò p r o v o c a n d o c inquecen to mor t i . Pare che l 'at tentato fosse stato compiu to da alcuni emissari del bandi to . C o m u n q u e , costui lo attribuì al Generale accusandolo di aver contravvenuto ai patti e, arrestatolo seduta s tante lo m a n d ò a Napol i , dove v e n n e i m m e d i a t a m e n t e processato e condanna to a mor te ma, t rat tandosi di un Duca, il t r ibunale gli usò il r igua rdo di farlo decapi tare invece che impiccare. Il Generale esigette anche di essere steso supino e n o n bocconi, in m o d o da poter gua rda re la scure. E al m o m e n t o in cui il boia la librava in alto, gridò: «Dite alla Regina com'è mor to Carafa!», pe r sottolineare che a lei andava attribuito tutto quel massacro.
L'ultimo ritocco a questa tragica odissea lo det te il generale francese Méjean, che pe r dena ro consegnò ai borbonici non solo le sue piazzeforti, ma anche i repubblicani che vi si e r a n o rifugiati mimet izzandos i sotto la divisa mil i tare . Q u a n d o to rnò a Parigi, Championne t lo denunc iò al tribunale di guer ra . L'assoluzione aveva sempre fatto c redere che l'accusa n o n fosse stata provata. Invece dagli ultimi accertament i risulta che lo fu, in pieno. Ma Méjean fu ugua lmente r iassunto in servizio: in fondo, n o n aveva vendu to che degl'italiani.
87
I più fortunati furono quelli che languivano nelle galere. Fra di essi c ' e rano lo storico Vincenzo Cuoco e i musicisti Cimarosa e Paisiello. Dal fondo delle loro sordide celle potevano udire il r i tornello scandito in coro dai popolani esultant i (chissà mai di che): «A lu suono de li violini - s e m p r e mor te ai giacobbini!»
CAPITOLO NONO
IL '99
Per seguire le vicende di Napoli, abbiamo un po ' sopravanzato gli avvenimenti . R ip rend iamone d u n q u e il filo.
Visto che la g u e r r a e ra inevitabile, e ra stata la Francia a dichiararla all'Austria il 2 febbraio (del '99) p r ima che i suoi eserciti si congiungessero con quelli russi. Sul fronte tedesco le ostilità cominc ia rono subito. Quel lo i taliano gode t te ancora un mese di calma, di cui i francesi prof i t tarono pe r l iquidare sommar iamen te le poche p e n d e n z e ancora in sospeso.
Anzitutto, il Piemonte dove, abbiamo det to, era stata p ro clamata la Repubblica. I lombardi avevano subito avanzato il p roget to di annet ter la alla Cisalpina. Ma esso incontrò l'ostilità n o n solo di Parigi, ma anche di Tor ino , t imorosa di d iventare un ' append ice di Milano. I particolarismi regionali seguitavano ad essere più forti dello slancio uni tar io. Piuttosto che u n a d ipendenza lombarda , gli stessi repubbl icani prefer i rono fare del loro Piemonte una provincia francese e inviarono una richiesta in questo senso al Direttorio, che indisse un plebiscito n a t u r a l m e n t e t ruccato . Di p r o c e d e r e a un 'anness ione ufficiale n o n ci fu il t empo. Ma l 'amministrazione fu affidata a un Commissario che aveva i poter i di un prefet to, e la frontiera con la Francia fu p ra t i camente soppressa.
Poi fu la volta della Toscana. II g r a n d u c a F e r d i n a n d o n o n aveva la personal i tà , l ' impegno , lo zelo r i formatore di suo p a d r e Leopo ldo . Ma e ra un sovrano d i g r a n d e accortezza e corret tezza, equi l ibrato e u m a n o . Fin da l l ' appar i re del p r i m o eserci to francese, aveva d ich ia ra to la p r o p r i a
89
neutral i tà e l'aveva scrupolosamente osservata, nonos tan te le sollecitazioni di suo fratello l ' I m p e r a t o r e d 'Austr ia e di sua zia, Maria Carolina di Napoli, ch 'era anche sua suocera pe r ché ne aveva sposata u n a figlia. Abbiamo già de t to con quan ta amicizia aveva accolto Napoleone q u a n d o era sceso a s t r a p p a r e Livorno agl ' inglesi . La sua polizia n o n faceva ostacolo all 'alluvione di agenti della Cisalpina e ne tollerava la p r o p a g a n d a repubblicana. Non aveva bat tuto ciglio nemm e n o alla sovversione del reg ime di Lucca, fin allora Stato i n d i p e n d e n t e , che aveva dovu to ist i tuire un governo-fantoccio rad iocomanda to da Parigi. E aveva imbrigliato le dimostrazioni popolar i a favore del Papa, q u a n d o questi e ra stato scacciato da Roma.
Ma n e m m e n o questo bastò a salvarlo. Alla fine di marzo, q u a n d o gli eserciti austriaci discendevano l'Adige, i francesi discesero gli Appenn in i e p rocede t te ro all 'occupazione del Granducato . Test imone oculare, l'amica di Alfieri, Contessa d'Albany, scrisse che a Firenze essi t rovarono strade e piazze deserte: «A par te qualche canaglia, nessuno ha manifestato in loro favore». F e r d i n a n d o n o n si mosse, convinto che lo avrebbero lasciato sul t rono . Invece lo invi tarono, sia p u r e con tut t i i r i gua rd i , ad a n d a r s e n e . Part ì quasi senza bagaglio. Al m o m e n t o di salire in carrozza si avvide che t ra gli effetti personal i gli avevano messo u n a M a d o n n a del Trecento. «Questa n o n è mia; è della nazione» disse rest i tuendola al maggiordomo. Nel proclama di addio che lasciava ai sudditi , diceva ch'essi gli avrebbero dato prova di lealtà e di affetto so t tomet tendos i agli o rd in i dei nuov i p a d r o n i . La moglie dell 'ambasciatore francese Reinhard t scrisse: «E partito in modo da far sentire a disagio noi che restiamo».
La p roc lamaz ione della Repubbl ica fu saluta ta dai f ioren t in i con qua lche festa, ma senza g r a n d i en tus iasmi . I l giacobinismo in Toscana e ia debolissimo pe rché l 'illuminato e benevolo regime dei Lorena gli aveva fornito poco concime. Per di più i commissari francesi i r r i tarono subito il tenace spirito munic ipale di Firenze e il suo a t taccamento al
90
pat r imonio artistico, bu t tandosene al saccheggio. «Vediamo il palazzo g r a n d u c a l e vuotars i r a p i d a m e n t e dacché le sue chiavi sono nelle mani di questi barbari ladroni» scriveva la stessa signora Reinhardt . Anche qui i pochi patrioti che avevano salutato i francesi come «liberatori» venivano considerati dalla ci t tadinanza complici della rapina , e la loro causa ne guadagnò solo in impopolari tà .
Molte cose frattanto e rano ma tu ra t e anche nella Cisalpina, cui dobbiamo per un m o m e n t o to rnare .
Sebbene fosse u n o Stato, come oggi si direbbe, «a sovranità limitata», anzi limitatissima, essa e ra p u r s e m p r e u n o Stato, e come tale pretese di t ra t tare d i re t tamente con Parigi. Il Direttorio non aveva fatto sfoggio di generosità. Aveva imposto che a tutte le gue r re in cui la Francia si fosse trovata coinvolta, la Cisalpina contr ibuisse con un esercito di 30.000 uomini e che al man ten imen to dei 25.000 francesi di guarn ig ione nel suo terr i tor io provvedesse con un annua le s tanziamento di 18 milioni. Ma il pa r lamento milanese, che doveva ratificare il t rat tato, lo contestò: le finanze della Repubblica, disse, non e rano in g rado di far fronte a un simile gravame.
Questa resistenza irri tò Parigi che decise di sostituire gli u o m i n i al p o t e r e con altr i p iù docili e maneggevol i . Qu i pe rò si vide quan to anche i francesi fossero tra loro discordi. L'ambasciatore Trouvé era pe r un governo di moderat i ; i l c o m a n d a n t e mil i tare , B r u n e , era p e r i democra t ic i p iù avanzati. Dappr ima vinse Trouvé, che con un colpo di Stato fece nomina re un nuovo Direttorio (il governo si chiamava così anche a Milano) con poter i amplificati a spese di quelli del pa r lamento . Poi B r u n e riuscì a farlo r ichiamare e sostituire con Fouché - il futuro capo della polizia di Napoleone - con cui realizzò un secondo colpo di Stato che rimise in sella i democratici . Poco d o p o pe rò anche B r u n e fu richiamato e sostituito da Jouber t , che con un terzo colpo di Stato restituì il po tere ai moderat i .
91
Non vogliamo affliggere, col dettagliato resoconto delle successive crisi di governo, un lettore già abbastanza afflitto da quelle attuali. Ci basta avergli fatto capire t ra quali difficoltà agivano gli uomini della Cisalpina, alla mercé di un pad rone che, dilaniato dalle sue interne dissidenze, si contraddiceva ad ogni passo, e solo in u n a cosa si mostrava coerente e senza ten tennament i : nel saccheggio. Le finanze, grazie ai pesanti prelievi che vi operavano i francesi, e r ano in dissesto: la gestione del p r imo anno si era conclusa con un disavanzo di quasi 35 milioni. La vecchia burocrazia austriacante, invece di collaborare, creava intoppi. Per sottrarle alle requisizioni, i contadini imboscavano le der ra te provocando il ver t iginoso a u m e n t o dei prezzi . Ma più grave di tu t to e ra l'impossibilità di un p r o g r a m m a politico conseguente.
Per i democratici, che p u r con la loro inesperienza e pochezza ne costituivano la forza nuova e t raente , la Cisalpina doveva r a p p r e s e n t a r e l ' e lemento unificatore, il polo di attrazione di tut te le altre Repubbliche italiane che si venivano via via cos t i tuendo . E infatti, se n o n fosse stata ques to , n o n sarebbe stata che un regime di Quisling al servizio dell ' invasore. Perciò, ora che i francesi avevano sbancato i Savoia, il G r a n d u c a di Toscana, il Papa e i Borbone , Milano cercò di abbozzare u n a sua azione diplomatica allacciando relazioni con Torino, Firenze, Roma e Napoli . Ma i francesi b loccarono implacabi lmente questi tentativi , d i m o s t r a n d o in maniera solare ch'essi non e rano affatto venuti a l iberare l'Italia e a farne u n a nazione ind ipenden te , anzi intendevano impedirgl ie lo nel t imore - n o n del tu t to infondato , del resto - che un ' I ta l ia uni ta , anche se repubbl icana e d e m o cratica, sarebbe stata un vassallo meno docile di una galassia d ' impotent i staterelli.
Non meglio, anzi molto peggio, andavano le cose nella Repubblica Romana, la cui seconda versione ricalcava scrupolosamente l e o r m e della p r i m a , anche p e r c h é n o n poteva contare n e m m e n o su un ceto borghese abbastanza evoluto.
92
Ad appogg ia re il nuovo regime, d o p o il t ragicomico intermezzo dell 'occupazione napole tana , n o n furono che poche centinaia di persone , fra cui i profittatori facevano aggio sugl'idealisti, senza nessun seguito nel popolo , che i suoi umori li aveva dimostrati con le sue calorose accoglienze a Ferdin a n d o . I loro po te r i e r ano ancora più limitati di quelli dei loro colleghi della Cisalpina in q u a n t o sia i m e m b r i del «Consolato» che quelli del «Tribunato», come pomposamente si chiamavano il governo e il pa r lamento , e rano nominat i dal comandan t e francese, e i loro band i e discorsi non varcavano le m u r a della città. Fuori di essa, e ra un caos, in cui l 'unico e lemento d 'ord ine era rappresen ta to dai briganti: in nome della Santa Fede e con l'avallo dei pre t i che benedicevano le loro imprese, M a m m o n e in Abruzzo e Sciabolone in Ciociaria estorcevano tributi e tagliavano teste.
Questo era pressappoco il quad ro della penisola nel momento in cui vi calavano gli eserciti austriaci.
Era la metà di marzo del '99. Per occupare gli Stati del cent ro Italia, i francesi avevano sparpagl ia to le loro t r u p p e , e l ' e r ro re gli costò caro . P r ima di averle r iun i t e , i l loro com a n d a n t e Moreau fu ba t tu to a più r iprese , e l 'unico caposaldo che riuscì a d i fendere fu Genova. Lombard ia , Emilia e P iemonte cadde ro nelle mani degli austro-russi . E anche qui la reaz ione n o n t rovò res is tenze da p a r t e del p o p o l o , che anzi, alla par tenza dei francesi, aveva già p rovveduto a l iquidare il r eg ime repubbl icano e i suoi esponent i . Quell i lombardi non subirono la sorte dei loro colleghi napoletani perché po te rono mettersi in salvo oltre i confini ch 'e rano a d u e passi o seguire le t ruppe francesi nella loro ritirata. Ma quelli che caddero nelle mani del conte Cocastelli cui l'Austria aveva dato in appal to la rappresaglia finirono in galera o furono depor ta t i in Dalmazia.
Ma in P iemonte , p r i m a che gli austr iaci vi a r r ivassero , l ' insurrezione popola re cont ro la Repubblica d ivampò, capeggia ta da p re t i e da monarch ic i . U n a b a n d a ch iamata
93
Massa cristiana e comanda ta da un certo Brandaluccioni, che poi fu onora to come un patriota, si distinse nei saccheggi e nei massacri. I francesi, p r ima di ritirarsi, r isposero con alt r e t t an ta violenza, e i r epubbl ican i che n o n m o r i r o n o p e r m a n o dei rivoltosi si t rovarono coinvolti nelle responsabilità della rappresagl ia . Il caos era a l imenta to dal contras to fra gli alleati. I russi volevano l ' immediata restaurazione di Carlo Emanuele , m e n t r e gli austriaci la r i tardavano pe r potersi p r ima assicurare qualche guadagno terri toriale. I l governo provvisorio assunto da T h a o n di Revel in nome del Re non aveva poteri , e tanto m e n o quello di frenare le violenze. Ma anche qui si r ipeteva il fenomeno, che già si era visto a Napoli, delle masse popolar i in combut ta con la reazione più retriva contro la borghesia democrat ica e unitaria.
I l gene ra l e Macdona ld , che da Napol i risaliva verso il n o r d pe r r icongiungersi col grosso a Genova, era impegnato in continui combatt imenti con bande di guerriglieri . Nel Valdarno un ex-ufficiale della Gua rd i a Granduca le , Mari , aveva organizzato un'Armata aretina, di cui divideva il com a n d o con l 'amante inglese di sua moglie Sandr ina che tutti chiamavano «la pulzella» sebbene di amant i ne avesse avuti a bizzeffe. In questa specie di banda Cari tà avanti lettera mil i tavano anche pa recch i frati e p re t i che , n o n p o t e n d o esercitare vendet te cont ro i responsabili di un governo che in Toscana n o n aveva n e m m e n o avuto il t empo di formarsi, se la r i facevano con c h i u n q u e fosse sospet to di giacobinismo, specie se era ebreo. Ne andò di mezzo anche il Gianni, l ' i l luminato minis t ro di Pietro Leopo ldo che dovet te emigrare .
In ques to m a r a s m a v a g a b o n d a v a n o , sotto falsi n o m i e abiti, i superstiti delle repubbliche e repubblichette del cent ro . C ' e r ano anche i r o m a n i che i l genera le francese Gar-nier aveva sottratto p r ima di rit irarsi, alle furie del popolino , facendogli rilasciare dei salvacondotti . Ma n o n p ropr io tutti si con ten ta rono di scappare . Ci fu qua lcuno che volle battersi. E fu il caso di un curioso personaggio, di cui deplo-
94
r i amo che la storiografia italiana n o n abbia saputo lumeggiare la figura, che a noi sembra r iassumere le d rammat iche contraddizioni della nascente sinistra democrat ica italiana.
Si chiamava Giuseppe Lahoz, ed era un milanese di pad r e spagnolo. Giovane ufficiale dell 'esercito austriaco, aveva disertato pe r militare nell'ala più estrema, giacobina, dello sch ie ramen to repubb l i cano e si e ra messo al servizio di Napoleone che gli aveva affidato il comando della piazza di Milano. Ma q u a n d o i francesi pre tesero r i formare in senso m o d e r a t o e conserva to re la cost i tuzione della Cisalpina, andò a Parigi a protestare , e pe r castigo fu destituito. Riebbe il g r a d o e il c o m a n d o nella Leg ione pe r ché e ra l 'unico capo mil i tare che avesse d imos t r a to notevoli capacità, ma to rnò a pe rde r lo pe r la sua riottosità alle direttive francesi. Secondo qua lcuno , aveva già preso segreti contat t i con gli austriaci; ma ne manca qualsiasi prova. È provato soltanto che aveva perso ogni fiducia nella Francia, e perc iò aveva deciso di fare da solo, i s t aurando nelle Marche u n a specie di repubbl ica a cara t tere dit tatoriale e mili tare. Per questo n o n esitò a fare c o m b u t t a col b r igan te Sciabolone, il Fra ' Diavolo marchigiano, che terrorizzava la zona alla testa della sua banda . Q u a n d o francesi e austriaci r iapr i rono le ostilità, egli si mise a d is turbare gli un i e gli altri con azioni di guerriglia. La voce di una sua intesa sotto banco con gli austriaci sembra avvalorata dal fatto che, cadu to loro prigioniero in u n o di questi scontri, fu liberato. Ma in realtà il suo rilascio fu dovuto a un' intercessione del generale russo Su-vorov. Tornato fra i suoi, Lahoz li condusse all'assalto di Ancona, tu t to ra nelle man i dei francesi, e qui c adde combattendo . Non aveva ancora t rent ' anni .
E possibile che Lahoz sia stato soltanto un anarchico ribelle a qualsiasi autori tà e che la sua vera na tu ra fosse p ro pr io quella di un capo br igante , quale fu sul finire della sua breve e avventurosa vita. Ma è ancora più probabile ch'egli fosse u n o di quei pochi democratici che fecero in t empo ad accorgersi de l l ' e r ro r e commesso legandos i a u n a Francia
95
che di r ivoluzionar io aveva serba to sol tanto l 'e t ichetta , e c e r ca rono di r imed ia rv i ge t t andos i allo sbaragl io da soli, contro tutti. Forse in lui c 'erano insieme l 'una e l'altra cosa. C o m u n q u e , egli fu il p r imo italiano a pensare che gl'italiani dovevano «fare da sé» e ad agire in conseguenza , sia p u r e alla disperata. Che sia mor to da brigante dimostra u n a cosa soltanto: che pe r i patrioti italiani n o n c'era altra via da battere che fuori e cont ro ogni o rd ine costituito, sia di marca austriaca che di marca francese.
Era p r o p r i o q u a n t o cominciava a chiarirsi nella m e n t e dei supersti t i della g r a n d e illusione. Quasi tutt i r ipara t i in Francia, essi o ra e r ano intenti a red igere il fall imentare bilancio della loro avventura . I più se ne sbr igavano addossando tut te le colpe alla Francia, e gli argoment i a sostegno di ques ta tesi n o n facevano difetto. Che la Francia si fosse servita dei r ivoluzionari italiani pe r poi d e l u d e r n e tu t te le spe ranze di un i t à e di democraz ia , che li avesse screditat i agli occhi della popolaz ione facendoli complici dei p r o p r i saccheggi, e che alla fine li avesse abbandonat i e in certi casi perfino vendut i alla furia reazionaria, e ra vero. E queste fur o n o le denunz ie spor te dal Paribelli, dal Botta, dal Salvador, dal Fantoni e da tanti altri in numeros i «indirizzi» al Diret torio. Tutta la sua condot ta militare e politica in Italia fu messa sotto processo, e il fatto che alcuni dei nuovi dirigenti sposassero le tesi dei nostri democratici consentì a questi ultimi di sorvolare sulle p rop r i e responsabilità. Come sempre , nel giuochetto del «capro espiatorio», anche allora gl'italiani si d imostravano maestri .
U n o solo si rifiutò di seguirli su questa strada: il napoletano Vincenzo Cuoco.
CAPITOLO DECIMO
C U O C O
Nel suo n o m e ci siamo già imbattut i a propos i to della cong iu ra del Baccher, e d o b b i a m o r iconoscere che l 'episodio n o n gli fa mol to o n o r e . Sulla pa r t e ch 'egli vi ebbe ci sono mol te vers ioni , e q u i n d i p u ò anche dars i ch 'essa sia stata esagera ta dai suoi nemici (e ne aveva tant i) . Ma che fosse stato lui a sp ingere Luisa Sanfelice a d e n u n z i a r e il suo aman te , e anzi add i r i t tu ra a r ed ige re la delazione, sembra accertato, e p u r t r o p p o il carat tere del personaggio lo r e n d e verosimile.
Cuoco a p p a r t e n e v a a u n a famiglia di piccola borghes ia provincia le , ed e ra na to a C i v i t a c a m p o m a r a n o in quel di Campobasso. Ma fin da giovane era venuto a Napoli a farvi l'avvocato, unico mestiere, insieme a quello di prete , che offriva qualche prospett iva di «promozione» economica e sociale a chi n o n aveva il privilegio di nascere nobile. C o m e tutti i suoi contemporane i , si era imbevuto di cul tura illuministica, ma n o n se n 'e ra ubr iacato. Da corret t ivo gli faceva Vico, di cui fu forse il p r imo a capire la grandezza, e che lo t enne legato allo storicismo di Machiavelli. Fin d'allora aveva capi to che ogni naz ione e ogni cu l tu ra h a n n o u n a loro vocazione che le r e n d e al lergiche agl ' innest i d ' ideologie s t raniere . I «lumi» insomma li accettava, ma previo adattamento alle condizioni italiane.
Questo lo r endeva molto cauto nei confronti del regime borbonico. Lo criticava, ma n o n in tendeva sovvertirlo, anche perché non ci si trovava male. Reclamava pe r gli uomini della sua categoria più potere e più rango , ma al rango e al po te re ci teneva moltissimo e n o n in tendeva met te rne in
discussione la legittimità. Avrebbe po tu to benissimo diventa re un minis t ro del Re, se i l Re avesse avuto abbas tanza cervello pe r scegliersi dei ministr i come lui. Era i n somma un riformista, n o n un rivoluzionario. Infatti della rivoluzione francese fu un critico severissimo, né mai fece lega coi giacobini napoletani , anzi li combatté accanitamente corbell andone l'astratto dot t r inar ismo.
Ma ciò non gl ' impedì di arruolars i sotto le loro bandie re q u a n d o essi assunsero il po te re e p roc lamarono la Repubblica. Forse il b r u t t o ep isodio della Sanfelice va messo in r appo r to a questa conversione. I suoi passati a t teggiamenti dovevano render lo sospetto ai nuovi dirigenti . E per guadagnarsene la fiducia, Cuoco si sentì t enu to a u n a prova di zelo. Ma n o n ebbe il t e m p o di cavarne gli utili che probabi lmen te se ne r iprometteva. E fu p ropr io questa la sua fortuna, q u a n d o di lì a poco si trovò r inchiuso in galera come collaborazionista del regime giacobino.
Per le accuse che gli pendevano sulla testa e di cui l'affare Baccher costituiva il capo più grosso, gli andò abbastanza bene . Se la cavò con alcuni mesi di pr igione e la condanna a ven t ' ann i di esilio. Fu nel lungo girovagare «parte pe r mar e , p a r t e p e r gli a lberghi di Francia e senz 'a l t ro a iu to che quello della memoria» che scrisse la sua ope ra più nota e discussa, il Saggio storico sulla Rivoluzione napoletana del 1799, poi pubblicato a Milano dov'egli a p p r o d ò d o p o la r e su r re zione della Cisalpina.
Ques to libro fu considera to un mezzo t r a d i m e n t o dagli altri reduci napole tani e ancor oggi è violentemente contestato dagli storici di par te radicale. Ma in realtà contiene l'analisi più lucida di quegli avvenimenti e r appresen ta un documen to di profonda penet raz ione politica.
Sull'insuccesso della Repubblica pa r t enopea - dice in sostanza Cuoco -, le colpe dei francesi pesano molto, ma i nostri democratici n o n debbono farsene r ipa ro per nascondere quelle loro. La p r ima è quella di aver sposato in blocco e a scatola chiusa la causa r ivoluzionar ia di un Paese, le cui
98
condizioni n o n co r r i spondevano affatto a quelle dell ' I talia in gene re e di Napol i in par t ico lare . E r a n o diverse quelle economiche pe r lo stato di arretratezza e di sottosviluppo in cui versava - e versa - il nostro Mezzogiorno. Erano diverse quelle sociali pe r la pochezza e debolezza dei ceti medi . Erano sop ra t t u t t o diverse quel le cul tura l i . Le masse francesi e rano abbastanza istruite per poter c o m p r e n d e r e i l messaggio r ivoluzionario lanciato dagl ' intel let tuali e dargli con la loro par tecipazione la forza di t radurs i in istituti: l 'appello della cat tedra veniva raccolto dalla piazza e vi diventava barricata. In Italia ques ta p r e m e s s a mancava : «La cu l tu ra di pochi n o n aveva giovato alla nazione intera; e questa, a vicenda , quasi disprezzava u n a cul tura che n o n l 'era utile, e che n o n intendeva».
Perciò, dice Cuoco, la r ivoluzione in Italia era r imasta e n o n poteva che r i m a n e r e l'iniziativa asfittica di u n a esigua minoranza isolata dalle masse, con cui n o n poteva aver contatti. Lo impedivano il m u r o dell 'analfabetismo e il fatto che quella minoranza , invece di e laborare un suo p r o p r i o p ro g r a m m a basato sulle reali condizioni del Paese e in cui quindi il Paese potesse riconoscere i p rop r i aneliti e aspirazioni, s'ispirava a princìpi altrui, v ivendone passivamente d'imitazione e di r ipor to . «La nazione napol i tana si poteva consid e r a r e come divisa in d u e popoli , diversi pe r d u e secoli di t empo e pe r d u e gradi di clima. Siccome la pa r t e colta si era formata sopra modell i s t ranier i , così la sua cu l tu ra e ra diversa da quella di cui abbisognava la Nazione intera. Alcuni e rano diventati francesi, altri inglesi; e coloro che e rano rimasti napole tan i , e che c o m p o n e v a n o il massimo n u m e r o , e rano ancora incolti.»
Ecco perché la preparaz ione ideologica di u n a rivoluzione che, pe r diventare veramente democrat ica come si qualificava, avrebbe dovuto diffondersi in mezzo al popolo e suscitarne la par tec ipaz ione , era invece r imasta u n a dia t r iba di «iniziati» chiusi nelle loro accademie e intenti più a dibattere astratte questioni di dot t r ina, come sempre avviene ap-
99
p u n t o nelle accademie, che a risolvere i p rob lemi concret i di u n a società assai d iversa da quel le p re se a mode l lo , e ch'essi n o n conoscevano affatto. I m p e g n a t i a disser tare su Rousseau, i democratici napole tani n o n si e r ano mai curati di svolgere o p e r a di apos to la to fra le masse, n o n avevano mai visto un contadino lucano o calabrese, ne ignoravano le condizioni di vita, e quindi non potevano trovare in lui nessuna eco. Traditi dai francesi, avevano a loro volta t radito il popo lo , sia p u r e inconsapevo lmen te . Ed e ra ques to che l i aveva condannat i alla catastrofe.
Era fatale che le tesi di Cuoco venissero poi sfruttate dalla storiografia dell ' I tal ia monarch ica e «moderata» p e r dimost rare che i democratici del '99 n o n e rano che le scimmie dei giacobini francesi, degl ' inconcludent i retori , delle povere teste piene solo di vento demagogico. Il che è falso. Quegli uomin i ebbero il tor to di nascere in ant icipo sui t empi , ma senza dubbio contr ibuirono moltissimo a farli ma tu ra re . C o m e tu t te le g r and i imprese , i l Risorgimento aveva bisogno di pionieri , ed essi lo furono fino al sacrificio della p ro pr ia vita. Per p r imi v ide ro che la causa de l l ' i nd ipendenza nazionale faceva tu t t ' uno con quella democrat ica e che il solo m o d o di persegui r la era l 'azione r ivoluzionaria . Essi lasciarono, se non altro, l 'esempio del sacrificio. E anche i loro sbagli fu rono utili p e r c h é mise ro o av rebbe ro d o v u t o met te re i successori in guard ia dal ripeterli .
Ma che ne avessero compiut i n o n c'è da dubi ta rne , e non si p u ò far tor to a Cuoco di averli denunzia t i . Egli n o n p u ò esser t e n u t o responsabi le de l l 'uso e de l l ' abuso che altri avrebbe fatto delle sue tesi. Di fronte agli avvenimenti di cui era stato test imone, egli si p o n e da storico p r e n d e n d o da essi le distanze necessarie a d a r n e u n a visione critica. E questa visione è ineccepibile. Che la r ivoluzione napole tana fosse, come lui dice, «passiva», cioè copiata da quella francese, è scritto nei fatti. Il suo fallimento fu u n a vera e p ropr ia «crisi di rigetto» della società italiana a questo corpo estraneo trap ian ta to nel suo organismo. Al t re t tanto indubi tabi le è che
100
furono le masse - quelle cittadine dei «lazzari» e quelle contadine dei «cafoni» - a ribellarvisi. Questo è un fatto spiacevole, ma è un fatto. Cuoco avrebbe tradito il suo impegno se lo avesse disconosciuto, come fa certa nostra storiografia che i fatti spiacevoli, invece di ragionarci sopra pe r t r a rne le necessarie conclusioni, li rifiuta.
Ben altri son gli addebit i che a Cuoco si possono e si debbono muovere . Il p r imo e fondamenta le è quello di essersi messo pe r la sua sete di «impieghi decentissimi» come lui li chiamava, cioè pe r il suo arr ivismo, in u n a posizione falsa. Cuoco era se stesso quando , da b u o n illuminista corret to da Vico, come giustamente lo definisce Croce, criticava i giacobini. Cessò di esserlo quando , c r edendo che avessero vinto, si a r ruo lò nelle loro fila. E questo che dà al Saggio un certo sapore di fellonìa. Se Cuoco fosse r imasto sulle sue, a fare il test imone, com'era nella sua vera vocazione, oltre che la galera e l'esilio, si sarebbe r isparmiato anche le accuse di dop pio gioco.
L'altro suo difetto è l 'at teggiamento pedagogico. Cuoco è u n o storico di g ran classe, infinitamente super iore al Colletta e a tutti gli altri della sua epoca. La sua diagnosi della società napole tana è ineccepibile e ancor oggi p u ò essere cont rapposta a certo meridional ismo p iagnone e vittimista che imputa tutte le magagne del Sud al malvolere del Nord . Le sue pagine traboccano di osservazioni taglienti e a bersaglio, come quella del l ' impiegomania dei meridionali . Ma non resisteva alla tentazione di fare il moralista. E vero che quella di far discendere la luce dal p ropr io podio è la vocazione di tutta la storiografia illuministica, che in Voltaire tocca le sue p u n t e più alte e s t renue . Ma forse Ti tone è nel giusto quando dice che Cuoco la derivava ancora di più dalla tradizione precettistica italiana che affonda le sue radici fino a Machiavelli e a Tacito. Io tuttavia ci aggiungerei anche un altro elemento : il cinismo. I cinici sono tutti moralisti, e spietati pe r giunta.
Cuoco è terribile. Per pagine e pagine, pe r interi capito-
101
li, la sua storia si t r amu ta in requisitoria, e ce n'è pe r tutti; reazionari e rivoluzionari, statisti borbonici e t r ibuni giacobini, nobili, intellettuali e popolo. Anche lui p rocede per capri espiatori , cioè pe r semplificazioni, talvolta anche molto grossolane . I l Re e r a un pove ro i r responsabi le , la Regina u n a pazza isterica, i loro ministr i degl ' imbecil l i o dei ma-riuoli, la sconfìtta dell 'esercito borbonico ad opera di quello francese è colpa di Mack: il quale era effettivamente un som a r o , ma anche se fosse stato von Moltke, al c o m a n d o di t r u p p e come quelle, non avrebbe potu to far meglio di quel che fece Mack, cioè scappare.
I razzo lament i di Cuoco n o n furono in pa r i con le sue prediche. Dell ' impiegomania che rinfacciava ai suoi compatrioti , egli stesso fornì un e sempla re model lo . A Milano si attaccò subito al Melzi, ne d ivenne grandissimo amico e grazie a lui o t t enne la d i rez ione del Giornale italiano. Anzi, fu forse anche per far piacere a lui, antigiacobino fino all'osso, e pe r procacciarsene le simpatie, che pubblicò il Saggio. Più tardi diventò il por taparo la di Eugenio di Beauharna i s , di cui avrebbe potu to restare fino in fondo al servizio. Ma non resistette alla nostalgia di Napoli q u a n d o i Borbone rifecero fagotto, e più ancora forse alla smania di tornarvi da vincitore e vindice. A lungo tuttavia contrat tò, p r ima del r impatrio, lo scatto di grado, e lo ebbe: fu nomina to m e m b r o del Sacro Real Consiglio con diritto a carrozza e valletti, poi dire t tore del Tesoro Reale di Mura t e alto consulen te pe r la pubblica istruzione. Teneva moltissimo alle insegne del potere e ne faceva u n o sfoggio spagnolesco. Non c'era carica a cui n o n ambisse e n o n c'era piaggeria a cui rinunciasse, p u r di p rocura r se la . P robab i lmen te fu anche i l do lo re di pe r derle, q u a n d o i Borbone to rna rono definitivamente sul t rono e procedet tero alla solita «purga», a procurargl i la malattia mentale che afflisse i suoi ultimi anni . Una strana e terribile nemesi volle che il cervello più lucido di quel t empo finisse ot tenebrato dalla follìa.
CAPITOLO UNDICESIMO
L'ITALIA REPUBBLICANA: SECONDA FASE
Gli avvenimenti si susseguivano rapidi , come mai fin allora era avvenuto.
Uno dei motivi per cui il Direttorio di Parigi aveva favorito la spedizione in Egitto era - lo abbiamo già detto - il desiderio di liberarsi di Napoleone, che lo aveva salvato dalla minaccia di u n a controrivoluzione monarchica, ma che si mostrava un credi tore sempre più esigente. Fu un calcolo sbagliato. Le folgoranti vittorie r iportate anche in Africa accrebbe ro la popo la r i t à del Genera le , m e n t r e l ' incalzare degli eserciti russi, austriaci e turchi uniti alla flotta inglese nella seconda coalizione ne aizzavano nel popolo la nostalgia.
In questo clima di emergenza nazionale il giacobinismo rialzava la cresta, e il Diret tor io, sen tendosene minacciato, accen tuò la p r o p r i a i m p r o n t a au to r i t a r i a grazie a Sieyès, questa «talpa della rivoluzione» come lo aveva chiamato Robespierre : un ambizioso e spregiudicato intr igante. Egli redasse u n a nuova Costituzione che pra t icamente esautorava il Consiglio dei C inquecen to , cioè il Pa r l amento , pe r d a r e tut to il po te re all'esecutivo nella speranza di essere lui a beneficiarne. N a p o l e o n e infatti ne sembrava o rma i tagliato fuori perché non aveva più u n a f lot ta che potesse r icondurlo in patria: Nelson gliel'aveva distrutta ad Abukir e lo teneva bloccato in Egitto. Ma il Generale , avver tendo col suo fiuto l'occasione propizia, p iantò in asso il suo esercito, ed elud e n d o le navi inglesi che pa t tug l i avano i l M e d i t e r r a n e o , r ient rò a Parigi accolto come un trionfatore.
Rendendos i conto di non poter compete re con lui, Sieyès preferì cercare un accordo che si risolse in u n a vera e p ro -
103
pria cong iura pe r la spar t iz ione del po te re . I l Pa r l amento ne ebbe qualche sospet to, e il 9 n o v e m b r e (del '99) alcuni deputa t i p ronunc ia rono violenti attacchi contro il Generale , invano richiamati all 'ordine dal fratello di lui, Luciano, che sedeva al tavolo della presidenza. Napoleone venne di persona a r i spondere . Q u a n d o i suoi avversari chiesero che fosse dichiarato fuori legge, si rivolse ai soldati di guard ia sollec i tando la loro p ro t ez ione . Essi es i t a rono , ma Luc iano toccò i loro cuori denunz iando un tentativo di assassinio che in real tà n o n c'era stato. Le guard ie i r r u p p e r o nella sala e ne scacciarono i Cinquecento . Senza più opposizione, al posto del Direttorio fu istituito un Consolato di tre membr i , con Bonapar te in veste di Primo Console, cioè pra t icamente capo del governo.
Subito d o p o il colpo di Stato, Bonapa r t e volle che il popolo lo consacrasse con un plebiscito che n o n t rad ì le sue speranze: oltre t re milioni votarono a suo favore, solo 1.500 contro. E ormai sicuro del p ropr io potere , to rnò alla sua attività favorita: la gue r r a . Affidato il fronte del Reno a Mo-reau , discese con un nuovo esercito le Alpi pe r affrontare gli austriaci . Stavolta, p iù che al p r o p r i o genio strategico, dovette la vittoria alla fortuna. Il nemico lo colse di sorpresa a Marengo e lo avrebbe cer tamente sconfitto, se pe r caso in quel m o m e n t o n o n fosse s o p r a g g i u n t o i l gene ra l e Desaix con la sua divisione di cavalleria che prese gli austriaci alle spalle e spinse la p ropr i a generosi tà fino a mor i re sul campo in m o d o da lasciare tutti gli allori del trionfo al Bonaparte. Questi volle por t a re di persona la notizia a Parigi anche p e r sminu i r e quel la dei successi o t t enu t i in G e r m a n i a da Moreau , o r m a i a pochi ch i lomet r i da Vienna , e l 'Austria, con l 'acqua alla gola, si rassegnò a firmare con lui la pace di Lunéville che pra t icamente richiamava i termini di quella di Campoformio, cioè rifaceva dell 'Italia u n a provincia francese. La Russia si e ra già ritirata dalla coalizione. In campo restava solo l ' Inghil terra, ma di lì a poco (marzo del 1802) anch'essa si decise a firmare la t regua di Amiens.
104
In quel m o m e n t o Napo leone era già a l lavoro pe r d a r e al nostro Paese un nuovo assetto. Anche lui dall 'esperienza del '99 aveva trat to le sue lezioni.
La p r ima r iguardava il Piemonte. «Da q u a n d o la Casa d'Austria poss iede Venezia, il P i emon te è d iven ta to necessario alla Francia» disse b ru ta lmente Napoleone al plenipotenziario San Marzano, mandatogl i dal re Carlo Emanue le . Ma i veri motivi dei suoi p ropos i t i annessionist ici e r a n o quell i economici e quelli logistici.
I setifici di Lione e rano piombati in u n a gravissima crisi da q u a n d o e ra venu to a m a n c a r e i l g reggio del P iemonte che ne p r o d u c e v a pe r 17 milioni di lire a l l ' anno, cifra p e r quei t empi colossale. I lionesi r appresen tavano u n a grossa forza nel capitalismo francese, che a sua volta rappresen ta va una grossa componen te dell 'elettorato di Bonapar te . Essi volevano garant irs i u n a volta pe r s empre la mater ia prima, e Napoleone si mostrò sensibilissimo al loro appello.
Ma forse su di lui influì ancora di più la preoccupazione dei passi alpini: Sempione , Cenisio e Monginevro . Era qui che nelle sue spedizioni italiane aveva sempre incontrato le più grosse difficoltà, e ora n o n voleva più condividerne con nessuno gli sbocchi. «La loro facile transitabilità - scriveva -p u ò cambiare tutto il sistema delle gue r r e in Italia.»
Ai suoi disegni c'era un ostacolo: lo Zar di Russia, Paolo I, aveva preso il Piemonte sotto la sua protezione, e il Bonapa r t e n o n voleva in imicarselo . Ma nel m a r z o (del 1801), Paolo fu assassinato, e il suo figlio e successore Alessandro diede subito a d ivedere che il P iemonte lo interessava ben poco. Bonapar te non gli dette il t empo di cambiare opinione. In aprile fece di quello Stato u n a semplice divisione amminis t ra t iva e mil i tare della Francia , affidata al genera le J o u r d a n . Questo fu il p r imo passo. Il secondo venne tre mesi d o p o , q u a n d o l 'esercito p i e m o n t e s e fu i nco rpo ra to in quello francese.
A ques to p u n t o l ' indeciso e abulico Car lo E m a n u e l e
105
t rovò f inalmente la forza di abdicare in favore del fratello Vittorio Emanuele , p r imo di questo nome , che invano tentò di riallacciare u n a trattativa. Napoleone gli propose di riconoscerlo come Re di Sardegna (quale tut tora era), ma «l'avvenire del Piemonte - gli disse - è fissato pe r sempre». E infatti nel se t tembre del 1802 il P iemonte fu cancellato dalla carta politica d 'Europa : al suo posto n o n ci furono più che sei d ipa r t imen t i francesi. Lo storico Car lo Botta p ro tes tò . Protes tò i l cosiddet to «part i to Italico» compos to da d e m o cratici che, p u r avversi al vecchio reg ime dei Savoia, e r ano tuttavia fedeli alla tradizione del l ' indipendenza piemontese come p e g n o e forza unificatrice della penisola . Ma la loro voce non trovò eco nella popolazione.
Molto più laboriosa e complessa fu la sistemazione della vecchia Cisalpina. Essa emergeva dai tredici mesi della rioccupazione austriaca in condizioni disastrose. Come al solito, la «caccia al giacobino» aveva fatto da alibi di ogni sorta di soprusi, ruber ie e vendet te personali . Impegnat i nella guerra, gli austriaci n o n avevano avuto il t e m p o di res taurare il vecchio r eg ime . Si e r a n o limitati a l iqu idare gl ' isti tuti di quello repubbl icano e a persegui ta rne i responsabil i con la galera , la d e p o r t a z i o n e e l'esilio; e tu t to e ra r imas to alla mercé di u n a burocrazia improvvisata e senza controlli. Come sempre capita in Italia, il pad rone nuovo, regolarmente accolto come «liberatore», faceva r i m p i a n g e r e quel lo vecchio. Sicché q u a n d o , nella p r imavera del 1800, Napo leone r icomparve alla testa del suo esercito in marcia su Marengo, Milano lo accolse con entusiasmo, anche se con m e n o illusioni della volta precedente .
In settembre Napoleone ricostituì ufficialmente la Cisalpina ar ro tondandola con la provincia di Novara, distaccata dal Piemonte. E dopo la definitiva vittoria sull'Austria, vi aggiunse anche la provincia di Verona fino all'Adige, di cui il trattato di Lunéville faceva la nuova frontiera fra Lombardia francese e Veneto austriaco. La Cisalpina ora raggiungeva u n a certa compattezza territoriale e quasi quattro milioni di abitanti.
106
Si t ra t tava di da r l e un assetto polit ico, e n o n e ra facile perché mancavano gli uomini . I tre che formavano il governo provvisorio - Ruga, Sommariva e Visconti - valevano poco, e Bonapar te lo sapeva. C 'era poi u n a Consulta, cioè un piccolo Par lamento di c inquanta membr i , in cui qualche fig u r a di spicco allignava: Cicognara , Mascheroni , Moscati, Greppi , Marescalchi. Ma Bonapar te , che di uomini s'intendeva, sbrancò subito quello che più faceva al suo caso: Melzi d'Eril.
Melzi appar teneva a u n a delle più g rand i famiglie dell'aristocrazia lombarda , e ne por tava nel sangue le doti migliori: la re t t i tudine, la cul tura, la cortesia, ma anche u n a certa alterigia, che probabi lmente gli veniva dalla m a d r e spagnola. Aveva fatto pa r te dei circoli illuministici dei Serbelloni, dei Beccaria e di Pietro Verri, di cui era anche cognato. Napoleone lo aveva conosciuto al t empo della sua p r ima camp a g n a d'Italia, d o p o la battaglia di Lodi lo aveva invitato a Mombello, e ne aveva fatto il p ropr io consigliere. Quel gran signore che por tava ancora il costume settecentesco, le calze bianche e la par rucca incipriata, gli piaceva. Gli piaceva perché n o n era servile, pe rché n o n era venale, pe rché n o n era n e m m e n o ambizioso. U n a leggera sordità e u n a salute piuttosto precar ia , insidiata da un forte artr i t ismo, l'obbligavano a r i g u a r d i incompat ibi l i con l 'esercizio de l po t e r e . Più che il protagonista, preferiva fare il suggeri tore. Non era affatto un democratico. Anzi, al t empo della p r ima Cisalpina, coi democra t ic i s 'era t rovato in cont ras to , t an to che a un certo p u n t o aveva abbandona to non solo ogni attività politica, ma anche Milano, pe r r i t i rarsi nella vasta p r o p r i e t à di Saragozza che sua m a d r e gli aveva lasciato. Dei giacobini lombardi pensava ciò che di quelli napoletani stava scrivendo Cuoco, suo g rande amico: ch ' e rano degli astratti dottr inari , incapaci di affrontare i problemi concreti.
Di questi problemi, a lui ne interessava soprat tut to uno : la costituzione di u n o Stato italiano abbastanza forte da poter diventare un polo d 'at trazione pe r tutti gli altri. Ma n o n
107
10 voleva repubblicano, né tanto meno par lamentare . Nelle trattative eli Rastadt tra Francia e Austria, nel '98, si era adop e r a t o pe r la t ras formazione della Cisalpina in un Regno lombardo-emil iano da affidare a un Borbone di Spagna. Ma 11 proget to era stato respinto.
Ora che Napoleone lo r ichiamava da Saragozza pe r sollecitare nuovamente i suoi lumi, Melzi rispolverò quell ' idea, ma senza miglior successo. Capì subito che Bonapar te voleva tenersi la Cisalpina pe r sé e che l 'unica cosa da fare era secondarlo nel senso più favorevole agl'interessi italiani. La Costituzione ch 'era stata appron ta ta attribuiva poter i quasi illimitati al Presidente. Ma per l'elezione di costui, occorreva il voto di un'Assemblea che si potesse considerare in qualche m o d o rappresentat iva. La Consulta non lo era in quanto i suoi m e m b r i e r ano nominat i in massima par te dal Governo. Si provvide quindi a convocarne un'al t ra di 500 «notabili», scelti fra le personal i tà p iù in vista delle varie città lombarde ed emiliane.
Melzi pe rò s'avvide subito che della loro arrendevolezza non c'era molto da fidarsi perché , sebbene divisi in «moderati» e «democratici», e rano accomunati dalla ferma volontà di fare della Cisalpina u n o Stato italiano, anzi lo Stato-guida dell 'Italia. E, pe r poterl i meglio maneggia re , decise di sottrarli alle suggestioni ambientali , convocandoli n o n a Milano , ma a Lione pe r i p r imi di gennaio del 1802. Sperava che lì, in mezzo ai francesi, i loro sent iment i e r isent iment i nazionalisti si sarebbero addolciti.
Non fu così. I 450 (c'è chi dice anche meno) che ader i rono all'invito ar r ivarono a Lione dopo un viaggio massacrante flagellato da p iogge a d i ro t to , e t r o v a r o n o quel la città piuttosto lugubre , inospitale e carissima. «Si paga anche l'aria che si respira» scriveva uno di loro a sua moglie. Credevano di essere subito ricevuti da Napo leone e convocati in assemblea plenaria. Invece furono accolti dal ministro degli esteri Talleyrand e divisi in c inque sezioni, con la scusa che così avrebbero po tu to meglio s tudiare il testo della Costitu-
108
zione e m a t u r a r e le loro decisioni. In realtà si voleva impedire un loro eventuale pronunciamienlo.
I l t imore n o n e ra in fonda to . «Ci ha t rascinat i qua con u n a legge informe, emanata da un corpo legislativo più vile del Senato di Tiberio. Nella sezione ci si o rd ina di esaminare in vent iquat t r 'ore u n a Costituzione letta in fretta, già accettata con un decreto sin ora incognito, che r imet te ad un magis t ra to es tero la n o m i n a alle p r i m e car iche del nos t ro Paese... Frat tanto i deputa t i vanno e r r a n d o di caffè in caffè, annoia t i dei lo ro ospiti e dei con t inu i affronti che ricevono...»
N a p o l e o n e a r r ivò 1' 11 genna io , a c c o m p a g n a t o da Giuseppina. Fu un ingresso spettacolare, s tudiato appos ta pe r impres s iona re i Cisalpini e r i d u r n e la p ro te rv ia . A n o m e della Consul ta t ravol ta nelle acclamazioni , Melzi lo salutò con queste parole: «Si rialzino tutte le speranze! Voi, Bonapar te , lo avete voluto, e la Cisalpina ecco esiste. Se voi lo volete, sarà anche felice».
Ma il 20, q u a n d o l 'assemblea si r iunì in seduta plenaria, di felicità se ne vide poca, anzi si vide soltanto u n a g ran delusione allorché il pres idente Marescalchi invitò i deputa t i a des ignare un Comita to di t r e n t a membr i , che a loro volta avrebbero provveduto a eleggere il Presidente. Era pe r questo che li avevano fatti scomodare fino a Lione? Per delegare i loro poteri a un Comitato che si poteva costituire anche a Milano?
Sebbene avessero perfe t tamente capito cosa gli si chiedeva, i Trenta det tero un solo voto a Bonapar te , e Capra ra disse che se questi voleva il po te re , se lo prendesse con la forza. Venticinque voti si r iversarono su Melzi, che rifiutò. Una seconda votazione det te la maggioranza all'Aldini, che seguì l 'esempio del Melzi. La terza designò un oscuro depu ta to di Milano, Villa, che n o n potè rifiutare pe rché n o n era a Lione . E la seduta fu aggiornata.
Bisognava i n f o r m a r n e B o n a p a r t e . Tal leyrand, che acc o m p a g n ò i delegat i a l l 'udienza, li avvertì che il Genera le
109
«somigliava a un leone con la febbre». Secondo alcune testimonianze, si rifiutò di riceverli. Secondo altre, li ascoltò senza p ronunc ia r parola. Secondo il Motti, scagliò u n o sgabello contro di loro: cosa che cer tamente avrebbe voluto fare, ma altret tanto cer tamente non fece.
Fu Tal leyrand che a m m o r b i d ì i ribelli e li r icondusse al senso della real tà . Nelle vostre condizioni , gli disse, senza u n o Stato né uomini di Stato, in u n a situazione internazionale che p u ò precipi tare da un momen to all 'altro, avete bisogno di u n a m a n o forte che vi p r o t e g g a col suo esercito, con la sua diplomazia, con la sua esperienza.
I Trenta esi tarono ancora due giorni, t ra t tenut i dalla ferma e coraggiosa opposizione del Cicognara. Ma alla fine dovettero a r r ende r s i agli a rgoment i di Talleyrand, che e rano quelli stessi di Melzi. E il 24 decisero di p r o p o r r e alla Consulta i l n o m e di N a p o l e o n e , che p e r la p r i m a volta v e n n e des ignato in un at to ufficiale solo col suo n o m e di battesimo.
L'Assemblea fu convocata il giorno dopo in seduta plenaria pe r la ratifica, e dal processo verbale risulta che questa fu concessa fra i generali applausi . Ma n o n è vero. La battaglia fu lunga e d u r a . Bellani disse che , con un Pres iden te francese, la Repubblica sarebbe stata più sicura, ma non più italiana. Terzi r incarò la dose. I loro oppositori furono zittiti. Vedendo la mala parata, Marescalchi strozzò la discussione e b a n d ì la votazione p e r alzata e seduta . Un tes t imone assicura che ad alzarsi furono al massimo un terzo dei p re senti , ma gest icolando e l anc iando tali g r ida da s e m b r a r e maggioranza. Tale c o m u n q u e la considerò Marescalchi, che immedia tamente procedet te alla let tura del p r imo articolo: «Il cit tadino Napoleone Bonapar te è eletto pe r acclamazione Presidente della Repubblica cisalpina».
L'indomani il Generale si presentò di persona a ricevere l 'investitura. G r a n d e at tore come sempre , rifiutò la t r ibuna speciale che gli avevano allestito, decorata di ori e di bronzi come un t iono , sedette sullo scanno presidenziale e par lò in
110
italiano (lo parlava abbastanza bene) . Ma il suo discorso fu di u n o spietato real ismo. Accetto questa carica, disse, pe r ché fra voi n o n c'è nessuno in g rado di occuparla. Nessuno di voi ha un seguito popola re . Nessuno di voi è al di sopra degl ' interessi particolari che rappresenta .
Ma d o p o Tamaro venne il dolce. La scena è stata riferita in vari modi , ma sembra che si sia svolta così. Alla fine della sua f rus tante a r r i n g a N a p o l e o n e o r d i n ò al segre tar io : «Si dia let tura della Costituzione della Repubblica...», e qui fece pausa . I depu ta t i cap i rono immed ia t amen te . Balzarono in piedi e u r l a r o n o in coro, finalmente unan imi : «Italiana!... Italiana!...» N a p o l e o n e sorr ise e, p l acando con un gesto i l tumul to , disse: «Ebbene, Repubblica italiana!» Stavolta l'acclamazione fu immensa e generale . Bonapa r t e d iede l'ultimo tocco alla sua vittoria a n d a n d o incontro a Melzi, abbracciandolo e facendolo sedere alla sua destra nel posto di vicep re s iden te . Era un omaggio n o n solo a l l ' uomo, ma anche alla Consulta che gliel'aveva contrapposto .
L'episodio aveva un suo significato che t r a scendeva la quest ione di nomencla tura . Fin allora il p r o g r a m m a di un ' I talia unita era stato privativa dei patrioti di estrazione giacobina. Que l g iorno diventò a p p a n n a g g i o anche dei «moderati». Uno di loro scriveva al Melzi, a proposi to della nuova Repubblica: «Il g rande suo oggetto a d u n q u e si è di t endere ad ampliarsi pe r tu t ta la circonferenza d'Italia». E, a pa r t e quegli orribili adunque e circonferenza, era l 'espressione di un pensiero ormai condiviso, se non da tutti, dai più. Ma il lettore n o n p r e n d a abbagli: q u e s t i o n i vanno sempre riferiti a quella sparu ta pat tugl ia di p e r s o n e che costi tuivano la cosiddetta «pubblica opinione» pe r il semplice motivo ch 'erano le uniche ad avere un 'opin ione: poche migliaia di uomini sperdut i in una massa iner te e priva d ' idee pe rché priva degli s t rument i pe r farsene.
I m p a z i e n t e d i c o r o n a r e la sua ascesa a l s u p r e m o p o t e r e , Napoleone liquidò alla svelta le p e n d e n z e con gli altri Stati
111
della penisola. Nel marzo del 1801 aveva stipulato a Firenze la pace con Napol i , lasciando il Reame ai Bo rbone , ma m e t t e n d o l o p r a t i c a m e n t e sotto i l p r o p r i o cont ro l lo come poi d i r emo. Quasi c o n t e m p o r a n e a m e n t e aveva firmato col n u o v o Papa, Pio V I I , un Conco rda to con cui s ' i lludeva di averlo asservito al suo ca r ro . A Genova aveva istallato il fido Saliceti col compi to di da re a quella Repubblica u n a Cos t i tuzione che la legasse e c o n o m i c a m e n t e e m i l i t a r m e n t e alla Francia. Due sole questioni restavano da definire: Parma e la Toscana.
Il p rob lema era delicato perché i l Duca di Parma era un Borbone spagnolo s t r e t t amen te i m p a r e n t a t o con quelli d i Madrid , della cui amicizia Napoleone faceva gran conto pe r n o n trovarsi un nemico anche sui Pirenei . E fu infatti con loro ch'egli si accordò col trat tato di Aranjuez di quello stesso marzo 1801. Esso disponeva che il Duca di Parma r inunciasse al suo Stato e che in compenso suo figlio Luigi assumesse il Granduca to di Toscana, ribattezzato Regno di Etru-ria.
Luigi si e r a affrettato a p r e n d e r e possesso del p r o p r i o t rono , ma il p a d r e si era rifiutato di abbandonare il suo. All 'ambasciatore spagnolo che ne perorava la causa, Bonaparte r i spose con insolita a r rendevolezza : «Se vuol r e s t a re dov'è, ci resti!» Il fatto è che non sapeva come cavarsela con quelli della Cisalpina, che immed ia t amen te avevano avanzato le loro p re t e se a l l ' anness ione del Ducato . «Capisco -aveva det to a Melzi - che sarebbe un b u o n a r ro tondamen to pe r la Repubblica italiana». Ma a p p u n t o pe r questo non volle concederglielo n e m m e n o quando , di lì a poco, il Duca lo l iberò della sua presenza , m o r e n d o pe r un ' indiges t ione di c a rne di maiale. P a r m a r imase i n d i p e n d e n t e , cioè alle dipendenze diret te della Francia che vi nominò u n a specie di prefetto con qualifica di Residente.
A Fi renze , il n u o v o Sovrano e sua moglie , la spagno la Maria Luisa, e r ano stati accolti con indifferenza. Lui era un povero epilettico che n o n sapeva n e m m e n o m o n t a r e a ca-
112
vallo e passava le sue nott i a t i rar sciabolate cont ro i fantasmi. Lei era intelligente, astuta e intr igante, ma mezzo gobba e sciancata. Sebbene si fossero presentat i con un seguito di qua ran t a carrozze spagnole , i fiorentini cap i rono subito c h ' e r a n o figure di passaggio , e n ' ebbero u n a confe rma il g iorno stesso del loro arr ivo, q u a n d o videro che a riceverli in Palazzo Pitti e a metterl i sul t rono era il generale Murat , che comandava le t r u p p e francesi di stanza in Italia centrale. Il vero Re sembrava lui, bello e marziale nella sua rut i lante divisa. E come tale infatti seguitò a comportars i oscur a n d o con le sue brillanti feste a Palazzo Corsini quelle sussiegose e tetre di Palazzo Pitti.
Questa e ra in sintesi la situazione della penisola, m e n t r e Napoleone a Parigi si p reparava all 'ultimo balzo: quello sul t rono imperiale. Il 25 marzo (del 1802) anche il suo nemico più irriducibile, l ' Inghi l terra , aveva abbandona to la lotta e f i rmato con lui la pace di Amiens . N o n sarebbe stata in realtà che u n a breve t regua, ma Bonapar te la mise a profitto.
Il 18 maggio del 1804 un plebiscito Io proclamò Imperatore. L'Inghilterra aveva rot to la pace e r ipreso le armi l'anno pr ima. Ma per i l m o m e n t o non trovava alleati. Napoleone poteva bada re soltanto al riassetto politico che il cambiamen to istituzionale esigeva e in cui anche l'Italia doveva andare di mezzo. Le Repubbliche avevano fatto il loro tempo.
CAPITOLO DODICESIMO
REX T O T I U S ITALIAE
Alla cer imonia della consacrazione imperiale di Napoleone il 2 d icembre del 1804, c 'era anche u n a depu taz ione della Repubblica italiana, guidata da Melzi. Non e rano venuti solo pe r dovere di «rappresentanza». Alla vigilia del plebiscito, Napoleone aveva avvertito l 'ambasciatore milanese Marescalchi che la proclamazione de l l ' Impero obbligava anche l 'Italia a dars i a d e g u a t e forme istituzionali, cioè in pa ro le povere a r inunziare a quelle repubbl icane. Per Milano, l'unica soluzione era u n a monarchia . Non disse chi doveva esserne il titolare, ma lo lasciò capire.
Melzi non pose t empo in mezzo. Convocò la Consulta, e le fece votare un p roge t to di legge che t rasformava la Repubbl ica in un R e g n o e red i t a r io des t ina to a B o n a p a r t e . Quest i n o n si affrettò ad accettare. Disse che avrebbe da to una risposta al r i torno da un suo viaggio d'ispezione in Belgio e Renania. In realtà era contrar ia to: non dall'offerta, si capisce, ch 'egli stesso aveva sollecitata, ma dalle formule cautelative di cui gliel 'avevano condita: gl'italiani chiedevano che, alla mor te de l l ' Impera tore , le due corone venissero separa te , che l ' un ione fosse sostituita da un t ra t ta to di alleanza, che i tributi cessassero, e che il po tere della Consulta venisse accresciuto a spese di quel lo regio . «Cosa d u n q u e vogliono questi signori di Milano?» aveva gridato Napoleone a Marescalchi che gli aveva recapi ta to il messaggio. «Se pe r caso pensassero di tirarsi indietro, potrei anche r i d u r r e il loro Stato a d ipar t imento francese come il Piemonte!»
Non era la p r ima volta che Bonapar t e faceva scenate ai suoi italiani. Da q u a n d o a Lione lo avevano acclamato Pre-
114
siderite, a Milano n o n aveva p o t u t o r i s iedere mol to , e gli affari li aveva lasciati nelle mani di Melzi, che faceva quel che poteva, ma n o n poteva tu t to quello che avrebbe voluto. Di lon tano , Napoleone n o n si r endeva conto delle difficoltà in mezzo a cui il suo vicario si d ibat teva . Ma ques te difficoltà e rano grosse, e c o m u n q u e sproporz ionate alle capacità degli uomin i che dovevano risolverle. Milano forniva qua lche b u o n ammin i s t r a to r e ; ma , n o n essendo più la capi tale di u n o Stato dai t empi di Ludovico i l Moro , n o n aveva u n a classe dotata di esper ienza politica. Nel governo di Melzi, personal i tà di rilievo n o n ce n ' e rano . Villa e Felici, che si avvicendarono al minis tero degl ' in terni , si d imos t ravano t i tubant i e di cor te vedu te . Gli esteri e r a n o stati affidati a Marescalchi , che p e r ò B o n a p a r t e obbligava a ris iedere a Parigi pe r b e n sot tol ineare che la politica estera della Repubbl ica la faceva lui. Il guardasigi l l i Spannocch i era un b u o n giurista, ma n ien te a l t ro , e i l conte Trivulzio, ministro della gue r ra , un gran s ignore che di g u e r r a sapeva poco sebbene al t e m p o della Cisalpina si fosse improvvisato genera le .
L'unico che avesse qualità di u o m o di Stato era il ministro delle finanze, Prina, anche perché era piemontese , cioè veniva da un Paese che u n o Stato lo era da secoli. Ex-procura to re genera le della Cor te dei Conti di Tor ino e m e m b r o del gove rno provvisor io del '99, s i e r a poi trasferito nella Cisalpina e ne aveva preso la cittadinanza. N o n aveva un carat tere che attirasse simpatie. Anzi, chiuso e freddo com'era, le respingeva. Ma era un lavoratore instancabile e scrupoloso, do ta to di un acuto senso politico e - diceva S tendhal -«ha del g rande in testa».
Far quad ra r e i conti della Repubblica era un ' impresa ardua . Essa doveva p r o v v e d e r e a l m a n t e n i m e n t o del co rpo d ' a rma ta francese, di quel lo i tal iano, e alla cos t ruzione di fortificazioni e di s trade militari. Queste spese, su cui Napoleone non ammet teva r iduzioni , assorbivano c inquanta milioni, m e n t r e le en t ra te n o n superavano i settanta. Non ne
115
y
r i m a n e v a n o che u n a vent ina , insufficienti anche a p a g a r e gli stipendi dei funzionari.
Perché n o n andasse ro pe r se n e a n c h e le briciole, Pr ina r i formò tu t to il sistema fiscale r i d u c e n d o n e il pe r sona le e facendone una macchina di s t raordinaria efficienza. Fu lui a inventare la «tassa di famiglia», o meglio a ripristinarla, perché la sua vera iniziatrice era stata Maria Teresa. Ma la maggior pressione la esercitò nel campo delle imposte indiret te che colpivano tutti i consumi senza dist inguere fra quelli di lusso e quelli di p r i m a necessità. N a t u r a l m e n t e a farne le spese furono soprat tut to le classi popolari , che di lì a pochi anni gliel 'avrebbero fatta pagare . Ma con questi sistemi riuscì a po r t a re le en t ra te da settanta a oltre cento milioni e a pa regg i a r e i l bilancio. Un 'a l t ra ope raz ione di g r a n d e successo fu la sistemazione del debito pubblico, che versava nel caos. P r ina ne accer tò l ' a m m o n t a r e (217 milioni) e t rasformò i crediti in veri e p ropr i «titoli di Stato» al 3,50%. Per le operazioni che li r iguardavano, istituì il Monte Napoleone , facendone n o n più una corporazione privilegiata di creditori com'e rano i vecchi Monti di tut ta Italia, ma un vero e p r o p r i o istituto f inanziar io qualificato anche all 'emissione di buoni fruttiferi. Finché d u r a r o n o le esazioni francesi che fagocitavano una b u o n a metà delle entra te , questa rigorosa politica servì più a d r e n a r e i reddi t i che ad accrescerli. Ma dopo , ereditata e gestita da padron i m e n o esosi come gli austriaci, si rivelò - come oggi si di rebbe - uno s t rumento p ro mozionale di g r ande efficacia pe r l 'accumulo del capitale e il suo investimento a scopi produtt ivi . Le fondamenta della b u o n a amministrazione che nell 'Ottocento consentì al Lombardo-Veneto di d iven ta re la sola «area di sviluppo» di un Paese sottosviluppato, era stato il Prina a gettarle.
Ma le difficoltà in mezzo a cui la Repubblica si dibatteva non e rano soltanto quelle economiche. Formata di province e t e r o g e n e e , r educ i da esper ienze s tor iche assai d iverse , e che p r ima di allora n o n avevano avuto fra loro altri rappor ti che di rivalità e d ' inimicizia, essa restava u n o Stato im-
116
provvisato, senza tradizioni e minato dai particolarismi municipali. Quest i e r ano forti sopra t tu t to nelle vecchie Legazioni di Emilia e Romagna, restìe a riconoscere il p r imato di Milano. A Bologna bastò u n a piccola carest ia di p a n e p e r sca tenare nel 1802 u n a sommossa , e la g u a r d i a civica che avrebbe dovuto repr imer la si schierò invece coi ribelli.
A soffiare sul fuoco e rano anche i patrioti di tutte le altre par t i d'Italia. Ce n ' e rano migliaia. Tutti di estrazione democratica, e r a n o t enu t i alla larga dal r e g i m e «modera to» di Melzi. Questi anzi a un certo p u n t o propose di r inchiuderl i in un campo di concen t ramen to o di depor tar l i , ma Napoleone si oppose. Guardat i con sospetto, delusi nei loro sogni r ivoluzionari e uni tar i , resi inquieti da u n a disoccupazione che pe r molti di loro significava anche fame, questi fuorusciti n o n facevano che aizzare con t ro i l gove rno . Mancava u n a vita politica e u n a lotta di parti t i , in cui la loro opposizione potesse manifestarsi e svolgersi legalmente . E questa era forse la p iù grossa tara del reg ime. Anche negli organi che avrebbero dovuto funzionare da pa r l amen to - la Consulta e il Consiglio legislativo -, il p redomin io dei «notabili» modera t i era assoluto. Le f igure più rappresenta t ive e rano il Paradisi e l'Aldini. Ma i loro contrasti con Melzi - e ce ne furono di aspri - e rano di na tu r a personale, non ideologica. Fin d 'al lora la politica italiana palesava questo vizio, di cui non doveva mai più guar i re .
N a t u r a l m e n t e la convers ione del la Repubbl ica in Reg n o , sollecitata da Melzi, avallata senza mol te obbiezioni dalla Consu l t a e dal Consigl io, accet ta ta con indifferenza dalla popolaz ione , rese ancora più acuto il disagio dei democratici e li spinse ad arruolars i nelle società segrete, che avevano cominciato a diffondersi pe r i motivi che d i r emo . Non avevano al t ra s t rada . Il gua io è che la ba t t evano con malaccortezza. Badavano più a litigare fra loro che a svolge re o p e r a di apostola to in mezzo alle masse popola r i , di cui p r e t e n d e v a n o sollecitare l ' iniziativa. N o n ne avevano l 'umiltà. Non ne avevano il l inguaggio. Si dicevano «incom-
117
presi», ma n o n facevano nessun serio sforzo pe r farsi comp r e n d e r e . E sebbene fra loro ci fossero mok i uomini onesti e disinteressati , n o n riuscivano a guadagnars i alcun credito. Ques t a «sinistra» democra t i ca e r ivoluzionar ia confermava in somma, in tu t to e p e r tu t to , l'analisi che ne aveva fatto Vincenzo Cuoco.
Dopo la cerimonia della consacrazione, l ' Imperatore ricevette Melzi e gli altri deputat i lombardi . Ma era ancora incerto sul da farsi. Assumendo di persona la corona d'Italia, temeva di scatenare la reazione dell 'Austria, con cui in quel mom e n t o era in pace. Preferiva, disse, delegarla a suo fratello Giuseppe, anche perché questo gli consentiva di risolvere un al t ro spinoso p rob lema . N a p o l e o n e n o n aveva avuto f ig l i . Qu ind i , se fosse mor to , la successione sarebbe automaticamente toccata a Giuseppe: soluzione che non lo seduceva affatto, e che si poteva e legantemente evitare separando le d u e corone e assegnando a suo fratello quella d'Italia.
Melzi accettò subito: un po ' perché non poteva far altro, un po ' pe rché la separazione era p ropr io quello a cui gl'italiani aspiravano. Ma a rifiutare fu Giuseppe , che preferiva restare pr incipe eredi tar io di Francia. Napoleone r ipiegò su un nipote, figlio del fratello Luigi. Ma il giovane, tu t tora min o r e n n e , aveva bisogno del consenso del pad re che lo negò. N o n restava che t o r n a r e a l p r i m o p r o g e t t o : l ' I m p e r a t o r e dei francesi sarebbe stato anche il Re d'Italia.
Nell 'apri le del 1805 si mise in viaggio pe r Milano, dove aveva spedi to in avanscoper ta i l f igliastro E u g e n i o di Beauharna i s col pre tes to di assumervi un c o m a n d o militare . Aveva o rd ina to di d a r e a l l ' avvenimento la massima solennità, e i suoi desideri vennero pun tua lmen te soddisfatti. Per la para ta militare, furono ammassati i più bei repar t i dei d u e eserciti, e i bastioni di Porta Ticinese venne ro sfondati p e r r e n d e r e più impre s s ionan t e i l colpo d 'occhio. Mai si e r ano visti archi di trionfo più sontuosi e più splendide luminar ie .
118
L'imponente messinscena raggiunse l'effetto voluto. L'accoglienza fu trionfale, e l 'entusiasmo toccò l 'acme q u a n d o il cocchio imper ia le a t t raversò la piazza del D u o m o , gremi ta di folla festante La cer imonia in cat tedrale n o n ebbe nulla da invid iare a quella che poch i mesi p r i m a si e ra svolta a Not re -Dame, anzi i tes t imoni d icono che fu ancora più solenne. Affiancato da sedici Vescovi, il cardinale Capra ra benedisse e impose al nuovo Re gli onori di Car lomagno: scett ro, spada, anello e mante l lo . Poi fu por ta ta la corona . Era quella, di ferro, che avevano cinto gli antichi Re longobardi e che si conservava a Monza nella chiesa di San Giovanni , eret ta dalla regina Teodolinda. Napoleone la sollevò in alto con le p ropr i e mani e se l'infilò in testa, come aveva fatto a Parigi, p r o n u n c i a n d o la formula di r i to: «Dio me l 'ha data, guai a chi la tocca!» Gli rispose, fragoroso, il grido della folla den t ro e fuori della cattedrale: «Viva l ' Impera tore e Re!» La sua eco arr ivò anche a Vienna, dove si disse che Napoleone si e ra p roc lamato n o n «Re d'Italia», ma «Re di tu t ta l'Italia», e che aveva fatto incidere questo mot to , Rex totius Italiae, sulla medag l ia c o m m e m o r a t i v a de l l ' avven imento . Non e ra vero, ma tutti ci c redet tero . E fu la spinta decisiva alla guer ra .
N a p o l e o n e , che vi e r a già p r e p a r a t o , se ne rese conto . Ma, p r ima di lasciare Milano pe r r imetters i alla testa delle sue t r u p p e , convocò il Co rpo legislativo p e r i n a u g u r a r n e i lavori e presentargl i Eugenio nella sua veste di Viceré. «In mezzo alle cu re e alle amarezze inseparabi l i dall 'alta posizione che occupiamo - disse -, il nostro cuore ha avuto bisogno di t rova re un confor to nell 'affetto e nella conso lan te amicizia di questo nostro figlio adottivo.»
N o n e r a n o sol tanto pa ro le convenzional i . In mancanza di figli suoi, Napo leone si e ra effett ivamente affezionato a questo ragazzo, frutto del p r i m o ma t r imon io di Giuseppina, e ne era ricambiato. Eugenio amava Napoleone e gli rim a r r à fedele anche nel le o r e a m a r e del d isas t ro , q u a n d o tut t i lo a b b a n d o n e r a n n o , compres i i suoi fratelli e sorelle.
119
N o n aveva che vent i t ré ann i , ed e ra un bel g iovanot to , d i modi semplici, ma di scarsa comunicativa, che aveva cercato di mer i ta re i rapidi avanzamenti di cui aveva beneficiato con g rande invidia e stizza del clan Bonapar te . Ogni sua p romozione aveva p rovoca to violente scenate fra N a p o l e o n e e i suoi che, da b u o n i còrsi, n o n volevano dividere con nessuno ciò ch'essi cons ideravano il bot t ino di famiglia. E anche quella sua nomina a Viceré - di un Regno di cui nessuno di loro aveva voluto d iventa r Re - aveva fatto scoppiare u n a t empes ta di reciproci r infacciamenti che aveva richiesto la convocazione di un consiglio di famiglia con l ' intervento di M a m m a Letizia - Madame Mère - in qualità di paciera.
I poter i conferiti a Eugenio e rano scarsi. Napoleone n o n si contentava di dirgli in u n a lettera d'istruzioni: «Se un ministro viene a dirvi che occorre spengere il fuoco pe rché Milano brucia dovete r ispondergli che bisogna aspet tare gli ordini del Re. E se questi ordin i n o n vengono, dovete lasciarla bruciare»; voleva anche che tutt i toccassero con m a n o questa posizione subal terna . Eugenio e ra autorizzato a sedersi sul t rono reale ma sotto un baldacchino su cui campeggiava un g r a n d e r i t rat to del Re, cioè di Napoleone ; e q u a n d o riceveva il Corpo legislativo doveva scenderne e p r e n d e r e posto su u n o sc ranno d i f ianco . L ' Impe ra to r e n o n dub i tava della lealtà del suo figlioccio. Ma temeva, data la sua giovane età, che si montasse la testa, o che gliela montassero i milanesi e cercassero di s t rumental izzarlo, solleticando le sue ambizioni, pe r affermare t endenze separatiste. Nel passargli le consegne, lo mise in guard ia dai collaboratori, nei quali n o n r iponeva nessuna fiducia: «Qui - gli disse -, n o n c'è che un u o m o intelligente e di carat tere: Prina».
Melzi infatti n o n c 'era p iù . Fin al lora i l vero Viceré e ra stato lui. Ora che ce n 'era un altro, n o n avrebbe po tu to restare che a prezzo di u n a degradazione , cui n o n r ipugnava soltanto il suo orgoglio. La sua vita era stata difficile fra un p a d r o n e au to r i t a r io e impaz ien te e un p a r l a m e n t o i m p o t en te ma velleitario. N o n amava abbas tanza i l p o t e r e p e r
120
soppor t a r e tu t te queste contrar ie tà , e approf i t tò dell 'occasione pe r ritirarsi in u n a carica p u r a m e n t e rappresentat iva: la pres idenza del Senato. Ma lo fece da pa r suo, andandose ne con inchino e in p u n t a di piedi senza sbattere la por ta , e m a n t e n e n d o inalterato il suo prestigio.
Un mese d o p o l ' incoronazione nel D u o m o di Milano, i l 23 g iugno , Napo leone firmò un decre to che decideva le sorti di Lucca.
Per secoli questa piccola Repubblica era riuscita a salvare la p rop r i a ind ipendenza dalla cupidigia dei G r a n d u c h i nel cui terr i tor io era incastrata. Era un'oligarchia un po ' sul tipo di quella di Venezia. I l po te re era monopol io di un cent inaio di famiglie che lo gest ivano a t t raverso d u e Consigli - i Nobili e gli Anziani - e lo i n c a r n a v a n o nella figura del Gonfa lon ie re , simbolica come quel la del Doge . I francesi d a p p r i m a si l imi tarono a impor le un t r ibuto e a requisir le armi, stoffe e calzature pe r il loro esercito. Poi le ingiunsero un cambiamento di regime in senso democratico. E alla fine Napoleone ci m a n d ò il fido Saliceti a red igere u n a Costituzione. Qua l cuno dice ch'egli volle di p ropos i to c rea re u n a situazione d' incertezza e confusione che gli desse un pre te sto d ' intervento. C o m u n q u e , questo fu il risultato. Q u a n d o u n a d e p u t a z i o n e di lucchesi v e n n e a Milano a r e n d e r e omaggio al Re d'Italia e si sentì r improvera re con asprezza il disordine in cui versava lo Stato, capì che il reg ime r epub blicano aveva fatto il suo t empo e che, pe r evitargli u n a fine violenta, era meglio farlo mor i re di mor te natura le . Fu subito band i to un plebiscito che de t te i l r isultato voluto anche perché le astensioni furono considerate «sì»: Lucca chiedeva a Napoleone l'alto onore di en t r a re a far pa r te del suo Impero . Ricevendo il 23 g iugno i delegati che gli por tavano il responso, Napoleone disse: «Accetto il vostro voto».
L'offerta gli veniva b u o n a pe r contentare sua sorella Elisa che, nella spartizione del bot t ino di famiglia, si considerava la più sacrificata. A suo mari to Felice Baciocchi n o n era toc-
121
cato che il Pr incipato di Piombino, poco più che u n a fattoria. E la sorella de l l ' Impera tore n o n poteva restare una fat-toressa. Napoleone fece di Lucca un Principato e gliel'asse-gnò . L ' insediamento avvenne il 14 luglio e fu so lenne . Ai lucchesi Elisa p iacque (di Baciocchi n o n si accorsero n e m meno) : bene o male , e ra u n a garanzia d ' i nd ipendenza dal Granduca to .
Poche ore d o p o aver accolto i l voto dei lucchesi, N a p o leone part ì pe r Genova.
Anche questa Repubbl ica aveva os t ina tamente difeso la sua i nd ipendenza , specia lmente quella delle sue b a n c h e e delle sue flotte, e anch'essa e ra re t ta da u n a oligarchia. Ma d o p o Marengo , Napo leone le aveva ing iun to di r i formare la sua Costituzione, e pe r facilitarle il compi to ci aveva trasferito da Lucca il solito Saliceti, che coi plutocrati genovesi era in stretti r appor t i dal '96, q u a n d o aveva contrat tato con essi un prest i to p e r f inanziare (ricordate?) la p r i m a spedizione di Bonapar te in Italia.
N o n vai la p e n a a p p r o f o n d i r n e i dettagli . L'articolo più impor tan te e ra il 14 che diceva: «Sarà istituito a Genova un arsenale di costruzioni, e la Repubblica avrà un a r m a m e n t o mari t t imo che c o m p r e n d e r à a lmeno d u e vascelli da 74, d u e fregate e quat t ro corvette». Era questo infatti, e niente altro, che N a p o l e o n e voleva assicurarsi : un b u o n p o r t o , b u o n i cantieri e un po ' di flotta pe r t ene re quella inglese lontana dalle coste italiane.
Ma, pr iva di e n t r o t e r r a , Genova viveva solo di m a r e , i l mare era in m a n o agl'inglesi, e gl'inglesi ne interdicevano il transito non soltanto alla Francia, ma anche agli amici della Francia. La città cominciò a dar sintomi di asfissia, e Saliceti scrisse in un suo r a p p o r t o che bisognava scegliere: o farne un por to franco come Trieste e Livorno, o annet ter la all 'Imp e r o ing lobandola nel suo sistema dogana le . N a p o l e o n e scelse na tu ra lmen te la seconda alternativa. E Saliceti, mentre il doge Durazzo viaggiava alla volta di Milano pe r r endere omaggio a l l ' Impe ra to re , fece votare dal Senato u n a di-
122
chiarazione in questo senso. Il Doge non se ne rammaricò, o pe r lo m e n o n o n lo dette a divedere, anzi egli stesso presentò a Napoleone l 'appello che terminava con queste parole: «Vogliate accordarci il bene di d iventare vostri sudditi». Al che N a p o l e o n e r ispose: «Tornate nella vostra pat r ia . Fra poco anch'io ci verrò a suggellare l 'unione fra i nostri popoli».
Ci si fermò infatti il 30 giugno nel suo viaggio di r i to rno a Parigi, accolto con le solite feste. La sua visita in Italia era d u r a t a poco più di d u e mesi, e n o n si p u ò cer to d i re che l i avesse sprecati. Ci aveva raccolto u n a corona di Re, u n a dote pe r sua sorella e un bel regalo pe r la Francia: i t re dipart imenti in cui la Liguria era stata divisa. Ma sapeva benissimo che tu t to ques to aveva un prezzo, e Melzi glielo aveva de t to : «Io n o n ho mai cessato d i r ipe tergl i che doveva abb a n d o n a r e l 'a t teggiamento che egli teneva in Italia pe r cessare di da re preoccupazioni a tutte le potenze europee». Ma lui gli aveva risposto che, anche se lo avesse abbandona to , le potenze eu ropee avrebbero seguitato a insidiarlo e combatte r lo . Era p r e p a r a t o alla g u e r r a . Forse la des iderava . Com u n q u e , n o n aveva fatto nulla pe r evitarla, anzi aveva fatto di tu t to p e r prec ip i ta r la . Vero o inven ta to che fosse, que l Rex totius Italiae aveva fornito i migliori argoment i ai «falchi» di Vienna. Ma ancora p iù decisiva si rivelò l 'annessione di Genova che - dice lo storico inglese Hol l and Rose - «fece nascere in nove set t imane u n a coalizione che la diplomazia bri tannica n o n era riuscita a creare in ventisei mesi».
Il 9 agosto (del 1805), l 'Austria ader ì all 'alleanza anglorussa. La paro la era di nuovo agli eserciti. E noi siamo costretti a seguirne, sia p u r e in rap ida sintesi, la vicenda, poiché da essa p r e n d e avvio un ennes imo r imescolamento delle carte italiane.
«Tutta la G r a n d e A r m a t a è in marc ia e il p r i m o v e n d e m miaio sarà sul R e n o . Farò a l nemico u n o scherzo tale che n o n avrà i l t e m p o di ven i re ad annoia rv i in Italia» scrisse Napoleone a Eugenio.
123
Lo scherzo consisteva nella rap id i tà dei moviment i . Gli austriaci, che avevano scelto come principale teatro di guerra la Germania , basavano il loro p iano sulla previsione che ai russi sa rebbero bastati sessanta g iorni p e r raggiunger l i , m e n t r e a Napoleone ne sarebbero occorsi ottanta: i d u e alleati avrebbero quindi avuto il t empo di un i re le loro forze e di assumere lo sch ieramento più favorevole. Napo leone lo aveva capi to. R inunz i ando a soste e a misure di sicurezza, giunse con tre sett imane d'anticipo, colse gli austriaci da soli e in fase di assestamento a Ulm, e in poche ore di battaglia li sbaragliò e r idusse alla resa. Lo scherzo era riuscito.
Gli austriaci dovet tero r ichiamare in tut ta fretta l'esercito che avevano manda to in Italia per tenervi agganciate le forze francesi. Napoleone , r i t enendo Eugenio t r o p p o giovane e i m m a t u r o , ne aveva affidato il c o m a n d o a Masséna che , n u m e r i c a m e n t e inferiore, avrebbe dovuto limitarsi alla difensiva. Ma ora r icevette l 'o rd ine di bu t ta r s i alle calcagne del nemico in ritirata in m o d o da impedirgliela o r i tardarla . Il compi to fu b r i l l an temente assolto. Solo con molta fatica gli austriaci r iuscirono a r ipassare le Alpi e, attaccati sul fianco dalle cavallerie francesi, dove t t e ro d i ro t ta rs i verso Est. E r a n o c o m p l e t a m e n t e tagliati fuori, q u a n d o N a p o l e o n e sferrò l'attacco risolutivo ad Austerlitz il 2 dicembre, p r imo ann ive r sa r io della sua incoronaz ione . N o n po teva festeggiarlo meglio: fu il suo più g r a n d e trionfo, l 'acme della sua favolosa carr iera di condot t iero.
Per gli austriaci, fu un a m a r o Natale. L ' indomani dovettero firmare la pace di Presburgo che, oltre a costargli gravi perd i te in Germania , li estrometteva definitivamente dall 'Italia obbligandoli a r inunc ia re a tutti i compens i o t tenut i a Campoformio e a Lunéville. Riconoscevano a Napoleone il titolo di Re d 'I tal ia e gli cedevano Venezia coi suoi antichi domini di terraferma, Istria e Dalmazia. Q u a n d o cercarono di spendere una buona parola pe r i Borbone di Napoli, che si e r ano schierati al loro fianco, Napoleone tagliò corto: «Dite al vostro I m p e r a t o r e che n o n ficchi il naso in questa fac-
124
cenda. È venuto il m o m e n t o di saldare i conti con quella miserabile». Quel la miserabi le e r a la r eg ina Maria Carol ina , zia de l l ' Impera to re d'Austria. L' indomani lanciò da Schòn-b r u n n i l celebre proc lama: «Soldati! La dinast ia di Napol i ha cessato di r egnare . La sua esistenza è incompatibile con la pace de l l 'Europa e l ' onore della mia corona . But ta te in mare , ammesso che vi aspett ino, i deboli battaglioni di quei tiranni».
Le scenate di Napoleone e rano sempre a freddo. Questa era a caldo. I testimoni assicurano che mai nessuno lo aveva visto p r e d a d i un furore vendicat ivo così violento come q u a n d o impar t ì alle sue t r u p p e d'I tal ia l 'o rd ine di «scaraventare giù dal t rono questa infame criminale». Ma ne aveva qualche motivo.
CAPITOLO TREDICESIMO
G L ' I N T R I G H I DI NAPOLI
Dobbiamo fare un passo indietro: il lettore - sper iamo - ce lo pe rdone rà . Come abbiamo già raccontato, la restaurazione borbonica a Napoli aveva fatto il suo debut to con le forche. Ma re Fe rd inando , p u r sollecitandole, n o n aveva nessuna voglia di veder le in azione. Solo nel luglio (del '99) si era deciso a to rnare insieme ad Acton nella sua capitale, ma facendo divieto a sua moglie di seguirvelo.
Maria Carol ina fece scene terribili. Dopo aver inseguito Nelson e la sua a m a n t e con a izzament i alla ferocia («Non preoccupatevi del n u m e r o : molte migliaia di del inquent i in m e n o r e n d e r a n n o la Francia più povera, e noi s taremo meglio»), o ra si sentiva def rauda ta della vende t ta e sfogava la sua de lus ione in le t te re r anco rose , p i ene di esclamativi e ana t emi . Ne scriveva a tut t i p e r c h é e ra g r a fòmane , al tern a n d o i toni solenni alle invettive più volgari, p iangendos i addosso, coinvolgendo il b u o n Dio nelle sue passioni, contraddicendosi ad ogni passo e sempre in b u o n a fede, senza un briciolo di senso critico e di umor ismo. Ma il Re fu irremovibile.
A Napoli si t ra t tenne poco e preferì alloggiare sulla nave di Nelson invece che a palazzo reale: ci si sentiva più sicuro. De Nicola racconta che u n a matt ina, men t r e era sulla tolda, vide e m e r g e r e dal fondo del m a r e un c o r p o u m a n o . «Cos'è?» gr idò sbiancando. «Il cadavere di Caracciolo che chiede sepoltura» gli disse un ufficiale. «Gli sia concessa» rispose, r id iscendendo precipi tosamente in cabina.
In agosto era già di r i torno a Palermo, dove fu data u n a sp l end ida festa p e r o n o r a r e gli e ro i della r iconquis ta del
126
Reame. Nelson ricevette il feudo di Bronte col titolo di Duca trasmissibile agli eredi e la spada con l'elsa tempestata di d iamant i che Luigi XIV aveva dona to a suo nipote Filippo V, n o n n o del Re. E m m a Hamil ton ebbe una collana di diamant i e d u e carrozze di gala p iene di vestiti. C 'e rano anche i due briganti Fra' Diavolo e Mammone , che furono decorati e promossi colonnelli. Ma r ipar t i rono quasi subito pe r rip r e n d e r e il comando delle loro bande in marcia con l'esercito napole tano su Roma.
Era infatti il m o m e n t o in cui, profi t tando dell 'assenza di N a p o l e o n e bloccato in Egit to dalla d i s t ruz ione della sua flotta ad Abukir, le a rma te austro-russe spazzavano i francesi dall'Alta Italia, e Maria Carolina aveva persuaso il mari to ad approf i t ta rne pe r p ian ta re nuovamen te la sua band ie ra nel l 'Urbe. D'accordo con la Regina, Nelson cercò di far capi re a Fe rd inando ch 'era difficile d i r igere le operazioni diplomat iche e militari da Palermo, ma il Re faceva orecchio da m e r c a n t e . A Napol i avrebbe dovu to t o r n a r e a palazzo reale insieme alla moglie, e n o n c 'erano riserve di caccia ricche di selvaggina come quelle che i ba ron i siciliani gli mettevano a disposizione. Eppoi , voleva p r ima vedere che piega avrebbe preso quella guer ra , in cui s'era lasciato coinvolgere più per ignavia che per convinzione.
Gli avvenimenti si affrettarono a dargli ragione. Alla fine de l l ' anno, Napo leone t o r n ò in Francia, si fece p roc lamare P r imo Console e r i p r e se i l c o m a n d o de l l ' a rma ta d ' I ta l ia . Napoli doveva vedersela nuovamente con lui.
A Pa le rmo , il con t racco lpo fu i m m e d i a t o . N o n a v e n d o più ragione di tenerlo a guardia del Medi te r raneo ora che il B o n a p a r t e aveva a b b a n d o n a t o l'Africa, L o n d r a r ich iamò Nelson, e il r ichiamo di Nelson compor tò automat icamente quello degli Hamil ton, che o rmai facevano con lui u n a sola famiglia.
Per Maria Carol ina fu un terribile dolore . Era legatissima a E m m a . Chi delle d u e fosse lo s t r u m e n t o del l 'a l t ra , è diffìcile dire. Ma fatto sta che grazie alla loro amicizia il Rea-
127
me era diventato un p ro te t to ra to inglese e Nelson un ammiraglio borbonico molto più di quanto la situazione politica richiedesse. E infatti la loro par tenza, che rese la Regina «mezzo mor ta» , c o m p o r t ò notevol i novi tà nel le re lazioni con Londra .
Il nuovo ambasciatore, Paget, aveva ricevuto dal suo governo istruzione d ' i ndu r re il Re a to rnare a Napoli . Ma Ferd inando non voleva saperne perché ne aveva capito benissimo il motivo. Convinta che la lotta cont ro Napoleone fosse ancora lunga, l ' Inghi l te r ra voleva, scacciandone i francesi, occupare Malta che i siciliani consideravano u n a loro d ipendenza, e preferiva farlo col Re a Napoli piut tosto che a Palermo. Oltre a questo, Ferd inando era su tut te le furie perché il suo Acton, che lo aveva sempre sollevato da ogni peso e responsabilità, s'era innamora to e aveva sposato, a sessan-taquat t r ' anni , u n a nipote di tredici: il che lo rendeva pe r il m o m e n t o inutilizzabile.
A rest i tuirgli un p o ' di b u o n u m o r e fu solo la decis ione della Regina di anda re a Vienna a r insaldare i legami di famiglia - l ' impe ra to r e Francesco e ra ins ieme suo n ipo te e suo genero - , a lquanto deteriorat i dacché i l Reame era passato a rmi e bagagli a l l ' Inghi l terra . Ora che questa si faceva t r o p p o esigente, meglio crearle un cont rappeso . Ferdinando , sebbene incredulo sulla riuscita della missione, l'aveva approvata caldamente pe r liberarsi da quella insopportabile donna . Essa arrivò a Vienna quasi con temporaneamen te alla notizia della disfatta aus t r iaca a M a r e n g o , che lasciava nuovamente l'Italia in balìa di Napoleone e il Regno borbonico ancora più bisognoso della flotta inglese. La missione era fallita pr ima ancora di cominciare.
In set tembre, la band ie ra francese fu ammaina ta a Malta e sostituita da quella inglese. Anche le navi napole tane avevano partecipato al blocco dell'isola, ma d o p o la capitolazione fu rono amab i lmen te congeda t e . F e r d i n a n d o n o n ebbe neanche il t empo di protestare . L'Austria si appres tava a firmare il trat tato di Lunéville, che dava m a n o libera al Bona-
128
pa r t e sulla penisola, senza neanche ch iedere u n a garanzia p e r Napol i . Q u e s t a fu salvata solo da un in t e rven to del lo Zar di Russia, che Napoleone allora corteggiava. Il generale Murat , che aveva già ricevuto l 'ordine d ' invadere il Reame, fu fermato, ma r imase con l 'a rma al p iede , m e n t r e i plenipotenziari francesi e napoletani negoziavano a Firenze una pace che somigliava molto a un diktat. I Borbone dovevano cedere i Presidi Toscani, Porto Longone e Piombino, accettare guarn ig ion i francesi in Abruzzo, accol landosene tut te le spese, consegnare un pezzo di flotta, pagare una forte indenn i t à e concedere u n a p lenar ia amnist ia ai pr ig ionier i e agli esuli politici.
Que l t ra t ta to , che p ra t i camente sottraeva Napoli all ' Ingh i l t e r ra p e r farne u n p r o t e t t o r a t o francese, n o n e ra u n successo pe r Paget, che cercò d ' i n d u r r e il Re a rif iutare la ratifica. Ma il Re gli rispose che n o n poteva farne a meno , e aveva ragione. Egli capiva che d 'ora in poi, quan to più avesse c edu to alla Francia p e r Napol i , t an to p iù pe r la Sicilia avrebbe dovu to cedere a l l ' Inghi l ter ra , cui l'isola diventava s e m p r e p iù preziosa. Tuttavia, di tutt i i pericoli che lo minacciavano, quello che più lo spaventava seguitava ad essere sua moglie. Le scrisse: «Ti p rego di non muover t i da dove sei senza il mio consenso...» N o n la voleva t ra i p iedi in quei r epen tag l i , o ra che aveva deciso di t o r n a r e a Napol i dove avrebbe dovuto convivere con lei.
La Regina gli obbedì anche pe r ché aveva dovu to sottopors i a u n a dolorosissima ope raz ione di emor ro id i , di cui come al solito aveva sentito il bisogno di da re minuziosissimi ragguagl i in u n a lettera cor reda ta anche di disegni che r a p p r e s e n t a v a n o la pa r t e opera ta . Q u a n d o rimise p iede a Napoli , la città, che aveva accolto t r ionfa lmente Ferd inando, finse di n o n accorgersi di lei.
Il governo che il Re aveva insediato navigava tra grosse difficoltà. Anche se i repubblicani non e rano che u n a sparuta minoranza ignorata o addi r i t tu ra mal vista dalla popolazione, la spietata purga abbattutasi contro di essi nel '99 ave-
129
va lasciato u n o strascico di rancor i nell 'aristocrazia e nella borghesia, dove non c'era famiglia che n o n avesse il suo decapitato o depor ta to . Col trat tato di Firenze che ne imponeva il r ichiamo, molti esuli e r ano rientrat i e, anche se n o n organizzarono veri e p r o p r i complott i , n o n svolsero di certo opera distensiva.
Par t ico la rmente grave era la si tuazione economica non sol tanto p e r i guast i provocat i dalla lunga guer r ig l ia di Ruffo, ma anche p e r c h é , ol t re a to l le rare le gua rn ig ion i francesi nel suo terr i torio, Napoli si e ra impegnata a mantenerle. Il ministro delle Finanze, Zurlo, sebbene u o m o di notevoli capacità, non riusciva a far fronte alla crisi, e fu questo che r ipor tò alla ribalta u n a delle figure più discusse, ma anche più interessanti di questo per iodo: Luigi de ' Medici.
Medici e ra un ar is tocrat ico che disprezzava i suoi pa r i pe r la loro ignoranza, ma ne condivideva il suscettibile orgoglio e teneva molt iss imo al suo b lasone . Si c i rcondava d'intellettuali, ma li trattava dall'alto con paternalistica condiscendenza. Detestava la Corte e ironizzava sui suoi intrighi, ma per fare strada si era servito di quelli di sua sorella, la marchesa di San Marco. Era stata costei, d o n n a scaltrissi-ma, a monta re la Regina contro Acton che rappresentava il p iù grosso ostacolo alle ambizioni di suo fratello. N o n pot e n d o s i lurare l 'ex-favorito, Maria Carol ina aveva pensa to di creargli un con t rappeso facendo n o m i n a r e Medici capo della polizia. Tut to ques to e ra avvenuto , s i capisce, p r ima che Napoleone si affacciasse sulle Alpi.
E probabile che Medici fosse in b u o n a fede usando i suoi poter i più pe r ammans i re che pe r persegui ta re gli oppositori politici, cioè i giacobini. Ma un po ' vi era anche costretto dai legami di amicizia che aveva contrat to con loro. Aveva pro te t to il loro circolo più radicale, l 'Accademia di Chimica, e d u e dei suoi adept i , i fratelli Giordano , vivevano addir i t tura in casa sua. Forse, se ne avesse avuto il t empo , sar ebbe riuscito a fare di quest i ribelli dei col labora tor i p e r p o r t a r e avant i un r i formismo d i m a r c a i l luministica. Per
130
quan to difficile, il giuoco si poteva tentare . Furono le circostanze e la pochezza degli uomini a farlo fallire.
Nel '94 e r a stato scoper to un complo t to r ivoluzionar io d ' ispirazione francese. Era l ' indomani della decapi taz ione di Luigi XVI e di Maria Antonietta, sorella della Regina. Polizia e tr ibunali ricevettero l 'ordine di p rocedere con la massima severità. Sotto le tor ture , gli arrestati «cantarono». Medici riuscì a far fuggire in t empo alcuni caporioni, fra i quali Laube rg ; ma i G i o r d a n o r imase ro nella pan ia . Medici tentò di farli evadere, e u n o ci riuscì, ma l'altro fu r ipreso e condanna to all 'ergastolo. Il loro padre , convinto che Medici li avesse traditi , lo denunz iò d icendo ch 'era stato lui a convert ire i suoi figli alle idee giacobine. Acton most rò la delazione alla Regina che la mos t rò al Re, e Medici si t rovò, da arres ta tore , arrestato. Gli ci vollero tre anni , la falsificazione di alcuni documen t i e un provvisorio m u t a m e n t o di situazione politica pe r essere assolto e liberato.
Malgrado questi precedent i , q u a n d o nel '98 assunsero il p o t e r e , i r epubbl ican i n o n lo c o n s i d e r a r o n o dei loro , ma dappr incipio non Io d is turbarono, anche perché sua sorella aveva tempes t ivamente abbracciato la loro causa ed esercitava su di essi un notevole ascendente . Ma negli ultimi mesi della resistenza, q u a n d o il pericolo aveva por ta to alla ribalta gli e lementi p iù estremisti, anche lui fu impr ig ionato come potenziale nemico. Più tardi qualcuno disse che, presentendo l ' imminente crollo della Repubblica, era stato lui stesso a denunziars i come monarchico pe r passare da mar t i re della causa borbon ica . Nien te suffraga ques ta voce. Ma il fatto ch'essa trovasse credito la dice abbastanza lunga sull 'opinione che la gente aveva di lui.
C o m u n q u e , anche questa seconda persecuzione n o n gli era valsa a nulla. Molto più abile di lui, sua sorella era r iuscita a r i e n t r a r e nelle grazie della Regina, che pe r la sua convers ione alla Repubbl ica l 'aveva ch iamata «traditrice», «vipera» e «megera». Ma la r iconcil iazione e r a t r o p p o recente p e r consent i r le di sos tenere i l fratello, n u o v a m e n t e
131
J
nei guai per una seconda delazione dell 'implacabile Giordano , che lo accusava d ' infami collusioni con la Repubbl ica . Sebbene l'inchiesta appurasse la falsità della denunzia , Medici venne bandi to .
Era t o rna to con l 'amnist ia , e la soccorrevole sorella fu pronta , come al solito, a dargli una mano . L'aggravarsi della crisi f inanziaria aveva p o r t a t o alla c adu t a di Zur lo , di cui pe rò n o n si riusciva a t rovare un successore. Il Blanch dice che la San Marco consigliò al fratello di redigere un rappor to sulla situazione, suggerendone anche i r imedi , e lo por tò alla Regina. Ques ta ne r imase p r o f o n d a m e n t e colpita, e a sua volta lo por tò al Re, che detestava Medici, ma ancora di più detestava leggere. Resp ingendo infastidito il memor ia le, le disse: «Fa' quello che vuoi, io n o n voglio diventar pazzo con questi briganti». La Regina sot topose il d o c u m e n t o ad Acton; ma, ben sapendo quanto anche lui odiasse Medici, non gli disse chi lo aveva scritto. Anche Acton rimase colpi to , sebbene di economia n o n capisse nul la , o forse p r o pr io pe r questo . Ma, t rovandos i con l 'acqua alla gola e ved e n d o in quel memor i a l e delle p r o p o s t e costrut t ive, s i lasciò scappar det to ch 'era p ropr io quel che ci voleva. Dopodiché n o n potè più sottrarsi al l ' impegno di p r o p o r n e l 'autore al Re come ministro delle Finanze.
Tutto ciò sa un po ' di romanzo, ma non è completamente inverosimile in un covo d' intrighi come la Corte di Maria Carol ina . Il Re rifiutò a Medici il titolo e il r a n g o di ministro, ma gli det te ugua lmente carta bianca in fatto di economia, e Medici d imostrò che i suoi non e rano vaneggiamenti . Con o p p o r t u n e mi su re di emergenza , egli mise r i p a r o a i dissesti più gravi e predispose u n a serie di r iforme che col t e m p o avrebbero po tu to scardinare l ' o rd inamento feudale del Reame. Pu r t roppo , fu p ropr io il t empo che mancò.
Un'al tra buona scelta si rivelò quella del nuovo capo della polizia. Nei salotti si rise q u a n d o si sparse la notizia che a quel posto era stato designato il Duca d'Ascoli, considerato u n a specie di play boy avanti lettera, donnaiolo e compare di
132
bisbocce del Re. E p p u r e , egli spiegò nel suo incarico dot i insospet ta te di accortezza e mode raz ione . In quel l ' incer ta si tuazione politica, egli comprese che l 'unico obbiettivo da perseguire era la concordia e fece di tut to pe r ristabilirla al di sop ra dei contras t i ideologici . Fece uscire di p r i g ione molti pregiudicat i politici e comminò p e n e severe a chi att r ibuiva a qua l cuno , senza d a r n e le p rove , la qualifica di «giacobino», un te rmine che aveva fatto da alibi a t roppi soprusi .
Ciò n o n imped ì che qua e là seguitassero a manifestarsi dei focolai rivoluzionari. Il più vasto e attivo fu quello acceso in Calabria da Rodino con la collaborazione di un giovanot to di cui u d r e m o r ipar la re , Gugl ie lmo Pepe. Ma abbiamo l ' impressione che queste attività rivoluzionarie siano state a lquanto esagerate dagli storiografi risorgimentali . Per il Reame borbonico la minaccia non veniva da l l ' in te rno , ma dal l ' es terno, cioè dalla s i tuazione in te rnaz ionale . E a farla precipi tare in catastrofe furono ancora u n a volta gl ' intrighi della Regina.
Sul p i ano diplomatico, la situazione di Napoli e ra obbiettivamen te difficile. Il suo m a r e , e perf ino il suo golfo e r ano p ian tona t i dalla flotta br i tannica , m e n t r e i l suo e n t r o t e r r a era presidiato dalle guarnigioni francesi. La pace di Amiens t ra Francia e I ngh i l t e r r a al p r inc ip io del 1802 n o n fu p e r Napoli che un sollievo molto relativo. Tutti capivano che le d u e Potenze avevano negozia to la t r e g u a solo p e r megl io p r e p a r a r s i a u n a nuova g u e r r a , e Napol i e ra p r o p r i o u n o dei p u n t i in cui p iù se ne aveva la sensazione. Sia l 'ambasciatore di Londra , Elliot, che quello di Parigi, Alquier, vi si compor tavano da proconsoli t enendo la Cor te sotto il fuoco incrociato delle loro minacce e ricatti.
Dei due , Alquier era il più scomodo. Maria Carolina considerava u n a provocazione la presenza di ques t ' uomo ch'era stato u n o di quei deputa t i della Convenzione che avevano c o n d a n n a t o a m o r t e sua sorella Mar ia Anton ie t ta . Ma
133
doveva fare i conti con la sua abilità e spregiudicatezza. La posta del giuoco era la testa di Acton. Alquier aveva capito che con lui al po te re Napoli avrebbe sempre gravitato nella sfera br i tannica. Ma aveva capito anche che la Regina n o n amava più i l suo ex-favorito, specie ora che di favorito ne aveva un altro, di vent 'anni più giovane di lei. Per trarla dalla sua par te , la mise in diretta corr i spondenza con Napoleone . Dopo averlo tanto maledet to , l ' impulsiva d o n n a scrisse al «cane còrso», come lo chiamava, una lettera p iena di piaggerie e proteste di amicizia. Napoleone le rispose p r e m u r o samente che l'amicizia gliela ricambiava in pieno. «Ma - aggiunse - le circostanze mi obbligano a considerare il Regno di Napoli come un Paese governato da un ministro inglese.»
Pur p ro tes tando la sua indignazione cont ro questo velato ultimatum, la Regina most rò la let tera ad Acton, che offrì immedia tamente le dimissioni. Ma il Re le rifiutò in maniera decisa, e l 'episodio n o n contr ibuì di certo a migl iorare i r appor t i con la Francia. Ma il colpo di grazia lo det te la t resca di Maria Carolina con Madrid .
Il lettore cer tamente r icorda che Ferd inando era figlio di quel Carlo I I I di Borbone che, d o p o essere stato Re di Napoli, e ra diventato Re di Spagna. Ora su questo t rono sedeva il suo p r imogen i to , Car lo IV, fratello di F e r d i n a n d o . Il l egame dinast ico e ra stato ro t to da un pezzo pe r o p e r a d i Maria Carolina, che aveva por t a to Napoli a gravi tare sempre più nella sfera degli Asburgo di Vienna, da cui essa stessa proveniva. Ma negli ultimi tempi era stato r i annoda to da un d o p p i o m a t r i m o n i o . I l p r inc ipe e red i t a r io d i S p a g n a aveva sposato Maria Antoniet ta , figlia di Ferd inando , e sua sorella aveva sposato il pr incipe eredi tar io dì Napoli , Francesco.
Mezzo ebete, Carlo IV era comple tamente nelle man i di sua moglie Maria Luisa, che a sua volta era comple tamente nelle mani del suo favorito e amante Godoy, che a sua volta era comple t amen te nelle man i di Napoleone . Quest i forse non aveva ancora delle mire sul t rono di Madrid , ma teneva
134
all'amicizia della Spagna. La sua collera quindi non conobbe limiti q u a n d o Godoy lo informò che Maria Antonietta, su istruzioni di sua madre , stava m o n t a n d o un parti to del principe eredi tar io pe r met tere fuori causa lui e la Regina e rovesciare il sistema delle alleanze.
Era vero. Le torrentizie lettere di Maria Carolina a sua figlia erano tutte un aizzamento contro la suocera, che replicava chiamando la nuora «ranocchia semimorta», «vipera velenosa» e «sputo di sua madre». Che atmosfera dovesse regnare in quella Corte , lo dice il fatto che nessuno osava toccare cibo senza p r i m a farlo assaggiare a qualche servo. U n a di quelle lettere fu intercettata o sottratta dagli scrigni di Maria Antoniet ta e fatta recapi tare da Godoy a Napoleone . C'era scritto che, appena salito al t rono, il principe ereditario doveva a r res ta re la m a d r e e il suo aman te e scendere in g u e r r a contro il «còrso bastardo, villan rifatto e nuovo Attila».
Napoleone rispose a un ricevimento del corpo diplomatico a Milano. A n d a n d o incontro all 'ambasciatore di Napoli, lo a l luvione di epi tet i da fureria r infacciandogli i l d o p p i o giuoco e i t rad iment i dei suoi Sovrani, e concluse: «Dite alla vostra Regina che n o n le lascerò neanche la Sicilia e la manderò coi suoi figlioli a mendicare il pane pe r tut ta Europa!»
Era i l 1805. La pace di Amiens era finita. L ' Inghi l terra , di nuovo in gue r ra con la Francia, cercava alleati che gliela combattessero pe r ter ra . Già da d u e anni , Napoli si e ra segre tamente impegnata a lasciar occupare Messina dalla flotta b r i t ann ica , se fosse stata minaccia ta dal le gua rn ig ion i francesi che presidiavano il Reame. In cambio aveva ricevuto un grosso aiuto finanziario per ricostituire alla chetichella un po ' di esercito. Ma Ferd inando n o n voleva avventure . Fu Maria Carol ina che gli forzò la mano , q u a n d o si profilò l ' intervento di Russia e Austria.
Abbiamo già visto come e pe r ché si formò ques ta coalizione (la terza), e con quale fulminea rapidi tà Napoleone ne venne a capo a Ulm e ad Austerlitz. Ma rivediamolo dall 'angolatura di Napoli.
135
Da q u a n d o le aveva por ta to via i suoi amat i Hami l ton e Nelson, l ' Inghil terra n o n godeva più i favori di Maria Carolina. I suoi entusiasmi ora e rano tutti pe r lo zar Alessandro, che sul Reame teneva a svolgere, sia p u r e di lon tano , u n a par te di alto pro te t tore . Temeva che i francesi se ne servissero come d ' u n t r ampol ino d i lancio pe r un 'az ione cont ro la Turchia , del cui i m p e r o egli si cons iderava il legi t t imo e r e d e . E p r o p r i o p e r ques to aveva indo t to N a p o l e o n e , q u a n d o era in buon i r appor t i con lui, a negoziare coi Borb o n e la pace di F i renze , lasciandoli sul t r o n o . Ques to ne aveva fatto il nuovo Eroe di Maria Carol ina che senza Eroi n o n sapeva stare.
Nel maggio (del 1805) giunsero a Napoli, sotto falso nome e con l 'aria di semplici tur is t i , d u e genera l i russi p e r concertare l'azione contro la Francia. L'entusiasmo della Regina salì alle stelle. Siccome il Re n o n in tendeva r inunciare alle sue cacce (era il m o m e n t o del passo delle quaglie), fu lei ad assumere di persona i negoziati, na tura lmente segretissimi. A p p e n a la gue r r a fosse scoppiata, i russi s ' impegnavano a m a n d a r e nel Reame 25.000 uomin i in agg iun ta ai 7.000 che s ' impegnava a m a n d a r e l ' Ingh i l t e r ra . Sa rebbero stati loro a decidere la data e il luogo dello sbarco e ad assumere il comando delle operazioni . Alle spese doveva p rovvedere Napoli . Il p r emio sarebbe stata la garanzia dello Zar all'integr i tà del Reame . Ques t i pa t t i e r a n o p r a t i c a m e n t e u n a cambiale in bianco rilasciata ai russi senza cont ropar t i ta . E n o n era f ini ta . Lo sbadato Elliot, che n a t u r a l m e n t e sapeva dei negoziat i , ne lasciò t r ape l a r e il segre to , e così ne fu informato anche Alquier, che si p resen tò furente alla Regina. La scena la descrisse lei stessa in u n a delle sue solite lettere. «Mi ha trattata come l 'ultima delle donne , u r l ando come un e n e r g u m e n o , lui, i l regicida Alquier, a me , figlia di Maria Teresa!»
Da b u o n còrso, Napo leone sapeva che la vende t ta è un piatto da mangiare freddo. Al r appo r to del suo ambasciatore , che lo raggiunse men t r e si p reparava all'attacco su Ulm,
136
reagì a p r e n d o trat tat ive con Napol i . In cambio della neutrali tà offriva il r i t i ro delle t r u p p e dal Reame . Sal tando la Regina, Alquier por tò il testo della proposta al Re, e nel successivo r appor to scrisse: «La cosa più strana è che nel mezzo di u n a discussione il cui risultato avrebbe por ta to la pace a Napoli , o pr ivato il Re della sua corona , questi si preoccupava soltanto della vendemmia , e fu p rop r io in un vigneto ch'egli appose t ra i vendemmiator i la sua firma al trattato».
In real tà quel la f i rma n o n valeva nul la p e r c h é pochi giorni p r ima egli ne aveva già apposta un 'a l t ra sul pat to di alleanza con la Russia e l ' Inghi l terra: la volontà della Regina aveva come al solito prevalso sulla sua. All 'ambasciatore russo egli spiegò che aveva dovuto sottoscrivere il foglio di Alquier pe rché le guarnigioni francesi avevano già ricevuto l 'o rd ine di marc i a re su Napol i , e q u i n d i aveva agito sotto costrizione.
I russi cominciarono i loro sbarchi q u a n d o a Napoli era già arr ivata la notizia della strepitosa vittoria r ipor ta ta da Napoleone a Ulm. E vero che subito d o p o e ra arr ivata quella del trionfo di Nelson a Trafalgar. Ma il g r a n d e ammiragl io vi aveva perso la vita, N a p o l e o n e avanzava su Vienna , e quanto più la sua marcia si accelerava, tanto più rallentavano gli arr ivi anglo-russ i . Ques t i e r a n o anco ra a mezzo, q u a n d o giunse l ' annunz io di Austerlitz, della resa dell 'Austria e del p roc lama rivolto da Napo leone alle sue t r u p p e : «Soldati, p e r dieci anni ho fatto il possibile pe r salvare il Re di Napoli , e lui ha fatto il possibile pe r rovinarsi . . . Soldati, avanti! Mio fratello vi guiderà...»
Ment re a Corte lo sgomento dilagava, i comandan t i russo e inglese tenevano consiglio di guer ra , di u n a gue r ra che non avevano nessuna intenzione di fare. Infatti la decisione che presero fu di m a n d a r e i repar t i napoletani a guarn i re i confini, men t r e le loro t r u p p e sarebbero r imaste a presidio di Napoli, o pe r meglio dire a guard ia delle loro navi, su cui avevano già deciso di reimbarcarsi . Il Re non mosse un dito
137
per impedir lo . Seguitava ad a n d a r e t ranqui l lamente a caccia come se tutto quel che succedeva non fosse affar suo. Un giorno incontrò un repa r to in marcia. E, sentito che andavano in Abruzzo a far la guerra , chiese: «Contro chi?» «Contro i francesi» gli r isposero. «Dio ve la mand i buona!» disse, e proseguì dietro i suoi cani.
Anche questo suo a t t egg iamento contr ibuiva a me t t e r e fuori di sé la Regina, che non abbandonava il suo scrittoio. «Gl'infami s ' imbarcano!. . . Ci a b b a n d o n a n o , i vigliacchi!...» Tempestava di lettere Vienna e Londra . Faceva scenate agli ambasciator i russo e inglese. Il 7 genna io (1806) m a n d ò a Roma il cardinale Ruffo, l 'uomo del l ' emergenza, a pa r l a re con Masséna. Come al solito, aveva scelto male. Sia p u r e a tol to, i francesi consideravano Ruffo il persecutore dei loro ant ichi alleati r epubbl ican i . Masséna lo mise alla p o r t a e gl ' impedì di proseguire per Parigi. «La sorte di Napoli è già stata i r revocab i lmente decisa» gli disse. Maria Caro l ina si rassegnò alla sup rema umiliazione. Prese la p e n n a e scrisse a Napoleone: «Ravvedutami dall 'accecamento nel quale fui trascinata da u n o zelo e da un amore male calcolati e male intesi, e che m' isp i rarono una forte inimicizia, r inunc iando ormai ad essere la nemica di Vostra Maestà Imperia le e Reale, r icorro alla vostra generosità...» La risposta di Napoleone fu l ' o rd ine alle sue t r u p p e di marc ia re su Napol i «per p u n i r e i l t r a d i m e n t o della Regina e b u t t a r e giù dal t r o n o questa criminale...»
In quel m o m e n t o gT«infami» se n ' e r a n o già anda t i . La Regina decise di rivolgersi al popolo, e scese in mezzo ad esso per le strade. Ma non riuscì a toccargli il cuore pe r il semplice motivo che non gliene aveva mai mostrato. Il Re, molto più popo l a r e di lei, si rifiutò di accompagnar la . Preferì a n d a r e a M o n d r a g o n e pe r d i s t rugge re con u n a colossale ba t tu t a di caccia tu t t a la selvaggina in m o d o che a l m e n o quel la non cadesse in m a n o ai francesi, e annunz iò che se ne tornava in Sicilia. A stento lo persuasero ad aspet tare alm e n o il m o m e n t o in cui i francesi avessero varcato la fron-
138
tiera. Rimase fino al 23, poi s ' imbarcò alla chetichella dicendo alla Regina di sbrigarsela lei, che aveva provocato quella catastrofe, insieme a suo figlio: lui ne aveva abbastanza.
«Sono p repa ra t a a tut to - scrisse la Regina al suo ambasciatore a Parigi, Gallo - non ho p a u r a di n iente . Mi r i t roverò povera ed e r ran te , d o p o aver sempre pensato agli altri e mai a me stessa... Vi raccomando la mia adora ta famiglia: l'affido alla vostra fedeltà...» In quel m o m e n t o Gallo aveva già offerto i suoi servigi a Napoleone che, dopo averli accettati, scriveva a suo fratello Giuseppe: «Il marchese Del Gallo si appres ta a me t t e r e a tua disposizione tut t i i suoi talenti . Sarà il p r imo napole tano a giurart i fedeltà».
Vestita a lutto, la Regina faceva il giro dei Santuari . Sperava ancora che il popolo di Napoli scendesse pe r le s trade come aveva fatto nel '98. Ma del '98 il popolo di Napoli ricordava solo la fuga dei suoi Sovrani. L' 11 febbraio anch'essa s ' imbarcò con la n u o r a (il Pr incipe Eredi ta r io si e ra già trasferito in Calabria) e il resto della famiglia. «Noi part iamo» disse alla piccola folla che si era riunita sulla banchina. Le risposero: «Pregheremo perché facciate b u o n viaggio».
Era p r o p r i o f in i ta .
CAPITOLO QUATTORDICESIMO
I VICERÉ
L'esercito che ai p r imi del 1806 Napo leone aveva scagliato contro Napoli aveva come comandan te effettivo il generale Masséna, ma formalmente e ra agli o rd in i di Giuseppe Bonapar te , già designato al t rono .
In un p r i m o m o m e n t o Napo leone aveva pensa to di offrirlo a un al tro Borbone , il secondogeni to del Re di Spagna, p e r ga ran t i r s ene ancora d i p iù l 'amicizia. Ma Car lo aveva declinato un po ' perché il piccolo Principe n o n aveva che quat tordici anni , e un po ' pe r scrupolo dinastico. Sebbene da un pezzo egli fosse in p iena rot ta con Ferd inando , questi era p u r sempre suo fratello, e n o n volle u s u r p a r n e il posto.
Fatto il bel gesto, Napoleone n o n dovette dispiacersi del rifiuto. Quella corona gli faceva gola e gli permet teva finalmen te di risolvere il p rob lema di Giuseppe, che seguitava a cullarsi nelle sue p re tese di successore al t r o n o imper ia le . Quello che gli rivolse n o n era un'offerta, ma un o rd ine per en to r io : «Gli d i re te che lo faccio Re di Napol i , ma che la più piccola esitazione, la più piccola incertezza da par te sua lo p e r d e definitivamente ai miei occhi. Non posso più avere paren t i che vivano nell 'oscurità. Quelli che n o n accetteranno d'innalzarsi con me, n o n faranno più par te della mia famiglia. Del resto, ne faccio u n a famiglia di Re». Ci r ipensò un m o m e n t o , poi aggiunse : «O megl io di Viceré». Perché l 'unico vero Re, si capisce, era lui.
G iuseppe capì che stavolta n o n po teva r i f iutare come aveva fatto pe r il Regno Italico e, sia p u r e senza molto entusiasmo, assunse il comando dell 'esercito in marcia su Napo-
140
li, lasc iando a Masséna quel lo effettivo. La divisione dei compiti si rivelò superflua perché tutto si risolse in u n a passeggiata mil i tare . L'esercito bo rbon ico si a r r e se p r i m a di combattere , o pe r meglio dire si dissolse. Solo Gaeta, grazie alle sue fortificazioni, resistette p e r c inque mesi; ma na tura lmente non potè arres tare le colonne francesi.
G iuseppe giunse a Napol i il 15 febbraio, so l ennemen te accolto dal Senato in p o m p a magna , dalle campane a distesa e dalle salve di cannoni . Prese possesso di palazzo reale, e immedia tamente si recò a r e n d e r e omaggio a San Gennaro , anche stavolta puntualissimo al solito miracolo. La messa fu officiata dal cardinale Ruffo, ormai guari to della sua fedeltà ai Borbone d o p o il t ra t tamento che ne aveva ricevuto. Nell ' interno si combatteva ancora, specialmente in Calabria. La rivolta che dopo qualche sett imana di repressione sembrava domata , to rnò a d ivampare in estate, q u a n d o sbarcò un piccolo co rpo di spediz ione inglese. I francesi lo a t taccarono alla cieca, sub i rono un sanguinoso smacco, e ques to bastò pe r r ida r fuoco alle polveri. Fu un 'a t roce guerrigl ia , di cui un g rande giornalista, Paul Louis Courier, allora in servizio militare, ha lasciato nelle sue let tere un palpi tante e raccapricciante affresco. Fra' Diavolo vi riacquistò il suo rango di protagonista, ma lo t enne pe r poco: in novembre il suo corpo già dondolava, appeso a u n a forca, in piazza del Mercato a Napoli. Tuttavia ci vollero d u e anni di operazioni di polizia condot te con metod i spietati pe r ristabilire l 'ordine nel «profondo Sud» e venire a capo del br igantaggio o meglio per r ipor tar lo alle sue normal i misure.
A Napoli , Giuseppe faceva il Re in condizioni di «sorvegliato speciale». Oltre che Masséna pe r la par te militare, Napoleone gli aveva messo alle costole il solito Saliceti pe r gli affari politici. Aveva nel fratello u n a totale sfiducia, e forse sbagliava. Giuseppe n o n possedeva, si capisce, né il suo genio né il suo carat tere. Ma era un u o m o equilibrato, ricco di umani tà e n o n privo di fiuto. Di formazione illuminista, aveva studiato a Pisa, quindi conosceva bene l'Italia, la sua lin-
141
gua e i suoi problemi, p u r così diversi da regione a regione. Ma n o n e ra un lo t ta tore , e n o n cercò mai di sot t rars i alla posizione subalterna che il suo imperiale e prepotent iss imo fratello gli assegnava. Questi lo bombardava di consigli che suonavano come ord in i : «Aumenta le tasse, sii severo, da ' degli e sempi : in un paese conquis ta to n o n bisogna essere uman i . Ruba senza riserve: nulla è sacro d o p o u n a conquista. Non fidarti di nessuno, tieni d'occhio la tua cucina, ado-p ra solo cuochi francesi. Non pensare a formare un esercito napole tano: diser terebbe al p r imo segno di pericolo».
Ma p r o p r i o da ques te le t te re s i capisce che G iuseppe avrebbe voluto governare con altri metodi , meno autori tari . Se non ci riuscì, fu colpa soprat tut to degl ' intrighi e dei complotti orditi dagli emissari borbonici e inglesi. Specialmente Saliceti fu bersaglio di parecchi attentati . Una macchina infernale gli fece crol lare in testa la casa, e fu un miracolo ch'egli e sua figlia non perissero sotto le macerie. In queste condizioni era difficile fermare la m a n o alla polizia. Ma ciò n o n imped ì l'avvìo di u n a saggia ope ra di r i forme, che poi avrebbe avuto i suoi sviluppi sotto il Regno di Murat .
Ma torn iamo al nuovo assetto che Napoleone stava dando alla penisola, ora che la pace di Presburgo gli dava mano libera su di essa. «L'Italia - diceva - è un ' amante , di cui n o n voglio dividere le grazie con nessuno.»
Il 19 gennaio del 1806 la band ie ra austriaca fu ammaina ta sui p e n n o n i di Piazza San Marco a Venezia e sostituita dal tricolore italiano. Napoleone aveva deciso di anne t te re i terr i tor i venet i s t rappa t i al l 'Austria a l R e g n o Italico che o ra contava circa sette milioni di abitanti e si es tendeva fino all 'Istria e alla Dalmazia. Il Pr incipe Eugen io venne a p r e n d e r n e ufficialmente possesso in febbraio, accolto con schietto en tus iasmo. Alla vecchia Repubbl ica , divisa ora in sette d ipa r t imen t i , fu rono lasciate delle mag i s t r a tu re speciali e u n a certa au tonomia nei confronti di Milano. Grazie alla sua lunga e gloriosa tradizione politica, la Serenissima dispone-
142
va ancora di u n a classe d i r igen te di notevole livello. Nella loro qualità di Podestà di Venezia, sia Renier che Gradenigo d iedero prove eccellenti. La Dalmazia venne affidata, col titolo di Provveditore Generale , a un patrizio di lontana origine ebraica, ma il cui n o m e brillava nel «Libro d 'Oro» della città, Dandolo , di cui Napoleone aveva det to: «E con Melzi l 'unico vero u o m o politico italiano». Ce n ' e ra bisogno perché la Dalmazia, come a n c h e l 'Istria, n o n era governabi le né da Milano né da Venezia, ed ebbe un'esistenza tribolata dalle cont inue rivolte delle popolazioni slave. Per repr imerle, Eugenio vi m a n d ò dei repar t i dell 'esercito italiano, che lì fece le sue p r ime esperienze di gue r r a d o p o secoli d'imbelle passività. Si ba t te rono con onore , ma sempre a fianco delle t r u p p e francesi, che n o n po te rono mai sguarni re quelle terre dilaniate da una endemica guerriglia.
In o m a g g i o alla giustizia dis t r ibut iva nel la spar t iz ione delle spogl ie fra i pa r en t i , N a p o l e o n e p r o c e d e t t e ad altri parziali aggiustamenti . Avendo dato al Regno Italico, cioè a Eugenio, tut to il Veneto, gli tolse la Garfagnana e il Ducato di Massa-Carrara pe r a r ro tonda re la dote di sua sorella Elisa, Principessa di Lucca. Ma costei non si contentò . Voleva tut ta la Toscana, e la voleva da vera sorella di Napo leone , tenace e imper iosa come lui. «Fare il sottoprefetto a Lucca non p u ò e non deve piacermi» gli scriveva.
Ma con ten ta r l a n o n e ra facile. Luigi di B o r b o n e , a cui nel 1801 la Toscana e ra stata assegnata col titolo di Re di E t rur ia , n o n aveva r e g n a t o - e male - che d u e ann i . Nel 1803 era mor to , ma sul t rono restava la vedova Maria Luisa in qualità di «reggente» pe r conto del f iglioletto mino renne . N a p o l e o n e che q u a n d o e r a n o in giuoco interessi politici n o n si lasciava cond iz iona re da scrupol i di ga lanter ia , le avrebbe dato volentieri i l benservito. Ma essa e ra u n a Borbone di Spagna, cioè appar teneva a u n a dinastia e a un Paese, di cui l ' Impera tore voleva a tutt ' i costi serbare l'amicizia. Bisognava d u n q u e risolvere il p rob lema d 'accordo con loro, e alla ricerca di questo accordo fu intavolata u n a complessa
143
trattativa che d u r ò quasi d u e anni , ma di cui a noi interessa solo il risultato.
Abbiamo già det to che l 'uomo di fiducia di Napoleone a Madr id era Godoy, il favorito della Regina. Per averlo dalla p ropr ia par te in una transazione di quel l ' importanza, ci voleva u n a mancia adegua ta . Napo leone , che o rma i c redeva di poter d isporre dei t roni europe i come di suoi beni privati, offrì a Godoy quello del Portogallo, o pe r meglio dire di una metà del Portogallo l'altra sarebbe anda ta a Maria Luisa in cambio dell 'Etruria.
Del pa t to fra i d u e compar i nessuno fu informato, nemm e n o il Re Carlo IV, che del resto n o n veniva mai informato di nulla e si limitava ad avallare regolarmente ciò che avevano deciso la Regina e il suo amante . Questi ultimi, mirando a c r e a r e anche stavolta i l fatto compiu to , ai p r imi del 1807 r i ch iamarono alla chetichella le t r u p p e spagnole che presidiavano la Toscana. Subito dopo , quelle francesi occup a r o n o i l por to di Livorno. In novembre l 'ambasciatore di Napo leone a Firenze informò Maria Luisa ch'essa non era più Regina di Etruria, ma del Portogallo set tentr ionale. La Regina n o n solo non mosse obbiezioni, ma n o n se ne mostrò n e m m e n o sorpresa. Unica sua preoccupazione fu quella di stivare nelle casse tut to ciò che da palazzo Pitti si poteva po r t a r via, compresa la salma del mar i to . La colonna di carri che nel d icembre (1807) si avviò p e r la via Bolognese r i cordò ai fiorentini quella che aveva seguito Francesco di Lorena e sua moglie Maria Teresa dopo la loro p r ima e unica visita a Firenze come successori dei Medici. Ma i saccheggi non li subiscono che coloro che se li mer i tano. E i toscani e gl'italiani da secoli non meri tavano altro.
Con l 'abituale docilità il Senato fiorentino, in un p r i m o «consulto» del maggio 1808, proclamò la Toscana terr i tor io de l l ' Impe ro , e con un secondo del marzo 1809 r e s t au rò i l G r a n d u c a t o sotto la c o r o n a di Elisa Baciocchi B o n a p a r t e . Firenze se ne dimostrò così poco entusiasta che la nuova sovrana preferì farvi il suo ingresso nelle o re an te lucane , in-
144
sieme - dice Bargellini - agli erbivendoli e ai lattai. Abituati al t ono affabile e alla m a n o m o r b i d a dei loro G r a n d u c h i , Medici o L o r e n a che fossero, i fiorentini avevano s e m p r e detestato i francesi soprat tut to pe r le loro manie re imperiose e altezzose. Siccome in testa ai loro o rd in i e b a n d i c 'era s empre la tronfia espressione nous voulons, noi vogliamo, li chiamavano «i nuvoloni».
Bisogna dire che Elisa, nel poco t empo ch'ebbe a disposizione, fece del suo meglio pe r affezionarseli. I suoi po te r i e rano ancora più circoscritti di quelli di Giuseppe a Napoli e di Eugenio a Milano: si l imitavano a una vaga supervisione sull 'operato delle autori tà politiche e militari che prendevano gli ordin i d i re t tamente da Parigi. Ma essa li esercitò con accortezza e con una diligenza che rasentava il puntiglio. «Il lavoro è diventato la mia unica passione» scriveva al fratello, e infatti voleva vedere , sapere e controf i rmare tut to . Confinato in un platonico comando di t ruppe , il mari to aveva così poca voce in capitolo che l 'ambasciatore Menou consigliò a Napoleone di «rinchiudere questo r imbambito in Senato».
Piena di fiducia, la Granduchessa scriveva: «Fra qualche a n n o i toscani s a r a n n o c o m p i u t a m e n t e francesi». Q u a n t o fondato fosse il suo ott imismo, mancò il t empo di verificarlo. Ma per il m o m e n t o tuttavia il sogno italiano di Napoleone pareva avverato. Meno le d u e isole, egli era davvero Rex totius Italiae. Ne disponeva da p a d r o n e assoluto, e lo d imostrò pe r l 'ennesima volta col cambio della guard ia sul t rono di Napoli : un avvenimento s t re t tamente legato a quelli internazionali che lo condussero alla catastrofe.
Uno dei pun t i fermi della sua politica, lo abbiamo già detto, era sempre stato l'amicizia con la Spagna pe r n o n essere costretto a combat tere anche sul fronte dei Pirenei. Ma dell'amicizia N a p o l e o n e aveva un concet to mol to pe r sona le : la confondeva con la d ipendenza . Quella che Godoy gli assicurava, grazie a l l ' ascendente che esercitava sulla Regina, da qualche t empo n o n lo contentava più. E siccome non riusci-
145
va a r e n d e r l a p iù sollecita, decise di tagliar cor to alla sua maniera , cioè impad ronendos i anche del t rono di Madr id . Dopo il trionfo di Austerlitz e l 'accordo di Tilsit con la Russia, egli era convinto di poter ormai d ispor re del l 'Europa.
N o n r i fa remo la storia dei sord id i in t r ighi con cui egli cercò di screditare agli occhi del m o n d o e dei loro stessi sudditi i Borbone di Madr id . E ven iamo al r isultato di ques ta manovra . Nel maggio del 1808 tutta la famiglia reale, compreso il favorito Godoy, fu convocata a Baiona e cost re t ta con un ricatto a r inunc ia re al t rono . Napoleone credeva di aver risolto tut to con quell 'estorsione. Non aveva fatto i conti con l 'orgoglio degli spagnol i , s e m p r e disposti a sbeffeggiare i loro Re in carica (e Carlo IV ne aveva offerto abbondant i pretesti), ma altret tanto pront i a scendere in a rmi pe r difenderli dal sopruso straniero.
In un bat t ibaleno il Paese fu in fiamme, Napo leone dovette dislocarvi 300.000 uomin i p e r venire a capo della ribellione, e n o n ci riuscì. L'Austria, che d o p o Austerlitz n o n spiava che l'occasione della rivalsa, credet te ch'essa fosse venu ta e scese di nuovo in g u e r r a con un attacco a sorpresa. Napoleone fece in t empo a r ien t ra re a Parigi e a r iassumere il c o m a n d o dell 'esercito. Vinse ancora , a Wagram, ma faticosamente e n o n in m a n i e r a risolutiva: la Spagna gli stava d ivorando uomini e materiali .
La pace fu saldata con modif iche ter r i tor ia l i che , p e r quan to r igua rda i l nos t ro Paese consistet tero nell 'assegnazione dell'Alto Adige al Regno Italico, e con un matr imonio . Da quando gli e ra sbollita la passione pe r Giuseppina e questa si e ra dimostrata incapace di dargli un erede , Napoleone meditava di divorziare da lei pe r con t ra r re un 'a l t ra un ione che fosse a n c h e po l i t i camente reddi t iz ia . L ' Impe ra to r e d 'Austr ia d isponeva di u n a f igl ia che, ol tre a p roven i re da u n a famiglia che forniva solide garanzie di prolificità, e ra disposta , come diceva Met te rmel i , «ad accet tare tu t to ciò che possa cont r ibu i re al benessere e alla pace dello Stato». Sposandola , N a p o l e o n e s ' imparen tava con la p iù antica e
146
prestigiosa dinastia d 'Europa , gli Asburgo, e se la faceva alleata o a lmeno n o n più nemica.
Bisognava pe rò annul lare la p recedente un ione con Giuseppina pe rché i cattolicissimi Asburgo non si contentavano d ' u n m a t r i m o n i o civile; volevano anche quel lo rel igioso. Dopo pianti e disperazioni , Giuseppina dovet te consent i re a dichiarare ch'essa aveva «costretto» Napoleone a sposarla, e il t r ibuna le ecclesiastico finse di c reder lo . Il ma t r imon io con Maria Luigia fu celebrato nel 1810, e l 'anno d o p o nacque i l sospirato e r ede , p roc lamato subito Re di Roma, ma destinato a non salir mai su nessun t rono.
Abbiamo anticipato questi avvenimenti pe r far capire al lettore quelli italiani che ne furono il riflesso.
Torn iamo per un m o m e n t o a Madr id . Ad annunc ia re al Consiglio di Reggenza che i Borbone avevano «rinunciato» al t rono di Spagna, era stato il genera le Murat , cognato di Napoleone , di cui aveva sposato la sorella Carolina. Su ordine d e l l ' I m p e r a t o r e , egli aveva invitato gli spagnol i a designare un altro Re nella speranza - pare - di essere lui il p re scelto. Ignorava che Napoleone aveva già tut to predisposto: i l t r o n o di Madr id era des t inato a Giuseppe pe rché , come fratello maggiore , gli toccava il posto più impor t an t e . Lui, Murat , veniva des ignato al t r ono di Napoli , e n o n a titolo personale, ma come marito di sua moglie, «la quale - diceva l'atto d' investitura - con la presente cessione at tuata soprattutto in suo favore, met te la sua famiglia sul trono». E questa formula piuttosto insul tante era destinata a far sentire i suoi effetti sui successivi at teggiamenti di Murat .
Qua l cuno si aspettava un cambio della guard ia anche a Milano, ora che il viceré Eugenio non poteva più contare su sua m a d r e Giusepp ina . Ma N a p o l e o n e s i mos t rò pe r u n a volta tan to gene roso , anche p e r c h é d i quel f ig l ias t ro n o n aveva da lagnars i . Eugen io n o n aveva mai t rasgred i to un suo o rd ine e aveva esercitato i suoi scarsi poter i con m o k a oculatezza. Conduceva una vita esemplare con la moglie che
147
Napoleone gli aveva assegnato, la figlia del Re di Baviera. E anche se n o n riusciva a farsi a m a r e dai suddi t i p e r la sua scarsa comunicatività, e ra riuscito a farsi s t imare. Suo suocero aveva s t r appa to a Napo leone la p romessa di d a r e un giorno a Eugenio e a sua moglie un vero Regno. Dopo il divorzio da Giuseppina era chiaro che la promessa n o n sarebbe stata mantenuta , ma questo n o n impedì a Eugenio di restare fedele a l l ' Imperatore .
Ecco d u n q u e all 'ingrosso il q u a d r o di questa Italia alla fine in te ramente napoleonica dalle Alpi allo stretto di Messina. Al mosaico manca un pezzo solo: gli Stati pontifici. Ma questa è u n a vicenda che meri ta un capitolo a par te .
CAPITOLO QUINDICESIMO
CESARE E P I E T R O
La crisi che por tò alla soppressione dello Stato della Chiesa ha origini lontane, che ci obbligano nuovamen te ad alcuni passi indietro.
Q u a n d o nel 1800 to rnò in Italia d o p o l 'avventura egiziana, Napoleone era già Pr imo Console e cer tamente meditava la scalata al t r ono imper ia le . Per compier la , aveva bisogno del l 'appoggiò delle forze conservatrici, di cui n o n voleva u r t a r e i sent iment i cattolici, e questo l 'obbligava a cambiare politica verso la Chiesa. N o n restituì al Papa le Legazioni, cioè le province di Bologna e di Ferrara, o rmai annesse alla Cisalpina. Ma tut to il resto glielo lasciò, e anzi gli p ro pose un C o n c o r d a t o p e r r ego la re tu t te l e p e n d e n z e fra Chiesa e Stato.
Non era facile perché il regime politico francese si basava su princìpi e aveva in t rodot to istituti che la Chiesa non poteva app rova re : i l p iù indigesto era il g iu r amen to impos to ai sacerdoti, che faceva di essi quasi dei funzionari di Stato e di quella francese una Chiesa «gallicana», cioè nazionale. Infatti i negoziati d u r a r o n o dieci lunghi mesi e misero a d u r a prova la pazienza d i Napo leone , che n o n ne aveva mol ta . Per farli p rogred i re , egli ricorse varie volte alle minacce e ai pugn i sul tavolo, e alla fine lanciò un u l t imatum, che dava alla Cur ia solo c inque giorni di t e m p o per decidersi . Il lettore richiami alla memor ia quel particolare m o m e n t o politico. La gue r r a sembrava finita, l'Austria era spazzata via dall 'Italia, la stessa I n g h i l t e r r a stava p e r f irmare la pace di Amiens. N o n p o t e n d o p iù contare su nessun aiuto, i l Papa respinse l ' ingiunzione, ma m a n d ò a Parigi il Segretar io di
149
Stato, cardinale Consalvi, e l 'accordo fu firmato il 19 marzo del 1801.
Alcuni storici dicono che fu questo successo, diplomaticamen te importantissimo, a t r a r re in e r ro re Bonapar te facendogli c redere di avere nel Papa un inter locutore dalle mosse lente, ma debole e docile. Non era così. Pio VI I n o n app a r t e n e v a di cer to alla ca tegor ia dei g r a n d i Papi r inascimentali , uomini più di politica e di gue r r a che di p reghie re . Di umili origini, t imido, fragile e minuto , con gli occhi incavati nel volto ossuto e olivastro, n o n aveva nulla d ' imponente. Ma era sacerdote fino al midollo e p ron to , q u a n d o e rano in ballo gl ' interessi della Chiesa, a t r amu ta r s i in mas t ino . Questo , Napoleone non capì. E il suo ambasciatore a Roma, Cacault, che cercò di spiegarglielo, fu silurato e r impiazzato dal cardinale Fesch, un u o m o rozzo, che aveva un solo merito: quello di essere zio del Primo Console.
Il 18 maggio del 1804 ci fu il plebiscito che proc lamava Napoleone Impera to re . Dieci giorni p r ima questi aveva accenna to a l cardinal Cap ra ra , Lega to pontificio in Francia, all 'eventualità che il Papa venisse a investirlo a Parigi dove la Chiesa avrebbe così r i g u a d a g n a t o tu t to il suo pres t igio . Na tu r a lmen te il prestigio che a Napo leone interessava e ra quello suo. La sua corona ne avrebbe acquistato molto agli occhi di tut to il m o n d o , se il Papa si fosse scomodato a venire fin lì pe r consacrarla.
Vecchio, ma landa to e facilmente influenzabile, C a p r a r a informò la Curia suggerendo u n a risposta favorevole. Ma le trattative, subito d o p o aper te tra Fesch e Consalvi, si rivelarono difficili. I francesi p roposero che il Papa andasse a condur le di persona a Parigi, dove ci s ' impegnava a t rovare soluzioni pe r ogni problema. I l d i lemma, pe r Pio VII , era angoscioso. Accet tando, temeva di consegnars i nelle man i di un in ter locutore capace di qualsiasi ricatto. Rifiutando, temeva di pe rde re pe r sempre la Francia, come i suoi p r ede cessori avevano perso l ' Inghi l terra ai tempi di Enrico V i l i . Delle d u e p a u r e , la seconda finì pe r p reva le re . E così il 2
150
n o v e m b r e i l Papa salì in carrozza, con g ran m a l u m o r e dei roman i che consideravano la loro città unica depositaria dei poter i d ' investi tura, e scandalo delle altre Corti , che seguitavano a vedere in Napoleone un usurpa tore .
Il viaggio fu penoso anche pe r ché il seguito era composto per gran par te di alti prelati molto avanti negli anni e di salute mal fe rma. U n o di essi infatti, i l ca rd ina le Borgia, morì a Lione. Finalmente, dopo tre sett imane di diligenza e di scossoni, nella foresta di Fontainebleau, avvenne l'incont ro con l ' I m p e r a t o r e , che la p r o p a g a n d a ufficiale spacciò pe r fortuito e «provvidenziale». Viceversa era stato accurat amente studiato e p r o g r a m m a t o . E la sera del 25 il corteo en t rò nelle Tuileries.
I l Papa si r i t rovò sul pe t t i ne p iù n o d i di quan t i avesse previsto e senza margine contrat tuale pe r risolverli. Se avesse b u t t a t o tu t to all 'aria, av rebbe n o n sol tanto fatto la fine del suo predecessore Pio VI, ma forse anche perso davvero la Francia. Decise quindi di concent rare la sua resistenza sul solo p u n t o che gli pareva essenziale: il g i u r a m e n t o costituzionale del neo- Impera to re . Se esso avesse fatto pa r te della ce r imonia e fosse stato p r o n u n c i a t o in sua p resenza , ciò avrebbe significato da p a r t e sua l 'accet tazione di cert i pr incìpi di governo , che la Chiesa n o n poteva sanzionare . Esigette quindi che il g iu ramento fosse pronuncia to a par te .
Su tut to il resto dovette cedere , e non e ran cose da poco. Anzitutto, dovette r inunciare a p o r r e con le sue mani la corona sulla testa de l l ' Impera tore , cioè al simbolo del suo potere d ' investi tura. Napo leone se la sarebbe infilata da sé, a significare ch 'e ra lui a d i sporne , e n o n il Papa a concedergliela. Quest i n o n doveva di re Eligimus, lo eleggiamo, come sempre si e ra fatto nelle incoronazioni , ma Consecraturi su-mus, lo consacr iamo. Per di p iù veniva abolita la p resen ta zione dei d u e Vescovi cui, secondo la p r o c e d u r a tradizionale, i l Papa avrebbe dovuto chiedere , ind icando l ' Impera to re: Scis illum esse dignumì, ti risulta che sia degno? Insomma, il mil lenario rituale era stato comple tamen te r ivoluzionato
151
/
per fare de l l ' Impera to re l 'unico protagonis ta della cerimonia e r i du r r e la par te del Papa a quella di semplice notaio.
Così fu. II ri to del 2 d icembre nella chiesa di Notre-Da-me fu i m p o n e n t e e ragg iunse i p iù alti effetti spettacolari . Ma il gesto di Napo leone che s'infilava da sé la corona era t a lmente inatteso e in contras to con la prassi t radizionale , che molti pensa rono a un colpo di forza; e q u a n d o seppero ch 'e ra stato concorda to , ne furono indignat i . «Tutto, nella rivoluzione - scrisse il cattolicissimo De Maistre - è miracolosamente cattivo, ma ques to è il non plus ultra. N o n res ta che des ide ra re che i l Papa scenda fino in fondo, in m o d o da n o n essere più che un pulcinel la senza peso né impor tanza.»
Q u a n d o risalì in carrozza pe r to rnare a Roma, Pio VII si e r a già accorto che que l l ' avven tu ra si ch iudeva p e r lui in net to passivo. Aveva spera to di o t t ene re a lmeno la rest i tuzione delle Legazioni, ma Napoleone se l 'era cavata con parole vaghe che n o n lo i m p e g n a v a n o a nulla. A p p e n a r ient ra to , scrisse a l l ' I m p e r a t o r e : «Non poss iamo n a s c o n d e r e che res ta in noi mol ta amarezza». Ma poi , a q u a n t o p a r e , stracciò la lettera e l 'amarezza se la t enne in corpo. Q u a n t o a N a p o l e o n e , si e r a v ieppiù convin to de l l ' a r rendevo lezza del Papa. «E un b u o n uomo» diceva, sicuro di poter lo tenere a guinzaglio. E su questo e r r o r e di valutazione impostò tut ta la sua politica con la Chiesa.
Come abbiamo già det to, è difficile stabilire quanto l 'incoronazione di Napoleone p r ima a Impe ra to re dei francesi, poi a Re d'Italia, abbia influito sulla formazione della terza coalizione anglo-russo-austr iaca. Ma che vi abbia influito n o n c'è dubbio. C o m u n q u e , nel set tembre del 1805 la parola era - scusate se ci r ipet iamo - di nuovo agli eserciti. E, sebbene il teatro principale delle operazioni fosse stavolta la Germania, anche l'Italia ne fu coinvolta, e le forze francesi vi si t rovarono in una situazione piuttosto delicata. Se i port i pontifici e sopra t tu t to Ancona avessero consenti to uno sbarco ai
152
russi e agl ' inglesi, pe r l ' a rmata del Beauharna i s n o n ci sarebbe stato scampo. Per p r even i r e ques to pericolo, N a p o leone ord inò l 'occupazione di quella città.
Il Papa reagì con una let tera t raboccante di collera e di minacce. Napoleone , che n o n se l 'aspettava, la ricevette propr io alla vigilia della battaglia di Austerlitz, decisiva pe r le sue fo r tune . La cons ide rò u n a p u g n a l a t a nella schiena e de t tò u n a r isposta b ru t a l e e b ruc i an t e in cui in t imava al Pontefice di sbarrare la por ta dei suoi Stati ai «nemici dell 'Italia», che e rano i nemici di Napoleone , cioè in parole povere di r inunziare alla neutrali tà.
Questa replica dovette arr ivare a Roma quasi contempor a n e a m e n t e alla notizia della c lamorosa vit toria r i p o r t a t a da l l ' Impera to re , che ribadiva il suo assoluto domin io sulla penisola e poneva fine a quella ennes ima g u e r r a . Ma n o n pe r questo il Papa disarmò, e la sua corr ispondenza con Napo leone segui tò a svolgersi su toni a s p r a m e n t e polemici . Tut to ormai era pre tes to di litigio fra i d u e . Ma il nocciolo della quest ione è in una lettera de l l ' Impera to re che la riassumeva così: «I nostri r appor t i devono basarsi sul fatto che Vostra Santi tà mi deve, nel c a m p o t empora l e , gli stessi riguard i che io ho pe r Essa nel campo spirituale. Vostra Santità è sovrana di Roma, ma io ne sono l ' Imperatore». Al che Pio VII r i spondeva: «Non esiste un I m p e r a t o r e che abbia diritti su Roma.. . Non esiste un Impe ra to re di Roma».
N a p o l e o n e p r o p o s e nuovi negoziat i , ma a condiz ione che si svolgessero a Parigi e che il delegato di Roma fosse un Cardinale francese muni to di pieni poteri . Il Papa p r ima si piegò, poi ritirò la delega e respinse l'abbozzo di trattato che gli avevano spedito. Napoleone tagliò corto. In gennaio (del 1808) ord inò al generale Miollis di muovere con le sue t ruppe su Roma, e l 'ambasciatore Alquier a m m o n ì la Santa Sede che qualsiasi at to di resis tenza avrebbe i m m e d i a t a m e n t e provocato l 'annessione degli Stati della Chiesa al Regno Italico.
Stando alle dichiarazioni ufficiali, doveva trattarsi soltan-
153
to di un 'occupazione t e m p o r a n e a pe r i n d u r r e i l Papa a un at teggiamento più ar rendevole . Ma le istruzioni ad Alquier par lavano un linguaggio assai diverso: «L'Imperatore vuole che la Corte Papale cessi insensibilmente, senza che quasi ci se ne accorga, di esistere come potere temporale».
I r o m a n i avevano assunto , nei confront i dei francesi, il solito a t t egg iamen to canzona to r io , che gli p e r m e t t e v a di manifes tare ostilità senza c o r r e r e rischi. Ma n o n mossero un dito quando gli videro disarmare gli svizzeri e incarcerare in Castel Sant 'Angelo la Guard ia Nobile. Napoleone stava già smantel lando gli Stati Pontifici. Ne aveva staccato Ancona, Urbino, Macerata e Camer ino , annet tendole al Regno Italico. Forse avrebbe seguitato di quel passo, senza precipitare le cose, se ancora una volta n o n si fosse trovato in guerra. L'Austria lo aveva attaccato di sorpresa m e n t r e era impegnato in Spagna. Rient ra to in g ran fretta, aveva fulmineamente rintuzzato l 'aggressione a Wagram, e dalla Germania si e r a avventa to sulla capi tale nemica . Fu nella r i nnova ta certezza della p ropr ia invincibilità che dal «campo imperiale di Vienna» firmò nel maggio (del 1809) il decreto che decideva il destino del l 'Urbe.
Miscuglio di so lenni tà e di d i le t tan t i smo, di s toria e di teologia, quel d o c u m e n t o in tendeva pa r l a r e a l Papa in un l inguaggio da Papa e impart irgli alcuni insegnament i sulle faccende del cielo. In Cur ia dovette suscitare u n a certa ilarità, ma fugace, perché scendendo sulla te r ra il discorso diventava t e r r ib i lmen te serio. La donaz ione fatta da Car lo Magno ai Pontefici con tutti i diritti temporal i che ne conseguivano, veniva abrogata, il loro Stato soppresso e i loro territori annessi a l l ' Impero. Roma diventava città imperiale. Al Papa venivano lasciati sol tanto i suoi palazzi con garanz ia d ' immuni tà e u n a rendi ta di due milioni l 'anno.
II 10 giugno, fra le salve di cannone , la bandie ra pontificia veniva ammaina ta su Castel Sant 'Angelo e sostituita dal tricolore francese. Lo stesso giorno il Papa emanò una «bolla», che scomunicava i responsabili degli at tentat i cont ro la
154
Santa Sede «qualunque sia l 'onore dell'alta dignità di cui sono investiti». I l n o m e di Napo leone n o n era citato. Ma era chiaro che l 'anatema ricadeva su di lui.
L ' Imperatore ne fu indignato come di un t rad imento : da un «buon uomo» come Pio VII n o n se l 'aspettava. Furibondo , scrisse a Miollis: «Non bisogna più avere r iguardi : questo pazzo furioso va rinchiuso». Se questa lettera fosse giunta al dest inatario, u o m o accorto e cauto, forse non sarebbe stata i n t e r p r e t a t a come un o r d i n e . Ma v e n n e in te rce t ta ta dal capo della gendarmer ia Radet che, come tutti i gendar mi, n o n distingueva che fra obbedienza e insubordinazione.
Nella notte fra il 5 e il 6 luglio, alla testa di un drappel lo formato di soldati e di fabbri, Rade t si recò al Qui r ina le e, t r o v a n d o n e chiusa la por ta , ne fece demol i re le se r ra tu re . L'operazione fu r ipetuta altre tredici volte perché altrettante e rano le por te da at traversare pe r raggiungere l 'appartam e n t o del Papa. I cupi tonfi della scure si mescolavano ai rintocchi delle campane sciolte a distesa pe r ch iamare il popolo alle a rmi . Il popo lo accorse, ma d i sa rmato , e stette a guardare .
Q u a n d o fu davanti al Papa che, pallidissimo, con una stola sulla veste bianca e un crocefisso in m a n o , lo a t t endeva nel suo s tudio, a Rade t la baldanza cadde di dosso. Sull'attenti e incespicando con le parole , intimò al Papa di r inunciare a l p o t e r e t e m p o r a l e e , n o n a v e n d o o t t e n u t o che un fermo rif iuto, disse: «Poiché tale è la decis ione di Vostra Santi tà, devo d ich ia ra r le che ho l ' o rd ine d i c o n d u r l a con me». Il Papa lo seguì senza o p p o r r e resistenza. Q u a n d o fu in mezzo alla t r u p p a che presidiava il cortile, la benedisse. E salì sulla carrozza che lo at tendeva.
Il seguito della sua vicenda lo vedremo più tardi .
Con la depor taz ione del «buon uomo», Napoleone credeva di aver risolto una volta pe r tut te i rappor t i fra Stato e Chiesa. Ma dovette presto accorgersi che la Chiesa n o n era u n a provincia o un Reame da potersi alienare o anne t te re a pia-
155
cere. Siccome c 'erano delle diocesi vacanti, egli ne nominò i titolari, convinto che il Sacro Collegio avrebbe approvato le sue scelte. Invece il Sacro Collegio si rivolse al Papa internato a Savona e, siccome questi rispose che nella sua condizione di pr igioniero n o n e ra libero di decidere , negò la ratifica. Firenze e Asti si rifiutarono di ricevere il nuovo Vescovo, Fioccarono i p r imi arrest i di sacerdoti e il Papa fu sot toposto a un isolamento quasi totale. «Non c'è d u n q u e un mezzo canonico di pun i r e un Papa che predica la rivolta e la guerra civile?» chiedeva l ' Impera tore furibondo.
E v i d e n t e m e n t e , n o n c 'era. Convocat i p e r suo o r d i n e , d u e Consigli ecclesiastici si r imisero pe r le decisioni finali a un Concilio che a sua volta si r imise al Papa . Più che dal «vertice», la resistenza veniva dalla base, cioè dal basso clero . Quello alto, disse il cardinale Pacca, mostra «un compiac imento servile, malat t ia endemica fra i prela t i che fin dai t empi d i Costant ino h a n n o f requenta to le Corti». Ma n o n era del tu t to vero: q u a n d o gli fu imposto il g iu ramen to all ' Impera tore , nove dei dodici Vescovi del l 'Umbria lo rifiutarono . «Voglio che si esca da questa situazione ridicola» tuonava N a p o l e o n e . C o m i n c i a r o n o le depor t az ion i . In m a n canza di vagoni piombati , lunghe colonne di pret i e frati furono avviate a piedi oltre le Alpi e in Corsica. C 'erano anche parecchi laici, che avevano anch'essi rifiutato il g iu ramen to cui e rano tenut i pe r le loro funzioni: a Roma, su mil leduecento avvocati, solo quaran ta lo avevano prestato. Chissà se Napoleone rifletté sulla singolarità di questo Paese che sfornava con altret tanta generosità renitenti alla leva e volontari della persecuzione.
Nessuno p u ò d i re come si sarebbero sciolti questi nodi , se a tagliarli n o n fosse sopravvenu to il crollo de l l ' Impe ro . Pio VII diceva: «E u n o scisma», e forse lo sarebbe diventato. Ma n o n ce ne fu il t empo . Il poco che gli restava, Napoleone lo impiegò a fare di Roma, dove n o n aveva mai messo piede, ma di cui subiva il fascino, la seconda città del l ' Impero . Dappr ima aveva pensato di mandarc i come governatore
156
qualcuno della sua famiglia. Ma poi vi lasciò, a t t r ibuendogl i il titolo di L u o g o t e n e n t e e vasti po ter i , il genera le Miollis, dal quale d ipendevano i d u e prefetti del Tevere e del Trasimeno , cioè del Lazio e del l 'Umbria. Il resto era stato annesso al Regno Italico.
Tut to sommato , fu un b u o n governo . I l p rosc iugamento delle pa ludi pont ine , già iniziato da Pio VI e Pio VI I , ricevette un 'energica spinta, e alcune drast iche r iforme misero fine al caos amministrat ivo e finanziario in cui versava quello Stato, di cui Goe the diceva che «stava in p iedi solo perché a n c h e l ' in ferno si r if iutava d ' inghio t t i r lo» . I l deb i to pubblico fu l iquidato, sia p u r e con metodi di rap ina . Molti m o n u m e n t i e palazzi che d i roccavano v e n n e r o res taura t i . Vennero compiu t i n u m e r o s i tentativi p e r r ipopo la re i l semideser to «agro», ma qui i successi furono scarsi: la gente n o n voleva starci pe r p a u r a n o n tanto della malar ia quan to dei br igant i , le cui b a n d e e r ano a l imentate sopra t tu t to dai disertori .
I l n u o v o r eg ime n o n v e n n e mai minaccia to da rivolte, ma fu sempre avversato dalla massa della popolazione, sensibile alle istigazioni di un clero disoccupato, r idot to in g ran par te alla clandestinità e b u o n fornitore anch'esso di reclute al br igantaggio. Solo u n a par te della nobiltà e dell'alta borghesia furono favorevoli al l 'opera riformatrice e vi collabor a r o n o . Ceti medi e popo l ino , abi tuat i a vivere di Papi, di Cardinal i e di elemosine, manifes tarono la loro ostilità con l'inerzia, il boicottaggio, le solite corbellature affisse alla statua di Pasquino e la larga ospitalità accordata agli agenti inglesi e borbonici . Di essere stata promossa a «seconda capitale del l ' Impero», Roma non mostrò mai l 'orgoglio.
CAPITOLO SEDICESIMO
MURAT
Q u a n d o , il 6 set tembre del 1808, venne a p r e n d e r e possesso de l suo Regno , Gioacchino M u r a t fece ai napo le t an i un 'eccel lente impress ione . Bello, giovane, a i tante , i l volto incorniciato in u n a cascata di riccioli ner i e i l luminato dagli s tupendi occhi turchini , aveva tut to e di tut to fece pe r piacere a tut t i : aveva inventa to anche u n a divisa appos ta p e r l'occasione, scintillante di fregi e di medaglie; e ra ent ra to in città seguito soltanto da un aiutante di campo pe r dimostrare la sua fiducia nella popolazione; anche lui era subito andato a r e n d e r e omaggio a San Gennaro ; e aveva al suo fianco, come pòlizza di assicurazione, Carol ina Bonapa r t e , sorella de l l 'Onnipotente .
I biografi dicono che in origine il suo n o m e e ra Murad , t ipicamente arabo, e l'ipotesi è suffragata dal fatto che nella sua con t r ada di nascita, il Quercy, ci sono ancora i resti di un villaggio mussu lmano dei t empi di Carlo Martello che si chiamava a p p u n t o Murad-la-Rave, cioè Murad- l 'a rabo. Era figlio di un piccolo albergatore, che lo mise in seminario pe r far di lui un pre te . Il ragazzo, che aveva solo la passione delle d o n n e , dei cavalli e delle avventure , fuggì, si a r ruolò nell'esercito del Re, e se ne fece cacciare pe r insubordinazione. Fu ques to incidente a convert i r lo alla Rivoluzione. Ques ta aveva fatto piazza pulita di tutti gli alti gradi militari, fedeli alla monarchia o sospetti di esserlo. L'occasione era d 'oro, e Gioacchino n o n se la fece sfuggire. Per propiziarsi u n a carr iera più rapida , d iede un ritocco a l p r o p r i o n o m e , t r amutandolo in Marat, ch 'era quello del più famoso t r ibuno dell'epoca. Il resto lo fecero le guer re . Sergente nel '92, l 'anno
159
d o p o Gioacchino era già capi tano . Gli scatti di g r a d o se li era guadagnat i a furia di cariche e di sciabolate. «Comandati da lui, venti uomini valgono un reggimento» diceva Bou-r ienne , e questa voce arr ivò anche all 'orecchio di un generale quasi suo coetaneo che si apprestava a invadere l'Italia con un esercito in brandell i : Bonapar te .
Q u a n d o , pochi mesi dopo , r i to rnò a Parigi pe r d e p o r r e ai piedi del Direttorio le ven tun bandie re che il suo comandan te aveva s t rappate agli austro-piemontesi , Murat era già colonnello, ma il Direttorio lo nominò seduta stante generale. In u n ' u n i f o r m e di sua invenzione - ve rde con c o r d o n i d 'oro , nastri d 'a rgento e stivali rossi -, questo «Apollo della Guerra» m a n d ò in f rantumi molti cuori femminili, e fra gli altri quello - fragilissimo - di Giuseppina Bonapar te . Quan to abbia pesato questa sua relazione con lei sulla diffidenza che Napo leone poi s e m p r e nu t r ì nei r igua rd i di Gioacchino , è difficile dire . Lo aveva decorato e promosso più volte, ma lo aveva ben misurato. Più che un vero generale, lo considerava un «guappo» capace d ' imprese eroiche, ma più pe r esibizionismo e spavalderia che pe r autentico coraggio. Nell ' impresa d 'Egit to pa re che n o n lo volesse con sé e che dovet te subirlo p e r imposiz ione del Dire t tor io . Ma in quel la c a m p a g n a di g r a n d i spazi e di car iche a brigl ia sciolta, Gioacchino rese tali servigi che Napo leone se lo r ipor tò al seguito q u a n d o di sorpresa r ien t rò a Parigi, e fu a lui che affidò il delicato compito di cacciare dal pa r lamento i deputa ti che facevano resistenza alla sua nomina a Pr imo Console.
La mancia che Gioacchino gli chiese fu la m a n o di sua sorella Carolina. Napoleone n o n voleva saperne , ma Carolina si era incapricciata e aveva dalla sua Giuseppina, sempre tenera e ma te rna con i suoi vecchi amant i . Il mat r imonio si fece, spalancando all 'avventuriero nuovi insperati orizzonti. Da b u o n còrso, Napo leone aveva il culto della famiglia. E, u n a volta diventato I m p e r a t o r e e p a d r o n e di mezza Euro pa , si e ra messo a d i s t r ibu i rne i t ron i fra i suoi congiun t i . M u r a t sperava che ne toccasse u n o anche a lui e q u a n d o
160
N a p o l e o n e , d o p o aver cacciato i B o r b o n e di Spagna , lo m a n d ò a Madr id p e r t ene re in briglia i l Paese, c rede t t e di essere il designato a quella successione.
Secondo qualche memorialista, Napoleone deluse la sua attesa pe r ché p r o p r i o allora venne a conoscenza di un piano segre tamente app ron ta to dai suoi ministri Tal leyrand e Fouché. In caso di mor t e de l l ' Impera to re , costoro si e r ano accordati, in mancanza di un e rede legittimo, a sostenere la candida tura alla successione di Gioacchino, considerandolo il più facile da maneggia re . N o n si sa se costui fosse al corren te . Ma Napoleone lo sospettava. Sempre più lo considerava un bravaccio velleitario, r u m o r o s o e past iccione che «quando mi vede, è tut to mio; lontano, cade nelle man i di chi lo lusinga», e n o n migliore op in ione aveva di Carolina, «donna ambiziosa e in t r igan te che met te mille sciocchezze in testa a suo marito...» Fatto sta che la Spagna l'aveva assegna ta a G iuseppe . E p e r ques to , sotto il sorr iso con cui i nuovi sovrani r i spondevano alle acclamazioni della folla di Napoli, c 'era soltanto u n a profonda amarezza. Si sentivano non soltanto defraudati di un titolo molto più illustre e qualificante, ma anche diffidati e sospettati.
Lo stesso a t to d ' inves t i tura che regolava i r a p p o r t i fra Napoli e l ' Impero era oltraggioso. Vi si diceva che la corona era assegnata «soprattutto in favore della principessa Carolina», i l che r iduceva p ra t i camente Gioacchino al r a n g o di un principe-consorte . Seguiva u n a sfilza di clausole jugula -torie. Il Reame avrebbe par tecipato a qualsiasi gue r r a - difensiva o offensiva - d e l l ' I m p e r o , c o n t r i b u e n d o v i con 16.000 fanti, 2.500 cavalieri , 20 c a n n o n i e 12 vascelli di guer ra ; doveva p rovvedere alle spese dell 'esercito di occupazione francese dislocato ne l R e a m e p e r d i fender lo , ma anche pe r tener lo sotto controllo. Per di più, le cariche più impor tan t i dovevano res ta re nelle m a n i dei f iduc ia r i dell ' Imperatore , fra i quali faceva spicco Saliceti, ministro della polizia. Della sua fe rma in t enz ione di t e n e r e il cogna to a guinzagl io, N a p o l e o n e n o n faceva mis te ro n e a n c h e nelle
161
sue lettere a lui: «Non fatevi illusioni: vi ho fatto Re soltanto nell ' interesse del mio sistema». Glielo faceva r icordare , con poco garbo , anche dai suoi sot topost i . Ber th ie r scriveva a Gioacchino: «Per i vostri sudditi , siate Re. Per l ' Impera tore non siete che un viceré».
Mura t m o r d e v a il freno. «L ' Impera tore - scriveva a sua moglie - e m a n a decre t i come se fosse il p a d r o n e , i m p o n e ordini a Napoli come se fosse a Parigi. Non si è Re soltanto pe r obbedire .» Ques to e r a l 'unico p u n t o su cui Caro l ina consentiva con lui perché su tut to il resto, compreso il letto, e rano in p ieno disaccordo. Non bella, ma piena di femminilità, Carolina aveva l 'ambizione di Elisa e il sesso di Paolina, ma era più di loro calcolatrice e ambigua. Detestava il fratello, disprezzava il mari to , e cercava di giuocarli l 'uno contro l 'altro pe r accrescere il p r o p r i o potere . I napole tani fecero pres to ad accorgersi che con l 'altra Carol ina, quella di Pale rmo, essa n o n aveva in c o m u n e soltanto i l n o m e ; ma era molto più intelligente, abile e tortuosa.
Per sottrarsi alla tenaglia della moglie e del cognato, Murat n o n aveva che un ' a rma: la popolari tà. E per procurarsela, ricorse a tutto. Si aggirava senza seguito pe r le s t rade di Napol i p a r l a n d o con la gen te e r accog l i endone le suppl i che, moltiplicava le para te militari - che tanto piacciono ai napoletani - esibendovisi a cavallo alla testa di repar t i rivestiti in sgargianti uniformi, andò perfino in processione pe r San G e n n a r o m a n d a n d o in bestia Napo leone che gli det te del «burattino».
Ma questa attività di «pubbliche relazioni» non era che il complemento di un disegno politico ben preciso, ispiratogli dai consiglieri e funzionari di cui si era c i rcondato: fare di Napoli u n o Stato in te ramente napole tano, che all 'occorrenza potesse d iventare i n t e r amen te italiano. Il compito gli fu facilitato dall ' improvvisa mor te di Saliceti che, pe r la sua fedeltà a l l ' Impera tore e pe r il posto che occupava di ministro della polizia, e ra il p iù autorevole e r igoroso dei suoi control lori . N a p o l e o n e disse che con Saliceti « l 'Europa aveva
162
perso u n a delle sue teste più forti». Ma Murat prese la palla al balzo pe r rimpiazzarlo con un uomo suo che tuttavia, essendo di Genova , aveva o r m a i c i t tad inanza francese: Maglietta. Le male l ingue dissero ch ' e r a stato lui a e l iminare col veleno Saliceti. N o n era vero. Ma il fatto che lo dicessero d imos t ra che fama godesse ques to pe r sonagg io e q u a n t o fosse qualificato a un posto in cui i galantuomini n o n h a n n o mai fatto b u o n a figura. Era insomma propr io l 'uomo che ci voleva pe r il dopp io giuoco che Mura t si p r epa rava a svolgere pe r affrancarsi dalla Francia senza rimetterci il t rono .
Su questa strada lo spingevano gli alti dignitari napoletani del suo r eg ime : i l minis t ro degli Esteri Gallo, che nella sua carr iera era riuscito ad essere l 'uomo di fiducia di tutti: p r i m a di Caro l ina d i B o r b o n e , poi d i N a p o l e o n e , po i d i G iuseppe , e o ra di Mura t . C 'e ra i l min is t ro d e g l ' I n t e r n i Zurlo, anch'egli ex-servitore del vecchio regime. C'era quello della Giustizia, Ricciardi. C ' e r ano militari , funzionar i e intellettuali, come Carascosa, Colletta, Cuoco, Borrelli, tutti o quasi tutti affiliati alla Massoneria, di cui Gioacchino si atteggiava ad alto pa t rono .
Esponent i di un movimento che si chiamava italico, questi uomin i speravano , p e r realizzare i l loro p r o g r a m m a di unità nazionale, di servirsi del Re, il quale sperava di servirsi di loro pe r diventare un Re italiano ind ipenden te . Per far questo, occorreva anzi tut to sloggiare dalle più alte cariche dello Stato i francesi, cui N a p o l e o n e le aveva affidate ap p u n t o pe r impedi re che questo avvenisse. La lotta fu a coltello e si svolse in un groviglio d ' intr ighi da far impall idire quelli orditi a suo t empo da Carolina di Borbone. La polizia di Maghella sorvegliava quel la dei servizi napoleonic i che sorvegliavano il Re e la Regina, che a loro volta cercavano di sorvegl iare tut t i e di sorvegliarsi t r a loro in un nugo lo d ' in fo rmator i al servizio di un cer to Boria che , a furia di dopp i giuochi, n o n sapeva più egli stesso da che par te era. In ques to guazzabugl io n a t u r a l m e n t e i n z u p p a v a n o tut t i : non soltanto gli agenti borbonici e inglesi, ma anche i diplo-
163
matici austr iaci , russi e quelli del R e g n o Italico di Milano che cercava un contatto con gl'Italici d i Napoli pe r un p ro g r a m m a di azione unitaria.
Di tu t to ques to , N a p o l e o n e e ra informat iss imo. La sua collera esplodeva in lettere fulminanti al cognato. U n a delle crisi p iù grosse scoppiò q u a n d o l ' Impera tore decise di r ipud iare Giusepp ina p e r i m p a l m a r e l 'austriaca Maria Luigia. Essa era la nipote di quella Carolina di Borbone, che Napoleone odiava a mor te , ma che con questo mat r imonio diventava ora sua zia. I napole tani , pe r i quali n o n c'è rag ion di Stato che t enga con t ro quel la d i famiglia, p e n s a r o n o che Napoleone volesse restituire Napoli ai Borbone, e a quanto p a r e lo t eme t t e a n c h e Mura t , che accorse a Parigi p e r le nozze. L'incontro fu tempestoso. L ' Imperatore minacciò addir i t tura il cognato di fargli tagliare la testa. Poi si riconciliò con lui e anzi, come pegno di benevolenza e b u o n a volontà, lo autorizzò a u n a spedizione contro la Sicilia pe r annet ter la al Reame.
To rna to a Napol i , M u r a t affidò l ' impresa al gene ra l e Grenier che, di qua t t ro divisioni, riuscì a sbarcarne nell'isola u n a sola; ma, attaccato dagl'inglesi, r ichiamò anche quella. Que l fiasco fu causa di nuovi e più gravi dissapori fra i d u e cognati . Napoleone rinfacciò a Gioacchino di aver mal p repa ra to la spedizione e di aver dato pubblicità al suo fallim e n t o . Gioacchino si convinse o si lasciò conv incere che Grenier si e ra ritirato su o rd ine segreto de l l ' Impera tore cui interessava soltanto tenere impegna te le forze inglesi in Sicilia. E n o n è da escludere che fosse p ropr io così.
Abi lmente sfrut tato dai suoi consiglieri «italici», ques to incidente lo spinse ad accentuare i suoi a t teggiamenti d'ind ipendenza . Già da t empo egli andava rafforzando l'esercito e molt ipl icandone gli effettivi. I 20 mila uomini lasciatigli in e red i tà da Giuseppe e r a n o diventat i 40 e ora si s tavano avviando ai 60 mila. Napoleone se ne al larmò. «Il deficit del vostro bilancio - scrisse al cogna to - è dovu to al man ten i m e n t o di u n a milizia sproporzionata ai vostri bisogni. Se vi
164
contentas te di quindic i o vent imila uomin i , sareste ricco.» Murat fece orecchio da mercante , e anzi volle da re a questo suo esercito u n a band ie ra che ne sottolineasse l ' indipendenza: un tricolore bianco, celeste e amaran to . Nell 'annunziar-lo a l l ' Imperatore , gli disse che il bianco voleva simboleggiare i legami di Napol i con l ' Impe ro e gli chiese il pe rmesso di accorrere a Parigi pe r la nascita del sospirato e rede .
Vi andò infatti nel marzo del 1811. Pare che nei colloqui a t uppe r tù si r ipetessero le scenate del p recedente incontro. Ma formalmente i r appor t i furono cordiali, anzi Napoleone pregò Carolina di tenere a battesimo il Re di Roma. Il fatto è che l ' Impera to re n o n voleva creare incidenti con Napoli , ora che gran par te delle sue forze e rano impegna te in Spagna e il resto aveva dovuto concentrar lo in Polonia pe r p re venire un attacco della Russia che , da alleata, s i stava trasformando nuovamen te in nemica. Probabi lmente si r iproponeva di regolare più tardi i conti con Murat , che in caso di gue r ra gli faceva comodo, anzi era insostituibile.
Tornato a Napoli con la certezza della p ropr ia intoccabi-lità, Gioacchino credet te di po te r assestare il colpo decisivo. Nel g iugno e m a n ò un decre to che ord inava a tutti gli stranieri che occupavano cariche civili di naturalizzarsi, pena la perdi ta del posto. Era chiaro che la misura era diret ta contro i francesi. Furiosi, essi si appe l l a rono a Napo leone che in tervenne con un contro-decreto brutale : «Tutti i cittadini francesi sono anche ci t tadini del Regno delle D u e Sicilie» diceva. Ma c'era anche di peggio: l 'esercito napo le tano veniva t ras formato in semplice «corpo di osservazione» agli ordini del generale Grenier, il quale li avrebbe presi direttamente da l l ' Impera tore . E il p r imo di questi ordini , segreto, era di occupa re , in caso di reaz ione da pa r t e di Mura t , la fortezza di Gaeta su cui s ' imperniava tutto il sistema difensivo settentrionale del Reame.
Come spesso gli accadeva fuori del campo di battaglia, il cuor-di- leone d iventò cuor di coniglio e scrisse al cogna to una lettera piagnucolosa: «Mi avete fatto quasi morire , avete
165
pe rdu to il vostro amico migliore, mai mi sarei aspettato un'azione così barbara da par te vostra...» Ma Maghella gli fornì il pretes to di u n a rivincita facendogli recapi tare delle let tere dalle quali risultava che il minis t ro francese della g u e r r a Daure , u n o dei p iù r inghiosi gua rd i an i d i Mura t , e ra l'amante della Regina. Gioacchino lo sapeva da un pezzo, e sapeva anche che Daure non era il solo ad aver goduto i favori di sua moglie, alta pa t rona del part i to francese. Ma finse di esserne sorpreso e indignato per liberarsi del l 'uno e met tere l'altra in castigo. Rientrato a Parigi, Daure sporse le sue contro-accuse al l ' Imperatore che frattanto aveva ricevuto anche u n a let tera di Carol ina . Fu r ibondo , Napo leone o r d i n ò a Grenier di occupare Gaeta, tolse le credenziali all'ambasciatore di Napoli, Campochiaro, convocò a Parigi Maghella e lo incriminò di fellonìa e intelligenza col nemico.
C o m e s e m p r e avveniva fra i coniugi Mura t , l ' interesse delia ditta f inì pe r prevalere sulle loro disarmonie. Rendendosi conto che la disgrazia del mari to era anche la disgrazia sua, Carolina corse dal fratello pe r p lacarne le ire. Ma, più che la sua sottile diplomazia , furono le circostanze ad aiutarla. La g u e r r a con la Russia appar iva o rmai inevitabile e imminen te . Per ba t tere quelle cosacche, le cavallerie napoleoniche avevano bisogno di Murat , che infatti fu richiamato alla loro testa nella pr imavera successiva (1812). La guerra, di cui d i r emo più tardi , fu dappr inc ip io la solita marcia trionfale del l 'armata francese. Ma q u a n d o a Napoli il cardinale Firrao celebrò un Te Deum, di r ingraz iamento per questi successi, Zur lo gli disse: «Mons ignore mio , anco ra un paio di queste vittorie, e Voi ed io siamo fottuti!»
A Napol i , M u r a t n o n si era limitato a fare la f ronda al cognato . Aveva anche spinto avanti le r i forme già iniziate da Giuseppe . Ques t i , a l m o m e n t o di pa r t i r e p e r a s sumere la corona di Spagna, sapeva che l 'unico sostegno del reg ime, oltre le baionette francesi, e ra la nuova borghesia di funzionar i , magistrat i , ufficiali, professionisti, intellettuali , divisi
166
da varie sfumature ideologiche, ma uniti da d u e ideali: l'unità nazionale e qualche forma di governo rappresentat ivo. N o n p o t e n d o , è ovvio, concedere la p r ima , concesse la seconda lasciando in eredi tà al suo successore un abbozzo di Cost i tuz ione che p r evedeva la convocazione di un par la mento .
Mura t r iprese con maggiore energia l 'opera r i formatr ice, e successi ne o t tenne . Le resistenze degl'interessi conservatori che fin allora e r a n o riusciti a r e n d e r e i nope ran t i le leggi contro la feudalità venne ro demolite. «Divise le te r re e suddivise, videsi n u m e r o infinito di nuovi possidenti, franca la p ropr ie tà dei già baroni e dei già vassalli; tut te le servitù disciolte» scrive Colletta, che fu par tecipe di quest 'azione, e qu ind i t e n d e v a a sopravvalu ta r la . In rea l tà i nuov i possidenti mos t r a rono un'ostinata reni tenza a moltiplicarsi, ciascuno aggrappandos i al suo ed esercitandovi i diritti di p ro pr ie ta r io con lo stesso egoismo e p r e p o t e n z a che avevano caratterizzato i «già baroni». Per quan to di estrazione cittadina, essi se rbavano u n a menta l i tà te r r ie ra , anche p e r c h é quasi esclusivamente in t e r r e invest ivano, in mancanza di attività industriali , mai decollate un po ' pe r scarsezza di capitali e molto pe r totale assenza di spirito imprendi tor ia le .
Mura t , c o m e Giuseppe , cons iderava ques ta classe borghese il puntel lo del regime, e aveva ragione. Ma commise, nei suoi confronti, d u e error i . Il p r imo fu di sopravvalutarne la forza, e si capisce perché : era questa classe che gli forniva funzionari e consiglieri , e che qu ind i esercitava su di lui la maggiore influenza. Il secondo fu quello di de luder la nelle sue aspirazioni a un governo rappresentat ivo. Salendo sul t rono , egli aveva definito «eccellente» lo Statuto abbozzato da Giuseppe . Ma lo aveva messo nel d iment ica toio , e questo dimostra la sua malaccortezza politica. Quello Statuto prevedeva un par lamento muni to di poter i soltanto consultivi e formato di «notabili» già perfe t tamente , come oggi si direbbe, integrati nel sistema e quindi facili da domina re e maneggiare . Gioacchino avrebbe potu to farsi forte del lo-
167
ro avallo nel l 'az ione che s i r i p r o m e t t e v a d ' i n t r a p r e n d e r e per affrancarsi dalla tutela della Francia e presentars i come un Re «nazionale». Ma da b u o n militare r ipugnava a qualsiasi decen t ramento di poteri : credeva che anche in politica tut to dipendesse soprat tut to dalla rapidità delle decisioni, la quale esige uni tà di comando .
Un'al t ra cosa che dovette t rar lo in inganno fu la sua popolarità. Egli scambiava pe r devozione alla sua persona e alla sua corona gli applausi che mieteva quando , nelle sue rutilanti un i formi , si mos t rava a cavallo alla testa delle sue t r u p p e in parata o q u a n d o si aggirava nei vicoli e si fermava a pa r la re con la gente . I suoi mod i di «guappo» piacevano molto a quei meridionali , e perfino in Calabria, la più ribelle di tu t te le sue p rov ince , lo avevano accolto con calore . N o n capiva che si t ra t tava di en tus iasmi di pel le , suscitati soltanto dalla sua prestanza e spavalderia.
Per rafforzare la p ropr i a posizione, egli cercò di at t i rare a sé anche quella frangia estremista di patrioti di formazione democra t ica e giacobina che aveva cominciato a raccogliersi nelle società segrete e specialmente nella Carboneria . Ufficialmente, ques ta e ra fuori legge. Di fatto Maghel la , lungi dal persegui tar la , teneva con essa stretti contatti cercando di at trarla nel giuoco del Re. Forse ci sarebbe riuscito, se M u r a t avesse concesso la sospirata Cost i tuzione. Ma anche d o p o l 'aper ta ro t tu ra provocata dall 'ost inazione del Re, Maghella m a n t e n n e i suoi buon i rappor t i coi Carbonari, così come li manteneva - a quanto pa re - anche coi Borb o n e di Pa lermo. Molto più accorto del suo p a d r o n e , egli comprendeva che la sorte del regime d ipendeva soltanto da u n a s i tuazione in te rnaz iona le che poteva cambia re da un m o m e n t o all 'altro. Il part i to italico su cui esso si appoggiava era quello di u n a borghesia asfittica, poli t icamente immatura, con pochissimo seguito in provincia e p u n t o nelle campagne , tu t tora pervase dai sent imenti sanfedisti e dall 'odio verso i «giacobini».
Mura t se ne sarebbe presto accorto a p ropr ie spese.
CAPITOLO DICIASSETTESIMO
LA C O S T I T U Z I O N E SICILIANA
Ment re Mura t a Napoli faceva la fronda a Napoleone , Maria Carolina da Palermo pre tendeva fargli la guer ra . Privato del pun te l lo di Acton o rma i def in i t ivamente in d i sa rmo e assorbito dalla sua fresca sposina, Ferd inando si e ra ritirato nella sua villa della Ficuzza, unicamente intento alla caccia, e il Principe Eredi tar io lo imitava dedicandosi alla pollicoltura nella sua tenuta di Boccadifalco. A pres iedere il Consiglio dei Ministri era lei, più egocentrica, p iù imperiosa, più intrigante, p iù declamatoria e più grafomane che mai. Scriveva a tutti, allo Zar, a suo nipote l ' Impera tore d'Austria, ai ministr i e d iplomat ic i inglesi, e s o r t a n d o , c o n d a n n a n d o , p r o p o n e n d o alleanze e piani di g u e r r a u n o più assurdo dell'altro. Q u a n d o nel 1809 l'Austria r i tentò la carta contro Napoleone impegnato dalla rivolta spagnola, essa riuscì a persuadere gl'inglesi a t r a spor t a re con le loro navi un contingente di t r u p p e a Napoli, convinta che alla loro vista la città sarebbe insor ta con t ro Mura t . I napo le t an i s a lu t a rono la flottiglia dai loro balconi, e n o n si mossero. Anzi, accorsero in Via Chiaia pe r acclamare l 'altra Carol ina che passava in carrozza. Gl'inglesi occuparono Ischia e Procida, vi lasciarono dei distaccamenti e si r i t i rarono.
A questa delusione ne seguì un'al tra. Ferd inando diede il consenso al m a t r i m o n i o della f iglia Amalia col Duca d 'Orléans, figlio del famoso Luigi Filippo Egalité, considerato il t radi tore di casa Borbone perché aveva simpatizzato coi rivoluzionari che avevano tagliato la testa al Re. «La disobbediente Amalia - scrisse Maria Carolina - ha sposato il Duca d 'Orléans (nome terribile!), e io posso soltanto sospirare
169
e sot tomet termi . Non h a n n o mezzi pe r vivere...» Que l mat r imon io da lei avversato , che d u r ò senza nub i p e r ol t re q u a r a n t ' a n n i e condusse Amalia sul t r o n o di Francia, fu il più felice tra quelli delle sue figliuole.
Ma il colmo per lei doveva ancora venire e lo toccò quando da Vienna giunse notizia delle prossime nozze di Napoleone con sua nipote Maria Luigia. Ecco cosa le toccava: diventare zia del «brigante còrso» che l'aveva cacciata dal t rono! «Ho det to addio per sempre alla te r ra dove sono nata e che ho t e n e r a m e n t e amato . Tra tutt i gli eventi terribili che mi minacciano, speravo di t rovare là un rifugio sicuro dove mor i re in pace, ma è finita anche questa speranza...»
C'è tuttavia da credere che quella parente la le dispiacesse m e n o di quan to mostrava perché in quel momen to , nella gerarchia dei suoi odi, al p r imo posto n o n c'era più il «brigan t e còrso», ma i l gene ra l e Bent inck, che c o m a n d a v a i l cont ingente inglese in Sicilia, circa 17 mila uomini , e quindi era i l vero p a d r o n e dell'isola. Bentinck era un u o m o d' idee radicali, complicate da un cattivo carat tere. In India, dov'era stato governatore , aveva vietato ai suoi soldati di po r t a re i segni di casta, p r o v o c a n d o n e l ' ammut inamen to . S'era rifatto a r ruo landos i con gli spagnoli in rivolta cont ro Napoleone e guadagnandos i i galloni di Generale . Nei suoi ideali democratici portava un imperioso a rdore , che lo rendeva di difficile maneggio.
La situazione che trovò a Palermo, q u a n d o venne ad assumervi il comando , era fra le più ingarbugl iate . Gl'inglesi avevano b u o n i motivi d i scontentezza nei confront i del la Cor te . I l sussidio ch'essi le passavano p e r c h é provvedesse alla difesa dell'isola contro i francesi, si pe rdeva pe r mille rivoli come sempre avviene in Sicilia e n o n produceva neanche un r e g g i m e n t o . I l Re n o n aveva band i to n e m m e n o la coscrizione, t rovando molto più comodo farsi difendere dalle forze terrestr i e navali br i tanniche.
Economicamente , l'isola attraversava un m o m e n t o di relativa p rospe r i t à . Gl ' inglesi e r a n o b u o n i clienti: n o n solo
170
compravano sul posto de r r a t e al imentari , ma vi sollecitavano la nascita d ' indus t r ie po r t andov i i loro capitali e il loro spirito imprendi tor ia le . Fu in questo per iodo che le zolfare si molt ipl icarono e nacquero i cantieri O r l a n d o . Ma questa r ianimazione rendeva ancora p iù u rgen te u n a revisione d i tut to il sistema fiscale, tu t tora inceppato dai privilegi baronali: i l p r o b l e m a che il Caracciolo aveva invano ten ta to di risolvere tornava a galla.
Come il lettore r icorderà, la competenza in questa materia e r a r iservata a l Pa r l amento , un p a r l a m e n t o ch ' e ra tale solo p e r m o d o di d i re . Diviso in t re C a m e r e come quel lo francese di p r ima della rivoluzione, esso era comple tamente d o m i n a t o dalle p r i m e d u e , quel la dei nobili o ba ron i , e quella del clero, contro cui la terza, quella delle città «demaniali», cioè sottratte alla giurisdizione di qualche feudatario, non poteva nulla, e con essa qu ind i n o n po tevano nul la le classi medie che in maggioranza la componevano .
La Regina, che seguitava a governare nella totale assenza del Re, aveva bisogno di soldi p e r finanziare le sue assurde imprese di riconquista. Si rivolse a Medici, che stavolta aveva segui to i suoi Sovrani a Pa le rmo , e Medici si rivolse al Pa r l amen to c e r c a n d o d i d iv idere la C a m e r a del clero da quella dei baroni con promesse di esenzione pe r i beni della Chiesa. Ma i baroni con t ra rono la mossa facendo al clero altre e più sostanziose promesse. Sicché q u a n d o l'assemblea si r iunì ai p r imi del 1810, si r i fo rmò con t ro le p re t e se della Corte il solito fronte clerico-baronale, guida to dai Principi di Castelnuovo e di Belmonte , che fra l'altro e rano zio e nipote. Esso dimezzò il contr ibuto richiesto dal governo e accettò solo l ' imposizione di u n a tassa del 5 pe r cento su tutti i beni mobili, che q u i n d i n o n colpiva le i m m e n s e p r o p r i e t à terr iere della nobiltà e della Chiesa.
Abi lmente sfrut tata dalla p r o p a g a n d a , ques ta vit toria inorgoglì tut ta la Sicilia, che credet te di vedervi un'affermazione della p ropr i a ind ipendenza . In realtà n o n aveva fatto che r ibadire i poter i e i privilegi dei ba ron i e del clero che,
171
dietro lo schermo del l ' indipendent ismo siciliano, seguitavano a far r icadere tut to il peso fiscale sulle altre classi. Secondo i calcoli di Mack-Smith, i baroni pagavano annua lmen te 35 mila scudi, il clero 31 mila e il resto povero della popolazione oltre 400 mila. Ma i siciliani n o n lo sapevano. Vedevano soltanto che i loro baroni davano scacco mat to al governo del Re napoletano, e ciò bastava a r iempirl i di fierezza.
A smontare il meccanismo di questa omer tà n o n era riuscito Caracciolo. Figuriamoci se poteva riuscirvi Maria Caro l ina che , col suo solito pass ionale egocen t r i smo , in terpre tò l 'opposizione pa r lamenta re come un affronto alla Corona e a lei stessa, fo rnendo così alla pubblica opinione validi motivi p e r v e d e r e in quel la d ia t r iba un con t ras to fra i l po tere centrale e l 'autonomia siciliana. Essa diede di «giacobini» ai baroni , di «usurpazione» al loro rifiuto, e suo genero D'Orléans , che aveva un certo b u o n senso, dovette mettercela tutta pe r persuader la che il ricorso alla forza n o n solo e ra impossibile p e r c h é l 'unica forza del gove rno e r a n o gl'inglesi che mai si sarebbero messi al servizio di quella causa, ma sarebbe anche stata con t roproducen te . Su suo consiglio, a lcune alte cariche furono affidate a ba ron i siciliani, e ques to bastò ad a m m o r b i d i r n e la resistenza. Si consent ì al Re d ' impor re una tassa sulle vendite che, pe r quan to modesta, infrangeva l'esclusiva pa r l amen ta re in mater ia d ' imposte, e su ques to p u n t o si r u p p e il f ronte de l l 'oppos iz ione . Qua lcuno dice che Belmonte si ribellò pe rché dalle cariche e ra r imasto escluso, ma ne m a n c a n o le p rove . C o m u n q u e , la sua reazione fu da siciliano vero, cioè abnorme . Si rivolse s eg re t amen te agl ' inglesi d icendosi p r o n t o a convocare un al t ro p a r l a m e n t o a Messina e a fargli p r o c l a m a r e Re qualsiasi pr incipe, anche protes tante , L o n d r a designasse al t rono di Sicilia.
Il Re ne fu subi to in fo rmato e, sotto le solite p ressan t i sollecitazioni della Regina, fece a r res ta re e depo r t a r e in varie isole Belmonte , suo zio Castelnuovo e altri t re influenti ba ron i . I nvano l 'Orléans cercò di oppo r s i a quel gesto av-
172
ventato . Maria Carol ina disse a sua figlia: «Poiché ho commesso la pazzia di p r e n d e r l o pe r genero , devo soppor tar lo , ma deve r ende r s i conto che l 'autori tà legit t ima vince sempre». Sembrava che fosse p rop r io così. Privata dei suoi capi e in t imid i ta da l l ' e sempio , l ' oppos iz ione b a r o n a l e vacillò. Ma p r o p r i o in quel m o m e n t o a r i a n i m a r l a s o p r a v v e n n e Bentinck.
Il manda to che aveva ricevuto dal suo governo era anche politico. Allarmata dalla totale inefficienza del regime di Palermo e dal malcontento che regnava nell'isola, L o n d r a credeva che a r imediarvi bastasse qualche istituto rappresentativo che desse ai siciliani «una giusta partecipazione al potere» e che il Pa r l amen to dovesse a p p u n t o servire a ques to . Era logico che gl'inglesi lo credessero pe rché così era avven u t o in Inghi l te r ra . Il loro e r r o r e - del resto comprensibile - e ra di at tr ibuire al Par lamento siciliano le stesse finalità che aveva persegui to quello inglese, men t r e esso non era in realtà che il ba luardo dei privilegi feudali. Ma ad aggravare l 'equivoco c'era anche il fatto che questi privilegi feudali il governo borbonico n o n voleva eliminarli o r idurl i pe r istaura re u n a maggiore giustizia sociale, ma solo pe r a l imentare i p r o p r i sciali, soprusi e capricci. Lo scontro era quindi fra d u e antagonist i en t rambi prevaricatori ed en t r ambi in malafede. O g n u n o di essi si batteva pe r i p rop r i esclusivi interessi. Ma era logico che l'occhio del radicale Bentinck fosse colpito soprat tut to dalle inadempienze della Corte.
Avendo capito che i l Re c 'era solo p e r figura, egli a n d ò subito dalla Regina e le t enne tale l inguaggio ch'essa lo definì «un insolente caporale». Fra i d u e cominciò un duel lo senza esclusione di colpi. O ra ch 'era diventata sua zia, pa re che Mar ia Carol ina iniziasse un negozia to sotto banco anche con N a p o l e o n e , i l qua le le d i ede spago p e r t e n e r e in briglia Mura t , che a: sua volta denunz iava queste manovre agl'inglesi. La tensione e ra tale che la Regina fu colpita da un attacco apoplettico, ma se ne r iprese con disperata energia. Era convinta che gl'inglesi volessero servirsi del Parla-
173
mento pe r rovesciare la monarchia e annet ters i l'isola, e di questo cercò di convincere anche il Re.
Fe rd inando ne fu più annoia to che al larmato: non voleva seccature specie o ra che , ol t re alla caccia, aveva trovato anch e un al t ro piacevole pas sa t empo : la c o m p a g n i a del la Principessa di Par tanna. Ma come al solito si lasciò travolgere dalle frenesìe del la mogl ie e si rifiutò di r icevere Ben-tinck. Costui si rivolse al pr incipe eredi tar io Francesco, e gli pa rve di t rova re in lui un in t e r locu to re rag ionevole e di b u o n senso. In realtà il pr incipe era un burocra te pignolo e abi tudinar io, pedan tescamente attaccato al part icolare, che «si p e r d e nelle piccole cose e n o n vede le grandi» come diceva Ascoli, e cercava di evadere le responsabilità. Ma tale lo aveva reso sua m a d r e te r ror izzandolo . Anche stavolta essa cercò d' intimidirlo tacciandolo di «ribelle» perché si era mostrato accomodante con Bentinck. Ma questi n o n gliene dette i l t e m p o . Ai p r imi di genna io del 1812 o r d i n ò alle sue t r u p p e di marciare su Palermo e int imò al Re di delegare il po tere al Principe in qualità di Vicario sotto minaccia di depor taz ione di tu t ta la famiglia reale a Malta e d ' is t i tuzione di u n a reggenza affidata al l 'Orléans. Maria Carol ina gr idò al t rad imento e invocò la resistenza a oltranza. Ferd inando, più ragionevole di lei e in fondo contento di essere esentato da tutti quei fastidi, si rassegnò.
Le pr ime misure del Vicario furono il r ichiamo dei baroni depor ta t i , la n o m i n a di Be lmon te agli Affari Esteri e di Cas te lnuovo alle F inanze , e la revoca del la tassa impos ta senza il consenso del Par lamento . Dopodiché fu nomina to un comitato di giuristi, p res ieduto dall 'abate Balsamo, pe r redigere un testo di Costituzione. Secondo alcuni storici, fra cui Haro ld Acton, fu Bentinck a volerlo ricalcato sul modello inglese. Secondo Mack-Smith invece il Generale , il quale o rma i agiva da proconsole in t e r r a di conquista , fece p r e senti a Balsamo i pericoli di un simile t rapianto in un contesto sociale così diverso da quello br i tannico e molto più arcaico. Per il modello inglese si p ronunc iò invece cer tamente
174
i l Re, cons iderandolo n o n il meglio ma il m e n o peggio pe r gl'interessi suoi e della dinastia. Egli odiava la Costituzione, si r i p r o m e t t e v a di abolir la e sperava che il suo complesso meccanismo contribuisse al suo discredito r e n d e n d o l a inope ran te . Il calcolo si rivelò abbastanza fondato.
Un ' au ra di entusiasmo pervadeva i l Par lamento q u a n d o si r iun ì pe r la discussione e l 'approvazione di quello Statuto, nell 'estate del '12. Sulla carta, esso rappresentava la fine del reg ime feudale. I «bracci» da t re e rano ridotti a d u e che si chiamavano, come in Inghi l ter ra , dei Pari e dei Comuni . La Sicilia e ra p roc l ama ta R e g n o i n d i p e n d e n t e : i l Re n o n po teva lasciarla senza il consenso del p a r l a m e n t o , e se un g iorno fosse tornato a Napoli avrebbe dovuto affidare il t rono dell ' isola a l f ig l io p r i m o g e n i t o . Tut t i e r a n o ugua l i d i fronte alla legge e nessuno poteva essere imprigionato senza regolare processo. La to r tu ra e ra abolita e la censura limitata alle questioni religiose.
Ancora p iù impor t an t e fu l 'abrogazione di tut t i quegl ' i -stituti su cui si basava l ' impalcatura feudale della società siciliana. Questa dichiarazione di pr incipio fu letta fra le general i ovazioni, comprese quelle dei ba ron i che avrebbero dovuto farne le spese. Ma q u a n d o si cominciò a discuterne l 'applicazione ai casi concret i , ci si accorse che il feudalesimo o g n u n o lo vedeva a m o d o suo e aveva un ' idea sua p ro pria di cosa in realtà dovesse essere abolito e come lo si dovesse abolire.
La battaglia più grossa s ' imperniò sul fedecommesso che fin allora aveva fatto obbligo al testatore di lasciare la p r o pr ie tà indivisa a un unico successore, pe rché era su questo diritto di «maggiorasco» che si reggeva tutta la s t ru t tura feudale. Q u i i l f ronte dei ba ron i , che d o m i n a v a n o la C a m e r a dei Pari, s i r u p p e perché Castelnuovo, n o n avendo f igl i , e ra per l 'abolizione, cioè pe r la libertà di r ipar t i re il pa t r imonio fra più eredi , m e n t r e Belmonte che, come suo p r imo nipote, e ra designato alla sua cospicua eredità, voleva la conferma della indivisibilità, cioè del fedecommesso.
175
y
Non fu il solo p u n t o su cui non si riuscì a t rovare l'accordo , pe r il semplice motivo che mancava quello di base. Alcuni baroni e rano per la resistenza indiscriminata e la difesa di tut t i i privilegi, anche i p iù retr ivi , come l 'esenzione totale dai t r ibut i e il m a n t e n i m e n t o della p r o p r i a giurisdizione nei rispettivi feudi. Ma anche quelli che con maggiore accortezza si most ravano disposti ad abbandona r e queste t r incee del p iù ot tuso conservator ismo, in real tà mi ravano n o n a l iqu idare , ma solo a r i d imens iona re il feudales imo, salvandone l'essenziale e anzi punte l landolo . Facendosi come al solito s c h e r m o del la pa ro l a «libertà», essi vo levano soltanto rafforzare la p ropr i a nei confronti del po te re centrale, cioè del Re. Quella delle plebi, in s t ragrande maggioranza contadini , restava p u r a m e n t e platonica pe rché , n o n avendo essi p rop r i mezzi di sussistenza, tut ta la loro libertà consisteva al massimo nel cambiare p a d r o n e . Insomma, era u n a r ivoluzione t i p i camen te i tal iana, cioè che s i esaur iva nei nomi . Nel pa r l amen to siciliano si faceva un g ran scialo di parole inglesi: le leggi si chiamavano bills, il bilancio budget e ad ogni passo s'invocava Yhabeas corpus. Ma al r ipa ro di ques ta t e rmino log ia , d i r i fo rme sostanziali , come quel la agraria, non se ne varò una , e il risultato fu u n a r iconferma degli assoluti e intangibili dirit t i del p rop r i e t a r i o n o n soltanto sul suolo, ma anche sul sottosuolo, che p rop r io allora d iven tava impor t an t i s s imo p e r l a famelica d o m a n d a d i zolfo sul mercato mondiale . Alcuni propr ie ta r i come i Lampedusa ci fecero degli affari che compensavano la rgamente la r inunzia alla giurisdizione sul «feudo», il quale in sostanza tale restava.
Ques to imbroglio fu favorito dalla inesperienza e pastic-cioneria di chi cercava di avversarlo, cioè della Camera dei Comuni , in terpre te delle esigenze dei ceti medi , sopra t tu t to delle province orientali . Essa era guidata da d u e ex-fuorusciti vissuti en t rambi in Francia, dove si e r ano intrisi di giacobinismo: Vaccare e Rossi, det to «il Mirabeau della Sicilia». Invece di appoggia re il r i formismo realistico, anche se mo-
176
dera to , di Castelnuovo, col loro astratto e demagogico massimalismo - dest inato a res tare la dannaz ione delle sinistre italiane -, favorirono soltanto il subdolo giuoco dei Pari, intesi a svuotare la Costituzione di ogni contenuto economico e sociale. Come i loro predecessor i della Repubblica Partenopea , essi par lavano delle masse popolar i come se le avessero avute d ie t ro di loro , m e n t r e queste e r a n o in piazza a t umul tua re cont ro il Par lamento , cui addebi tavano la carestia di p a n e che le aveva colpi te , e Be lmon te dove t te fare appello alle t r u p p e inglesi pe r r iprist inare l 'ordine.
Il Re si fregava le mani . Egli aveva accettato la Costituzione perché Bentinck gliel'aveva imposta e pe rché essa gli assegnava una «lista civile» che, con g rande scandalo del Generale inglese, ammontava alla metà del reddi to nazionale. Ma la Regina n o n si contentava di questo e seguitava a trescare, t an to che Bent inck a un cer to p u n t o chiese al Re di a l lontanar la come pe r tu rba t r i ce de l l ' o rd ine pubbl ico. «La figlia di Maria Teresa p u ò essere oppressa e calunniata, non disonorata!» essa rispose nel suo melodrammat ico tono. Ma di lì a poco, q u a n d o il Principe Vicario cadde vittima di un malanno che lo r idusse in fin di vita e presentava tutti i sintomi di un ' intossicazione, la voce pubbl ica accusò sua mad r e di averlo avvelenato ed egli stesso ne ebbe i l sospet to. Bent inck, ci c redesse o n o n ci credesse , ne approf i t tò pe r rei terare in termini ultimativi la sua richiesta, e Ferd inando dove t te rassegnars i a esiliare la moglie a S. Margher i t a in quel di Girgenti , con l ' impegno che nella successiva pr imavera essa sarebbe part i ta pe r Vienna.
Invece di tenersi finalmente tranquilla, la turbolenta donna tornò segretamente da lui pe r indur lo a revocare il Vicariato, a r ip rendere in mano il potere e ad annul lare la Costituz ione . Bent inck, q u a n d o lo seppe - e lo seppe subito -, perse le staffe. Della Costituzione, anche lui era deluso: «Da q u a n d o è e n t r a t a in v igore - scriveva -, n o n si è e m a n a t a una legge che si sia conformata alle sue regole», e aveva finito pe r da r ragione a Balsamo q u a n d o diceva che la libertà
177
nelle man i dei siciliani era «come u n a pistola nelle mani di un b imbo o di un pazzo». Ma a l m e n o su u n a cosa n o n intendeva to rna re indietro: nella r iduzione dei poteri del Re. Q u a n d o seppe che questi, come al solito succubo di sua moglie, e ra to rna to a Pa lermo pe r d isarc ionare il figlio, lo affrontò di persona e lo costrinse a r inunciare al proget to e a firmare u n a lettera con cui ingiungeva alla Regina di part ire , «consigliando ciò come amico, chiedendolo come mari to e o rd inando lo come Re».
Come al solito Maria Carol ina si r icordò di essere figlia di Maria Teresa e si sfogò in let tere degne di un personaggio di Racine. Ne scrisse a tutti, anche a Bentinck. «Fu forse pe r subire questo t ra t tamento che sfuggii alla scure, alle cospirazioni , ai t r ad imen t i dei giacobini napole tan i? Fu p e r questo che aiutai Nelson a vincere la battaglia del Nilo? Per ques to che por t a i il vostro eserci to in Sicilia? Gene ra l e , è questo il vostro o n o r e inglese?» Partì in maggio e impiegò ot to mesi p e r r agg iunge re Vienna, dove se n 'escogi tarono di tut te pe r r i t a rdare il suo arrivo. Q u a n d o vi giunse, il Primo Ministro Metternich la confinò a sei miglia dalla Corte , col divieto di recarvisi. «Vi a n d r ò ugua lmente - ella disse -: vedremo se ne scacceranno l 'ultima figlia di Maria Teresa.» N o n la scacciarono. E fu, fra t an te amarezze , l 'unica sua consolazione.
, Pochi mesi dopo , morì .
A Pa le rmo, il g iuoco con t inuava se r ra to nella paralisi de i pubblici poter i . Bentinck, impress ionato dal massimalismo parolaio dei Comuni , cercò di r ipor ta re la concordia almeno fra i Pari r iconci l iando Be lmonte con Caste lnuovo, ma n o n c i r iuscì . Fu forse p e r ques to che chiese un c o m a n d o militare ih Spagna. L'ottenne, ma n o n vi guadagnò molti allori e ci r imase poco. L o n d r a lo rivolle a Palermo, dove la situazione n o n faceva che deteriorarsi . Belmonte p ropose add i r i t t u r a che , p e r r imet te rv i o r d i n e , l ' I n g h i l t e r r a facesse della Sicilia un suo prote t tora to , e Bentinck non respìnse l'i-
178
dea. Ma da L o n d r a r isposero che, come fonte di guai, l ' I rlanda gli bastava, e che l 'unico interesse inglese in Sicilia era strategico e quindi sarebbe finito con la guer ra , cioè con Napo l eone . Nel P a r l a m e n t o n o n si r iusciva a fo rmare u n a maggioranza su nulla, il governo si dimise, quello che prese il suo posto era formato di uomini la cui età media superava i 75 anni , e i conservator i prof i t ta rono di tu t to ques to pe r abbozzare u n a manovra intesa a restituire al Re tutti i poteri, compreso quello di abolire la Costituzione.
Di fronte a ques ta minaccia, Bent inck assunse il m a n t o del d i t ta tore , sciolse governo e p a r l a m e n t o , indisse nuove elezioni e vi par tecipò di pe rsona raccogliendo tali ovazioni dovunque si presentava che ricominciò ad accarezzare il sogno di u n a Sicilia r i do t t a a suo p roconso la to in n o m e di S.M. Britannica. Per sua for tuna la gue r ra che ormai divampava in Eu ropa dopo la catastrofe di Napoleone in Russia lo richiamò ad altre mansioni . Ma il seguito di questa vicenda lo ved remo dopo .
A Pa le rmo il suo pos to e r a stato p reso dal d ip lomat ico A Court , che nei suoi r appor t i a L o n d r a fece della situazione u n a disamina molto obbiettiva. In Sicilia, scrisse pressappoco, un g o v e r n o cost i tuzionale p u ò reggers i solo su u n a forza esterna, pe rché di sue non ne ha. L'analfabetismo n o n consente la nascita di u n a pubblica opinione che possa esercitare il suo peso. «Abituati all 'obbedienza passiva, i siciliani si aspet tano che a far pe r loro siano gli altri», e nel caso specifico gl'inglesi. Se costoro, invece di appoggia re «una cosa poco adatta al Paese come la Costituzione», avessero appoggiato delle riforme spicciole come l 'uguaglianza di fronte alla legge e u n a p iù equa r ipart izione fiscale, avrebbero fatto molto meglio. Ora , bisognava scegliere: seguitare a difendere la Costi tuzione significava assumere in qualche m o d o il governo dell 'isola. Disinteressarsene, significava abbando narla nelle mani di un Re che n o n vedeva l'ora di revocarla. Q u a n t o a l l ' indipendenza della Sicilia da Napoli , questo sarebbe equivalso ad abbandona re l'isola alla mercé di u n a ca-
179
sta ba rona l e ancora più sa t rapesca e re t r iva dei B o r b o n e . Per i siciliani, concludeva A' Court , la Costituzione è soltanto un balocco, un pretes to di vuota logomachia, in cui n o n si sa se sia più spregevole il dopp io giuoco dei reazionari o la demagogia dei radicali. I siciliani h a n n o capito che la liber tà è solo la libertà dei baroni di cont inuare a oppr imer l i . Perciò, sotto sotto, e p u r d i ss imulandolo , essi d e s i d e r a n o u n a res tauraz ione dei poter i del Re, i l quale ce r t amen te l i userà p e r i m p o r r e u n a «tirannia esosa», ma s e m p r e m e n o esosa di quella dei baroni .
Ma a ques to p u n t o b isogna far pausa p e r r i p r e n d e r e i l corso degli avvenimenti internazionali , di cui quelli italiani n o n e rano che un riflesso.
CAPITOLO DICIOTTESIMO
LA CATASTROFE
Verso la fine del 1812, il vocabolario degl'italiani si arricchì di nuove e strane parole, ch 'e rano soprat tut to nomi di città e di fiumi: Vilna, Kovno, Smolensk, la Vistola, Borodino , il Niemen. Abituato ad aspet tare che altri decidesse la sua sorte, il popol ino n o n aveva mai seguito con molto interesse le avven tu re g u e r r i e r e di N a p o l e o n e . Ma stavolta, sotto le bandie re de l l ' Impera tore , c 'erano anche gl'italiani: 30 mila l omba rd i sotto i l c o m a n d o del viceré Eugen io , e o t tomila napoletani sotto il comando di Murat . Le notizie sembravano a r r ivare da un al tro m o n d o , t an to r e m o t o e ra i l t ea t ro degli avvenimenti . Ma da una lettera di Eugenio a sua moglie, a Milano si r iseppe che in un certo paese dalla p r o n u n cia impossibile, Malojaroslawetz o qualcosa del gene re , 17 mila italiani guidat i dal genera le Pino avevano re t to vittor iosamente il confronto contro 60 mila russi, tanto da meritarsi la citazione al l 'ordine del giorno.
Di singoli italiani dotati di virtù militari, ce n ' e rano sempre stati, anzi era l'Italia che aveva fornito alla Spagna e all'Austria i loro d u e più g rand i generali : Alessandro Farnese ed Eugenio di Savoia. Ma era la p r ima volta che si sentiva di un reparto italiano che si copriva di gloria sotto bandiera italiana. E per quanto scarsi fossero nel nostro Paese l'orgoglio e gli en tus iasmi mil i tari , la gen te si appass ionò a quegl i eventi e ne at tese con impaz ienza i r educ i p e r farseli raccontare.
Di reduc i ce ne furono pochi, a p p e n a un migliaio. Altri to rnarono alla spicciolata d o p o mesi, e qualcuno dopo anni , distrutti nel fisico e nel mora le . Ma di ol tre 25 mila n o n si
181
ebbe più nessuna notizia. I sopravvissuti par lavano con gli occhi sbarrati di u n a marcia senza fine in solitudini senza fine , coper te da un man to di neve in cui le gambe sprofondavano, di mort i e moren t i lasciati pe r strada. Così era termina ta la c a m p a g n a di Russia, con cui N a p o l e o n e aveva sognato di diventare il Car lomagno della nuova Europa , e che invece lo aveva condot to alla catastrofe.
Riepiloghiamone il filo.
Nel 1810 egli aveva b u o n i motivi di c reders i a l r i p a r o da qualsiasi sorpresa. A combatterlo, perseverava solo l 'Inghilterra , r imasta da sempre in gue r ra con lui, salvo l'armistizio di Amiens du ra to a p p e n a tredici mesi fra il 1802 e il 1803. Ma era una g u e r r a che n o n si combatteva pe rché gl'inglesi po tevano farla solo sul m a r e , dove invece N a p o l e o n e n o n poteva farla d o p o l ' annientamento della sua flotta a Trafal-gar da pa r t e di Nelson (1805). Gl'inglesi cercavano di mettere in crisi la Francia e i suoi satelliti i m p e d e n d o n e il commercio mari t t imo. Napoleone r ispondeva col «blocco continentale», cioè c h i u d e n d o i por t i alle navi inglesi. Sebbene recasse gravi dann i all 'economia di en t rambi i contendent i , ques ta s i tuazione avrebbe p o t u t o c o n t i n u a r e all ' infinito. L'Inghilterra n o n poteva risolverla che a n n o d a n d o alleanze con potenze in g rado di attaccare Napoleone anche coi loro eserciti. A ques to aveva s e m p r e teso la sua diplomazia , instancabile suscitatrice di «coalizioni» antifrancesi.
Ma o rma i sembrava che ques to giuoco n o n potesse più riuscirle. Di po tenze infatti in g r a d o di sfidare Napo leone ce n 'e rano d u e sole: la Russia e l'Austria, e di en t rambe egli si e ra g u a d a g n a t a l 'amicizia. Nel 1807 si e ra i ncon t r a to a Tilsit con lo Zar Alessandro, e aveva stabilito con lui una pace, che fin allora aveva funzionato abbastanza bene e pareva fornire garanzie anche pe r i l futuro. Q u a n t o all'Austria, dopo averla pe r l 'ennesima volta bat tuta a Wagram nel 1809, Napo leone se n 'e ra assicurata la benevolenza con un legame dinastico sposando la f igl ia del suo I m p e r a t o r e , Maria
182
Luigia. Queste parente le t ra famiglie regnant i in realtà contavano m e n o di quan to pensasse e sperasse Napoleone . Ma contavano. Sicché q u a n d o nel 1811 Maria Luigia gli det te il sospirato e rede , che fu subito insignito del titolo di «Re di Roma», N a p o l e o n e c rede t t e d i aver f ina lmente da to u n a stabile base al suo I m p e r o e di poter lo t rasmettere al legittimo successore: mescolato con quello Asburgo, il «sangue di Napoleone», come lui lo chiamava con orgoglio, avrebbe regnato su mezza Europa .
Ma fu p r o p r i o in quel m o m e n t o che l ' accordo di Tilsit en t rò in crisi. Non è qui il caso di analizzare i complicati motivi che ne provocarono l ' incrinatura. Quello fondamentale è che en t rambi i contraent i lo avevano stipulato in mala fede, diffidando l 'uno dell 'altro e in attesa di u n a b u o n a occasione p e r rego la re i conti . Per lo Zar quest 'occasione fu la raggiunta pace con l ' Impero Turco che finalmente lo liberava da un nemico insidioso, coraggioso e ostinato. Egli r iaprì i po r t i al commerc io inglese e impose forti dazi alle merc i francesi, cioè fece il con t ra r io di ciò che aveva p romesso a Tilsit. E Napoleone , che dal canto suo aveva r idot to il Granducato di Varsavia a base militare, decise la «spedizione punitiva».
Quella che nel g iugno del 1812 iniziò la lunga marcia nel cuore della Russia, si chiamava «Grande Armata», e lo era: quasi 800 mila uomini delle più diverse nazionalità. I tecnici dicono che fu p ropr io la sua imponenza a fare la sua impotenza di fronte alla strategia russa, basata su rapidi sganciamenti e r i t i rate . Sta di fatto che pe r t rovare un esercito schierato in quel l 'ordine di battaglia in cui era un insuperato maes t ro , N a p o l e o n e dove t te a r r iva re fino a Mosca, e n e m m e n o lì riuscì a r ipor ta re una vittoria definitiva. Sebbene ba t tu to , il nemico riuscì a sfuggire alla sua manovra aggirante, men t r e la città, quasi tutta di legno, finiva in un immenso r o g o e i p r imi f reddi cominc iavano a m o r d e r e la t r u p p a s t remata da que l l ' in te rminabi le cavalcata. Per cinque sett imane, Napoleone attese dei plenipotenziari con of-
183
ferte di pace . E forse fu ques to il suo p iù t ragico sbaglio. Q u a n d o diede il via alla ritirata, già la neve ricopriva come un funebre sudario quegl ' immensi spazi, e il nemico riorganizzato tornava alla controffensiva con le sue cavallerie.
Q u a n t i ne m o r i r o n o ? Impossibi le d i r lo . Ma sta di fatto che l 'unico r e p a r t o organico che riuscì a r i a t t r ave r sa re il confine polacco fu quello delle Guard ie al comando di Ney. Napoleone aveva affidato il comando sup remo a Mura t pe r accorrere a Parigi dove alcuni congiurat i , dandolo pe r morto, avevano tentato un colpo di Stato e pe r poco non c'erano riusciti. Con la sua sovrumana energia e a mezzo di misure spietate raccolse un altro esercito pe r farsi incontro ai russi cui ora si e r ano uniti anche i prussiani. Bisognava batterli pe r p r even i r e un in te rven to dell 'Austria, i l cui a t tegg iamento , m a l g r a d o i legami dinastici, stava r i d iven t ando incer to . Ma incer to fu anche l'esito delle d u e p r i m e battaglie. Seguì un armistizio che si sarebbe anche po tu to t r adur re in u n a pace, se Napoleone si fosse indot to a qualche concessione. Ma ne e ra incapace , e ques to fornì all 'Austria il pretesto pe r scendere in campo contro di lui. Dresda fu l'ultima vittoria del g r ande condott iero. A Lipsia, d u e mesi dopo , il suo raccogliticcio esercito, p iù che essere disfatto, si disfece, e l 'esausta Francia n o n era più in g rado di fornirne un altro.
Ment re gli Alleati cominciavano a invaderla, il Parlamento chiedeva la pace, cioè la resa. Se Napoleone ne avesse accolto l ' invito r i n u n z i a n d o a tu t t e le sue conquis te , forse avrebbe po tu to conservare il t rono . Invece sconfessò i parlamentar i tacciandoli di fellonìa, riuscì a raccogliere qualche migliaio di uomini , e tra il febbraio e il marzo 1814 inflisse ancora gravi pe rd i t e agli invasori , ma senza r iuscire a fermarl i . Essi e n t r a r o n o a Parigi, e v ' i s taurarono un governo provvisorio con cui in tavola rono negoziat i d i pace . N a p o leone era ancora col suo quar t ier generale a Fontainebleau, a pochi ch i lometr i dalla capi ta le . N o n voleva a r r e n d e r s i . Consultò i suoi marescialli che a lui dovevano tut to: carrie-
184
ra, gloria, titoli, onori . Ma il loro rifiuto di r i p r ende re le armi n o n era un t rad imento , anche se tale a lui parve; era solo u n a constatazione d ' impotenza.
Il 6 apri le abdicò. Ma pe r il comodo del let tore, seguiam o n e ancora la vicenda. I suoi riflessi sull'Italia li ved remo dopo .
Pr ima ancora che i vincitori decidessero il da farsi, r i en t rò in Francia i l legi t t imo p r e t e n d e n t e al t r o n o dei B o r b o n e . Era il Conte di Provenza, fratello minore del Re finito sotto la ghigliott ina. Egli assunse il titolo di Luigi X V I I I , «Re di Francia e di N a v a r r a p e r grazia di Dio» d i m o s t r a n d o con ques ta fo rmula che n o n teneva a lcun con to della volontà della Nazione e cioè che si cons iderava un Re assoluto sec o n d o i l concet to del l 'ant ico r eg ime , come se in que i vent 'anni n o n fosse successo nulla. E gli Alleati cominciarono a negoziare con lui i l secondo dei t an t i t ra t ta t i che ora sono conosciut i col n o m e r iassunt ivo di «Trattati di Vienna», dove si conclusero.
I l p r i m o , quello di Fonta inebleau , lo avevano st ipulato fra loro pe r decidere la sorte di Napoleone . L'avversario più cavalleresco nei r iguardi del vinto si era mostrato lo Zar, che gli aveva fatto assegnare l'isola d 'Elba col ti tolo di Re, un decoroso appannaggio e un piccolo presidio pe r difendersi contro le incursioni dei pirat i saraceni. Napo leone par t ì in carrozza pe r Fréjus. Nel Nord ricevette le acclamazioni delle città in cui passava. Ma via via che scendeva verso Sud, l'accoglienza si faceva s empre più ostile: tanto che pe r non farsi r iconoscere , indossò u n a divisa di ufficiale aust r iaco (un episodio che a noi italiani dovrebbe r icordare qualcosa) e prefer ì imbarcars i su u n a fregata inglese t e m e n d o che i francesi lo avvelenassero.
Non aveva che quaran tac inque anni , un 'e tà a cui è difficile rassegnarsi, e le notizie che gli arr ivavano dalla Francia non e rano tali da invogliarvelo. I saccheggi commessi dagli Alleati avevano resuscitato il pat r io t t i smo francese m e n t r e
185
l 'assolutismo del nuovo regime r ianimava lo spirito rivoluzionario. Luigi aveva già firmato la r inunzia a tut te le conquiste pe r cui il Paese si e ra d issanguato : O landa , Belgio, Germania , Svizzera, Italia. Certo, non poteva sottrarvisi. Ma era la fine di u n a Grandeur, di u n a grandezza cui la Francia o rmai si era abituata. E pe r di più infierivano le «purghe», disgrazia di tu t te le Restaurazioni . Gli alti comand i civili e militari venivano monopolizzati dagli émigrés, dai fuorusciti, che la Francia si e ra ormai avvezzata a considerare dei traditori, e che ora sfogavano le loro vendet te sugli uomini che avevano contribuito a render la potente e temuta . L'indignazione raggiunse il colmo quando al vecchio glorioso tricolore , che aveva sventolato su tanti campì di battaglia e di vittoria, fu sostituito il vessillo bianco dei Borbone.
Di tutto questo, Napoleone era informato dai suoi seguaci. Alla fine di febbraio (del 1815), part ì di nascosto dall'Elba, e il 1° marzo sbarcò a Fréjus. I suoi calcoli si r ivelarono esatti. Alla sua comparsa la Francia prese fuoco. Un repar to mandatogl i incontro, invece di arrestarlo, si mise ai suoi ordini. La colonna in marcia su Parigi n o n faceva che ingrossare . I vecchi genera l i di N a p o l e o n e , che poi e r a n o quasi tutti giovani, si schieravano con lui. Il Re fuggì. Le Grand i Potenze accan tona rono i negoziat i pe r res t i tui re la paro la agli eserciti.
Da Parigi, che lo aveva accolto in delirio, Napoleone lanciò un proclama con cui s ' impegnava a r inunciare al g rande Impe ro , ma senza precisare fino a che pun to . Sapeva benissimo che, anche se si fosse contentato delle antiche frontiere natural i , n o n avrebbe evitato la guer ra . Voleva soltanto dimostrare ai francesi che questa gli era imposta, e infatti non perse t empo a prepararv is i pe r n o n da re al nemico quello di concentrare le sue imponent i forze.
I p repara t iv i , da u n a pa r t e e dal l 'a l t ra , d u r a r o n o circa t re mesi, i famosi «Cento giorni». Al t e r m i n e Napo leone , che aveva sperato di raccogliere 600 mila uomini , non se ne trovò sotto le bandie re che 130 mila. I soli prussiani ne ave-
186
vano altrettanti, e con gli altri alleati lo a t tendevano in Belgio. Ancora una volta furono sorpres i dalla sua rapid i tà e colti di contropiede , p r ima che russi e austriaci arrivassero. Il 18 g iugno , a Water loo, il c o m a n d a n t e in capo inglese, Wellington, fu sopraffatto, e Napoleone spedì a Parigi l'annunz io della vittoria. Ma al m o m e n t o di assestare il colpo decisivo, fu a sua volta sorpreso dai prussiani, e la vittoria si t r amutò in disfatta.
Rientrò a Parigi il 2 1 . Voleva ancora tentare . Ma il Paese stremato n o n gli obbediva più. Per la seconda volta abdicò, e stavolta senza speranza. Scrisse u n a lettera al Re d ' Inghilterra r imet tendosi alla sua generosità. E l ' Inghil terra , a cui Napo leone era costato ven t ' ann i di gue r re , r ispose inviandogli a Rochefort una nave che lo condusse, senza dirglielo, nel l ' Isola di Sant 'E lena , a duemi l a chi lometr i dalla costa africana.
Ci visse, o meglio ci agonizzò ancora sei anni.
Lo Zar Alessandro che aveva dato il maggior contr ibuto alla vittoria cercò di res ta rne anche il maggior beneficiario imp e g n a n d o gli altri alleati ( Inghi l te r ra , Austr ia e Prussia) a firmare quel documento che poi fu chiamato «Santa Alleanza». Gli storici ancora si scervellano sulle in tenzioni che lo spinsero a compi la re ques ta specie di magna charta della nuova Europa , redat ta su toni ispirati di «pietismo mistico». Goethe la salutò come l 'accendersi di u n a g rande speranza per tutta l 'umanità. Ma il ministro inglese Castlereagh ci vide soltanto «un sublime miscuglio d' idealismo e di follia» e quello austriaco Metternich «un pomposo vuoto». A loro interessavano d u e cose sole: r ipr is t inare in E u r o p a il pr incipio della legitt imità dinastica, che la Rivoluzione francese aveva negato e violato, e impedi re che il vuoto di potere lasciato da Napoleone fosse r iempito da qualche altra Potenza. La più qualificata a occuparlo era l ' immensa Russia, vera vincitrice di quella gue r ra che aveva por ta to i suoi eserciti nel cuore d 'Europa . Bisognava d u n q u e imbrigliarla. E a
187
ciò p rovvide l ' Ingh i l t e r r a , insuperab i le maes t r a in questi giuochi di cont rappeso, i nducendo gli altri alleati a trasform a r e la Santa in u n a Q u a d r u p l i c e Alleanza, che ne impegnava i m e m b r i a regolar i consultazioni tra loro allo scopo di garant i re , anche con interventi armati , l 'ordine europeo , e appogg iando le mire territoriali dell 'Austria in m o d o che questa potesse far da diga all 'avanzata russa.
La sistemazione italiana fu a p p u n t o il frutto della combinazione fra queste d u e esigenze: quella del legittimismo che imponeva la rest i tuzione dei vecchi Stati ai Sovrani spodestati da Napoleone , o ai loro discendenti ; e quella dell 'equilibrio, che favoriva l 'Austria in quan to ba lua rdo ant irusso. Ecco pe rché , p r i m a di vedere come venne in concreto applicata, occorre fare un rap ido sopral luogo a Vienna che si appres tava a svolgere sulla penisola la par te fin allora svoltavi da Parigi.
Sul suo t rono sedeva, col titolo di Sacro Romano Impera tore , Francesco I I . Era f igl io di Leopo ldo , l ' ex-Granduca di Toscana, e ra nato e cresciuto a Firenze, e qu ind i l 'Italia la conosceva abbastanza bene . Al pad re era succeduto nel '92, q u a n d o aveva a p p e n a vent iquat t r 'anni , e sulle sue spalle era r icaduto il peso delle cinque gue r r e combat tute contro Napoleone. Per al tret tante volte aveva dovuto umiliarsi a chiedergli pace. Ma questo non aveva affatto sminuito il concetto quasi religioso ch'egli aveva della dinastia Asburgo e della sua missione. Dal p a d r e aveva eredi tato lo zelo e la tenacia, ma n o n l ' intell igenza politica e lo spiri to r i formatore . Era un buroc ra te coscienzioso, ma freddo e senza fantasia. Lavorava quat tordici o re al g iorno un po ' perché era di l'i-flessi lenti , un po ' p e r c h é r i p u g n a v a a qualsiasi de lega di potere . Sospettoso verso ogni novità e diffidente di tutti, voleva tutto vedere e regolare di persona. «Qualche volta sono riuscito a governare l 'Europa, ma mai l'Austria» si lamentava il suo p r imo ministro.
Era questi il Principe di Metternich, un r enano cresciuto
188
nell 'odio della r ivoluzione da q u a n d o , bambino , l'aveva vista arr ivare a Coblenza sulla pun ta delle baionette francesi e sovvertire tutti i valori nei quali l 'avevano educato a credere. Tutti i suoi talenti, ch 'e rano notevoli, li aveva spesi in diplomazia al servizio d e l l ' I m p e r o e della causa legittimista. Ed era p e r questo che Francesco aveva preso a benvoler lo fino a farne, oltre che il suo Cancelliere, anche il suo uomo di fiducia, come sua n o n n a Maria Teresa aveva fatto col p r inc ipe Kauni tz , d i cui Met te rmel i e r a anche n ipo te pe r par te di moglie. Mettermeli e ra destinato a restare alla guida dello Stato anche oltre la mor te del suo Sovrano, fino al ] 848, cioè fino allo sfaldamento in tutta Europa del sistema di cui egli era stato nel T5 il massimo artefice e di cui d'allora in poi sarebbe rimasto il più vigile guard iano .
Nelle sue voluminose Memorie, Metternich assume spesso la posa di uomo di pensiero . Se lo fosse veramente stato, si sarebbe accorto che la sua ope ra andava contro la Storia, di cui p re tendeva invertire il corso. Ma a questo era fatalmente por ta to dal suo t e m p e r a m e n t o ed educazione. Per lui la parola «libertà» n o n era che un sinonimo di «anarchia», alla quale n o n vedeva altra alternativa che un ord ine basato sull 'autorità e la tradizione. Tutta la vita spese a punte l lare Trina e l 'altra sino a fare dell 'Austria «la Cina dell 'Europa», un fossile isolato in un m o n d o avviato alle libertà individuali e alle i nd ipendenze nazionali . Ma al servizio di questa causa sbagliata, egli mise incomparabili doni di tempismo, d'intelligenza tattica, di zelo e di onestà. Non aveva la spregiudicatezza e lo spiri to tagl iente di Ta l leyrand, ma n e m m e n o la sua disponibil i tà al d o p p i o giuoco e la sua a r rendevolezza agl ' interessi persona l i . Ta l leyrand n o n c redeva a nul la , e qu indi e ra s e m p r e p r o n t o a t r ad i re c h i u n q u e . Met te rn ich rimase sempre specchiatamente fedele al suo Paese e al suo Sovrano, e in ciò che faceva ci credeva, anche se era sbagliato. Q u a n d o diceva che l'Italia era «un'espressione geografica», n o n ci faceva un t ra t tamento di sfavore. Così considerava anche le al tre nazioni che facevano pa r t e del Sacro Ro-
189
mano I m p e r o affidato alla sua custodia: la Polonia, la Moravia, la Boemia, l 'Ungher ia , la Slovenia, la Croazia. Era fermamen te convinto che il vero interesse di tutte queste p ro vince e dei loro rispettivi popoli fosse di res tare unit i sotto la corona di u n a dinastia come quella degli Asburgo in grado di garant i re a tutti o rd ine e sicurezza. Ed era al tret tanto convinto che dello stesso p a r e r e fossero d o v u n q u e le d u e classi che ai suoi occhi contavano: i nobili e i contadini . Le sue antipatie e diffidenze si appun tavano tutte verso le borghesie c i t tadine, e dal suo p u n t o di vista n o n aveva to r to . Ma era questo che faceva di lui, anche socialmente, un conservatore dell'ancien regime, del vecchio reg ime pre-illuminista. Per lui, anche Pietro Leopoldo era stato un pericoloso e avventato progressista.
Tale e r a l ' uomo che o ra d iventava l ' a rbi t ro de l nos t ro Paese. Per il comodo del lettore, r iassumiamo alla svelta l'assetto ch 'egli gli d i ede coi t ra t ta t i di V ienna del 1815, che rappresen tano il suo capolavoro. Essi furono il frutto di un intenso e complicato armeggio diplomatico su cui esiste u n a s terminata let teratura, ma in cui n o n vogliamo addent ra rc i pe rché l'Italia e gl'italiani vi figurano solo come oggetto. Per chi voglia approfondi re questo capitolo, che coinvolge tutti i g rand i Stati d 'Eu ropa e la loro politica, ind icheremo nella nota bibliografica i testi principali . E veniamo agli Stati nostri.
Il p r inc ip io che prevalse fu quel lo della r e in tegraz ione delle dinastie prenapoleoniche , ma con qualche deroga, eccezione e compromesso . Il P iemonte venne restituito ai Savoia, ma maggiorato. Nei trattati di Parigi del '14, quelli cioè stipulati p r ima del r i torno di Napoleone dall 'Elba, si e ra stabilito di anne t te re la Repubblica di Genova al Regno sabaudo pe r compensar lo della perdi ta di Nizza e della Savoia lasciate alla Francia. Ma in quelli di Vienna del '15, a p p u n t o p e r cast igare la Francia de l l ' appogg io da to a N a p o l e o n e , anche Nizza e Savoia fu rono res t i tu i te al P i emon te senza pe r questo ritogliergli Genova.
190
Sulla Lombard ia che già p r ima le appar teneva come dominio diret to, e sul Veneto che col trat tato di Campoformio le era stato «venduto» da Napoleone , anche se poi questi se lo era r ipreso, l 'Austria fece facilmente valere i suoi diritti , a iutata - come v e d r e m o - dalle divisioni, dalla litigiosità e dal confusionarismo degli esponent i locali che cercavano di contestarglieli . Le d u e province furono alla fine r iuni te in un Regno Lombardo-Veneto che non fu n e m m e n o un Viceregno , tanto e ra s t re t tamente sottoposto a l po te re centrale di Vienna.
Pa rma e Piacenza furono un p o m o di discordia. Su questo Ducato i Borbone spagnoli , che lo avevano r icevuto in dote da Elisabetta Farnese moglie del loro Filippo V, avanzavano pretese indiscutibili sul p iano della legittimità, e che infatti furono riconosciute. Essi ne sarebbero tornat i in possesso, ma solo alla mor t e di Maria Luigia, la moglie di Napoleone, che frattanto avrebbe occupato quel t rono a titolo vitalizio. Nell 'attesa, Maria Luisa di Borbone che Napoleone, d o p o averla istallata nel Granduca to di Toscana, aveva scacciato, avrebbe gest i to , p e r sé e p e r il figlioletto Car lo Ludovico, il Pr incipato di Lucca che , q u a n d o essi avessero r e c u p e r a t o P a r m a , sa rebbe stato annes so a l G r a n d u c a t o . Un bel l ' imbrogl io , come vede te . Ma ques ta e ra la politica dinastica cui si p r e t endeva to rna re , che concepiva gli Stati come pa t r imoni di famiglia, da r ipar t i re secondo le pa rentele.
Sempre pe r il principio di legittimità, il Ducato di Modena toccava agli Este, rappresenta t i da u n a donna , Ricciarda, vedova di un Arc iduca L o r e n a , e da suo f ig l io . La m a d r e ebbe a titolo vitalizio il piccolo Principato di Massa e Carrara. M o d e n a a n d ò al figlio Francesco IV, che aveva sposato una Savoia, figlia di Vittorio E m a n u e l e I: ma t r imon io che sulle sorti del Piemonte era destinato a pesare.
Il Granduca to di Toscana e gli Stati pontifici furono restituiti nel la loro in terezza ai Sovrani che ne e r a n o stati spossessati e che tu t tora vivevano: il p r imo a Ferd inando I I I
191
di Lorena , figlio di Pietro Leopoldo e fratello de l l ' Imperatore, i secondi a papa Pio VII , il pr igioniero di Napoleone.
La s is temazione più difficile e complessa fu quel la del Reame delle Due Sicilie, che r imase a lungo in sospeso per via della ondegg ian te politica di Mura t . E di questa, come di tu t te le al t re vicende che a c c o m p a g n a r o n o la Restaurazione come si chiamò, nel suo complesso, il r i torno dell 'Italia al suo vecchio r eg ime pulviscolare, d i r e m o a propos i to dei singoli Stati.
Ma p r ima occorre s tendere un rap ido consuntivo dell 'eredi tà lasciata da Napoleone.
CAPITOLO DICIANNOVESIMO
C O N S U N T I V O
A N a p o l e o n e sono stati a t t r ibu i t i mol t i p i an i e mi ragg i . Qua lcuno dice che il suo sogno era quello di ricalcare le orme di Alessandro il G r a n d e conqu i s tando l 'Or iente e l 'India. Qua lche al tro dice che tut ta la sua politica si svolse in funzione dell 'Italia pe rché egli stesso e ra e si sentiva italiano . Ques t 'u l t ima tesi t rovò e loquent i avvocati specie al tempo del fascismo che nella sua cupid ig ia di g lor ia mi l i ta re cercò di a p p r o p r i a r s i i l g r a n d e condo t t i e ro cambiandogl i anche il c o g n o m e da B o n a p a r t e in B u o n a p a r t e . Se oggi a ques te ba lordaggin i si è r inunc ia to , n o n è tan to p e r a m o r d i ver i tà q u a n t o p e r un rovesc i amen to d i m o d e che o r a h a n n o ceduto il passo a quelle pacifiste e antimili tariste. Il napoleonismo è, come quella maltese, u n a febbre a fasi r icorrent i .
Ai sos teni tor i del la sua i tal ianità, N a p o l e o n e stesso ha prestato argoment i con le parole e coi fatti. «Più che francese e còrso, io sono italiano e toscano» disse u n a volta. E n o n c'è dubbio che dei molti Paesi in cui p ian tò b a n d i e r a nella sua vertiginosa corsa di conquistatore, l'Italia fu quello a cui più t enne e in cui più si sentiva a suo agio. Ne parlava la lingua, ne predi l igeva la cucina, ne capiva i l ca ra t t e re anche pe rché in molte cose Io condivideva: da b u o n còrso, anche lui era, come gl'italiani, un «uomo di famiglia» che odiava la famiglia, ma si sentiva t e n u t o a r e n d e r l a pa r t ec ipe delle p ropr ie for tune. Di s tampo t ipicamente italiano, anzi guic-ciardiniano, e rano la sua sfiducia negli uomini , il suo realismo spinto fino al cinismo. Per quan to di cul tura abborracciata, sentiva il valore del g r ande retaggio italiano, e soprat-
193
tut to Roma lo affascinava sebbene n o n ci avesse mai messo piede, o forse p r o p r i o pe r questo . Roma era p e r lui i l modello della s t ru t tura che in tendeva da re a u n ' E u r o p a unificata sotto la stessa legge. Non è da escludere che l'ambizione di dare a suo figlio l 'altisonante titolo di Re di Roma abbia contr ibui to alla sua rovinosa ro t t u r a col Papa. E infine c'era il r ichiamo dei ricordi. Era stato in Italia che il piccolo genera le , manda tov i a reci tare u n a pa r t e di compr imar io , era diventato protagonista. Era qui che aveva combat tuto le sue più belle battaglie e r ipor ta to le più squillanti vittorie. Era a Mombello che aveva trascorso la sua luna di miele con Giuseppina nel m o m e n t o della sua bruciante passione pe r lei.
Ma questo è tut to, e r imane confinato in un ambito pura m e n t e sen t imenta le . Pol i t icamente egli assegnò all ' I talia u n a pa r t e d i p r i m o p i ano f inché ques to gli pe rme t t eva d i assumerla egli stesso nei confronti del Direttorio e agli occhi dei francesi. Fu il suo t r ampo l ino di lancio nella scalata al po t e r e . Ma u n a volta r agg iun to lo , essa n o n fu p iù p e r lui che una provincia di conquista, anche se la più vicina al suo cuore , e u n a dispensatrice di troni pe r i suoi familiari. A resti tuirla agl ' i tal iani, f acendone un Paese un i to e i nd ipenden te , non pensò mai. Ma gli uomini n o n con tano p e r ciò che pensano . C o n t a n o pe r ciò che fanno, e che spesso è il contrar io di ciò che pensano di fare. Se lo proponesse o no, fu Napoleone a da re avvìo al Risorgimento, o a lmeno ad abbreviarne di parecchi decenni la scadenza. E vediamo perché.
Apparen temen te , il bilancio del suo quasi ventennale dominio si chiudeva pe r l'Italia in passivo, specialmente dal punto di vista economico. Già fragile e dissestato di suo, il Paese era stato messo a d u r a prova dai tr ibuti e dai saccheggi. Il man ten imen to del l 'armata di occupazione francese, che Parigi g l ' imponeva, era al di sopra delle sue forze. I capitali, già scarsi, venivano drenat i da un fisco implacabile. E diffi-
194
cile fare un conto globale delle estorsioni subite. Ma all'ingrosso si p u ò dire che un b u o n terzo del reddi to nazionale, in dena ro e in na tura , finiva nelle fauci dei commissari francesi. A questo si aggiunga la spoliazione del pa t r imonio artistico. E vero che g ran par te venne restituito d o p o la caduta di Napoleone . Ma parecchi vuoti r imasero.
Napo leone non nascose mai la sua in tenzione di fare di quella italiana un 'economia complemen ta re di quella francese, u n a sua appendice agricola e coloniale. Tutti gli Stati in cui egli aveva frazionato la penisola erano tenuti per diktat a espor ta re soltanto in Francia i loro p rodo t t i e a i m p o r t a r e manufatt i soltanto dalla Francia. Secondo le parole dell 'ambasciatore francese a Napoli , l 'Italia doveva «restare paese agricolo, esclusivamente agricolo».
Questa d ipendenza dalla Francia diventò ancora più rigida nel 1806, d o p o la proclamazione del blocco cont inentale contro l ' Inghil terra . I por t i italiani, pe r i quali la flotta inglese era la migliore cliente, furono fra quelli che più ne r isentirono. «Venezia è un cadavere» si legge in un r appor to del 1807. Anzi, la crisi arrivò a tal p u n t o che, pe r salvare le città di mare , furono introdot te delle «licenze di esportazione e importazione», cioè in parole povere delle eccezioni al blocco. La misura era circoscritta alle merci considerate «indispensabili». Ma servì di grimaldello per far saltare tut ta la serratura. Se il blocco fallì, fu in gran par te pe r colpa (o merito) degli i taliani che sp i ega rono un au ten t i co gen io nel con t rabbandare anche le merci proibite. Ma e rano , si capisce, palliativi.
La medaglia tuttavia aveva il suo rovescio. Se la r iduzione dell 'I talia ad a p p e n d i c e agricola della Francia bloccò il suo t imido slancio industriale, giovò allo sviluppo dell 'agricoltura, che ricevette parecchi incentivi . Per r e n d e r l a p iù produttiva, Giuseppe e Murat abolirono nel Reame le strozzature doganali e v ' introdussero alcune colture, come quella del cotone. Negli Stati pontifici il prefetto T o u r n o n spinse a fondo con energia la bonifica delle paludi pont ine già ini-
195
ziata da Pio VI. In Piemonte venne sviluppata al massimo la cul tura dei bozzoli da seta, da cui le industr ie lionesi strettamente d ipendevano . E gran par te dei pascoli lombardi venne ro convertiti a risaie.
Ma dal suo assorbimento nel sistema politico ed economico francese, l'Italia trasse ben altri e p iù sostanziosi benefìci . Anzitutto, le s trade. Napoleone era un tecnocrate pianificatore che, p r ima ancora che la parola venisse coniata, credeva nelle «infrastrutture». Delle s trade aveva la passione, e l'Italia fu il Paese in cui più la sfogò. Abbiamo già det to che u n o dei motivi fondamenta l i del l 'annessione del P iemonte fu il controllo e la sistemazione dei passi alpini. Non si conten tò d ' i n t r a p r e n d e r e g r a n d i lavori sul S e m p i o n e e sul Moncenis io . Siccome l ' inverno r e n d e v a malcer ta la loro transitabilità, fece costruire la s trada della Comiche che collega i d u e Paesi a t t raverso la Riviera. A guidar lo e r ano sopra t tu t to le considerazioni strategiche: di tut te le gue r re , la p ianura p a d a n a era sempre stata u n o dei principali teatri. E siccome la sua strategia era affidata soprat tut to alla rapidi tà di manovra , egli curò par t icolarmente la rete settentrionale, quella che si snoda trasversalmente da Torino a Trieste.
Ma non vi si limitò. Nei suoi piani l'Italia doveva diventare u n a specie di p ropagg ine allungata verso il Levante, i cui mar i e rano gli unici che sfuggissero al controllo della flotta inglese. Le merci in arrivo dall'Asia Minore e da Salonicco, sop ra t tu t to i l co tone , s a rebbero sbarcate nelle Puglie. Per avviarle alle Alpi, bisognava d u n q u e costruire anche u n a rete s t radale dal sud al n o r d , che infatti venne affidata a un corpo d ' ingegner i appos i t amen te costituito nel 1809. Esso n o n ebbe il t empo di c o n d u r r e a t e rmine l ' impresa, ma costruì alcuni pont i come quello sul Garigliano e a p p o r t ò sostanziosi miglioramenti , specie alla via Emilia.
E difficile calcolare l ' incidenza che questa r istrutturazione , come oggi si dice, ebbe sulla vita del Paese. Ma è certo che u n o dei motivi della «incomunicabilità» fra italiani era anche l 'arteriosclerosi s tradale. Un po ' pe r incapacità e in-
196
curia, un po ' pe r istinto di conservazione, i vecchi Stati non favorivano la circolazione degli uomin i e delle idee, in cui vedevano u n a minaccia al lo ro immobi l i smo. Traspor t i e servizi postali e rano , specie dal Po in giù, fra i più arre t ra t i d 'Europa . La g rande massa della popolazione rura le , ch 'era la g r ande massa della popolazione italiana, nasceva, viveva e mor iva nello stesso p o d e r e o nello stesso villaggio, mummificata nelle sue piccole autarchie, nei suoi tabù, p re giudizi e abitudini.
Su questo intorpidito organismo, l 'invasione napoleonica agì da elettrochoc. Dietro alle a rmate pe r raccoglierne le briciole o davanti ad esse pe r sfuggire le loro angher ie , chi pe r sottrarsi alla persecuzione dei vecchi regimi, chi pe r par te cipare alla costruzione di quelli nuovi , gl'italiani cominciarono a muoversi e quindi anche a conoscersi fra loro. L'emigraz ione in t e rna , che p r i m a e ra stata un fatto sol tanto d i «notabili» e d ' intellet tuali , d iventò un f enomeno di massa. Sulle s trade riassettate dai genieri francesi pe r i bisogni dell'esercito, passavano anche le diligenze, che por tavano lettere e giornali . A saperli leggere e r ano pochi . Ma costoro ne comunicavano il contenuto anche agli altri. L'orizzonte municipale, e spesso pa r rocch ia l e de l l ' uomo del b o r g o e del campo, si allargava ponendo lo in contat to con nuove realtà che, anche q u a n d o gli r ipugnavano, gli facevano sentire l'anacronismo di quelle tradizionali. Infatti n e m m e n o i regimi della Restaurazione po t e rono più ristabilire del tu t to i vecchi compar t iment i stagni che pe r secoli avevano preservato le loro arca iche s t r u t t u r e : alla l iber tà di m o v i m e n t o e di scambio dovet tero fare delle concessioni.
Più importante ancora fu la rivoluzione legislativa. Napoleone era tutto fuorché un ideologo. Però si e ra formato nel clima illuministico del Settecento e, da b u o n allievo di Rousseau, e ra f e rmamen te convinto che la salute dei popol i dipendesse unicamente dalle loro leggi e istituzioni e che quelle francesi fossero le migliori di tutte. In Italia aveva trovato il caos. N o n solo i sistemi giuridici e r a n o diversi da Stato a
197
Stato, ma o g n u n o di essi era una jungla di regolamenti speciali che si contraddicevano o si eccepivano a vicenda. Nella sola Toscana, che poi era una delle regioni più organiche e meno ingarbugliate, c 'erano 1.500 leggi speciali, fra le quali lo stesso magistrato non riusciva a raccapezzarsi.
Su questo intrico, Napo leone o p e r ò con l'accetta, né altro poteva fare pe r venirne a capo. Le regioni d i re t tamente annesse come il P iemonte ebbero senz'altro le leggi francesi. Ma anche le altre dovet tero accettarle, sia p u r e con qualche ada t tamento . Nel Regno (per capirci una volta pe r tutte: q u a n d o si dice Regno s ' in tende quello italico l ombardo -emil iano-veneto; q u a n d o si dice Reame, s ' intende quello di Napoli), il codice civile francese, che fra l'altro contemplava anche il divorzio, venne introdot to nel g iugno 1805, e pe r i suoi parziali adat tament i alle necessità locali Napoleone non concesse ai legislatori che sei mesi di t empo . I nvocando il nome di Beccaria, costoro o t tennero un te rmine più largo e magg io re a u t o n o m i a pe r i l codice pena le . Ma N a p o l e o n e accettò i sugge r imen t i di Romagnos i solo p e r q u a n t o riguardava la p rocedura . Per il resto, non fu che la t raduzione di quello francese.
Nel Reame l 'operazione fu in pa r t e r i ta rda ta dalle resistenze di Giuseppe, che si fece in te rpre te delle esigenze locali con m a g g i o r e au to r i t à di Eugen io . Egli paventava (e n o n senza qualche fondamento) gli scompensi che potevano derivare da u n a drastica abolizione di tutti i diritti e privilegi feudali in un Paese di s t ru t tu re t r o p p o a r re t ra te pe r potersi adat tare d ' un colpo a quelle mode rne . Ma Napoleone lo pungo lava : «Non lasciatevi inf luenzare: i n t roduce te nei vostri Stati il codice francese, così com'è». Tutto sommato, aveva ragione lui. Scompensi ce ne furono, e gravi. L'abolizione del «fedecommesso» che rendeva intoccabili e indivisibili i beni eredi tar i da un pr imogeni to all 'altro, e quella dei «monti di famiglia» che ne congelavano grosse aliquote, le cui r e n d i t e dovevano servire pe r l ' is truzione dei ragazzi e la do te delle ragazze, m a n d ò in l iquefazione molti
198
patr imoni . Ma e rano pat r imoni di parassiti, la cui scomparsa n o n r app re sen t ava p e r la società nessuna perd i ta . Purt roppo , ad approfi t tarne non furono i contadini , t r oppo poveri, ignorant i e legati alle loro abi tudini di gleba; ma u n a borghesia te r r ie ra non m e n o avida, reddi t ie ra e feudalesca dell 'aristocrazia.
Lo stesso si dica del divorzio. Nel Reame, a quanto pare , n o n ce ne furono che un paio di casi, tanto a fondo era radicata l'intoccabilità del mat r imonio n o n nella coscienza, ma nel costume della gente. Ma il r iconoscimento del diritto di divorziare det te uno scossone a questa mentalità, così come glielo de t t e ro le l imitazioni poste all 'esercizio della pa t r ia potestà, che fin allora aveva fatto del capo di casa un despota e della famiglia la roccaforte di tutte le resistenze ai dirit-ti della società.
Il t r auma più grosso lo subirono Roma e gli Stati pontifici perché qui il disordine legislativo e giudiziario era al colmo, grazie alla e terna incapacità della Chiesa di dist inguere fra legge e precet to morale , fra giustizia e legalità, fra reato e peccato, fra p e n a e peni tenza. Neanche i p iù g rand i luminari della p rocedura riuscivano a orientarsi nel groviglio di compe tenze fra t r ibunal i del Campidogl io , della Rota, del Governatore , della Camera Apostolica, del l 'Udi tore Pontificio, del Buon Governo (!) eccetera, oltre a quelli che pre tendevano di costituire per loro conto i singoli prelati e pa r ro ci. Ques ta fungaia di Fori fu abolita con un trat to di p e n n a insieme ai privilegi del clero e allo scandaloso «diritto di asilo» che, cons iderando «ospite di Dio» e quindi intoccabile il d e l i n q u e n t e r ifugiato in chiesa, faceva di R o m a la m a d r e non più del diritto, ma del delitto. Lo sconvolgimento p ro do t to da l l ' i n t roduz ione d i pr inc ìp i e l emen ta r i come: «La giustizia è dovuta a tutti, e tutti debbono ot tenerla a mezzo delle stesse leggi» e «Gli autori e i complici di delitti n o n pot r a n n o in alcun luogo essere prote t t i dal l 'azione delle leggi», d imost ra in quale stato confusionale versasse la legislazione pontificia.
199
Sui vantaggi recati all'Italia da questo massiccio t rapianto di princìpi e istituti giuridici francesi, si p u ò discutere a lungo . Si p u ò d i re che fu t r o p p o precipi toso e b ru ta le . Si p u ò dire che certe n o r m e violentavano la società italiana obbl igandola a fare un passo p iù l u n g o della gamba . Si p u ò dire che tutta questa riforma s'ispirava al proposi to colonialista di francesizzare l 'Italia. Si p u ò di re ch 'ebbe il tor to di spregiare i suggeriment i del pensiero giuridico italiano, più p r o f o n d o - a lmeno sul p iano teorico - di quel lo francese. Ma c'è u n a cosa che n o n si p u ò discutere: il suo effetto unificatore. L'Italia ancora n o n c'era, ma già c 'erano dei princìpi giuridici che valevano per tutti, a qua lunque Stato appar tenessero, di Roma, di Napoli, o di Milano. La Restaurazione n o n riuscirà che parzialmente a d is t ruggere questa unità e ad ogni m o d o ne lascerà un diffuso r impianto .
Ma anche a un 'al t ra unità gl'italiani si e rano frattanto affezionati: quella amminis t ra t iva. O g n u n o degli Stati in cui Napo leone aveva diviso la penisola aveva, si capisce, la sua amministrazione. Ma tutte r i spondevano agli stessi criteri di simmetria e di centralismo, e tutte r ichiedevano gli stessi requisiti di competenza e di efficienza. In fatto di au tonomia politica, Napoleone era avaro: non ne concedeva n e m m e n o ai suoi più fidati vicari, come Eugenio a Milano e Giuseppe a Napoli. Ma ai suoi «funzionari» n o n lesinava onori e p r e bende . Salvo il Piemonte e un po ' Napoli , l'Italia non aveva mai conosciuto la re l ig ione del servizio di Stato p e r c h é lo Stato e ra un Pr inc ipe s t ran ie ro , s i confondeva con la sua pe r sona e qu ind i lo si poteva servire solo da cortigiani. Fu Napoleone a in t rodur la , e i suoi effetti si videro soprat tut to a Milano. Molte delle più impor tant i cariche e rano occupate da francesi. Ma molte altre furono aper te ai figli dell 'aristocrazia e della borghesia, che pe r la p r ima volta sentirono l 'orgoglio del pubblico servizio e ci t rovarono il loro tornaconto . Un capodivis ione era un pe r sonagg io i m p o r t a n t e , che poteva contare su un lauto st ipendio e sugl'inviti ai ricevimenti di Corte. Un magistrato era quasi un intoccabile. I l
200
sogno del giovane laurea to in ingegner ia era l 'assunzione nei r a n g h i del Genio Civile, indaffarat issimo a cos t ru i re s t rade e canali. I Verri di questo t empo n o n avevano bisogno di fondare Caffè p e r p r o p u g n a r e le loro r i forme; si a r ruolavano, pe r realizzarle, nel Ministero di Prina. Il p re mio di queste carr iere era il Senato. I suoi poteri e rano solt an to consult ivi , cioè po teva e s p r i m e r e dei pa r e r i , n o n p r e n d e r e decisioni. Però era ambitissimo sia perché riuniva il meglio della società, sia pe r il prestigio che conferiva, sia pe r la p r ebenda che procurava: 24.000 lire l 'anno.
Non d a p p e r t u t t o le cose e rano anda te allo stesso modo . A Napoli u n a classe legata allo Stato c'era già p r ima che arr ivassero i francesi, le cui in f ramet tenze p r o v o c a r o n o soltanto - come abbiamo detto - gravi conflitti. In Toscana n o n ci fu il t empo di formarla. A Roma ne mancò l'occasione, un po ' perché gli Stati pontifici furono ridotti a semplici dipartimenti francesi, un po ' per la reni tenza della borghesia, irriducibile nella sua fedeltà alla Curia di cui era abituata a vivere. Alla collaborazione si most rò molto più docile l'aristocrazia, u n o dei cui massimi esponent i , il pr incipe Borghese, aveva sposato la sorella di Napoleone , Paolina, l 'unica Bo-napar te che preferiva l 'amore al potere e lo faceva con tutti, qualche volta anche col mari to .
Ma insomma, anche là dove p r ima n o n c'era - Lombar dia, Veneto, Emilia - le amministrazioni napoleoniche avevano get tato il seme di quel sacerdozio laico ch 'è il servizio civile. E anche questa era u n a delle tante rivoluzioni provocate da Napoleone .
Un'altra fu la coscrizione obbligatoria, che meri ta un discorso a par te , anche perché ci sembra che la nostra storiografia ne trascuri i decisivi riflessi sociali e morali .
Oltre ai tributi in dena ro , Napoleone esigeva dalle te r re conquistate quelli in uomini . Non lo faceva soltanto pe r ingrossare i suoi eserciti, ma anche pe r fondere i popol i soggetti: n o n c'è nulla che unisca più dello «spirito di corpo» e
201
che affratelli più della «naja». Anche in Italia i giovani di leva vennero recensiti e ricevettero la cartolina-precetto.
In Piemonte la cosa n o n suscitò reazioni. C 'e rano abituati. Da secoli il P iemonte e ra u n o Stato e aveva un esercito. Qua lcuno in cuor suo avrà obbiettato che u n a cosa era servire l 'esercito p iemontese , un 'a l t ra quello francese, e avrà anche diser ta to . Ma l 'abi tudine al servizio l'aveva. Suo pad r e , suo n o n n o e suo b i snonno lo avevano assolto. Faceva par te dei suoi doveri di suddito. Anche nel Reame era pressappoco così. L'esercito napo le t ano n o n valeva quello p iemontese . Però anche a Napoli un esercito c 'era perché c'era u n o Stato, e quindi c 'era anche la coscrizione.
Ma in tu t to i l resto della penisola, no . Fin dal Trecento , le sue varie Repubbl iche e Principati avevano appal ta to la p r o p r i a difesa alle milizie mercena r i e s t raniere , e pe r questo l 'Italia si e ra r ido t ta a u n a galassia coloniale di Stati satelliti alla m e r c é di qualsiasi invasore , c o m e l u c i d a m e n t e aveva p rev i s to Machiavel l i . «Gl ' i tal iani n o n h a n n o v i r tù mi l i ta r i p e r c h é n o n h a n n o pat r ia» scriveva M a d a m e D e Staél d i m e n t i c a n d o solo di a g g i u n g e r e un «e viceversa». Foscolo la r imbeccò fur iosamente , ma di lì a poco n o n solo le de t t e r a g i o n e , ma r i nca rò la dose . Se n o n sape te comba t te re , disse agl ' i taliani in un suo celebre discorso, «siate servi e tacete».
La car tol ina-precet to provocò t ra loro il finimondo, sopra t tu t to negli Stati pontifici. Dei 450 giovani che la ricevette ro (450 in tu t to , m e n o di un bat tagl ione), se ne p resen tò m e n o della metà , seguiti da m a m m e e sorelle che si s t rappavano i capelli, e accompagnat i dai par roc i che li esorcizzavano con segni di croce. Gli altri d i ser ta rono e si de t te ro alla macchia p re fe rendo arruolars i nelle b a n d e dei fuorilegge che infestavano l ' i n t e r n o . Perfino l 'aristocrazia, che in tut te le altre par t i del m o n d o si atteggia a depositaria della t rad iz ione e delle vir tù mili tari , q u a n d o u n a se t tan t ina di suoi giovani r ampol l i v e n n e r o prece t ta t i , si vestì a lu t to e sp rangò le po r t e dei suoi palazzi. I l conte Patrizi, piut tosto
202
che consegnare i suoi figlioli, preferì addir i t tura farsi gettare in p r ig ione . N o n e r a n o «obbiezioni di coscienza», o lo e rano solo in pochissimi casi. Era la secolare disabitudine al concetto del «servizio». Gl'italiani consideravano quello delle a rmi un «mestiere» p e r c h é come tale lo p ra t i cavano i mercenar i a cui si e r ano s empre affidati. E il vederselo imp o r r e lo cons ideravano un inaud i to sopruso . I l conte Monaldo Leopard i , p a d r e di Giacomo, diceva che la gue r r a era un dovere pe r i soldati, ma un disonore per i cittadini. Non era una quest ione di codardia: i disertori, q u a n d o s ' imbrancavano coi bandi t i , mos t ravano un coraggio che spesso rasentava la t emer i tà . Era - come diceva M a d a m e De Staèl, che gl ' i tal iani l i aveva capiti megl io di q u a n t o pensasse ro Foscolo e gli altri - «la totale mancanza delle idee di ono re e di dignità» su cui si r eggono n o n soltanto gli eserciti, ma i popoli .
Le medes ime reazioni la coscrizione provocò dappr inci pio anche nel Regno. Anche qui, sebbene essa n o n colpisse che un giovane su tre, fu considerata un 'angher ia , e casi di diserzione ce ne furono parecchi. Ma poi questa reni tenza si a t tenuò, e sempre più docilmente i coscritti affluirono nelle caserme. Dai 23 mila uomin i del 1804, q u a n d o era ancora Repubbl ica Cisalpina, l 'esercito italico salì ai 90 mila de l 1813. E, cosa ancora p iù i m p o r t a n t e , n o n e r a n o affatto u n ' a r m a t a b ranca leone , come gli avveniment i s tavano pe r d imos t ra re . Erano , a l cont rar io , repar t i disciplinati, a d d e strati e ben comandat i , specialmente quelli speciali dei «Veliti» e della «Guardia».
Ques ta trasformazione era visibile soprat tut to negli ufficiali, sfornati dalle scuole militari di Modena pe r l'artiglieria, di Lodi pe r la cavalleria, di Pavia e Bologna pe r la fanteria. Fra di essi all ignavano alcuni fra i p iù bei nomi della nobiltà e della borghesia, su cui la carr iera militare cominciava p e r la p r i m a volta a eserci tare un notevole fascino. Fosse la smania di gloria o il semplice desiderio dell'evasione dalla vita quot id iana o l 'attrattiva della bella un i fo rme,
203
1
fatto sta che questi giovani dall 'aria marziale «costituivano - dice Pingaud - un fatto del tut to nuovo nelle città lombarde, emiliane e venete», fin qui abituate ai cicisbei e agli abatini. Fra di essi c 'era anche Ugo Foscolo che, d o p o aver abbandona to la divisa pe r la penna , nel 1812 tornò ad abbandona re la p e n n a pe r la divisa, t rovandola molto più consona alla sua vocazione d ' i tal iano. La camera te r ia del reggimento spegneva le differenze e i meschini campanilismi della vecchia Italia pe r accendere lo spirito di corpo e l'ansia di emulazione. A mensa, i dialetti e r ano fuori legge: tutti erano tenut i a pa r l a re i taliano, poss ibi lmente con un accento toscano.
Tutto questo d iede avvìo a u n o «snobismo» militare, che n o n si limitò alla retorica e alle appa renze . Q u a n d o Napoleone li chiamò a combat tere in Spagna, gl'italiani vi accorsero in t rentamila e ce ne persero ventimila. Altri venticinquemila caddero nelle s teppe russe. Leopard i pianse e r impianse nei suoi versi («Oh, misero colui che in g u e r r a è spento - non per li patr i lidi...») questo sacrificio di sangue, cons iderandolo inuti le. Ma sbagliava. E vero ch'esso aveva privato l'Italia della sua gioventù migliore, ma aveva lasciato un seme che non doveva a n d a r e pe rdu to . Furono infatti i reduci di queste ul t ime avventure napoleoniche, messi per castigo in congedo dai regimi della Restaurazione o rimasti in servizio da «sorvegliati speciali», ad a l imentare i focolai insurrezionali accesi dalla Carboner ia e dalla «Giovane Italia». Scrisse S tendhal : «Il colonnello di un r egg imen to del Papa, che in passato era un lacchè, oggi è il colonnello della Moscova e di Montmirail» e - aggiungiamo noi - n o n si rassegnava a r idiventare un lacchè.
Erano t roppo pochi pe r t rasformare l'Italia in una nazione guerr ie ra . Ma furono abbastanza pe r farle capire ch 'era imbelle e che pe r questo era divisa e schiava. Fu da loro che gl ' i taliani disposti a i m p a r a r e qualcosa i m p a r a r o n o che il servizio mili tare n o n è che u n a delle tante espressioni dell ' impegno civile, e cioè che un cittadino è t enu to anche a fa-
204
re il soldato, e anche a mor i re , q u a n d o la patria lo richiede. I l R isorg imento , cui le masse r e s t a r o n o cosp icuamen te es t ranee, q u a n d o n o n addi r i t tu ra ostili, doveva d imost ra re che ad approf i t t a re di questa lezione era stata solo un'esigua minoranza . Ma se un Risorgimento ci fu, lo si deve sopra t tu t to a questi uomini e al loro «inutile» sacrificio.
Ma forse lo sconvolgimento più grosso e decisivo fu quello sopravvenuto nel campo della cultura.
L'irrequieto Angeloni, che trascorse la vita a ord i re congiure cont ro di lui, accusava Napoleone di coar tare il pensiero italiano e di voler perf ino «cor rompere la nos t ra lingua dolcissima». Ma è un 'accusa rec isamente sment i ta dai fatti. Come tutti i dittatori, Napoleone considerava la cultura - n o n soltanto quella italiana, ma anche quella francese -un instrumentum regni, u n o s t rumento del potere . Ma in Italia n o n ebbe bisogno di fare sforzi pe r piegare a questo scopo u n a cul tura , che n o n era mai stata al t ro. I poet i non si fecero p regare per sciogliere inni al Conquistatore. La sfilza delle Napoleonie e delle Napoleonidi pubblicate nel ventennio è interminabile. Ce n'è anche u n a di Foscolo, la Ode a Bona-parte liberatore, che p e r ò ha il suo alibi: a ispirar la era u n a speranza sincera, n o n la piaggeria. Della piaggerìa, il grande c a m p i o n e fu Vincenzo Monti che ne fece u n a proficua industr ia . A furia di omaggi e di elogi, d iventò «assessore» del gove rno di Milano, storiografo ufficiale e poe ta aulico del Regno, ricevette u n a cospicua pensione e le insegne della Legion d ' O n o r e e della Corona di Ferro, si fece s tampare tutte le ope re a spese dello Stato, ed Elisa gli pagò in gioielli le sonanti quar t ine ch'egli le aveva dedicato. Ques to non gl ' impedì, q u a n d o Napo leone cadde , di spiegare a s tormo le sue argentee campane per il r i torno degli austriaci. E nessuno se ne scandalizzò; i poeti italiani da secoli non facevano che questo: sciogliere inni a l p a d r o n e di t u r n o pe rché , non avendo un pubblico, solo del p a d r o n e e dei suoi favori vivevano. U n a simile le t teratura non si poteva co r rompere :
205
smisero di anda re a sentire Goldoni. Era insomma la schiacciante superiori tà della le t teratura, della saggistica, del teat ro francesi che metteva in crisi la cul tura italiana, sottrattasi fino allora, grazie alla censura dei vecchi regimi , al confronto pubblico e diret to con quelle straniere. Era fatale che l ' irruzione dei Diderot, dei D'Alembert, dei Lesage, dei Do-ra t nel Paese dei pastorel l i del l 'Arcadia vi provocasse lo scompiglio.
La reazione fu goffa. Minacciata da questa terribile concor renza che smascherava tut te le sue m a g a g n e - l 'accademismo p a r r u c c o n e , la bor ia aulica, le iperbol i cor t ig ianesche, la disabitudine ad affrontare i problemi concreti della società, i l re tor ico t r ionfal ismo al servizio del p o t e r e - , la cu l tura i taliana assunse a t teggiament i di d i sdegnoso spregio. «Bestia francese» chiamò il Monti , che inondava l'Italia d ' inni ai francesi, l 'abate Guillon, che aveva osato muove re qualche critica alla poesia italiana. «Testa n o n italiana», «di st irpe e formazione straniera» si diceva e si scriveva di tutti quei francesi che osavano p ronunc ia re giudizi su cose italiane . Sembrava, a leggere questi scampoli polemici, che la cultu ra italiana fosse ancora, come lo era stata fra il Tre e il Cinquecento, il faro del l 'Europa, men t r e ne reggeva soltanto il fanal ino di coda. Foscolo c h ' e r a l 'unico vero e serio ant i francese, capì tut ta la r idicolaggine di questo starnazzìo di pedant i e gli det te il n o m e che meritava: eunucomachia.
Ma il f enomeno aveva anche un aspet to positivo. Per la p r i m a volta, di fronte alla minaccia della cu l tura francese, quella italiana si e ra sentita italiana. Di appelli all'Italia, nelle pagine dei nostri scrittori e poeti , ce n 'e rano sempre stati. Ma n o n e r a n o che vuota e tronfia retorica, un 'es igenza di r i tuale. Stavolta, no . Pur negandola , gl ' intellettuali italiani avevano capito che la superiori tà della cul tura francese derivava dal fatto ch'essa aveva alle spalle u n a patr ia e u n a società di cui finalmente avvert i rono la mancanza. La furiosa lotta ch'essi i m p e g n a r o n o cont ro i «gallicismi», cioè cont ro le contaminazioni della l ingua, n o n fu che l 'aspetto più pe-
208
dantesco di questa reaz ione , che ne ebbe degli altri mol to più sostanziosi.
I l dominio francese funzionò insomma da reagente . Per paura che Napo leone gliela togliesse, la cu l tura italiana ritrovò la p ropr ia an ima e serrò i r anghi in sua difesa con u n a compattezza che non aveva mai conosciuto p r ima di allora. Non avendo da con t r appor r e a quella francese nulla o quasi nulla di valido in senso m o d e r n o , si mise a r icercare e a r inve rd i r e i p r o p r i blasoni di nobil tà d isseppel lendol i dal sot tosuolo, e n o n sol tanto in senso figurato: si p r o p a g a la febbre archeologica , si scopre la civiltà e t rusca , cui v iene frettolosamente attribuito, a d a n n o della Grecia e di Roma, un ruo lo d i «grande madre» nei confront i d i quel la e u r o pea, si «lancia» Dante , o meglio lo si rilancia, ma in g r ande stile, facendolo «padre» di tu t to: della l ingua, della poesia, del pensiero, della democrazia, della patria.
Questa patr ia era ancora un concetto astratto e retorico, ma lo e ra molto m e n o di p r ima . I t r ombon i alla Monti segui tavano a farne ogget to solo di qua r t ine (e di quat t r ini) . Ma i giovani intel let tual i cresciuti nel clima di N a p o l e o n e cominc iavano ad accorgersi che solo un ' I t a l i a naz ionale avrebbe p o t u t o r i t rovare il suo pos to e il suo r a n g o anche nella cultura.
Ma stiamo attenti a non pe rde re , come spesso si fa, il senso delle misure . Ad averne coscienza n o n era neanche tut ta la cu l tu ra , ma solo u n a sua s p a r u t a m i n o r a n z a , che p u r t roppo n o n si rese conto del p ropr io isolamento e non fece nulla, o fece t roppo poco pe r romper lo . Per quanto infinitam e n t e migl ior i dei loro p a d r i e n o n n i , gl ' intel let tual i che nei successivi decenni salirono sulle forche e popola rono le galere , ne p o r t a v a n o ancora nel s angue i l vizio: quel lo di parlare soltanto fra loro come den t ro le m u r a di un'Accademia. Un 'ope ra di apostolato popo la re n o n la svolsero: n o n ne avevano l 'abi tudine, n o n ne avevano i l l inguaggio, n o n ne avevano l 'umiltà. Per ques to tu t ta la loro vita n o n sarà che un segui to d i t rag iche de lus ioni . Nel ' 2 1 , nel ' 3 1 , nel
209
'48, li ved remo insorgere lanciando appelli al popolo , nella certezza di esserne seguiti; e il popolo non si muoverà o addir i t tura li consegnerà agli sbirri. È logico. Ad esso nessuno aveva parlato. Il discorso seguitava a svolgersi fra «iniziati», anche q u a n d o verteva sulla «democrazia» (e tu t tora è così). Alla cu l tura i taliana seguitava a m a n c a r e ciò che mancava alla burocrazia, all'esercito, a tut to, cioè il senso, la religione del «servizio pubblico». Alle masse n o n volle o n o n seppe rivolgersi. Intrisa di clericalismo - anche q u a n d o faceva p ro fessione di fede anticlericale - le considerava «gregge», come faceva la Chiesa. Così c o n d a n n ò se stessa e la p r o p r i a o p e r a - il R isorg imento - a res ta re un fatto di élite e, n o n r iuscendo a dargli un contenuto popolare , dovette cede rne l'iniziativa alla monarchia sabauda.
CAPITOLO VENTESIMO
IL BALLETTO DI MI RAT
Di tutti i problemi italiani che i rappresentant i delle Grandi Potenze dovet tero affrontare pe r da re al l 'Europa u n a sistemazione che r ispondesse ai loro princìpi e soprat tut to ai loro interessi , e che va sotto il n o m e di Restaurazione, il p iù complicato fu quello del Reame, cioè delle Due Sicilie.
Abbiamo lasciato Mura t , alla vigilia della c a m p a g n a di Russia, intento a tessere la sua tela, combat tuto fra la paura di N a p o l e o n e e l 'ambizione di affrancarsi dalla sua tute la pe r diventare un vero Re, e non soltanto di Napoli . Con la sua consue ta leggerezza aveva condo t to le cose t a lmen te male che o ra si t rovava quasi e sau to ra to e sotto la s tret ta sorveglianza dei fiduciari del suo imperiale e p repo ten te cognato. Temeva di essere estromesso dal t rono, e pe r stornare questa minaccia m a n d ò a Parigi Carolina. Costei si vantò in seguito di avere riconciliato mar i to e fratello, e forse lo credeva sul serio. In realtà a compie re il miracolo n o n era stata la sua diplomazia, ma la situazione internazionale. Napoleone si e ra definitivamente persuaso che il conflitto con la Russia e ra inevitabile, e in quel r epen tag l io n o n voleva storie con Mura t , di cui anzi des iderava la col laborazione. Con lui avrebbe regolato i conti a campagna conclusa.
M u r a t fu in formato delle sue in tenzioni di g u e r r a solo quando , nell 'aprile del 1812, ricevette l 'ordine di raccogliere le sue migliori t r u p p e , di affidarne il c o m a n d o a un generale di sua scelta e di assumere egli stesso quello di tut ta la cavalleria francese. Napoleone lo voleva al suo fianco non solo perché a cavallo lo considerava insostituibile, ma anche perché non si fidava di lasciarlo a Napoli.
213
Gioacchino par t ì cont ro voglia. Per quan to di testa piuttosto debole, capiva benissimo che un Napoleone vittorioso gli avrebbe tolto il t rono o gliel'avrebbe lasciato in posizione più subalterna di pr ima. Per di più, doveva affidare lo Stato a sua moglie e temeva che costei, smaniosa com'era di potere pe r sona le , ne approf i t tasse p e r m a n d a r e in fumo quel part i to italico su cui egli fondava tut te le sue ambizioni.
La sua condotta in Russia fu condizionata da questi crucci. Alla testa dei suoi cavalieri si batté bene , come sempre . Ma quando, dopo la disastrosa ritirata, Napoleone gli affidò il comando di tutto l'esercito per accorrere a Parigi a repr imervi un colpo di Stato, egli contravvenne agli ordini r inunziando a qualsiasi resistenza anche sulle posizioni che vi si prestavano, t rasformando la ritirata in u n a vera e p ropr i a rotta, e finalmente cedendo a sua volta il suo posto a Eugenio di Beauhar-nais, per r ientrare precipitosamente a Napoli. Ci arrivò ai primi del '13, accolto da fiori e applausi. Apparve sorridente e sicuro di sé, ma n o n lo era affatto. Come avrebbe reagito alla sua diserzione il cognato, che non era più in grado di garantirgli il t rono, ma era ancora in grado di toglierglielo?
Il cognato reagì con d u e lettere. Una, a Carolina, diceva: «Vostro mari to e un gran b rav 'uomo sul campo di battaglia, ma è più debole di u n a d o n n a o di un frate q u a n d o n o n è davant i a l nemico. Manca comple tamen te di coraggio morale». L'altra, a lui, conteneva queste frasi: «Spero che n o n siate di quelli che pensano che il leone è mor to . Il titolo di Re vi ha fatto girare la testa. Se questa testa volete salvarla, comportatevi bene».
Per q u a n t o ferito nel l 'orgogl io , Gioacchino r e sp i rò : se l 'era cavata con un «cicchetto», e quel «comportatevi bene» implicava la concessione di u n a p rova d 'appe l lo . Ma c 'era anche un 'a l t ra consta tazione da fare, e i suoi consiglieri la fecero subi to: p e r mos t ra rs i così a r r e n d e v o l e , voleva d i re che Napoleone era p ropr io allo s t remo. Bisognava approfitt a rne , m a n o v r a n d o in m o d o da p r o c u r a r s i qua lche controassicurazione pe r il futuro.
214
La Potenza più disposta a dar la era l'Austria, tu t tora neutrale, ma p ron ta a gettarsi anch'essa sul vinto pe r partecipare alla spart izione del bot t ino. Met ternich pe rò voleva fare il giuoco suo, n o n quello della Russia che già aveva steso le mani sulla Polonia, e della Prussia che già reclamava la Sassonia. Era in Germania ch'egli voleva la gue r r a pe r sottrarla a questi d u e famelici concorrent i , ed era lì che contava quindi di concent rare tutte le sue forze. Per l'Italia, bastava neutralizzare Eugenio o Gioacchino, o tut t 'e due , staccandoli da Napoleone . E questo era compito della diplomazia.
Con Eugenio , Metternich n o n potè t ra t tare pe r t re motivi. P r ima di tu t to pe rché il Viceré era r imasto disciplinatamen te al c o m a n d o dei brandel l i della G r a n d e Armata , aveva raggiunto l ' Impera tore a Parigi, e solo nel maggio questi lo r i m a n d ò a Milano. Secondo, perché sarebbe occorso dargli qualche garanzia di p e r m a n e n z a sul t rono del Lombar do-Veneto cui l'Austria n o n intendeva assolutamente r inunziare. Terzo, pe rché fu subito chiaro che Eugenio n o n tradiva. Motivi ne avrebbe avuti : d o p o avergliela fo rma lmen te p romessa , Napo leone gli aveva s e m p r e rifiutato la co rona d'Italia e n o n gli aveva mai concesso un minimo di au tonomia. E, ne avrebbe avuto anche i mezzi: suo suocero, Re di Baviera, gli aveva già offerto la sua mediazione presso Vienna. Ma Eugenio l'aveva respinta . Come mot to si e ra scelto: «Onore e fedeltà», e n o n vi contravvenne.
Il Regno di Napoli n o n rivestiva, agli occhi di Metternich, la stessa importanza. U n a volta res taura to il p r edomin io austr iaco sull 'Italia, che su quel t r ono sedesse un Borbone o un Mura t , avrebbe c o m u n q u e dovu to accet tare i l pa t ro nato di Vienna. E pe r di p iù l 'ambasciatore austriaco Mier riferiva che Gioacchino era trattabile. Metternich lo sapeva già p e r c h é , p r i m a ancora di r i e n t r a r e a Napol i , M u r a t gli aveva m a n d a t o un messo, Cariati, a sondare le sue intenzioni. E r a n o così al let tanti che M u r a t si affrettò a r i sped i re a Vienna l ' in te rmediar io che, a q u a n t o sembra , invece di limitarsi ad ascol tare come Gioacchino gli aveva o r d i n a t o ,
215
par lò , e anzi par lò t roppo sino a p r o p o r r e una vera alleanza militare in cambio di u n a garanzia per la corona del suo sovrano.
La transazione restò a mezz'aria pe r vari motivi. Anzitutto , occor reva l 'avallo degl ' inglesi che o rma i eserc i tavano u n a specie di tutela sulle Due Sicilie, e gl'inglesi n o n e rano d ' accordo n e m m e n o t ra loro . A L o n d r a i l P r imo Ministro Castlereagh, preoccupato anche lui del rafforzamento russo e p russ iano , voleva in tutt i i modi secondare l 'Austria pe r consentirle di fare da contrappeso. Ma l'inglese di Palermo, cioè Bentinck, aveva tutt 'al tre idee. «Questo g r ande popolo - scriveva (bontà sua) degl ' i taliani - n o n deve d iventare lo s t r u m e n t o di un soldato t i r anno o di qualche altro oscuro personaggio , ma u n a formidabile bar r ie ra alzata sia contro l'Austria che contro la Francia.» Secondo lui insomma si doveva but tare a mare sia Mura t che i Borbone pe r pun t a r e su un'I tal ia unita e ind ipenden te . Questo inglese autori tar io e generoso precorreva il Risorgimento, ma di t roppi decenni .
Q u a n d o r icevet te l ' o rd ine d i p r e n d e r e conta t t i con Gioacchino, li eseguì, ma a m o d o suo. Andò a Ponza, che la sua flotta aveva occupa to con un colpo a sorpresa , e di lì m a n d ò ambascerie a Mura t invitandolo a r o m p e r e con Napoleone, ma senza dargli nessuna garanzia pe r i l futuro, anzi rec lamando la consegna di Gaeta, pilastro di tut to il sistema difensivo n a p o l e t a n o . M u r a t repl icò c h i e d e n d o , ol t re Napol i , gli Stati pontifici: anche lui voleva un ' I ta l ia uni ta , ma sotto la p ropr ia corona.
Napo leone e ra informato di tut to , e le sue let tere al cognato si facevano s e m p r e più violente. Fece pubbl icare sul giornale ufficiale la notizia che i napoletani , cioè Murat , avevano «venduto» Ponza agl'inglesi, impose il ritiro di Cariati da Vienna, e chiese otto battaglioni napoletani con contorno di artiglieria e di cavalleria pe r le successive operazioni in Germania . Gioacchino tergiversò finché potè. Ma alla notizia delle vit torie r i po r t a t e dal cogna to a Dresda e a Lut-zen, s ' impaurì , p iantò a mezzo le trattative con Mettermeli e
216
Bentinck, e accorse anche lui pe r par tec ipare alla battaglia decisiva.
Il rovesc iamento di fronte sembrava scongiura to , ma a ricucirlo fu Carolina, rimasta a Napoli. Essa conosceva molto bene Met ternich pe rché ne e ra stata l ' amante , e col suo femminile intui to aveva capito che la stella del fratello era ormai t ramonta ta e i suoi successi non avrebbero avuto domani . Il g iorno stesso in cui suo fratello e suo mar i to scendevano in c a m p o a Lipsia, essa convocò Mier e si disse disposta a conc lude re la t ra t ta t iva schierandos i in g u e r r a a fianco dell'Austria, q u a n d o questa vi fosse entrata, pu rché a lei e a suo mar i to fosse garant i to il t rono di Napoli . Mura t ne fu in formato d o p o la bat taglia che si e ra risolta in u n a completa sconfitta. Non poteva aver più nulla da eccepire. A b b a n d o n ò l 'esercito e il cogna to al lo ro des t ino , accorse prec ip i tosamente a Napoli , ch iamò Mier, e gli disse ch ' e ra p ron to a met tere a disposizione degli Alleati 30 mila uomini pe r marc i a re con t ro i l Regno Italico. Ma p o n e v a la solita condiz ione : gli Stati della Chiesa, e anzi ne agg iungeva un'altra: Corfù.
Per s t r ingere la trattativa, alla fine de l l ' anno Vienna inviò il conte Neipperg . La controfferta era questa: Gioacchino avrebbe fornito 30 mila uomin i in appogg io ai 60 mila che l 'Austria avrebbe m a n d a t o in Italia, e in compenso sarebbe stato confermato «nei suoi Stati attuali». Ne ippe rg vi aggiunse di suo l ' impegno , che n o n impegnava a nulla, di adoperars i pe r assicurargli «una frontiera migliore».
Subito d o p o aver accettato le deludent i proposte , Gioacchino scriveva a Napoleone: «Sire, eccomi nel m o m e n t o più doloroso della mia vita. Si tratta, pe r me, di scegliere t ra la perdi ta dei miei Stati, della mia famiglia e della mia gloria, ed il mio inalterabile affetto pe r la Francia... Voi n o n m'avete dato alcun potere sul paese da me occupato, n o n m'avete n e p p u r par la to della garanzia dei miei Stati...» Ot to giorni dopo firmò l 'accordo con gli austriaci, ne iniziò un altro, più difficile, con l'inviato di Bentinck, e riscrisse a Napo leone :
217
«Sire, colui che ha combat tu to a lungo vicino a Voi, vostro cognato, vostro amico, ha firmato un atto che sembra fargli assumere un a t teggiamento ostile nei vostri confronti... Ho dovu to farlo, ma il mio cuore è s e m p r e lo stesso. Ho bisogno di sapere che Voi mi amate ancora pe rché io vi a m e r ò sempre...» Quasi con temporaneamen te scriveva al l ' Imperatore d'Austria: «Prego Vostra Maestà di essere persuasa della mia sincera amicizia e riconoscenza.. .» Molti biografi di Mura t si chiedono se questi mentisse più a Napoleone o agli Alleati. Forse, nel m o m e n t o in cui scriveva, era sincero con l 'uno come lo e ra con gli altri: voleva b e n e a tut t i e voleva che tutti gli volessero bene .
Bentinck, che aveva r icevuto l 'o rd ine di ap r i r e i l negoziato con lui, stava facendo il possibile pe r mandar lo a monte, e q u a n d o da L o n d r a gl ' ingiunsero di concluder lo s'impegnò alla cessazione delle ostilità fra Napoli e l ' Inghil terra, ma senza fornire nessuna garanzia sul futuro del Regno. E ora bisognava agire. Alla testa dei suoi uomini , Gioacchino varcò i l confine pontificio ed e n t r ò in Roma. Il gene ra l e Miollis, non avendo forze da opporgli , si chiuse in Castel S. Angelo. Evitando di attaccare le t r u p p e francesi, Mura t p ro seguì pe r Bologna, e da Ancona lanciò un proc lama ai soldati in cui, nel tentativo di giustificare il p ropr io voltafaccia, denunciava «la folle ambizione di Napoleone», e pe r la pr i ma volta si firmava col solo n o m e italianizzato Gioacchino. Come u n a volta aveva cambiato il Mura t in Marat , così ora voleva farlo d imen t i ca re p e r meglio accredi tars i come Re ind igeno , p e r c h é ques to e ra o rma i i l suo giuoco: me t t e r e tut t i , amici e nemici (sebbene ancora n o n sapesse chiaramente chi fossero gli uni e gli altri) dinanzi al fatto compiuto di un'Italia unificata sotto il suo scettro.
«La condot ta del Re di Napoli che spara contro i francesi è infame e quella della Regina inqualificabile. Spero di vivere abbastanza a lungo pe r vendicare me e la Francia d 'una ingra t i tud ine così spaventosa» scrisse Napo leone che stava t en t ando un 'u l t ima dispera ta resistenza all ' invasione allea-
218
ta. In realtà fin allora Gioacchino aveva sparato solo parole. Ma i movimenti delle sue t ruppe , c reando una minaccia alle spalle di Eugenio, avevano costretto quest 'ul t imo ad abband o n a r e le difese dell 'Adige a p r e n d o così la s t rada agli austriaci in marc ia sulla Padania . Gioacchino, in p r e d a a un delir io di att ivismo, nelle pause dei suoi con t inu i trasferiment i scriveva a tutti i potent i della ter ra pe r professargli il suo amore e guadagnar l i alla causa del Regno Italico. Scrisse anche a Ferd inando VII di Spagna, ch 'era fuori del giuoco. Scrisse perfino a Luigi XVII I dicendosi p ieno di «veneraz ione pe r il s angue di Enr ico IV e di San Luigi». Aveva sguinzagliato i suoi fiduciari in tut ta la penisola a suscitarvi adesioni e d o m a n d e di a r r u o l a m e n t o nel suo esercito. Ma u n o di essi, Gabriele Pepe, sebbene fra i p iù entusiasti , annotava nel suo diario: «Il Re manca di coraggio politico. Crii alleati, che n o n h a n n o po tu to ancora constatar lo, n o n tard e r a n n o ad accorgersene e n o n m a n c h e r a n n o di approfittarne».
Il 1° marzo (sempre del T4) , Gioacchino scrisse ancora a Napoleone, sebbene ormai fosse con lui in gue r r a guer reggiata: «Sire, Vostra Maestà cor re pericolo. La Francia è minacciata nella sua capitale. Sire, dite u n a parola, e sacrifico la mia famiglia e i miei sudditi . Questa lettera vi r e n d e interamente p a d r o n e della mia sorte. La mia vita vi appar t iene . Amatemi. Mai fui più degno della vostra tenerezza. Fino alla mor te vostro amico». Cos'era accaduto? Era accaduto che Napoleone aveva r ipor ta to qualche piccolo successo, mentre il c o m a n d a n t e aus t r iaco aveva lanciato a sua volta un proclama in cui annunciava agl'italiani il proposi to di ricostituire i vecchi Stati «che h a n n o assicurato così a lungo la loro felicità e la loro gloria». Vedendo sfumare il suo sogno di Regno Italico, Gioacchino era p ron to a un ennes imo rovesciamento di fronte, ma le sorti della g u e r r a n o n gliene det tero il t empo: il 6 apri le (1814) Napoleone era costretto ad abdicare e pochi giorni dopo partiva per l'Elba.
Napoli r iservò le solite g rand i accoglienze a Gioacchino
219
che se ne finse pago. Non si sa cos'avvenne nell ' intimità fra lui e la moglie, ma n o n dovett 'essere un facile incontro. Napoleone diceva che Carolina «portava la testa d ' un uomo di Stato sulle spalle d ' u n a bella donna» . Molto p iù realistica del mari to , essa aveva capito fin dappr inc ip io che il Regno Italico era u n a ch imera , che conservare i l t r ono di Napoli sarebbe già stata u n a m a n n a e che , di tut t i gli Alleati, solo sull'Austria si poteva fare qualche affidamento. Perciò, non essendo riuscita ad accredi tare dei r app resen tan t i ufficiali al Congresso di Vienna, vi teneva d u e «osservatori» e privat amen te scriveva a Met termel i pe r rassicurarlo: la dinastia M u r a t si sarebbe legata s t r e t t amente all 'Austria e avrebbe monta to b u o n a guard ia cont ro i r ivoluzionari . Era il capovolgimento di tutta la politica di suo mari to.
Ques t i sapeva tut tavia che Met te rn ich e ra s e m p r e più isolato fra le altre Potenze che volevano r ipor ta re i Borbone sul t rono di Napoli, ed aveva r ipreso ad armeggiare . Alla fine di febbraio ricevette u n a lettera di Napoleone dall'Elba: «Caro Mura t , vi r ingraz io di quel lo che avete fatto p e r la contessa Walewska. Ve la raccomando, e vi raccomando suo figlio (che era figlio di Napoleone). Colonna vi dirà cose gravi e important i . Conto su di voi». Questo messaggio era il risultato di una complessa manovra di riavvicinamento condotta da Gioacchino, al l ' insaputa di sua moglie, at t raverso la cognata Paolina e il cardinale Fesch. Evidentemente lo avevano informato delle intenzioni di Napoleone e, vedendosi abbandona to dagli Alleati, puntava nuovamente su di lui che, freddo calcolatore, Io riaccoglieva nel p ropr io giuoco.
Pochi giorni d o p o il pr igioniero dell 'Elba fuggì, sbarcò a Fréjus, e sulle ali dell 'entusiasmo popola re volò a Parigi, dove lo raggiunse una lettera di Murat : «Sire, non ho mai cessato d'essere vostro amico. Attendevo solo un'occasione favorevole. Tutto il mio esercito è in movimento e alia fine del mese sarò sul Po». In quel l 'eserci to e r a n o affluiti da tut ta Italia i veterani delle gue r re di Spagna e di Russia, ma solo quelli dal g rado di colonnello in su. Di subal terni , sottuffi-
220
ciali e soldati, nessuno. E il part icolare ha il suo significato: il patr iot t ismo in Italia restava la prerogat iva di coloro che ad esso legavano un r a n g o e un s t ipendio. Sugli altri, n o n esercitava nessun fascino. Quasi tutt i gli storici d icono che questa reni tenza fu colpa di Mura t che, contro il pa re re dei suoi consiglieri e l uogo tenen t i , de luse le d u e p iù g r a n d i aspirazioni del popolo: l 'adozione della bandie ra tricolore e di una Costituzione liberale. Ma noi ci c red iamo poco. Queste d u e mi su re gli av rebbe ro a t t i ra to qua lche s impat ia in più; ma i l popo lo sarebbe r imasto u g u a l m e n t e iner te pe r ché quegl ' ideal i di naz ione e di l iber tà gli e r a n o del tu t to estranei. Pietro Colletta, che Gioacchino aveva nomina to capo di Stato Maggiore e comandan te del genio, lo disse chiaramente : «Un filone d 'uomini colti si abbandonerà a questa idea lusinghiera, ma la massa degl'italiani o la spregerà , o la r iguarderà con indifferenza, o si a rmerà per combatterla...»
Il 22 marzo Gioacchino, ormai deciso a p u n t a r e tut to sulla carta di Napoleone , par t ì alla testa del suo esercito, e il 30 lanciò da Rimini il famoso proclama, impastato di retorica e di ambigui tà : « . . .Ottantamila i taliani degl i Stati di Napol i marciano comandat i dal loro Re, e g iu rano di non d o m a n dare riposo se n o n d o p o la liberazione d'Italia... Io chiamo d ' intorno a me tutti i bravi pe r combattere.. .» Questo enfatico appel lo riuscì a i sp i rare a Manzon i a lcuni dei suoi più brutt i versi, che sono quasi tutti brutt i . Ma di veri bravi pe r combattere ne accorsero cinquecento in tutto.
Gli an imi n o n si sca ldarono n e m m e n o alla notizia dei pr imi successi di Mura t . Presi di con t rop iede , gli austriaci a b b a n d o n a r o n o M o d e n a e Bologna e si fecero ba t t e re sul Panaro. Ma l ' indomani , a Occhiobello, respinsero un assalto, sebbene condot to pe rsona lmente da Gioacchino col suo impeto consueto. Perdite fra gli italiani ce ne furono poche, ma diserzioni a centinaia.
A me tà apr i le gli austr iaci in iz iarono la controffensiva. Gioacchino si ritirò pe r at tenderl i fra Macerata e Tolentino. Abituato ai ferrei e disciplinati repar t i francesi, non riusciva
221
a d o m i n a r e quel raccogliticcio esercito dove ogni genera le faceva ciò che voleva e voleva sempre il contrar io di ciò che faceva l'altro. Pepe e Carascosa si odiavano. Pignatelli qualificava Colletta «un mozzorecchi». Ciò malgrado la battaglia iniziata ai p r imi di magg io sembrava volgere al megl io , q u a n d o giunse la notizia che u n a seconda colonna austriaca aveva sfondato in Abruzzo e u n a terza scendeva da Roma su Gaeta. R inunz iando a un successo che pa reva a por t a t a di mano , Gioacchino r ipiegò in furia e, abbandona to il comando ai suoi l uogo tenen t i , accorse a Napol i . La folla di Via Ghiaia lo p o r t ò in tr ionfo (non si capisce di che) a palazzo reale. Ma nei «bassi» si cantava: «Tra Macerata e Tolentino -è finito Re Gioacchino. - Tra il Chien t i e il Potenza - finì l ' indipendenza!», e si p r e p a r a v a n o luminar ie pe r il r i to rno dei Borbone . A Carolina disse: «Tutto è p e r d u t o fuorché la vita, n o n sono riuscito a mori re», le affidò i p ieni poter i , e s ' imbarcò p e r Cannes . O r a m a i d o p p i giuochi n o n po teva più farne. L'unica sua speranza era Napoleone .
Napoleone , che se ne rendeva conto, fu d u r o . Attraverso un messo, gli chiese spiegazioni sulla sua condot ta del l 'anno p r ima e respinse la sua d o m a n d a di a r ruo lamento nell 'esercito che intanto stava allestendo pe r l 'ultima battaglia. Scriverà nelle sue Memorie: «Non mi sentivo abbastanza forte da impor r e ai soldati francesi un t radi tore come quello. Eppure, a Waterloo, forse Mura t mi avrebbe dato la vittoria».
Conf inato in u n a casa d i c a m p a g n a presso Grenoble , Gioacchino trascorreva quella febbrile vigilia a piangersi addosso in l u n g h e le t tere a tutt i . Il 19 g iugno ne scrisse u n a anche a Napoleone: «Non ho più nulla da chiedere a Vostra Maestà. Ella p u ò o rma i pronunzia rs i t ranqui l lamente sulla mia sorte, le sue volontà sa ranno eseguite: felice d 'essermi p e r d u t o p e r voi, nes sun l amen to uscirà dalla mia bocca. Che i vostri ministri mi facciano conoscere il luogo del mio esilio...» Ma n e a n c h e N a p o l e o n e aveva p iù nul la da fargli conoscere . Era lui che , def ini t ivamente sconfìtto i l g iorno pr ima, aspettava di conoscere il luogo del suo esilio.
222
A Napoli , Carol ina aveva t rasmesso i suoi po te r i agl ' inglesi che vi e rano sbarcati alla fine di maggio e che l'accolsero su u n a loro nave p e r i s t radar la a Trieste e consegnar la agli austriaci. Por tò via tu t to quel che poteva, perf ino u n a mucca che aveva un corno solo e si chiamava come lei, Carolina, in modo che d u r a n t e la traversata i bambini avessero il latte fresco. Dopo pochi giorni di navigazione, la nave incrociò lungo le coste Calabre quella che r ipor tava a Napol i Ferd inando . II comandan te si scusò con la Regina di dover sparare ven tun colpi di cannone a salve. «Lo prescrive il regolamento» disse in tono mortificato.
CAPITOLO VENTUNESIMO
DA FERDINANDO IV A FERDINANDO I
Sulla nave che lo r ipor tava a Napoli e che aveva incrociato quella che ne conduceva via Carol ina Bonapar te , re Ferdin a n d o era allegrissimo, e i motivi n o n gli mancavano. Il ministro inglese a Palermo A Cour t gli aveva pra t icamente lasciato carta bianca sulla Costituzione che il suo predecessore Bentinck aveva imposto, e Ferd inando ne aveva approfittato pe r appor tarvi delle r iforme che pra t icamente l 'annullavano. Poi, siccome il pa r lamento n o n si decideva a stanziare i «sussidi» richiesti dalla Corona , lo aveva sciolto. E o ra si cons iderava l ibero da tut t i g l ' impegni che con esso aveva contrat to , compreso quello di n o n lasciare la Sicilia senza la sua autorizzazione.
Ma c 'era di più. Pochi mesi p r ima , a Vienna , e ra mor ta Maria Carolina, che pe r Ferdinando rappresentava un peso ancora più oppr imente della Costituzione. Egli fece celebrare in suo suffragio un' infinità di messe, o rd inò la ch iusura dei teatri , indisse sei mesi di stretto lutto, e alla fine del secondo lo infranse sposando la signora Migliaccio, promossa pe r l'occasione Duchessa di Floridia, «donna - dice Colletta -di nobile stirpe, di volgare ingegno e pe r antiche libidini famosa». Dicono che il figlio Francesco tentò di oppors i alle nozze r ivelando al p a d r e gli scabrosi precedent i di quella signora , e che Ferd inando rispose: «Pienza a màmmeta , figlio mio, pienza a màmmeta!» Anche se non è vero, po t rebbe esserlo. Ora , secondo Lady Morgan, il Re andava r ipe tendo a tutt i : «Che bellezza! Ho u n a moglie che mi lascia fare quel che voglio, e un ministro che non mi lascia niente da fare!»
Il ministro era Medici. Ferd inando n o n lo amava, anzi lo
224
detestava, ma ne riconosceva l'efficienza. Era stato lui che aveva ideato le manovre pe r l iquidare Costituzione e Parlamento e p repa ra to il g rande r i torno a Napoli senza bisogno di c h i e d e r e permess i a nes suno . Il Re si e r a imbarca to in g iugno (del '15 , si capisce) facendosi p recedere da un p ro clama che diceva fra l'altro: «Napoletani, r i tornate fra le mie braccia, io sono na to t ra voi» e si ch iudeva con la so lenne promessa «della moderaz ione , della bontà , della reciproca fiducia».
De Nicola racconta che , sba rcando a Portici, il Re sembrava in stato di ubriachezza, tanto era eccitato e felice. Strapar lava mezzo r i d e n d o , mezzo s inghiozzando, e di ques to suo stato d 'an imo Medici approfittò largamente per indur lo a m a n t e n e r e il suo impegno di moderaz ione e di bontà . In realtà u n a repress ione tipo '99 sarebbe stata impossibile: il regime francese era du ra to un decennio e tutti, di b u o n a o di malavoglia, vi avevano collaborato. Di epurazioni quindi n o n ce ne furono , o si r idusse ro a ben poco . Forse Ferdin a n d o avrebbe voluto a lmeno a l lon tanare dall 'esercito gli ufficiali che vi avevano fatto ca r r i e ra sotto le b a n d i e r e di Mura t . Ma un c lamoroso episodio sop ravvenne a d i m o strargli che n o n c'era motivo di diffidarne.
Abbiamo lasciato Gioacchino al m o m e n t o in cui, fuggiasco da Napoli, r iparava in Francia. Non ci si trovò bene . Inviso a tutti, nostalgici del vecchio e fautori del nuovo regime, viveva in semiclandestinità gi rovagando fra Marsiglia, Tolone e Lione. Attraverso Fouché, Met ternich gli fece sapere che l'Austria era p ron ta a dargli asilo, a riconoscergli il titolo di Conte e a concedergli una decorosa pensione p u r c h é facesse atto di solenne r inuncia al t rono di Napoli. Ma m e n t r e si svolgevano questi negoziati , Gioacchino seppe che a Parigi era stato spiccato contro di lui manda to di cat tura e pe r sot-trarvisi r iparò , d o p o varie per ipezie , in Corsica. Anche qui la genda rmer i a voleva arrestar lo, ma i veterani della Grande Armata insorsero in sua difesa.
225
;«••• -1
Forse fu questo episodio a t rar lo in inganno , facendogli c redere che il suo prestigio e la sua popolari tà e rano ancora intat t i . Spedì emissari a Napol i p e r saggiarne gli u m o r i , e quelli to rna rono con notizie incoraggianti, che poi si rivelar o n o del tu t to infondate : la popolaz ione lo r impiangeva e soprat tut to l'esercito sperava in un suo r i torno. Superficiale ed entusiasta com'era , e viziato dalla for tuna, fece presto a convincersi che il suo sbarco laggiù sarebbe stato come quello di N a p o l e o n e in Francia al r i t o rno dall 'Elba coi soldati che, d o p o avergli mirato al pet to, avrebbero abbassato i fucili p e r sollevarlo in t r ionfo. Alcune teste calde i tal iane e francesi che gli si e r ano raccolte in to rno gliela davano pe r fatta. Col loro aiuto noleggiò sei t a r t ane , e su di esse il 28 se t tembre (del T5) p rese i l largo. In tutti e r ano duecen to cinquanta.
Buono dapprincipio , il t empo si mise al brut to , e una violenta tempesta scompaginò la flottiglia. Due dei sei legni fur o n o trascinati verso la Sicilia, d u e su Policastro. U no solo riuscì a res tare in contat to con quello di Gioacchino spinto nel Golfo di Sant 'Eufemia . Scoraggiato dalla malasor te , Gioacchino chiese al cap i tano , un ex-corsaro mal tese , di p rosegu i r e il viaggio a t t raverso lo stret to di Messina e l'Adriatico fino a Trieste. Il capi tano rispose che in tal caso doveva scendere a t e r r a pe r far incetta di viveri. Mura t , che forse diffidava di lui, rifiutò, e ne seguì un lungo alterco, cui alla f ine Gioacchino tagliò corto con u n a brusca decisione: scialuppe in acqua, e via al l 'avventura coi t ren ta compagni rimastigli. Era l'8 ot tobre.
Per la g rande scena che aveva immaginato e che doveva concludersi con la marcia trionfale su Napoli, Gioacchino si e ra confezionata u n a divisa appos ta con un cappello guarni to d i un f iocco t r icolore a p p u n t a t o con fermagli d i diamant i , spada con l'elsa dora ta e un c in turone g rondan t e di pistole. Alla testa del suo piccolo drappel lo , salì verso il paese ch 'e ra Pizzo di Calabria, e ne trovò la piazza affollata di gen te p e r c h é e ra g io rno di merca to . I l canonico Masdea,
226
che si trovò presente alla scena, racconta che tutti r imasero a bocca aper ta e senza fiato all 'apparizione di quegli uomini forse scambiandoli pe r banditi , ma q u a n d o questi l 'invitarono a g r ida re : «Viva re Gioacchino!», vol ta rono le spalle, si d iedero a precipitosa fuga, e di colpo la piazza fu vuota.
Gioacchino s i g u a r d ò i n t o r n o in t e rde t to , vide poco distante u n a compagnia di reclute che facevano le loro esercitazioni, si diresse verso di loro e li apostrofò in tono militaresco: «Voi siete miei soldati, ubbidi temi . Anda te su quella torre , ammaina te la bandiera , e al suo posto metteteci questa tricolore del vostro re Gioacchino». Anche quelli lo guarda rono a bocca aper ta e senza fiato, poi fecero ciò che avevano fatto i villici in piazza: voltarono le spalle e si d iedero a precipitosa fuga.
In quel momen to Mura t dovette capire che né lui era Napoleone, né l'Italia era la Francia. Ma ormai non aveva più scelta: bisognava andare avanti. Avanti c'era il capoluogo del c i rcondario, Monte leone , dove forse poteva t rovare dei seguaci, e vi si avviò di b u o n passo. Ma intanto a Pizzo la notizia della sua comparsa, volando di casa in casa, giunse all'orecchio di un capitano Trentacapilli, borbonico arrabbiato e arrivista di pochi scrupoli, che ci vide subito la g rande occasione di u n o scatto di grado. Alla testa di u n a banda di paesani a rmat i di schioppi e forconi, si lanciò al l ' inseguimento della pattuglia murat t iana , la raggiunse e l'assalì. Sotto u n a gragnuòla di pallottole, Gioacchino e i suoi si get tarono per balzi e d i rup i verso il m a r e nella speranza di r agg iungere i canotti e con essi la tar tana. I canotti c 'erano, ma la ta r tana era già scomparsa al largo. Molti mor i rono sotto la fucileria, altri cercarono a nuo to scampo sugli scogli, e Gioacchino si trovò solo di fronte alla turba inferocita. Per aver salva la vita, offrì i suoi gioielli, ma quelli non capi rono perché dovevano mercanteggiarl i , visto che potevano strapparglieli , come fecero, lasciandolo seminudo è coperto di ecchimosi e di sputi : perf ino i baffi gli avevano po r t a to via. Poi a calci e spintoni lo ri trascinarono in paese e lo chiusero nel sotterra-
227
neo del castello negandogl i anche l 'acqua. Solo q u a n d o sopravvenne da Reggio il genera le Nunzian te , al pr ig ioniero fu concessa una stanza decente e un t ra t tamento umano .
A Napol i la notizia n o n g iunse inaspet ta ta . I servizi d ' informazione avevano già saputo dei preparat ivi di Gioacchino, ma ignoravano dove e q u a n d o sarebbe sbarcato e sop r a t t u t t o come sarebbe stato accolto. Perciò la città era in stato di p rea l la rme e i comandi militari sotto controllo pe r preveni re sollevazioni e ammut inament i . Ma i t imori si rivel a rono del tu t to infondat i . Nessuno mosse un di to , n o n c i furono n e m m e n o degli appelli alla clemenza. Il Re o rd inò a Nunz ian te d i r iun i re sedu ta s tante un t r ibuna le d i g u e r r a che giudicasse i l p r ig ion ie ro come pubbl ico nemico . N o n suggeriva quale dovesse essere la sentenza, ma ingiungeva ch'essa fosse eseguita en t ro un quar to d 'ora dalla sua lettura. Cosa intendesse, era chiaro.
Gioacchino non se l 'aspettava. Anzi, nei suoi colloqui con Nunz ian te aveva de t to ch ' e ra p r o n t o a met ters i d 'accordo con Ferd inando r iconoscendo tutti i suoi diritti sulla Sicilia pu rché Ferd inando riconoscesse a lui quelli su Napoli: il che d imos t r a q u a n t o fosse fuori della real tà . P u r e , q u a n d o la b e n d a gli fu s t rappata dagli occhi, quegli occhi n o n bat terono ciglio. Si rifiutò di compar i re e di difendersi di fronte al t r ibunale perché , disse, un Re n o n p u ò essere giudicato dai suoi sudditi; scrisse u n a lettera di addio, commossa, ma senza enfasi, alla moglie e ai figli, e dopo aver ricevuto la comun ione da p a d r e Masdea, si avviò dicendo: «Andiamo a fare la volontà di Dio». Davanti al p lotone di esecuzione, rifiutò la b e n d a , si d e n u d ò il pe t to e p r e g ò i soldati di m i r a r e al c u o r e r i s p a r m i a n d o la faccia. Più che coraggio , sarà stata magari spavalderia e teatralità. Ma quella mor te salvò la legg e n d a del «Re cavalleresco e sventura to» . Croce racconta che fino al '60 e oltre, «era dato incontrare vecchi napoletani che usavano por ta re come reliquia, nel taschino, u n a mone ta di quel Re, e la t r aevano fuori p e r con t empla r l a e la baciavano sospirando».
228
Con la sua abituale insensibilità, Fe rd inando n o n capì che, graziando Mura t e m a n d a n d o l o a fare il pens ionato in Austria, avrebbe più facilmente debellato il murat t i smo. Egli si finse dispiaciuto di aver dovuto sacrificare la sua vittima alla ragion di Stato, ma in realtà t r ipudiava pe r quella ch'egli riteneva u n a dimostrazione di lealtà da par te del popolo; e di questo Medici approfit tò pe r por t a re avanti la sua cosiddetta politica «di amalgama», cioè di distensione. Il codice napoleonico fu sottoposto a u n a commissione di giuristi pe r i necessari adat tament i alle esigenze locali, ma per il momento venne confermato con la sola revoca del divorzio che del resto nessuno voleva.
Il grosso problema era la Sicilia, che seguitava a reclamare la sua au tonomia nel r ispetto della Costi tuzione del '12, secondo la qua le , se il Re fosse t o rna to a Napol i , av rebbe dovuto insediare sul t rono di Palermo il figlio pr imogeni to . In realtà, fo rma lmen te , le d u e co rone e r a n o s e m p r e state divise, t an t ' è vero che F e r d i n a n d o si ch iamava «Re delle Due Sicilie», ed era IV a Napoli e I I I a Palermo. Ma su questo p u n t o Medici, da b u o n illuminista fautore di un po te re accentrato, la pensava come il suo Sovrano, che di deleghe e divisioni n o n voleva sentir par lare . Con un trat to di penna, cui le Grand i Potenze non mossero obbiezioni, il Re delle Due Sicilie diventò «Re del Regno delle Due Sicilie», e di questo Stato g iur id icamente nuovo si p roc lamò titolare col n o m e di F e r d i n a n d o I . N o n era u n a ques t ione soltanto d i parole. Ciò significava che il Regno era unico con u n a unica capitale, Napoli , e un unico regime, quello di Napoli , dove di Costituzioni non se n 'e rano mai p romulga te .
A Palermo reagirono i baroni e i loro clienti; ma non certo le masse, che dal l ' au tonomia n o n avevano mai t ra t to alcun beneficio. Essi si rivolsero al l ' Inghi l terra ch 'era stata la madrina delle loro libertà costituzionali. Ma l ' Inghil terra aveva in quel momento un governo conservatore e per di più legatissimo all'Austria, l'alta pa t rona dell'assolutismo. Ferdinando potè quindi procedere in tutta tranquillità anche perché l'u-
229
nifìcazione del Regno era caldeggiata dagli stessi quadr i militari e amministrativi murat t iani , formatisi nel culto francese del central ismo. Anzi, F e r d i n a n d o ebbe anche i l des t ro di p r ende r s i u n a rivincita persona le sul suo arcinemico Ben-tinck, che gli aveva fatto inghiott ire tante umiliazioni, e che propr io in quel momento ebbe la cattiva idea di fare una visita a Napoli. Il Re, sapendolo ormai in disgrazia presso il suo governo, gli fece dire che non si azzardasse. Bentinck, col suo caratteraccio, non se ne dette per inteso e si presentò ugualmente , a bordo di una nave. La polizia consentì a sua moglie di andare a u n o spettacolo del San Carlo, e ve la scortò. Ma a lui non permise di metter piede a terra.
Tutto d u n q u e sembrava p rocedere nel migliore dei modi pe r il vecchio Re che aveva r ipreso le sue abitudini «lazzarone», convinto che il Decennio non fosse stato che un brut to sogno o rma i d i leguato . Viceversa n o n tu t to e ra così roseo come lui lo immaginava. L'opera distensiva di Medici trovava un grosso ostacolo nel Principe di Canosa che, come ministro della polizia, sfogava i suoi uzzoli reaz ionar i in u n a lotta a coltello cont ro la Carboner ia . Per meglio colpirla, le con t rapponeva un 'a l t ra società segreta, quella dei Caldera-ri, «atroce avanzo dei sanfedisti del '99», come la chiamava Medici che, fedele alle p r o p r i e vecchie ricette, n o n voleva persecuzioni . Canosa n o n badava ai mezzi pe r discreditare il suo avversario. Ritirò fuori la storia delle sue collusioni coi giacobini, intercettava la sua corr ispondenza, ispirava libelli contro di lui, e poteva contare sulla benevolenza del Re che, di t emperamen to , p ropendeva più pe r i suoi criteri spicciativi e forcaioli che p e r quelli di Medici. Quest i p e r ò aveva dalla sua la Duchessa di Floridia, che sia p u r e con metod i mol to p iù sottili e sfumati di quelli di Maria Carol ina , ma a p p u n t o p e r ques to più efficaci, esercitava su F e r d i n a n d o un forte ascendente . Fra i d u e ministri ci fu ape r t a ro t tu ra che scoppiò in piena r iunione di Gabinetto alla presenza del Re. Canosa det te a Medici di doppiogiuochista e Medici rispose dandogl i di p ro te t to re degli assassini. Bisognava sce-
230
gliere: o la politica del l 'uno, o quella dell 'altro. Ferd inando ci p e n s ò sopra un mese , po i scelse quel la di Medici , ma a mal incuore . Canosa si trasferì a Pisa dove pose m a n o a un t ra t ta to in t re volumi dal titolo: Perché il sacerdozio dei nostri tempi e la moderna nobiltà non siansi dimostrati egualmente generosi ed interessati come gli antichi per la causa della Monarchia e dei Re. Era un inno all 'Inquisizione, ai roghi e alla tor tura .
Liberato da quell 'ot tuso opposi tore , Medici ne incont rò tut tavia degli altri a ostacolare il suo lavoro di ama lgama . Specie nelle forze a rmate la pressione e i raggiri dei vecchi e lementi borbonici si facevano sentire. Per sventarli, fu nominata u n a commissione pres ieduta dal pr incipe Leopoldo , secondogeni to del Re, e formata da d u e general i della vecchia guardia e da d u e murat t iani . Ma i pr imi, p iù vicini alla Cor te anche pe r ché nobili, r iusc i rono a i n t r o d u r r e discriminaz ioni facendo d i u n a nuova decoraz ione che a n d a v a solo ai fedelissimi pe r «Costante Attaccamento» un titolo di preferenza negli scatti di g rado . Questa infelice trovata acuì a tal p u n t o la tensione fra gli un i e gli altri che pe r impedirle di scoppiare il c o m a n d o s u p r e m o fu affidato a un Generale austriaco, Nugent . Ma il r imedio si rivelò peggiore del male pe rché en t r ambe le par t i ci videro un affronto all 'onore nazionale.
Un al tro grosso m a l a n n o era i l b r igantaggio , che aveva r ipreso più v i ru lento di p r ima nelle province de l l ' in terno . Anche p e r comba t t e r e ques ta piaga, s i prefer ì d a r n e l 'appalto a un generale straniero, l'inglese Church , che un certo o rd ine lo r ipor tò , ma a prezzo di carneficine. I l r eg ime insomma, malgrado gli sforzi di Medici, seguitava ad essere quello ch 'era sempre stato: un regime di polizia, basato sulla pazienza e la rassegnazione dei sudditi , non sul loro consenso e partecipazione. La sua unica vera garanzia restava il trat tato stipulato con l'Austria che s ' impegnava a man tene r lo anche con le baionette. Qualsiasi moto liberale o costituzionale sarebbe stato u n a provocazione alla Potenza protettrice e un invito al suo intervento.
CAPITOLO VENTIDUESIMO
LA FINE DEL R E G N O ITALICO
Alcuni storici dicono che se Gioacchino perse il t rono per il suo d o p p i o giuoco, Eugenio Io perse pe r la sua fedeltà. Ci p e r m e t t i a m o di d u b i t a r n e , anzi c r ed i amo che lo avrebbe perso comunque .
Il Viceré era r ientrato dalla campagna di Russia nel maggio del ' 13 , d o p o aver eserci tato p e r qua lche t e m p o i l com a n d o sup remo disertato da Murat . Napoleone lo aveva rim a n d a t o in tu t ta fretta a Milano a p r e p a r a r e la difesa del Lombardo-Veneto dall 'attacco dell 'Austria che o rmai si p ro filava imminente : un compito che la situazione politica rendeva molto difficile. Del disastro di Russia la gente sapeva poco pe r ché le notizie a que i t empi viaggiavano len te e la censura vigilava. Ma, abituati da secoli a fiutare il vento prima che soffiasse, gl'italiani avevano capito ch'esso era girato: lo diceva, se n o n altro, il mancato r i torno dei loro soldati. Di 27 mila che n ' e r ano part i t i , n ' e r ano r ientrat i solo un migliaio, e i loro brandel l i e i loro racconti n o n lasciavano dubbi . Questi reduci e rano ciò che restava di un esercito la cui formazione era costata una d u r a lotta contro la secolare reni tenza degl'italiani alla coscrizione. I pochi cui si era riusciti a istillare una certa coscienza militare e rano stati sperperat i nelle gelate s teppe russe. E ora che si trattava di sostituir l i , i coscritti r i s p o n d e v a n o con la d iserz ione in massa. Gl ' i taliani n o n si ba t t evano volent ier i n e m m e n o sotto le b a n d i e r e del vincitore; f iguriamoci se volevano ar ruolars i sotto quelle del vinto. Quelli che accorsero al b a n d o cercar o n o di c o m p e n s a r e i vuoti col coraggio ind iv idua le . Ma e rano pochi, i soliti pochi di tutte le gue r r e italiane.
232
Per n o n restare in t rappola fra le d u e colonne austriache che scendevano dall 'Est e dal Nord , Eugen io concen t rò le p r o p r i e t r u p p e sull 'Adige, a b b a n d o n a n d o n a t u r a l m e n t e Istria, Dalmazia, T ren t ino , Friuli e quasi t u t to il Veneto compresa Venezia, che pe r sei mesi resistè pe r conto suo all'assedio d e n t r o la c intura delle sue lagune. In quel momento al Viceré si p r e s e n t ò il des t ro di con t r a t t a r e il p r o p r i o t rono. Suo suocero, il Re di Baviera, che frattanto era passato nel campo degli Alleati, gli m a n d ò un messo pe r invitarlo a fare al t re t tanto promet tendogl i in compenso la corona di Re, che Napoleone gli aveva sempre negato. Rispose Eugenio: «Credo che anche Voi preferiate un gene ro senza corona a un g e n e r o senza onore» . N o n che alla co rona avesse ormai r inunziato. Q u a n d o l ' Impera tore gli o rd inò di accorre re col suo esercito in Francia dove stava t en tando l 'ultima resistenza, il Viceré nicchiò a p p u n t o pe r affermare i suoi diritti sul Regno Italico; ma si rifiutò di comprar l i col t radimento .
I l voltafaccia di Gioacchino che sopraggiungeva da Sud col suo esercito, l 'obbligò a r e t r o c e d e r e ancora sulla l inea del Mincio; ma qui gli austriaci r icevettero u n a secca batosta, e a infliggergliela fu rono sopra t tu t to i r epar t i italiani, comanda t i dal genera le Zucchi. Era i l m o m e n t o (febbraio del T4) in cui anche Napoleone r iportava i suoi ultimi successi. Sembrava che la for tuna stesse pe r cambiare nuovamente cavallo. Sebbene ufficialmente in gue r ra con la Francia, Gioacchino non si muoveva dalla linea del Po, anzi mandava lettere p iene di devozione a l l ' Impera tore e di affetto a Eugenio, assicurandolo che n o n avrebbe mai attaccato.
Ma a Milano sentivano tuonare il cannone , e il c annone in Italia trova sempre un part i to disposto a fargli eco. Quello austriacante, di cui negli ultimi anni s'era perso ogni traccia, risultò improvvisamente fortissimo. Dalla sua aveva n o n solo i buoni r icordi della seria, onesta, efficiente burocrazia di Vienna, ma anche la litigiosità degli avversari , divisi fra quelli che volevano la conferma del Regno Italico sotto la
233
corona di Eugenio, quelli che preferivano un Principe indigeno come Francesco di Lorena-Es te (il fu turo Francesco IV di Modena) ch 'era nato a Milano, e quelli che pensavano a d d i r i t t u r a a un R e g n o p iù vasto e di ca rà t t e re nazionale sotto lo scettro di Murat .
Costui nel mese di apri le rompeva gl ' indugi a t taccando da sud l'esercito franco-italiano. Sebbene ancora non sapesse che Napo leone aveva abdicato, lo aveva intui to e voleva g u a d a g n a r s i b e n e m e r e n z e presso gli Alleati. Per Eugen io non c'era scampo. Il 15 aprile concluse un armistizio col genera le austr iaco Bel legarde, che autorizzava ufficiali e soldati francesi a r ient rare in patria, men t r e gl'italiani sarebbero rimasti nelle loro fortezze e guarnig ioni . Le t r u p p e austr iache avevano l ibero passo, ma senza dir i t to di occupazione, nei terri tori del Regno, la cui sorte sarebbe stata decisa dagli Alleati a Parigi, dove i milanesi potevano m a n d a r e una delegazione pe r espr imere i loro desideri .
Di questi des ider i cercò di farsi i n t e r p r e t e Melzi d 'Eril . Era ancora il migl ior cervello polit ico, anzi l 'unico, di cui Milano disponesse. Con l'istituzione del Regno, non era più stato in p r i m o p iano , ma aveva segui ta to a eserci tare u n a forte inf luenza come p re s iden t e del Senato . Egli la usava con la discrezione del gran signore, ma a p p u n t o pe r questo il suo consiglio pesava, specie nelle emergenze . Il 17 convocò i l Senato , e sebbene n o n potesse in tervenirvi p e r un attacco di gotta, m a n d ò un messaggio con la propos ta d'inviare subito a Parigi la delegazione pe r ch iedere l ' indipendenza e l ' integrità del Regno sotto la corona di Eugenio. Ma il Senato n o n fu d 'accordo e preferì imboccare una di quelle «mezze vie» che sono sempre state la specialità del piccolo machiavellismo italiano. Esso decise di m a n d a r e a Mantova u n a commissione p e r e sp r imere al Viceré «i sent iment i di ammirazione pe r le sue virtù e di gra t i tudine per il suo governo», ma senza nessun impegno di difendere la sua causa a Parigi.
Disorientata da voci contrastanti e aizzata da improvvisa-
234
ti t r ibuni, la città tumultuava. Annusando odore di saccheggio, mol ta gente vi e r a accorsa dal con tado , carica di od io verso le cosiddette «marsine ricamate», cioè in parole povere gli esponenti del regime. Il 20 u n a folla inferocita n o n si sa b e n e con t ro cosa i r r u p p e d e n t r o il Senato e lo devastò, poi s ' incolonnò in corteo verso la casa di Melzi. Ma per strada cambiò idea e si diresse invece verso l 'abitazione di Pri-na, di cui si diceva che nascondesse favolose ricchezze. Non era vero: Prina non aveva un soldo, ma aveva monta to u n a macchina fiscale rigorosa ed efficiente, di cui tutti, dal più al meno , e rano stati vittime.
Gli amici gli avevano consigliato di p r e n d e r e il largo. Ma il ministro n o n aveva voluto saperne . Vedendosi assalito, si nascose in soffitta e tentò di ecclissarsi vestito da pre te . Ma lo r iconobbero, lo t rascinarono per strada e cominciarono a di laniar lo . Alcuni coraggiosi passant i lo sp insero d e n t r o il po r tone di un 'al t ra casa, e fra di essi c'era anche Foscolo che a r r ingò gli aggressori pe r persuader l i a desistere. Ma fu travolto anche lui e Prina, non volendo espor re a rappresagl ie i suoi soccorritori, si r iconsegnò di p ropr i a volontà ai manigoldi che lo sot toposero a un coscienzioso linciaggio s t rappandogl i occhi, dent i e lingua.
Q u a n d o Eugenio seppe di que l l ' o r r endo delit to, scrisse al genera le Pino che comandava la guarn ig ione di Milano: «Fate sapere al popolo che se n o n si acquieta, compromet te la sua esistenza politica e l ' i n d i p e n d e n z a avvenire». Ma il popo lo a tu t to pensava fuorché a l l ' i nd ipendenza ; e i dir igenti, atterrit i dall 'esempio del Prina, spedi rono emissari al quart ier generale austriaco pe r supplicare l'invio di t r u p p e che ristabilissero l 'ordine. Tale era l 'abi tudine a fidare soltanto nello s t raniero e a chiamarlo arbitro nelle contese italiane che a nessuno venne in testa di chiamare in soccorso i r epa r t i italiani tu t to ra concent ra t i a Mantova . E questa rinuncia alla p ropr ia difesa era anche la r inuncia alla p ropr ia indipendenza .
Per Met te rn ich fu la m a n n a . Egli aveva già avuto dagli
235
Alleati solidi aff idamenti circa i l r e c u p e r o del L o m b a r d o -Veneto. Ma la faccenda n o n e ra stata ancora regolata, e in sede di trattative potevano nascere complicazioni. L'appello della Reggenza milanese creava il fatto compiuto e lo giustificava d imos t rando che il Regno non aveva n e m m e n o la forza di garant i re i l p ropr io o rd ine in terno. Eugenio ne trasse le sue conclusioni. Scrisse a Melzi: «Tutti i miei doveri sono finiti , io n o n ho più ordini da dare», e la mat t ina del 27, con la moglie e i figli, si avviò attraverso il B renne ro alla volta di Monaco di Baviera, la capitale di suo suocero.
A insorgere contro la Reggenza furono gli ufficiali dell 'esercito che se ne sen t i rono tradi t i . Alcuni di essi corsero a Milano p e r i n d u r r e i l loro c o m a n d a n t e , genera le P ino , a band i re la resistenza a oltranza. Ma Pino diplomaticamente decl inò. Allora b r u c i a r o n o le b a n d i e r e sotto cui avevano comba t tu to in Russia sa lvandone sol tanto gli s t emmi che venne ro affidati al generale Lechi, il quale visse abbastanza pe r farne omaggio a Carlo Alberto nel '48.
Alla fine del mese le t r u p p e austr iache fecero il loro ingresso a Milano, dove si e r ano riuniti i collegi elettorali, ma della sola Lombardia , perché ormai Veneto ed Emilia e rano dati pe r persi. Li presiedeva il conte Giovio che, d o p o aver innalza to p e r a n n i elogi alla Francia , concluse così la sua orazione: «Possano le Alpi, le u n e sopra le altre ammassate, separarci da quella nazione che sempre por tò l ' infortunio e la desolazione nella patr ia nostra». E quell 'ammasso di Alpi dimostrava che questi Italici valevano poco anche come ré-tori.
Solo ora che l 'occupazione austriaca era cosa fatta, si decisero a m a n d a r e a Parigi la famosa delegazione, il cui capo più autorevole era il conte Confalonieri. Poco d o p o l 'arrivo, egli scrisse ai colleghi di Milano: «Tardi siam giunt i , e ciò pe r inesplicabile imbecillità di chi ordì la p ropr i a e la nostra rovina», comple t amen te d iment ico di essere stato p r o p r i o lui ad avversare e r i t a r d a r e f in al lora quella missione pe r odio cont ro Eugenio . L ' imperatore Francesco d'Austria gli
236
aveva det to chiaro e tondo: «Voi mi appar tene te pe r diritto di cessione e pe r dir i t to di conquista». E il p r i m o minis t ro inglese Cas t le reagh lo avvertì che cons iderava l 'Italia u n a r iserva di caccia austr iaca. Q u a n d o , di r i t o r n o a L o n d r a , p ropr io pe r questo fu attaccato in par lamento , Castlereagh r ispose: «Che ha d u n q u e fatto l 'Italia pe r meri tars i di meglio?»
I I n o n aver fatto nul la n o n i m p e d ì agl ' i tal iani, q u a n d o conobbero il t rat tato di Fontainebleau che faceva del Lombardo-Veneto u n a provincia austriaca, di sentirsi le vittime di un t r ad imento . Subito cominciarono a complot tare ; ma, come al solito, invece di affidarsi alle p ropr ie forze cercarono di evocarne qua l cuna dal di fuori che venisse a t rar l i d ' impaccio. E siccome nessuna delle Grandi Potenze ne aveva l ' intenzione, eccoli rivolgersi al pr igioniero dell 'Elba. Fra le molte lettere che questi cominciò a ricevere a p p e n a arr i vato nell'isola, le più pressanti e r ano p rop r io quelle degl'italiani raccolti in g r u p p i e circoli dai nomi immaginosi : Gli avvoltoi di Bonaparte, Lo spillo nero, I Cavalieri del Sole ecc. Dicevano: «Vasta congiura ferve pe r tut ta Italia... Sire, un sol grido vostro, un sol passo, bas te ranno a far sorgere la nazione intera...» Era l 'anticipo della g r a n d e illusione di cui si sarebbe nutr i to tut to il Risorgimento.
U n a congiura ci fu, ma tut t 'a l t ro che vasta, ed ebbe pe r protagonisti un g r u p p o di ufficiali. Gli austriaci avevano deciso d ' incorporar l i nel loro esercito, ma dislocandoli in altre province del loro I m p e r o pe rché di lasciarli in Italia n o n si fidavano. La r ipugnanza a questo trasferimento in cont rade r e m o t e d i cui n o n conoscevano n e m m e n o la l ingua, ol t re che quella a servire sotto una bandiera diversa dal tricolore, spinse alcuni di loro a cercare contatt i con gl'inglesi. A far sperare in un loro aiuto era Bentinck che si trovava tut tora in Italia e che, come al solito, seguitava a svolgere una politica personale in contrasto con quella del suo governo. Tra i fautori di questa iniziativa ci fu anche Foscolo ch 'e ra r imasto sotto le a rmi col g rado di maggiore e che prese contatti
237
col genera le Macfar lane. Ques t i fu esplicito nel r i f iutare qualsiasi collaborazione. Ma n e m m e n o questo valse a smonta re gli an imi . Tut t i e r a n o convint i che sa rebbe successo qualcosa, che qualcuno sarebbe venuto in aiuto, e il ba rone von Hùge l annotava nel suo diar io: «Aspettano un Messia, che ristabilisca il Regno di Dio in Italia».
Perfet tamente al co r ren te di queste tresche, gli austriaci a l l on tana rono Foscolo facendogli affidare dalla Reggenza u n a vaga missione militare a Bologna e accelerarono i tempi dell ' integrazione dei d u e eserciti. Fu in questo m o m e n t o che nacque la vera e p ropr ia congiura. Essa part ì dai colonnelli, coinvolse alcuni civili, ma n o n trovò nessun genera le in attività di servizio disposto ad assumerne la guida e la responsabil i tà . I l p iù au torevo le , Zucchi, accettò di esserne in formato , ma r ispose che n o n c redeva alla disponibi l i tà della t r u p p a né alla partecipazione popolare che i congiurati davano pe r scontate. Lo stesso Foscolo rifiutò la sua adesione. «L'Italia è cadavere - scrisse -, che n o n va tocco né smosso pe r non provocare più tristo il fetore», e si augurava che i venti ne disperdessero le ceneri .
Il Maresciallo austriaco Bellegarde non p rendeva sul serio questo t ramest io. Fu la polizia che l 'obbligò ad agire in seguito alla denuncia d 'un delatore francese, insinuatosi fra i cospiratori. Sulla fine del l 'anno i maggiori responsabili furono tratti in arresto e trascinati davanti a un t r ibunale speciale sotto accusa di t rad imento . Ma le condanne furono miti: nessuna superò i d u e anni di carcere. Zucchi, che già aveva assunto il suo c o m a n d o in Moravia, fu messo agli arresti in fortezza, ma poco d o p o re integrato nelle sue funzioni. La collocazione a r iposo la chiese egli stesso, c o m p r e n d e n d o che la sua carr iera era c o m u n q u e finita. Più spietato del tribuna le , Foscolo scrisse che i protagonis t i di quella vicenda ne uscivano copert i non di eroismo, ma di ridicolo. Forse a ispirargli tanta severità e ra anche i l r imorso di n o n avervi partecipato. Ma tutti i torti non aveva: quel tentativo era stato velleitario, di let tantesco e fuori t empo . La g r a n d e occa-
238
sione, gl 'I taliani di Milano l 'avevano persa q u a n d o , invece di unirsi a difesa della propr ia indipendenza , si e r ano divisi di f ronte agli avanzant i eserciti austr iaci , anzi l i avevano chiamat i a ristabilire l 'ordine , e o ra n o n facevano che r infacciarsi le colpe gli uni agli altri app ro fondendo e moltiplicando le p ropr ie divergenze.
Gli effetti si videro q u a n d o la gue r ra to rnò a d ivampare in segui to alla fuga di N a p o l e o n e dal l 'Elba. N e m m e n o la comparsa in Emilia di Murat e il suo proclama di Rimini susc i tarono in L o m b a r d i a a lcuna eco. In tu t ta t ranqui l l i tà l'Austria potè c o n d u r r e a te rmine la sua opera d' integrazione che poi , d o p o Water loo , i l Congresso di V ienna sanzionò. Il Lombardo-Veneto fu eret to in Regno, ma solo prò forma. I d u e Governa to ra t i che lo c o m p o n e v a n o - quel lo della Lombard ia con sede a Milano, e quello del Veneto con sede a Venezia - d ipendevano d i re t tamente dalla Cancelleria austriaca. Molto p iù intel l igente dei Savoia e del Papa, Met ternich n o n pre tese t i rare un colpo di spugna su tu t to l ' o rd inamento amminis t ra t ivo e legislativo francese. Molte cose le man tenne , e se altre ne riformò, fu pe r i n t rodu r r e al loro posto le regolamentazioni austriache ch 'e rano anch'esse fra le più avanzate d 'Eu ropa . Tuttavia a lcune conquis te a n d a r o n o p e r d u t e . Per esempio , v e n n e res taura to i l fede-commesso e altre consuetudini feudali che consent i rono alla nobiltà di r i p r e n d e r e il passo sulla borghesia. Fu abolita la pubblici tà dei processi ch ' e r a la più solida garanzia del cittadino contro i soprusi della polizia e gli arbitri della magistratura. Fu confermata la coscrizione, ma le reclute andavano a servire fuori d'Italia sotto u n a band ie ra che n o n era i l t r icolore, ma quella giallo-nera dell 'Austria ch ' e ra anche la b a n d i e r a del Regno . L 'o rd inamento t r ibu tar io , che con Pr ina aveva da to eccellenti p rove di funzionali tà, r imase . Quan to a quello scolastico, fu migliorato, ma anche sottoposto a un controllo molto più severo. «Sappiate, signori - disse l ' Impera tore ai professori dell 'Università di Pavia, quando venne a p r e n d e r possesso delle province lombarde - che
239
io n o n voglio letterati; voglio solo suddit i fedeli a me e alla mia Casa.»
Bellegarde, che dappr incipio esercitò i pieni poteri , non ne abusò, anzi. D'origine savoiarda e quindi mezzo italiano, fece del suo meglio pe r togliere al nuovo regime ogni carattere repressivo. Ma l'ostacolo più grosso lo trovò nella stessa popolazione. La sua scrivania era i ngombra di lettere anonime scritte da italiani contro altri italiani pe r farli licenziare e occuparne il posto: un vizio di antica data , dest inato a restare nel sangue del nostro Paese. Q u a n d o l 'arciduca Giovanni venne a Milano a insediarsi nella carica di Viceré, dovette mettercela tut ta pe r frenare lo zelo di nobili e pret i austriacanti che volevano far e p u r a r e perfino gli affreschi dipinti dall 'Appiani in palazzo Reale.
Nelle sue mani , Bellegarde aveva rimesso i p rop r i poteri e gl ' italiani g i u r a r o n o «di essere fedeli e obbedien t i a Sua Maestà». Il Viceré contava poco: i suoi compiti e r ano pura m e n t e r appresen ta t iv i . Ma i l Mont i , che tant i inn i aveva sciolto a Napo leone e a Eugenio , ne sciolse u n o g r o n d a n t e d'iperboli anche a lui. Foscolo, cui sarebbe bastata una quartina per «inserirsi», n o n solo tacque, ma rifiutò la direzione d ' un giornale let terario che gli austriaci gli avevano offerto per adescarlo, e prese la via dell'esilio. Non avrebbe mai più rivisto la sua patria.
CAPITOLO VENTITREESIMO
IL R I T O R N O DEI SAVOIA
Il 20 maggio 1814, Torino si e ra para ta a festa pe r accogliere i l Re sabaudo che tornava sul t rono . Napo leone in quel m o m e n t o era all'Elba, e doveva ancora giuocare la sua ultima carta. Ma il Congresso di Vienna aveva già deciso di rest i tuire il P i emon te al suo legi t t imo Sovrano e anzi di agg i u n g e r e alla sua co rona la Repubbl ica di Genova pe r indennizzarlo di Nizza e della Savoia che il ministro degli esteri francese Talleyrand era riuscito a conservare - pe r il momen to - al p ropr io Paese.
Vittorio Emanue le I aveva c inquantacinque anni , ma ne d imos t rava molt i di p iù . Era i l s econdogen i to di Vit tor io Amedeo I I I che, scomparso nel '96 q u a n d o la bufera napoleonica si abbat teva sui suoi Stati, aveva avuto sul letto di m o r t e u n a sola consolazione: quella d i vedersi c i rconda to da ben cinque figli maschi che sembravano garant i re la continuità della dinastia. A succedergli era stato il p r imogeni to Carlo Emanuele , che p u r t r o p p o era il m e n o qualificato a fare i l Re, specie in un m o m e n t o come quel lo . Tu rba to da scrupoli religiosi cui si agg iungevano forti crisi depressive, aveva anche avuto la disgrazia di sposare u n a pr inc ipessa spagnola ancora più bacche t tona e t imida di lui. I l matr i monio era anda to benissimo pe rché o g n u n o dei d u e cercava e trovava nell 'altro uno scampo alle p ropr i e angosce; ma non aveva dato eredi .
La situazione che Carlo Emanuele aveva eredi tato era catastrofica. La pace di Cherasco det tata da Napoleone nel '96 faceva p r a t i c a m e n t e del P i emon te un p r o t e t t o r a t o del la Francia, che solo p e r comodi tà vi aveva lasciato la vecchia
241
dinastia. Ma tre ann i d o p o il Diret torio decise di l iquidare anche quella. Il Re par t ì di not te con la Regina, suo unico confor to . Ma q u a n d o essa mor ì , n o n ebbe più la forza di cont inuare a por ta re da solo il peso di quelle t r e m e n d e responsabil i tà, e abdicò in favore del fratello pe r r i t i rarsi in un monas te ro p r ima di Firenze, poi di Roma, dove tu t tora viveva, mezzo cieco.
Vittorio Emanuele , che con gli altri fratelli aveva dovuto seguirlo nell 'esilio, n o n aveva molta più stoffa e vocazione di lui. Nella speranza che Napoleone fosse finalmente sconfìtto dalle coalizioni che c o n t i n u a m e n t e gli si a n n o d a v a n o con t ro , aveva girovagato fra Roma e Napoli pe r teners i in contat to con le altre Potenze e r ichiamar loro alla memor ia i suoi diri t t i sul P iemonte . Solo d o p o che il Bonapa r t e si fu annessa tut ta la penisola scacciando dai loro t roni anche il Papa e i Bo rbone , si decise a rifugiarsi nel l 'unico Stato rimastogli, la Sardegna , dove già si era istallato il resto della famiglia, e di cui aveva affidato il governo al fratello Carlo Felice.
Furono anni di afflizioni, anche finanziarie. I Savoia non avevano mai guazzato nel l 'oro , e poco c'era da s p r e m e r n e in quell ' isola a r re t r a t a , semideser ta e infestata dalla malaria, le cui uniche risorse e rano la pastorizia e un po ' d'agricoltura. Per quanto abituata alla parsimonia, la Corte dovette fare parecchi sacrifici. Ma alle difficoltà mater ia l i si agg iungevano le preoccupazioni politiche: Napo leone seguitava a vincere e il suo secondo mat r imonio con Maria Luigia, che creava un legame di parente la fra le dinastie imperiali di Francia e Austria, toglieva ogni prospet t iva di rinascita allo Stato p iemontese vissuto s e m p r e sulla rivalità fra quelle d u e potenze . E infine si profilava un altro pericolo, p r o p r i o quello da cui Vittorio Amedeo si era c redu to al sicuro : la mancanza di un successore. Dei c inque figli ch'egli aveva lasciato, d u e nel f ra t tempo e r ano mort i ; Carlo Emanue le n o n aveva avuto e red i , Vit torio E m a n u e l e ne aveva avuti t re , ma d u e e r a n o femmine, i l maschio era mor to in
242
fasce e la r eg ina Maria Teresa, figlia d ' u n Arc iduca d 'Austria e di u n a Este di Modena, non riusciva più a concepire. Restava, u l t ima speranza , l 'altro fratello, Carlo Felice che, p u r n o n avendone p u n t a voglia, dovette decidersi a l matr imonio , ma scelse male . La sposa, figlia di Fe rd inando e di Maria Carolina di Napoli, era p iena di virtù, ma sterile. Insomma, di tut ta la dinastia Savoia, così frondosa fino all'ultima generazione, non restava che un lontano cugino del ramo cadet to Car ignano : un ragazzo di n o m e Carlo Alberto, di cui si e r ano un po ' perse le tracce pe rché suo pad re , arruolatosi nell 'esercito napoleonico, lo aveva condot to e allevato in Francia.
Nel 1812, la magg iore delle d u e figlie di Vit torio Emanue le , Maria Beatr ice, a n d ò sposa a Francesco di Lo rena -Este, fratello della Regina e quindi zio della Principessa, e la voce corse che il Re si disponesse a nominar la e rede al t rono. N o n era così. Nel contrat to matr imoniale anzi era specificamente det to che Maria Beatrice giurava di r inunciare a qualsiasi pretesa sugli Stati del pad re . Ma il p rob lema si era posto ed era stato discusso. Se lo si e ra risolto in quel senso, era perché la legge salica che vigeva in casa Savoia escludeva la successione in l inea femmini le , e p e r inf ranger la sarebbe occorso i l consenso delle a l t re m o n a r c h i e e u r o p e e , che Dio sa di quale mercato ne avrebbero fatto oggetto. Tuttavia lo stesso contrat to aggiungeva che, in mancanza assoluta di eredi maschi - cioè nel caso in cui anche Carlo Alberto fosse venu to m e n o p e r qualche r ag ione - , l ' impegno n o n avrebbe avuto effetto. Restava quindi u n o spiraglio alla successione di Maria Beatrice, d o n n a ambiziosa e moglie di un mar i to ambiziosissimo. E ques to spiragl io e ra des t ina to a pesare sui successivi avvenimenti .
I l mat r imonio era avvenuto p ropr io nel m o m e n t o in cui Napoleone part iva pe r la catastrofica spedizione in Russia. Dopo poch i mesi rientrava con l 'esercito in b rande l l i , e le G r a n d i Potenze , n u o v a m e n t e coalizzate, Io ba t tevano a Lipsia. Vittorio Emanuele , che invano aveva cercato di met-
243
tere insieme un po ' d'esercito pe r par tec ipare all 'ultima fase di quella campagna , a p p e n a potè s 'imbarcò pe r Genova, affidando la Sardegna alla moglie e a Carlo Felice. E Massimo D'Azeglio, che vi si t rovò p r e sen t e , così descrive la sua ricomparsa a Torino nella carrozza prestatagli da suo pad re :
«In questo cocchio il b u o n Re, con quella sua faccia, via diciamolo, un po ' di babbeo, ma al tret tanto di ga lantuomo, girò fino al tocco d o p o mezzanotte passo passo le vie, fra gli evviva della folla, d is t r ibuendo sorrisi e saluti a diritta e a sinistra; i l che portava, pe r meccanica conseguenza, un incessante spazzolare da sinistra a destra di quella sua coda, tanto curiosa ormai pei giovani della mia età». Era infatti vestito all 'uso antico con par rucca incipriata, e in to rno a lui e ra tut to un frusciare di z imarre settecentesche e tonache fratesche.
Quale senso letterale egli desse alla parola restaurazione lo d imost rò i l decreto emana to l ' indomani , che r ichiamava in vigore tut te le leggi e costituzioni del '96 facendo tabula rasa di quelle degli ultimi t re lustri. Nobili e pre t i riacquistavano tutt i i loro privilegi ai d a n n i della borghesia che perdeva molti dei suoi più sudati diritti. E l 'applicazione di questa n o r m a venne affidata a funzionari come il Bellosio che proget tò addi r i t tura di far saltare il pon te sul Po pe rché era stato costrui to dai francesi, e dovet te r inunciarv i solo per ché a u n o dei suoi capi c 'era u n a villa della Regina. Ma se ne rivalse c h i u d e n d o i l valico de l Moncenis io p e r c h é ad apri r lo era stato Napoleone e i s t radando il traffico sulla disselciata e tor tuosa s t rada della Novalesa. Gli alti quadr i dell 'amminis t razione v e n n e r o epura t i p e r fare pos to a coloro che li avevano occupat i p r ima del '98 e, se frat tanto e rano mort i , ai loro figli e nipoti . Gli ufficiali che avevano servito sotto la band i e r a francese e vi avevano g u a d a g n a t o medaglie ed esperienza, venne ro retrocessi d i un g rado , men t re gli alti comand i venivano affidati a vecchi ufficiali in ri t iro da quindici anni . L'Università venne meticolosamente purgata dei suoi migliori docenti , i Gesuiti r iebbero l'esclusiva
244
dell ' istruzione, e il mercato del lavoro r icadde in mano alle resuscitate corporazioni, r igide custodi d'interessi m o n o p o listici.
E te rna dannaz ione di tu t te le Restaurazioni , gli ex-fuorusciti e r ano tornat i in massa, pieni di rancore e convinti di p o t e r r ip r i s t ina re i l vecchio r e g i m e assolutista, in tu t t a la sua feudalesca impalcatura. Si giunse fino a negare al creditore plebeo il diritto di citare in giudizio il debi tore nobile.
Men t re il Re era intento a r imet tere indiet ro di quindici ann i la lancet ta del suo orologio , gli g iunse u n a le t tera di Carlo Alberto, s tudente in un collegio di Bourges, che metteva «ai suoi piedi l 'omaggio della sua sottomissione». E subito d o p o la lettera, arrivò lui stesso. Vittorio Emanuele accolse pa t e rnamen te quel giovanotto altissimo e magrissimo, e scrisse al fratello di averne r i trat to l ' impressione di «un ragazzo di b u o n cuore e di b u o n a volontà, ma di cui c'è da rifare tut ta l 'educazione». N o n ci voleva molto pe rché l 'educazione di Carlo Alberto era poca cosa. Ma quella poca era pe r metà francese, cioè giacobina, e pe r l 'altra metà svizzera, cioè pro tes tan te : che, in u n a Cor te retr iva e bigotta come quella, e ra considerata farina del diavolo. Per far lui un b u o n Savoia, i l Re gli det te come tu tore i l conte d i m a ni, che ai Savoia r improverava di n o n aver res taura to l 'Inquisizione, la to r tu ra e i roghi .
F ina lmente , d o p o tanti u ragan i , sembrava che nel cielo del P iemonte il sole fosse to rna to a bril lare. La fuga di Napoleone dall 'Elba aveva costretto il Congresso di Vienna ad aggiornare le sue decisioni per da r m o d o alle Potenze di rip r e n d e r e la lotta con t ro i l «br igante còrso». P u r con un esercito in crisi di r icosti tuzione, Vittorio E m a n u e l e riuscì ad agganciars i all 'alleanza e , anche se n o n po tè esser p r e sente a Waterloo, fu in g rado di sparare qualche cannona ta con t ro i francesi a Grenob le . Q u e s t o gli valse, q u a n d o il Congresso to rnò a riunirsi , u n a posizione di cobelligerante, che a sua volta gli fruttò la resti tuzione di Nizza e della Savoia.
I In
245
Così, da tut to quel t rambusto di gue r r e e di occupazioni, il Regno usciva non soltanto re integrato nei suoi vecchi Stati, ma maggiorato della Liguria. E n o n era poco.
Ma n o n altret tanto favorevole era la situazione interna. Com'era logico at tendersi , sbolliti i p r imi entusiasmi pe r
il r i torno della vecchia dinastia cui la popolazione era sinceramen te affezionata, cominciò a farsi sentire la reazione degl ' interessi lesi da quel l ' insensato r i to rno al passato. L'epicentro della scontentezza era Genova, ent ra ta a mal incuore a far pa r t e di u n o Stato che aveva s e m p r e cons idera to nemico, e ancora attaccata alle p rop r i e istituzioni repubblicane . Q u i le incompat ib i l i tà n o n e r a n o sol tanto poli t iche e ideologiche; e r ano anche economiche . Come tut t i i g rand i port i , Genova viveva di traffici, cioè di libero scambio; e ora si trovava invece pr ig ioniera di un sistema vincolistico, che aveva riprist inato perfino le dogane in te rne fra provincia e provincia. Per di più vedeva affidate tut te le cariche amministrat ive a p iemontes i , che di m a r e , di navi e di noli n o n sapevano e n o n capivano nulla. Il r isent imento era condiviso da tutti: dagli scaricatori alle grandi famiglie, che si chiusero sdegnosamente nei loro palazzi r if iutando ogni contatto coi proconsoli di Torino.
In Piemonte la cosa era diversa. Contadina e montanara , la massa della popolazione aveva visto con favore quel ritorno all 'antico. Ma e r ano le borghesie ci t tadine che n o n vi si rassegnavano perché e rano esse a farne le spese. Sotto l'amministrazione napoleonica e r ano cresciute di n u m e r o e di po tenza p e r le g r a n d i occasioni che gli avevano offerto le forniture militari, la vivacità degli scambi con la Francia e la Svizzera, la facilità di accesso alle più alte funzioni militari e civili. Era logico che non si rassegnassero a un regime che le escludeva dal potere , le colpiva nel portafogli e le squalificava socialmente.
Il loro scontento trovava eco in quella frangia della nobiltà che, p u r devota alla dinastia, nutr iva sentimenti libera-
246
li, aveva in qualche m o d o collaborato con le autori tà francesi, e pe r questo era stata al lontanata dalla Corte e dalle cariche. Alcuni suoi rappresentant i , e fra i più illustri, str insero rappor t i s empre più stretti con gl'intellettuali di estrazione borghese. Di questi ultimi i più vivaci, come il Di Breme e il Pellico, prefer i rono emigrare a Milano, dove a lmeno avevano un giornale cui far capo: // Conciliatore. Gli altri si r iunirono in un'Accademia, i Concordi, che tuttavia potè fare ben poco, sottoposta com'era a u n a censura puntigliosa e ottusa.
In ques ta statica e asfissiante a tmosfera , in ques to ambiente meschino e senza orizzonti, era fatale che soprat tut to i giovani si volgessero alle società segrete che schiudevano, se n o n al t ro, prospet t ive di lotta e d ' i m p e g n o . Ce n ' e r a n o già d u e , gli Adelfi e i Filadel.fi che nel '18, a quan to pa re , si fusero nel corso di un segre to convegno tenutos i ad Alessandr ia , o p e r megl io d i re pa s sa rono sotto i l cont ro l lo di u n a nuova organizzazione, i Sublimi Maestri Perfetti, fondata e d i re t ta da un r ivoluzionario italiano ormai natural izzato francese, di cui dovremo r ipar lare: Filippo Buonarro t i .
Ma queste società por tavano nel sangue un vizio d'origine che ne annullava le capacità di proselitismo: e rano d'impor taz ione. Infatti si e r ano costituite sul model lo di quelle francesi, di cui condividevano anche le finalità: abbat tere il r eg ime napo leon ico p e r res t i tu i re alla Rivoluzione i l suo slancio repubblicano, democrat ico ed egalitario. Tut to questo aveva un senso finché Napoleone era stato sul t rono e il P iemonte un d ipa r t imen to francese. Ma ora queste condizioni n o n sussistevano più. Le vecchie società cercarono di adeguarsi a quelle nuove; ma Buonar ro t i , lontano dall 'Italia, e i suoi fiduciari e r a n o t r o p p o legati alle loro vecchie premesse ideologiche pe r poter capire le nuove esigenze e adattarvisi. Ai loro ordini n o n r imasero che i pochi sopravvissuti matusa delle cospirazioni del '92 e del '96. Le forze giovani s i o rgan izza rono in u n a n u o v a formazione che in poco t e m p o fu assoluta p a d r o n a del campo : la Federazione italiana.
247
I suoi quad r i e r ano formati da uomini che provenivano da quei ceti borghesi e aristocratici di cui abbiamo det to , e che a p p u n t o pe r questo n o n miravano alla sovversione del sistema, ma soltanto alla sua correzione in senso patriottico e l iberale. N o n contes tavano la monarch ia , cui anzi e rano tutti o quasi tutti s inceramente affezionati. Volevano soltanto che ripudiasse l 'assolutismo, concedesse la Costituzione e assumesse r isolutamente la guida del movimento nazionale e un i t a r io i ta l iano c o n t r o l 'Austria: cioè an t ic ipavano di qua lche decenn io quel lo che poi sarebbe d iventa to i l p ro g r a m m a del Piemonte sabaudo.
Ecco pe rché la Federazione potè svilupparsi e far proseliti senza t r o p p a difficoltà: l'affiliazione n o n implicava una slealtà nei confronti del Sovrano, e quindi potevano aderirvi anche uomini fedeli allo Stato e alla dinastia, come gli ufficiali dell 'esercito che infatti le det tero molte reclute. Ed ecco anche pe rché i loro sguardi cominciarono ad appuntars i su Carlo Alberto, unico Principe di Casa Savoia ch'essi potevano sperare di t r a r r e dalla loro par te , visto che sul retrivo Vittorio Emanue le e su suo fratello Carlo Felice, ancora più retrivo di lui, non c'era da fare assegnamento.
A far da t ramite fra Carlo Alberto e i Federati fu il Collegno, un ufficiale che aveva servito nell 'esercito napoleonico e pe r un momen to aveva avuto la tentazione di farsi francese. Il Principe lo aveva nomina to suo scudiere, e lui ne approfi t tò p e r i n t r o d u r r e a palazzo Ca r ignano San to r re di Santarosa e altri suoi amici - Provana, Vidua, Cesare Balbo -che subito ne d iventarono abituali frequentatori . Sebbene il Re gli dimostrasse molta benevolenza e lo avesse nomina to G r a n Maest ro , cioè c o m a n d a n t e in capo dell 'Artiglieria, i l Principe n o n nascondeva la sua insofferenza pe r le grettezze e il misoneismo della Corte . Si era ribellato al Grimani , e o ra recalcitrava al mat r imonio che gli avevano imposto con Maria Teresa, figlia del G r a n d u c a di Toscana e n ipote dell ' Impera to re d 'Austria. Q u a n d o a n d ò a Firenze pe r i l matr imonio, fece sosta ad Arquà e a Ravenna pe r inginocchiar-
248
si sulle tombe di Petrarca e di Dante , e a Firenze si legò di stretta amicizia con Gino Capponi con cui a lungo par lò della sua voglia «di m a n d a r via i tedeschi dall ' I tal ia». Tu t to questo fece presto a essere r isaputo anche negli ambienti liberali delle altre città. Vincenzo Monti scrisse a un p iemontese: «Beati voi che avete il Principe di Carignano», il Giordan i lo definiva «un Messia», e perf ino un incallito r e p u b blicano come l 'Angeloni ne par lava come di «un as t ro che maes tosamen te s 'erge sull 'a lpino lembo del l 'or izzonte nostro».
Tu t to ques to offriva a S a n t o r r e e ai suoi c o m p a g n i un fertile t e r reno , ed essi vi seminarono a piene mani . Influenzabile com'era , il Principe soggiacque alle loro suggestioni, si affezionò alla pa r t e di Eroe della «gioventù dorata» torinese , e s ' inebriò della popo la r i t à che gliene der ivava. Ciò n o n significa ch'egli fingesse. Il suo fremito d'italianità era sincero, anche se mescolato con un 'ambiz ione sproporz ionata ai mezzi suoi e a quelli del Piemonte. I discorsi dei suoi amici, che già lo vedevano alla testa di u n a crociata pe r la liberaz ione nazionale, lo entus iasmavano. Lo entusiasmavano a l p u n t o da fargli c o m m e t t e r e pa recch ie i m p r u d e n z e . Tanto che Cappon i si sentì in obbligo di scrivergli pe r raccomandargl i di «non p r o m e t t e r e quelle cose che non pot rebbe mantenere» . Ma Carlo Alberto ne fece poco conto anche pe r ché i l Re, nella sua bonomia , n o n ne faceva a lcuno dei rappor t i che gli pervenivano sulle pericolose frequentazioni del Pr incipe. Quest i , d o p o il ma t r imonio , gli aveva da to la più g r a n d e delle gioie: un bel maschiet to ch ' e ra stato battezzato con lo stesso suo nome: Vittorio Emanuele .
Sia p u r e p e r un r a m o col laterale , i l vecchio t ronco dei Savoia aveva ge rmogl i a to un n u o v o pol lone , e la dinast ia era salva.
CAPITOLO VENTIQUATTRESIMO
LA V I T T O R I A DEGLI «ZELANTI»
Di tutti i Sovrani spodestati da Napoleone , il Papa fu senza dubbio quello che ricevette, al suo r i torno, l'accoglienza più calorosa. Dalle Alpi a Roma, il suo viaggio fu u n a marc ia trionfale. Alle por te del l 'Urbe i nobili staccarono i cavalli dal cocchio pe r condur lo a braccia fino a San Pietro fendendo a fatica u n a mareggia ta di folla osannan te . Vestite di bianco, le ragazze gli rovesciavano addosso ghi r lande di fiori. Era il 24 maggio del 1814.
Era stato Napoleone stesso ad anticipare il suo r i torno, al termine di un duello di cui abbiamo ricapitolato soltanto la p r i m a par te . I l le t tore ci scusi se to rn iamo un po ' indie t ro pe r r icostruirne il seguito: esso esercitò un peso decisivo sui successivi a t t egg iament i assunt i dalla Chiesa sia in c a m p o spirituale che in campo temporale .
Poco dopo l ' in ternamento del Papa a Savona, nel 1810, e m e n t r e in tut ta l 'Italia fioccavano le depor taz ion i di sacerdot i e di laici che si r if iutavano di p res ta re g i u r a m e n t o all ' Impera tore , questi aveva r ipudiato Giuseppina pe r impalmare la principessa austriaca Maria Luigia. Ma a Vienna reclamavano il ma t r imon io religioso che p r e s u p p o n e v a l'annul lamento di quello precedente . Nel clero francese Napoleone trovò dei prelati abbastanza compiacenti pe r p ronunciare quella sentenza. Ma tredici Cardinali invitati alle nozze, che lo sposo voleva sp l end ide e solenni , si r i f iu tarono d ' intervenire. Napoleone ne fu ta lmente irritato che in piena cerimonia sbottò a gr idare : «Questi pazzi! Vogliono rovina re la mia dinastia r ec l amandone in dubbio la legittimità! Gliela farò vedere!» L ' indomani li convocò, e d o p o avergli
250
imposto u n a inutile ant icamera, li fece r ibut tare sulla s t rada d o n d e aveva fatto a l lon tana re le car rozze . D o p o d i c h é gli tolse gli e m o l u m e n t i , g l ' ing iunse di vestire come semplici p re t i , p e r cui d 'a l lora in poi v e n n e r o ch iamat i «Cardinal i neri», e ne m a n d ò alcuni in esilio, fra cui Pacca, il più d u r o .
Subito dopo convocò un concilio di Vescovi pe r fargli dich ia ra re che il Papa agiva con t ro i veri interessi della religione; ma i Vescovi, anche in assenza di Pacca, r innovarono il loro g iu ramento di fedeltà al Papa, e n o n vollero avallare le nomine fatte da Napo leone nelle sedi episcopali r imaste vacanti. L ' Imperatore m a n d ò a Savona u n a commissione di Cardinal i rossi, cioè docili ai suoi ord in i , pe r convincere il p r ig ion ie ro , t e n u t o r i g o r o s a m e n t e a l l 'oscuro di tu t to , a scendere a un accordo: se nello spazio di sei mesi egli n o n avesse disapprovato le nomine fatte, queste sarebbero state r i tenute regolari . Il Papa accettò, ma a m o d o suo, cioè diram a n d o c o n t e m p o r a n e a m e n t e u n a «lettera a i Vescovi dell ' Impero» in cui ribadiva che tutte le Chiese nazionali restavano sottomesse a quella di Roma, «loro Madre e Signora». Stavolta fu Napoleone a rifiutare. Pre tendeva che il Papa riconoscesse il p r imato del Concilio dei Vescovi di Parigi e si sottomettesse ai suoi deliberati. Più tardi scrisse nelle Memorie: «Volevo che i Concili della mia Chiesa fossero considerati i legittimi in terpre t i di tut ta la cristianità e che il Papa ne diventasse il portavoce. Sarei stato io ad a p r i r e e c h i u d e r e le sue sessioni e ad approvare e r e n d e r e obbligatori i suoi deliberati , come avevano fatto Costantino e Car lomagno». Forse Tal leyrand n o n faceva un paradosso q u a n d o si chiedeva se il cervello di Napoleone era del tut to in ord ine . Al principio del '12 l ' Impera tore scrisse al Papa invitandolo a dimettersi, come un prefetto, eppoi o rd inò che venisse trasferito a Fontainebleau, presso Parigi, pe r poter lo meglio controllare.
Per il fragile vecchio, quel viaggio fu un calvario, che pe r poco n o n gli costò la vita. Al passaggio del Moncenisio aveva la febbre alta, bisognò sistemare una lettiga den t ro la car-
251
rozza, e invano il medico che lo accompagnava chiese u n a sosta. Negli abitati i cavalli venivano messi al ga loppo p e r n o n da r t empo alla popolazione di r iconoscere il viaggiatore e di rendergl i omaggio, e le scosse met tevano a d u r a p ro va le res idue forze del malato. A Fontainebleau giunse più mor to che vivo, e stentò parecchio a r iprenders i , ma si trovò più isolato di p r ima e ancora più all 'oscuro di ciò che succedeva. Ai p r imi di genna io (del T3 ) a l l ' improvviso, gli annunz ia rono u n a visita de l l ' Impera tore .
Ques t i e r a a p p e n a r i en t r a to , sconfìtto, dal la Russia, s i p reparava a bandi re la leva in massa pe r l 'ultima battaglia, e qu ind i aveva b isogno di r i c rea re i n t o r n o a sé l ' unan imi tà della nazione che il conflitto con la Chiesa aveva pericolosamen te incrinato. Non c'era che un mezzo: la riconciliazione col Papa. Ma p r ima di tentarla gli m a n d ò , a saggiarne le intenzioni , u n a delegazione di Cardinal i rossi con un elenco di nuove proposte , u n a più insensata dell 'altra: che il Papato si trasferisse a Parigi, che i Cardinal i venissero designati pe r d u e terzi dai loro rispettivi Sovrani, cioè da Napoleone, e che i Cardinali ner i venissero castigati. Il Papa si disse sgomen to - e doveva esserlo - che dei prelati gli sottoponessero simili richieste, e le respinse ne t tamente .
Poi v e n n e Napo leone . Il colloquio si svolse a qua t t r 'occhi, si p ro lungò pe r sei giorni, e non n'è r imasta nessuna testuale documentaz ione . Anche in seguito il Papa si rifiutò di d a r n e esat to con to e solo casua lmen te ne lasciò t r ape l a re qualche episodio. Napoleone , disse, n o n aveva alzato la mano contro di lui, come si e ra raccontato in giro; ma u n a volta, d o p o aver f rantumato parecchie porcel lane, lo aveva afferrato pe r il lembo della sottana e trascinato qua e là pe r la s tanza. Alla f ine, d o p o u n a se t t imana di ques te scenate e scenette, aveva riconvocato i Cardinali rossi alla cui presenza aveva fatto f irmare al Papa un accordo di mass ima che i m p e g n a v a i con t r aen t i a ce rcare un c o m p r o m e s s o . Poi, con t ravvenendo all 'intesa, p resen tò quel d o c u m e n t o come un vero e p rop r io concordato; ma, pe r addolcire la pillola,
252
rilasciò i Cardinali ner i e gli permise di ragg iungere il Papa. Pacca raccontò in seguito che aveva trovato un uomo pal
lido, incurvito e come t rasognato, che con u n a voce d 'ol tre tomba rot ta dai singhiozzi gli aveva raccontato di essere stato trascinato al tavolo «da quei Cardinali» (i Cardinal i rossi) e costretto a firmare. Ma ora che aveva ri trovato i suoi, si affrettò a far sapere che il foglio firmato n o n aveva nessun valore p r ima di tut to pe rché era soltanto un d o c u m e n t o p r e parator io , eppoi perché la firma gli e ra stata estorta. Di questa protes ta p e r ò l 'opinione pubblica n o n seppe nulla. Ved e n d o che i Card ina l i ne r i e r a n o stati rilasciati e si e r a n o riunit i al Papa, tutt i p e n s a r o n o che questi o rmai n o n fosse più pr igioniero, né ebbero t empo di ricredersi sotto l'incalzare di nuovi e più d rammat i c i avveniment i . Sconfitto a Lipsia, Napoleone non era più in grado di fermare gli Alleati in marcia su Parigi. Un po ' perché non voleva che costoro si attribuissero il meri to di aver «liberato» il Papa, un po ' pe r vendicarsi di Mura t che, come abbiamo già raccontato, aveva invaso gli Stati pontifici nella speranza di annetterseli , rispedì in Italia quell ' imbarazzante e irriducibile prigioniero.
In que l m o m e n t o l ' au tor i tà mora le di Pio toccò i l suo apogeo. Anche gli anticlericali p iù arrabbiat i dovevano inchinarsi al coraggio, alla tenacia, alla forza d ' an imo con cui quel fragile vegliardo aveva difeso gl'interessi di u n a Causa che n o n era soltanto quella della Chiesa, ma anche della libe r t à e della d ign i tà de l l ' uomo . E di ques ta u n a n i m i t à di consensi dovet tero tener conto anche i p lenipotenziar i che a Vienna stavano dec idendo le sorti dell 'Italia.
Qu i nessuno metteva in discussione il diri t to del Papa a r ip rende re possesso dei suoi Stati. Ma c'era il p rob lema delle Legazioni (Bologna, Ferrara e la Romagna) che, annesse pr ima alla Cisalpina, poi al Regno Italico del Lombardo-Veneto, e o ra presidiate dalle t r u p p e austr iache, n o n mostravano nes suna voglia di t o r n a r e sotto i l gove rno di Roma . Metternich cercava di sfruttare la loro agitazione pe r r ende re p e r m a n e n t e l 'occupazione e confermare l 'unione di quel-
253
le p rov ince al Lombardo-Vene to , di cui l 'Austria e ra r idiventata padrona .
Per pa ra re la sua mossa, il Papa aveva manda to a Vienna l 'e lemento migliore di cui la Chiesa disponeva: il cardinale Consalvi, segretar io di Stato, un u o m o di formazione illuminis ta , f e r m a m e n t e avverso a ogn i ideologia che avesse qualche pa ren te l a con quelle della Rivoluzione, ma altrett an to ostile a un p u r o e semplice r i t o r n o al passato . Egli sventò la manovra del Cancelliere austriaco e o t tenne la resti tuzione delle Legazioni, ma solo al t e rmine di u n a spossante lotta n o n tanto contro la volpina abilità di Metternich quan to cont ro l'ottusità del suo p ropr io governo.
Part i to infatti Consalvi pe r la sua missione, la Cur ia era rimasta in m a n o agli Zelanti, cioè a quel g r u p p o di Cardinali che, pe r essersi distinti nella resistenza a Napoleone , ora tenevano banco e det tavano legge. I loro maggiori esponenti e r ano Pacca e Rivarola, uomini senza dubbio coraggiosi e risoluti, ma di cui la persecuzione aveva acuito l 'odio verso ogni novità fino a r e n d e r l o patologico. A p p e n a r ien t ra t i a Roma al seguito di Pio, si e r ano messi a cancellare tut to ciò che avevano fatto i francesi che avevano fatto anche molte cose buone . Al posto delle leggi semplici e chiare ch'essi avevano in t rodo t to sia nel campo penale che in quello civile e amministrativo, re in t rodussero quella j ung l a di n o r m e cont raddi t to r ie e di fòri privilegiati che lasciavano il ci t tadino al l 'oscuro dei p r o p r i diri t t i e che avevano s e m p r e fatto di quello pontificio lo Stato italiano più disordinato, inefficiente e arbitrario. Lo stesso D'Azeglio, che in quel m o m e n t o si trovava a Roma e che n o n si p u ò certo tacciare di giacobinismo, annotava scandalizzato: «Tutto fu rimesso com'era temporibus illis. Vidi to rna to il Bargello colla corte , i birr i , il cavalletto ecc. ecc. con tut to quel che gli s'assomiglia».
Invano Consalvi riferiva da Vienna nei suoi rappor t i che di queste d issennate misure Met te rn ich si faceva forte pe r pe r suade re gli altri soci del Congresso che il governo pontificio con la sua retriva ottusità avrebbe finito pe r sollevare le
254
violente reazioni dei suddi t i r ivelandosi così u n a fonte di per turbazione più che una garanzia di stabilità, e quindi era meglio r i d u r n e i te r r i tor i . Pacca e compagn i pers is tevano nella loro opera . Tutto, specialmente nelle province det te di «primo recupero» (Lazio e Umbria) fu ricostituito come prima e peggio di pr ima, cioè nell'esclusivo interesse di un ristretto g r u p p o di prelati che, come poi scrisse il Farini, «teng o n o lo Stato come un g r a n d e beneficio ecclesiastico, un predio da usufruttuarsi dagli uomini di Chiesa».
Q u a n d o , a l t e r m i n e della sua missione, Consalvi t o r n ò da Vienna con le Legazioni in tasca, mise a frutto il successo pe r r i p r e n d e r e in m a n o i l po te re e governar lo in man ie r a più ragionevole. Egli capì che quelle province, dette «di seconda recupera» n o n si potevano t rat tare come le altre, dato il loro super iore livello economico e sociale e gli consentì di conservare in g ran par te gl'istituti giuridici e amministrativi introdott i da Napoleone , ai cui benefici esse si e rano ormai affezionate. Poi o t t e n n e dal Papa un motuproprio che , col pre tes to della unificazione legislativa, es tendeva questo criterio a tutti gli Stati. Così la dissennata ope ra degli Zelanti venne bloccata e in certi campi addir i t tura capovolta. Per esempio venne ro riconosciute le alienazioni dei beni ecclesiastici compiu te nel pe r iodo francese, venne m a n t e n u t a la revoca delle giurisdizioni baronali , cioè del dirit to dei nobili a istituire loro p rop r i tr ibunali , e venne abolita la tor tura .
Erano sensibili progressi nei confronti dello Stato pont i f ic io d i p r i m a del la Rivoluzione. Ma n e m m e n o Consalvi , malgrado i suoi sforzi, riuscì a impedi re il solito s t rapotere di u n a polizia ciacciona e oppress iva , il r i t o rno alle infra-mettenze del po te re esecutivo in quello giudiziario, il ripristino di un sistema doganale asfissiante che condannava l'economia pontificia a un totale ristagno e di una censura ottusa come sono tu t te le censu re e specia lmente quel le dei preti , il r istabil imento dell 'assoluto monopol io ecclesiastico sul l ' i s t ruzione, s e m p r e cons ide ra ta un per icoloso veicolo d ' infezione. E sop ra t tu t to n o n riuscì a laicizzare g l ' ingra-
255
naggi amministrativi su cui parroci e monsignor i montavano ringhiosa guardia e in cui por tavano la loro tradizionale incompetenza.
Successe ciò ch 'era inevitabile che succedesse: e cioè che specialmente nelle province di seconda recupera , cioè le Legazioni, vissute pe r molti anni nel giro di un m o n d o più libero e m o d e r n o qual era il Vicereame del Lombardo-Veneto, il malcontento de te rminò immedia tamente gravi tensioni. La carestia del '16 acuì la crisi. Secondo calcoli del Cande lo ro , su u n a popo laz ione complessiva di d u e mil ioni e mezzo di abitanti, lo Stato pontificio contava mezzo milione di accattoni, u n o su cinque. Era il risultato dell 'amministrazione clericale. Essa n o n riusciva a renders i conto che la relativa libertà dei traffici, le forni ture militari, le vendi te dei ben i ecclesiastici e demania l i avvenute nel l 'u l t imo ventennio avevano p r o f o n d a m e n t e al terato il tessuto sociale dando l'aìre a u n a borghesia di funzionari, professionisti, mercanti, ex-fittavoli diventati propr ie tar i , che n o n si rassegnavano più a quel regime di lager e alla p ropr i a esclusione dal potere e dagli uffici.
Già nel '17 la polizia scoprì un complot to pe r u n a sollevazione popola re a Macerata. Ci furono un centinaio di arresti, e un processo che si concluse con undici c o n d a n n e a mor te . Consalvi ebbe il suo daffare pe r commutar le in carcere a vita. Irri tati dalla sua clemenza, gli Zelanti passarono al cont ra t tacco i s t i tuendo anch 'ess i u n a società segre ta di squadristi manganel latori , la Santa unione, det ta anche, senza alcun sottinteso umorist ico, Ipacifici. Era u n a riedizione del Sanfedismo di Ruffo. Così Consalvi si t rovò p r e s o fra d u e estremismi.
Egli n o n aveva p iù a l t ro a p p o g g i o che i l Papa . Ma Pio VII era ormai alla fine. Oltre ai triboli della vecchiaia, doveva affliggerlo la sensazione di essersi sopravvissuto t roppo a l u n g o . Fosse m o r t o a Fonta ineb leau , sa rebbe passa to alla Storia come un Gregor io V I I , e tale infatti e ra a p p a r s o ai cattolici di tut to il m o n d o q u a n d o era tr ionfalmente tornato
256
a Roma. Di tut to quel capitale di prestigio accumulato nell ' emergenza , d o p o sei ann i d i o r d i n a r i a ammin i s t r az ione n o n gli restava neanche una briciola. L'uomo che aveva saputo sfidare i fulmini di Napoleone e affrontare coraggiosamente depor taz ione ed esilio, non riusciva a sottrarsi al «sistema» e ne era restato pr igioniero.
CAPITOLO VENTICINQUESIMO
I DUCATI CENTRALI
Secondo le f igurazioni al legoriche del t e m p o , F e r d i n a n d o I I I di L o r e n a r i en t rò a Fi renze togato e cinto d 'a l loro, su un carro t rainato da un leone e da un agnello. L'agnello andava bene , ma il leone no. Il mite e affabile Granduca , che n o n aveva mai voluto dichiarar g u e r r a a Napo leone e anzi lo aveva invitato a cena q u a n d o era passato da Firenze, non gli serbava nessun r a n c o r e n e m m e n o del fatto d i esserne stato scacciato. Tut tora gli scriveva all'Elba lettere affettuose pe r dargli notizie della moglie Maria Luigia, sua p ropr ia nipote . Sicché q u a n d o alcuni vecchi nobili, andatigli incontro a porgergli il ben tornato , si vantarono di non aver mai collaborato coi francesi, rispose: «Faceste male. Se l 'ho servito io, potevate servirlo anche voi». E con questa bat tuta tagliò corto a ogni velleità di epurazioni .
La sua res tauraz ione n o n e ra stata esente da difficoltà. Come forse il lettore r icorda, la Toscana era stata oggetto di un barat to fra Napoleone e i Borbone di Spagna, che se l'er a n o accaparrata per la loro infanta Maria Luisa cedendo in cambio il Ducato di Pa rma . Poi N a p o l e o n e aveva cacciato via anche costei pe r assegnare i l G r a n d u c a t o alla p r o p r i a sorella Elisa. Al Congresso di Vienna la Spagna, che aveva dato un contr ibuto de te rminan te alla lotta antinapoleonica, e ra tornata ad avanzare i suoi diritti ch iedendo la restituzione di u n o dei d u e principati . Ma Metternich era riuscito ad assicurarseli en t rambi r i po r t ando Ferd inando , fratello dell ' imperatore Francesco, a Firenze, e facendo assegnare Parma a Maria Luigia con l'intesa che alla sua mor te il Ducato sarebbe r i tornato ai Borbone.
258
Q u a n d o ci arrivò nella primavera del '14, i fiorentini accolsero Ferdinando sventolando le tube al posto dei tricorni perché ormai vestivano «alla francese» con lunghi pantaloni attillati e alti colletti a sbuffo men t re le donne avevano smesso la parrucca e portavano la vita sotto il petto. Ma al Granduca anche la nuova moda piacque, perché in quel momento gli piaceva tutto. Unica ombra nella sua felicità di ritrovarsi a Firenze era il fatto di averci dovuto tornare da solo perché sua moglie era morta duran te l'esilio in Germania, e lui non era mai riuscito a consolarsene. Ma subito dopo lo raggiunsero le due figlie e poi anche il figlio, Leopoldo, che i fiorentini, appena lo videro, battezzarono immediatamente «Canapino» per il colore biondo sbiadito dei capelli. Il ragazzo, ch'era nato anche lui a Firenze, non prometteva, quanto a salute, granché. Infatti subito dopo l'arrivo si ammalò, e i medici gli prescrissero una strana cura a base di latte di donna. «L'hanno r imandato a balia» dissero i fiorentini e quando, guarito, il giovane ricomparve per le sue abituali passeggiate a cavallo alle Cascine, lo fermavano e gli chiedevano: «Che s'è divezzato, Altezza?»
Il r i o rd inamen to dello Stato si svolse in quest 'a tmosfera di familiarità. Invece che a qua lche vecchio nobile incarognito nelle nostalgie dell 'antico regime, Fe rd inando lo aveva appal ta to a un borghese ex-collaborazionista, l ' ingegnere a re t ino Vit torio Fossombroni , che aveva servito l ' amminis trazione francese e che Napo leone chiamava «un gigante nel mezzanino». La revisione del codice napoleonico si ridusse a ben poco. Fu abolito il divorzio, che nes suno d'alt ronde reclamava. Furono ristabilite le decime parrocchial i e r i s t re t te le a u t o n o m i e munic ipa l i , ma fu conserva ta la pubblicità dei processi e, sebbene alla polizia venissero concessi ampi poteri , essi furono usati in tale manie ra che la Toscana diventò lo Stato italiano di g ran lunga più libero e la Mecca di tutti i perseguitati politici. Q u a n d o Metternich cominc iò 'a l amenta r s i del fatto che la c e n s u r a n o n faceva i l p ropr io dovere , Ferd inando gli rispose: «Ma il dovere della censura è quello di n o n farlo».
259
Le innovazioni si r idussero al c a m p o economico, e n o n fu rono innovazioni p e r c h é si t r a t tò di un r i t o r n o ai saggi criteri liberistici di Pietro Leopo ldo . A p p e n a finita la carestia che in quest i ann i si e ra abba t tu ta sull ' I talia e che costrinse anche la Toscana a calmieri e cont ingentament i , Fos-sombron i spalancò le f ront iere alle impor taz ioni , facendo piazza pulita di dazi e gabelle. Indust r ia e agricoltura dilatar o n o i polmoni , e lo si vide dal bilancio. Per sedici milioni di spese annue , ce n ' e rano diciannove di entra te , e il Ministro ne approfit tò pe r da re avvìo a u n a serie di lavori pubblici o, come oggi si chiamano, di «infrastrutture» che contr ibuirono moltissimo al riequilibrio del Paese. Fu aper ta una strada p e r la valle t iber ina, un ' a l t r a da Volterra a Siena, un 'a l t ra ancora da Siena ad Arezzo che trasse la Valdichiana dal suo secolare isolamento. Ma gli sforzi maggiori furono rivolti alla M a r e m m a per guarir la dalla malaria e metter la a cultura. Molti cr i t icarono questa impresa cons iderandola spropor zionata alle forze del Granduca to . «Per la smania d 'e ternarsi asciuga-tasche e maremme» scriveva il Giusti di Baldasse-roni , il giovane tecnocrate livornese che dirigeva questo assalto contro b rughie re e acquitrini. E infatti l 'opera richiese i l sacrifìcio di parecchie generaz ioni . Ma n o n sarebbe mai arr ivata al t r a g u a r d o senza questo pionier ismo, che fu anche la scuola delle migliori energie imprendi tor ia l i toscane nel campo dell 'agricoltura.
Dove Fossombroni si rivelò inflessibile fu nella difesa dello Stato dal le in te r fe renze ecclesiastiche. N o n volle r iammet te re nel Granduca to i Gesuiti, di cui il Papa aveva ricostituito l 'Ord ine e si e ra fatto l'alto p a t r o n o , e fu un vigile gua rd iano del cos tume di tolleranza che il Granduca aveva is taurato. Gli stranieri avevano scoperto Firenze, ci venivano sempre più numeros i , e molti ci restavano. Questo ne faceva u n a f ines t ra spalancata sul m o n d o m o d e r n o , un pun to d ' incon t ro , u n a t a p p a d 'obbl igo, specie pe r gl ' intellettuali della penisola, messi in fuga dall'asfissiante atmosfera degli altri Stati. Il suo pr imato culturale cominciava a delinearsi.
260
Le p iù grosse p reoccupaz ion i d i F e r d i n a n d o furono di o rd ine matr imoniale . La p r ima ad a n d a r e sposa fu la figlia Mar ia Teresa con un giovanot to sul qua le c o r r e v a n o voci con t radd i t to r ie . Si chiamava Carlo Alberto di Savoia Cari-gnano , e sembrava destinato a salire sul t rono del Piemonte, ma n o n era del tut to sicuro perché contro questa successione p e r via collaterale manovrava Francesco IV di Modena, genero del Re in carica. Q u a n d o il Principe venne a Firenze a conoscere la fidanzata, i fiorentini lo t rovarono «di leggiadro aspetto e di maniere assai civili», ma «più lungo e malinconico d 'una quaresima». E il Principe, dal canto suo, confidò a Gino Capponi , di cui era diventato subito g r ande amico, che Maria Teresa era, sì, mol to graziosa, ma «terrib i lmen te austr iaca». Sbagliava p e r c h é ques ta aus t r iaca fu poi la più italiana delle regine , sposò in p ieno la politica di suo mari to , ne condivise i d r a m m i e l'esilio, e q u a n d o to rnò vedova a Firenze n o n volle più met te r p iede a palazzo Pitti pe rché c 'erano di guardia i soldati austriaci.
A Leopo ldo fu da ta in moglie u n a principessa di Sassonia, Maria Anna Carolina, che fece ai fiorentini la migliore impressione, ma n o n det te eredi maschi. Assillato dalla paura di un 'est inzione della dinastia, Fe rd inando dovette deciders i a r i p r e n d e r mogl ie a c i n q u a n t a d u e ann i , e p e r n o n cor re re avventure fuori casa se la scelse nella sorella di sua nuora , il che lo rese cognato di suo figlio. Ma e ran cose che succedevano spesso, in questi mat r imoni dinastici. Pur t roppo n e m m e n o lui riuscì a met te re al m o n d o un successore, e q u a n d o morì , ucciso p ropr io dalla malaria m a r e m m a n a che aveva cercato di debellare, temet te che l ' imperatore Francesco suo fratello ne approfit tasse pe r soppr imere , in caso di mor t e di Leopoldo , il Granduca to e r i d u r r e la Toscana come il Lombardo-Veneto. Era le mille miglia dal l ' immagina-re che a cacciare dal t r ono «Canapino» diventa to frat tanto «Canapone», sarebbe stato un cer to Vittorio Emanue le , f i glio di sua figlia Maria Teresa e del «giovane di l egg iadro aspetto».
261
A Lucca si e ra installata Maria Luisa di Borbone , colei a cui N a p o l e o n e aveva concesso d i r e g n a r e p e r a lcuni a n n i sulla Toscana, e che poi aveva costretto a cedere il posto alla p ropr ia sorella Elisa Baciocchi. Il pat to stabilito al Congresso di Vienna era, r ipet iamo, che i Borbone sarebbero rimasti Principi di Lucca finché non avessero r ecupera to il loro vecchio Ducato di Pa rma e Piacenza, assegnato a titolo vitalizio all 'altra Maria Luigia, la moglie di Napoleone; e che a quella scadenza, Lucca sarebbe stata annessa al Granduca to di Toscana.
Maria Luisa era rimasta la spagnola di sempre , sussiegosa, bigotta e p rofondamente avversa alle idee liberali, tanto che si era preso come consigliere Canosa, l 'ex-ministro della polizia di Napoli . E m a n ò u n a legge con cui faceva obbligo ai funzionari civili e militari di anda re a messa e ai genitori di m a n d a r e i figli a Dottrina, pena l'esclusione dai p u b blici impieghi . Era ossessionata dalla p a u r a dei Carbonar i , che a Lucca non c 'erano, e tutta la sua politica estera consistette in accordi di polizia con gli Stati vicini pe r il coordinam e n t o dello spionaggio e l 'estradizione dei colpevoli. Il p roblema che più l'assillò fu di da re u n a buona moglie a suo figlio Carlo Ludovico e, come spesso capita alle m a m m e t roppo ciaccione, la sbagliò.
Maria Teresa di Savoia, secondogeni ta di Vittorio Emanuele I (la pr imogeni ta Beatrice e ra anda ta sposa, come ricordere te , a Francesco IV di Modena) aveva diciassette anni, e ra a p p e n a uscita di convento e p a r e che fosse stata innamora t a di Carlo Alberto. Aveva abbastanza riserve sentimental i per innamorars i anche di Carlo Ludovico, ma fu lui che n o n s ' innamorò di lei. In c o m u n e ebbero un figlio, i l fut u r o Duca d i Parma, ma n ien te a l t ro . Car lo Ludovico era stato ta lmente oppresso dalla m a d r e che sognava di disfare tu t to ciò ch'essa aveva fatto, compreso il p rop r io mat r imonio; e q u a n d o le successe nel '24 , i n t rodusse anche , pe r b u o n a for tuna dei lucchesi, me tod i d i gove rno d iametra l men te opposti a quelli di lei. Ridusse l ' appannaggio che Ma-
262
ria Luisa esigeva pe r a l imentare i suoi fasti spagnoleschi, liberalizzò i commerci , e alla fine si convertì addir i t tura al luteranesimo, m e n t r e sua moglie diventava Terziaria domeni cana. Fu un cattivo mar i to , ma n o n un cattivo sovrano . E Lucca, sotto di lui, respirò.
A Parma, Maria Luigia giunse tardi , soltanto nel '16, e n o n fu bene accolta. I pa rmens i consideravano la moglie di Napoleone un personaggio sproporz ionato a un ducato che si es tendeva solo fino a Piacenza e a Guastalla. Ma cambiarono opin ione q u a n d o la Duchessa o rd inò che le somme raccolte pe r i festeggiamenti del suo arrivo fossero devolute alla beneficienza.
Maria Luigia n o n aveva la stoffa dell 'eroina. Malvolentieri e ra anda ta sposa al l 'uomo più potente della terra , n o n lo aveva mai amato , né mai si e ra senti ta compene t r a t a della sua grandezza. Per p u r o senso del dovere , aveva pensato di restare accanto al mari to anche nella disfatta e di accompagnar lo all 'Elba, ma se n ' e ra lasciata facilmente d i s suadere da suo p a d r e e da Met ternich , anche pe rché già allora era innamora ta del conte Neipperg , che il Cancelliere le aveva messo al fianco, e a u n a cosa sola aspirava: a u n a vita t ranquilla con lui, l on t ano dalla Cor te di Vienna , dove quel la «relazione» avrebbe c e r t a m e n t e i ncon t r a to degl i ostacoli. Per ques to aveva insistito pe r Parma: e ra u n a città di p ro vincia, ma piena di fascino, e con un suo r ango di capitale. Per averla, aveva consenti to a lasciare a Vienna anche il figlioletto avuto da N a p o l e o n e , i l piccolo Re di Roma, che Met te rn ich voleva al levare da aust r iaco p e r so t t ra r lo alle suggestioni della gloria pa te rna .
Con u n a b e n d a n e r a a c o p e r t u r a del l 'occhio p e r s o in combat t imento , Ne ipperg n o n era soltanto un be l l 'uomo e un p r o d e soldato. Era anche un politico di m e n t e ape r t a e di notevole accortezza, che seppe eserc i tare mol to b e n e i pieni po te r i conferit igli dalla Duchessa . Anzi, la vera Duchessa fu lui, anche se lo fece con molta discrezione.
263
Parma n o n aveva grossi problemi da risolvere. Subito dopo la caduta di Napoleone nel T 4 , i l suo governo e ra stato affidato dall 'Austria p r ima a Marescalchi col titolo di Commissario Imper ia le , poi al conte Magawly-Cerati , un ir landese naturalizzato, che si era rivelato un eccellente amminis t ratore . Ne ippe rg n o n appo r tò nessuna variante al suo sistema e spinse avanti i lavori ch'egli aveva iniziato: il g r ande p o n t e sul Taro , la r iorganizzazione del l 'Universi tà che diventò una delle migliori d'Italia, e la r iforma legislativa che salvò il meglio dei codici napoleonici . Sulla censura , Neipp e r g condivideva l ' op in ione del G r a n d u c a : che ci doveva essere, ma n o n farsi sent i re . E infatti i l Duca to gode t t e di u n a relat iva l ibertà, che a n d ò a vantaggio sop ra t t u t t o del suo sviluppo culturale. Sebbene ufficiale di carr iera , Neippe rg si contentò di un esercito di tremila uomini , e ciò che r i sparmiava in case rme , lo spese pe r le scuole, i l Museo, l 'Accademia, i teatri , e anche lui difese con tenacia lo Stato dalle in te r ferenze ecclesiastiche. Anche d o p o che , r imas ta vedova p e r la m o r t e d i N a p o l e o n e , Maria Luigia l 'ebbe morgana t i camen te sposato, egli r imase d iscre tamente nell 'ombra, lasciando che tut to il meri to di quel b u o n governo andasse a lei e giovasse alla sua popolari tà, che fu ed è ancora g rande .
A Modena si era istallato Francesco IV, figlio del l 'arciduca Ferd inando , a sua volta fratello de l l ' Impera tore . Francesco aveva eredi tato il Ducato di Modena, che comprendeva anche Reggio, dalla m a d r e Ricciarda, ultima della casa d'Este. E un po ' pe r questa ascendenza mate rna , un po ' pe rché era na to a Milano, veniva cons ide ra to un Pr inc ipe i tal iano, i l che contribuì ad al imentare sul suo conto parecchi equivoci. Era un giovanotto tut t 'a l t ro che sprovveduto , a cominciare dai mezzi. Una serie di fortunate coincidenze lo avevano reso e rede di molti cospicui pa t r imoni : quelli dei Cybo, dei Pico, dei Malaspina, il che faceva di lui uno dei più ricchi Principi d 'Europa . Fra poco gli sarebbe toccato anche il Ducato
264
di Massa e Car rara , che pe r il m o m e n t o era stato assegnato a sua m a d r e a titolo vitalizio. Ma alle viste c 'era anche un boccone p iù grosso: i l P i emon te , del cui re Vit tor io Emanuele I egli aveva sposato la figlia pr imogeni ta . Abbiamo già det to che costei, nel contrat to di mat r imonio , aveva già fatto solenne r inunz ia agli Stati del p a d r e , destinati a Car lo Alber to . Ma Francesco n o n era rassegnato e, se n o n p ropr io al Piemonte, a lmeno alla Sardegna ci pensava: tant 'è vero che seguitava ad agitarsi pe r o t t enere La Spezia pe r assicurarsi le comunicazioni con l'isola.
Subito d o p o la catastrofe di Napoleone , a Francesco avevano g u a r d a t o molti patr iot i l ombard i nella speranza che , essendo egli un Principe della sua dinastia, l'Austria gli affidasse il Regno Italico e che poi, italianizzandosi sempre più, egli realizzasse sotto il suo scettro l 'unità nazionale. Ma sarebbero occorse d u e cose: che Metternich fosse d 'accordo, e invece non lo era, a p p u n t o pe rché prevedeva con chiarezza quel lo sv i luppo di s i tuazione; e che Francesco andasse in qualche m o d o incontro alle generali aspirazioni di libertà, e invece fece p ropr io il contrar io. Il suo p r o g r a m m a di governo si compend iava nelle paro le che più tardi p r o n u n c i ò al congresso di Lub iana : «Il p a r e g g i a m e n t o di tut t i in faccia alle leggi, la soverchia spartizione delle ricchezze, la libertà di s tampa, la via delle carr iere aper ta a ch iunque , l'eccessiva considerazione accordata agli scienziati e agli uomini di lette re , la diffusione delle scuole, il l ibero passo accorda to a tutti d ' impara re a leggere e a scrivere: ecco i cattivi semi da cui germogl iano le rivoluzioni».
A questi princìpi aveva intonato i suoi criteri di governo. Tutta la legislazione napoleonica venne revocata e al suo posto ripristinata quella estense di p r ima del '97. Dell 'ordinam e n t o francese venne m a n t e n u t o solo i l sistema t r ibutar io perché il cont r ibuente lo sapeva spolpare. Gli ordini religiosi furono richiamati, compresi i Gesuiti. Fu istituito un esercito di set temila uomin i a s so lu t amen te s p r o p o r z i o n a t o al peso politico del Ducato e alle sue esigenze.
265
Francesco si rivelò un eccellente ammin i s t r a to re anche perché n o n distingueva fra finanze pubbliche e private, cioè considerava private anche quelle pubbliche. Fra le altre cose affidò il monopol io dell ' industria più sviluppata nel Paese, la concia delle pelli, a una società di cui poi si scoprì che il titolare era lui. Non si può di re che l 'economia di Modena ne soffrisse. Anzi, tu t to il suo a p p a r a t o p rodu t t i vo e commerciale funzionò bene perché Francesco aveva il culto dell'efficienza e come manager era abbastanza dotato. Ma il Ducato diventò u n a pr igione, in cui incubavano soltanto analfabetismo e ribellioni.
Qu i f inisce i l p a n o r a m a del l ' I ta l ia «res taurata». Alfredo Oriani doveva scrivere più tardi ch'essa n o n corr ispondeva più alla realtà del Paese pe rché «l'Italia dei cicisbei, addor m e n t a t a nelle r i forme, s t u p i d a m e n t e devota a i p r o p r i Re, adoran te il Papa come un semidio, sferzata da Parini, schiaffeggiata da Alfieri, n o n esisteva più». Ma sbagliava. Quest ' I talia esisteva, eccome. Solo, ce n 'e ra o rma i anche un 'a l t ra : quella di coloro che n o n l 'accettavano più. Facciamo un rap ido sopralluogo nei loro rifugi: le «vendite» carbonare .
CAPITOLO VENTISEIESIMO
I CARBONARI
Giovanni Ruffini, che fu dei loro , racconta come e n t r ò in contat to coi Carbonar i . Era la sera di un mar t ed ì grasso, e suo fratello J a c o p o gli aveva da to a p p u n t a m e n t o in u n a piazza gremita di maschere . Due di queste gli si avvicinarono e gli chiesero se stesse aspe t tando u n a donna . Giovanni annuì , u n o dei d u e inter locutori gli m o r m o r ò all 'orecchio: «L'ora è suonata!» ch ' e ra la paro la d ' o r d i n e già datagli da Jacopo , e lo invitò a seguirli . Arrivati in un vicolo scuro lo benda rono , gli trassero il bavero del mantello fin sulla bocca, lo p resero a braccetto e gli fecero fare un lungo percorso a giravolte in m o d o da disorientar lo. Con u n a chiave aprirono u n a po r t a e, q u a n d o gli tolsero la benda , Giovanni si trovò in una stanza rischiarata solo dal fuoco che ardeva nel camino , col p ianci to cope r to d ' u n t a p p e t o rosso s a n g u e e un globo d 'a labastro in mezzo. Ol t re agli accompagna tor i , c 'erano altri d u e domin i anch'essi mascherat i . U n o di loro gli chiese le generali tà e se aveva intenzione di far par te dei Buoni Cugini . Giovanni confermò.
«Hai un ' idea - disse l'altro - dei terribili doveri che t 'incombono? Sai tu che, appena prestato il solenne g iuramento, il t uo braccio, le tue sostanze, la tua vita, tu t to te stesso insomma non a p p a r t e r r a n n o più a te, ma al l 'Ordine? Sei tu p r o n t o a m o r i r e mille volte anziché rivelare i suoi segreti? Sei p ron to a obbedire ciecamente e a r inunziare alla tua volontà dinanzi a quella delle gerarchie dell 'Ordine?»
Finito l ' in terrogator io , al neofita fu imposto di p r o n u n ciare, inginocchiato e con un pugna l e in m a n o , la formula del g i u r a m e n t o : «Giuro e p r o m e t t o sopra gli s tabi l iment i
267
1 d e l l ' O r d i n e in gene ra l e e su ques to fe r ro p u n i t o r e degli spergiur i , di cus todi re ge losamente tut t i i segret i della rispettabile Carboneria , di n o n scrivere o incidere o disegnare cosa alcuna senz 'averne o t tenuto pe r iscritto il permesso dall'Alta Vendita. Giuro di soccorrere i miei Buoni Cugini pe r quanto compor tano le mie facoltà, e di n o n a t tentare all 'onore delle loro famiglie. Se divengo spergiuro, sono contento che il mio corpo sia fatto a pezzi, indi bruciato e le mie cener i sparse al vento affinché il mio n o m e sia esecrato da tutti i Buoni Cugini sparsi sulla terra . Così Dio mi aiuti!»
Dopodiché i l d o m i n o assegnò all 'iniziato un n o m e convenzionale, gl ' insegnò alcuni cenni e paro le pe r farsi riconoscere dai confratelli , ma r a c c o m a n d a n d o g l i di farne i l m e n o uso possibile. Poi gli disse: «Tu appa r t i en i da o ra al p r imo g rado de l l 'Ord ine , che è soltanto u n a fase di prova. N o n hai alcun dirit to, n e m m e n o quello di p resentare nuovi aspiranti ; hai p e r ò dei doveri , che ti sarà facile adempie re . Custodisci religiosamente il tuo segreto, a t tendi con pazienza, fede e sommissione, e dent i p ron to ad agire nel momento o p p o r t u n o . A suo t e m p o saprai il n o m e della Vendita cui appar te r ra i e del capo da cui riceverai gli ordini . Se frattanto dovremo dar tene qualcuno, t i sarà comunicato dal Cugino che ti presentò . L'Ordine ha occhi e orecchi ovunque , e da questo istante ti vigila o v u n q u e tu sia e q u a l u n q u e cosa tu faccia».
Ques to avveniva a Genova. Ma a Napoli s tando alle Memorie sulle Società segrete s tampate anon ime in Inghi l terra , la cer imonia dell ' iniziazione era molto più complicata e tenebrosa. L'aspirante, chiamato pagano, veniva p r ima condot to benda to nel bosco e sospinto attraverso u n a bar r ie ra di fuoco, «simbolo di quella fiamma di carità che deve a rde re semp r e nel vostro cuore pe r d is t ruggere i germi dei sette peccati capitali». Poi gli si mostrava la testa recisa o la m a n o mozza di un t r ad i t o r e , ed e r a su quest i trofei che gli si faceva p ronunc ia re il g iu ramento . Quind i il maestro vibrava t re colpi di scure su un t ronco, comunicava al neofita il n o m e e i
268
segni convenzional i , vibrava altr i t re colpi, e d ich iarava chiusi «i sacri travagli» con un dup l ice evviva al G r a n d e Maestro divino e u m a n o Gesù Cristo e a San Teobaldo.
Come si vede , n e a n c h e in questo p iù complesso r i tuale c 'erano accenni ai fini della società, cioè alla sua ideologia. Ed è na tu ra l e p e r c h é questa fu s e m p r e mol to composi ta e incerta , come composi ta e incer ta e r a l 'origine della setta. La Carboner ia era infatti un derivato, un amalgama di molte a l t re sètte, o g n u n a delle qual i c i aveva po r t a to del suo, spesso in contraddiz ione con quello delle altre. La loro storia è e s t remamente arruffata e forse nessuno riuscirà mai a d ipanar la in manie ra esauriente anche pe rché ne mancano le impron te digitali, cioè i document i , che la segretezza imponeva di d i s t r u g g e r e . Noi ci l im i t e r emo q u i n d i a r icos t ru i rne i l f i lone pr inc ipale , ma senza i m p e g n o di assoluta esattezza.
La g rande m a d r e di tu t te era stata cer tamente la Massoneria, di cui abbiamo già disegnato la vicenda. Per non r ipeterci, ci l im i t e r emo a r i c o r d a r e che di segre to , p e r l u n g o tempo, essa n o n aveva avuto che la liturgia. I suoi aderent i , quasi tut t i «illuministi», n o n pe r segu ivano scopi rivoluzionari e qu indi non avevano motivo di nascondersi . Lungi dal perseguitarli , molti governi li p ro teggevano, e fra di essi mil i tavano anche dei Re: G iuseppe I I d 'Austr ia , Ca te r ina di Russia, perfino Maria Carolina di Nàpoli ne fecero par te .
Le cose cambiarono con la rivoluzione francese, che mise anche i massoni alla scelta: o col vecchio regime, o col nuo vo. La spacca tura fu p ro fonda , e n o n si è mai p iù sanata . Per il nuovo regime e al servizio delle idee democrat iche fu cer tamente la massoneria di rito scozzese, che tutti r i tengono, p e r ques ta sua qualifica, di o r ig ine inglese. E r r o r e . Si chiamò così pe r ché i suoi aderen t i sos tennero pe r qualche t empo le pretese al t rono d ' Inghi l te r ra degli scozzesi Stuart - che oltre a tut to e rano fior di reazionari -, ma e rano francesi. Essi si conver t i rono ben pres to all 'ideologia rivoluzionaria , e le loro logge ne d iven ta rono fra i p iù efficaci s tru-
269
menti di p ropaganda all 'estero. Ma ce ne furono delle altre che invece questa ideologia la r i f iutarono e anzi passarono all 'estremo opposto . Per s t rano che possa sembrare a qualche le t tore ab i tua to a cons ide ra re la Massoner ia come la roccaforte dell 'anticlericalismo più arrabbiato, fra la fine del Sette e i pr imi del l 'Ottocento ce ne fu anche una domina ta dai nostalgici del vecchio reg ime assolutistico e dai Gesuiti al contrattacco dopo la soppressione del loro Ord ine .
Lungi dal combat ter la , Napo leone cercò di asservire la Massoneria e, anche se non del tutto, ci riuscì. Anche in Italia i regimi ch'egli v ' instaurò ebbero l 'appoggio delle logge, che infatti furono pro te t t e sia da Eugenio a Milano che da Mura t a Napoli. E fu p ropr io pe r questo loro at teggiamento collaborazionistico che i dissenzienti se ne s e p a r a r o n o pe r da re avvìo ad altre società molto più segrete di quan to non fosse la Massoneria perché in dissenso con l 'ordine costituito che il dissenso lo perseguitava come sovversione.
La p r i m a ad a t tecchi re in Italia fu, a q u a n t o p a r e , u n a Lega nera, di cui avrebbero fatto pa r te uomini di varie tendenze, ma accomunati dal proposi to di l iberare l'Italia dallo s t ran ie ro , austr iaco o francese che fosse. La cita nella sua Storia d'Italia il Botta che, senza da rne altri ragguagli , nel seguito della sua - molto confusa - nar raz ione , attribuisce gli stessi connotat i a un 'al t ra società, quella dei Raggi, fra i cui più important i affiliati spicca il nome di Lahoz.
N o n si riesce a capire se le d u e organizzazioni facessero t u t t ' u n o o fossero in conco r r enza . Si è a p p u r a t o sol tanto che i Raggi si chiamavano così perché si diffondevano a raggerà dalla casa-madre centrale di Bologna, che la loro fioritura risale al pe r iodo della Repubblica Cisalpina, cioè fra il '96 e il 1804, e che in ogni capoluogo c'era u n a succursale formata di c inque «patrioti» sotto la gu ida di un «capo-colonna». Secondo un r a p p o r t o della polizia napoleonica , la setta aveva messo radici anche in Piemonte, dove perfino alcuni membr i del governo provvisorio ne facevano par te . Essi e r ano in stretti r appor t i coi giacobini di Parigi pe rché di
270
questo a p p u n t o si t rat tava: di u n a r ipresa di giacobinismo d o p o la l iquidazione di Robesp ie r re e cont ro la politica di un Direttorio, s empre più domina to dai militari e soprat tutto da Napoleone .
Tu t to lascia c r e d e r e che i Raggi siano stati al mass imo qualche centinaio di persone . Ma la loro presenza è importante pe rché segna u n a ro t tu ra del fronte patriottico destinata ad approfondirsi sempre più lungo il Risorgimento: da u n a p a r t e i «democratici», di cui i Raggi r a p p r e s e n t a v a n o l 'avanguardia , e che la l iberazione dell 'Italia volevano affidar la all'iniziativa popo la re , cioè a un moto r ivoluzionario dal basso; dall 'altra i cosiddetti «moderati» che, non credendo a questa iniziativa e n o n volendola pe r t imore dei disordini sociali ch'essa avrebbe compor ta to , cercavano di addossarla a qualche potere costituito e alla fine lo t rovarono nella monarchia piemontese dei Savoia.
Nel '99 ci fu nel Monfe r ra to u n a piccola i n su r r ez ione contro il regime instaurato dai francesi, che la polizia addebitò ai Raggi. Ma gli studi più recenti h a n n o dimostrato che l 'attribuzione era arbitraria. La rivolta era scoppiata per autocombustione, cioè dal malcontento dei contadini pe r i soprusi e le requisizioni delle t r u p p e francesi. I Raggi cercarono di appropr iarse la e di darle un contenuto politico distrib u e n d o opuscol i d i p r o p a g a n d a e r i t ra t t i de i g r a n d i capi giacobini di Parigi . Ma gl ' insort i , quasi tut t i contad in i , gli opuscoli n o n li lessero perché e rano analfabeti e i ritratti dei capi giacobini li scambiarono pe r immagini di Santi. Il loro p r o g r a m m a politico e ra l ' incolumità del pollaio, n iente altro.
I Raggi n o n ressero alla repress ione poliziesca di cui poi finirono pe r fare le spese: tant 'è vero che, dal 1802, della loro setta non si trova più traccia. Ma da essa ne pul lu la rono infinite a l t re , di cui sarebbe vana impresa cercar di ricostruire i dati anagrafici e ideologici. U n a delle più impor tanti fu YAdelfia, versione ind igena della Filadelfia francese d'ispirazione giacobina. Ma ce ne furono anche di tendenza
271
diametra lmente opposta, cioè reazionaria, come i Trinitari e i Calderari a Napoli, diretti discendenti dei Sanfedisti del cardinale Ruffo, che cospi ravano pe r i l r i t o rno dei B o r b o n e ; come l'Amicizia cattolica e XAmicizia cristiana a Torino, dominata dai Gesuiti e dai nostalgici dei Savoia; e come la Società del Cuore di Gesù in Lombard ia , o rgano del par t i to austriacante.
I motivi di questo improvviso pullulìo di sètte sono evident i . Alla base, na tu ra lmen te , c 'erano le scontentezze p ro vocate dai regimi napoleonici . Ma questo non spiega nulla pe rché di regimi stranieri e sopraffattori gl'italiani soffrivano da secoli, senza che ciò li avesse mai spinti a cospi rare . L'unica loro manifestazione di protesta e rano stati i tumult i e il br igantaggio . Di qualcosa che assomigliasse a una lotta politica organizzata n o n e r a n o mai stati capaci. Cominciavano ad esserlo ora grazie all ' invasione francese che aveva acceso non soltanto molte speranze, ma anche molte ambizioni.
Le sètte pescavano i loro adept i sopra t tu t to nei ceti medi. Abituati da secoli a restare esclusi dal potere , essi avevano visto nella rivoluzione la g rande occasione pe r inserirvisi e d iventa rne i protagonist i , come a p p u n t o era avvenuto in Francia; e perciò e rano corsi incont ro al conquistatore che la incarnava. Ma Napo leone aveva in g r a n pa r t e deluso le loro aspettative. All'Italia egli chiedeva soldati, ufficiali, magistrati, funzionari, insomma m a n o d o p e r a e tecnici. Politici, no . La politica era privativa sua e dei suoi. Ci fu chi si contentò di diventare colonnello o magistrato. Ma ci furono anche quelli che n o n si conten tarono . E furono costoro i pr imi militanti delle società segrete d'ispirazione democratica. Ma poco d o p o sopraggiunse u n a seconda e più massiccia ondata: quella dei colonnelli e dei magistrati epura t i pe r collaboraz ionismo col despo ta , q u a n d o quest i c a d d e . Infatt i la g r ande fioritura delle sètte comincia p ropr io con la restaurazione, la quale mise sul lastrico tutta una categoria di «notabili» borghes i che , d o p o avere morso l ' inebr ian te p o m o
272
del po t e r e , n o n i n t e n d e v a n o r e s t a rne a d ig iuno . C 'e ra d i mezzo anche una quest ione di pane . In un Paese economicamen te depresso e cu l tu ra lmen te a r r e t r a t o come l 'Italia, dove il «posto» rappresen tava la più ambita delle grazie, la politica appariva la più p romet t en te di tutte le «carriere».
Con ciò non vogliamo dire che gli adept i delle società segrete fossero soltanto degli ambiziosi carrieristi. Fra loro c'era di tut to, e di tut to forse c'era in o g n u n o di loro, salvi i casi eccezionali di p u r o idealismo e di p u r o arrivismo. Vogliamo soltanto dire che non c'è materiale più esplosivo e quindi p iù d isponibi le alla cospi raz ione di u n a classe messa al b a n d o dal p o t e r e d o p o averlo assaggiato ed esserne stata, sia p u r e in avara misura, compartecipe. Fu essa infatti a fornire le reclute della Carboneria .
Era la più giovane di tu t te le sètte, a lmeno in Italia. E perché prevalse su tutte le altre che l 'avevano preceduta , è difficile dire . Ma, pe r quanto ancora molto discusso, a noi sembra che il suo albero genealogico sia abbastanza chiaro.
A fondar la , o p e r meglio d i re a t r ap i an ta r l a nel nos t ro Paese fu un commissar io politico francese, Briot, venu to a Napoli al seguito di Giuseppe Bonapar t e nel 1806, e mandato in qualità d ' i n t enden te , cioè pressappoco di prefet to , p r ima a Chieti eppoi a Cosenza dove nacquero infatti le prime vendite. Briot e ra un ex -depu ta to giacobino che nel '99 aveva p ronunc ia to nel pa r l amento di Parigi un violento discorso in favore del l 'uni tà italiana cont ro la politica del Direttorio che l'avversava. Originar io della Franca Contea, faceva pa r t e di un vecchio compagnonnage - o confraterni ta -locale di boscaioli, cacciatori e con t rabbandie r i che si chiamavano charbonnìers, carbonai. Fra loro si davano di cugini o buoni cugini, e dicevano di risalire ai tempi medievali di u n a leggendaria regina Isabella che coi suoi soprusi li aveva costretti a rifugiarsi nella foresta. Qui si e r ano imbattut i in un eremita, Teobaldo, che poi era diventato i l loro Santo p ro tettore e li aveva miracolati facendogli incontrare e t r a r re a
273
salvamento il Re smarritosi d u r a n t e una caccia che pe r ringraziarli si fece anche lui carbonaio.
A pa r t e questa mitologia, e ra u n a società di m u t u o soccorso, che n o n aveva mai avuto con tenu to politico. Lo acquistò con la rivoluzione, forse pe r ope ra dello stesso Briot che, essendo dei suoi, la convert ì ai p r o p r i ideali democratici e repubblicani . Q u a n d o questi ideali furono accantonati e con t r adde t t i dal Di re t tor io , i C a r b o n a r i pas sa rono all 'opposizione e, siccome l 'opposizione n o n e ra tollerata, si r i fugiarono nella clandestinità, d iven tando u n a vera e p ro pr ia setta.
Che da questa discendesse la Carboner ia italiana, lo prova n o n solo l ' ident i tà del n o m e , ma anche la qualifica di Buoni Cugini che si at tr ibuivano gli adepti , l 'organizzazione pe r Vendite, Alte vendite e Vendite madri, la gerarchia dei gradi - apprendista, maestro, gran maestro -, il r i conosc imento di Teobaldo come Santo prote t tore . Lunica differenza era forse il con tenuto ideologico. E n o n già pe rché quello italiano differisse da quello francese; ma p e r c h é la Carboner ia italiana, a differenza di quella francese, un con tenu to ideologico preciso n o n l 'aveva, o p e r lo m e n o n o n lo formulava ch iaramente ; e questa fu forse la ragione del suo prevalere sulle altre sètte.
Ques te e r ano m o r t e non tan to d i persecuzione , quan to di asfissia, cioè pe r mancanza di seguito e di eco in u n a popolaz ione t r o p p o i g n o r a n t e e a r r e t r a t a p e r cap i re , o com u n q u e p e r cond iv idere , cert i ideali . La Ca rbone r i a n o n volle r ipe t e re ques to e r r o r e . E p e r evitarlo, n o n c 'era che un m o d o : adegua r s i agli u m o r i della pubbl ica o p i n i o n e e sopra t tu t to ai suoi malumor i , che variavano secondo il mom e n t o , la la t i tudine e le circostanze. Nel Sud, al t e m p o di Murat , le Vendite cercarono di sfruttare il sent imento cattolico offeso dalla politica anticlericale del reg ime e raccattarono proseliti perfino diffondendo u n a falsa «bolla» di Pio VII che consacrava la Carboner ia e invitava i fedeli ad aderirvi. In Romagna , dove ar r ivarono più tardi , esse furono r igoro-
274
samente democra t i che e repubbl icane . In P iemonte , d o p o la Restaurazione, fecero fronte con la Federazione monarchi ca, o add i r i t t u r a vi si fusero. Ecco p e r c h é nelle iniziazioni non si faceva cenno al suo p r o g r a m m a .
Questa sua elasticità fu u n o dei motivi che contr ibui rono al r ap ido diffondersi della setta. Un altro furono i suoi lati ciarlataneschi. Essa si giovò moltissimo dell 'alone di t ruculento mistero che seppe creare in torno a sé e delle leggende a cui d i ede avvìo. Si raccontava di spergiur i r invenu t i p u gnalati nel letto accanto alla moglie ignara , di altri t rovat i crocefissi nel bosco con u n a corona di spine in testa, di altri fulminati da veleni inesplorabili . E l ' impressione che tu t to questo suscitava, insieme con la lugubre simbologia, esercitava sugli adept i un g ran fascino.
In seguito Mazzini denunz iò questo scialo di pugnal i , di veleno, d i croci , d i scuri , d i pa ro le d ' o r d i n e , tu t t a ques ta messinscena di formule, di sigle, di segni di r iconoscimento, d i cenni , d i ammiccamen t i , tu t to ques to t e n e b r o r e d i ap pun tamen t i nel bosco, di b e n d e , di baveri rialzati, d icendo che molto spesso e rano fine a se stessi, un giuoco pe r darsela da be re a vicenda e credersi impor tan t i e pericolosi. Infatti l ' a r ros to n o n e ra in p r o p o r z i o n e al fumo. Alla p rova dei fatti, risultò che questi g rand i cospiratori n o n riuscivano a sventare l ' infil trazione delle spie di cui le Vendite e r a n o sempre p iene , né i t r ad imen t i degli spergiur i con t ro cui i l castigo si r iduceva quasi s empre a innocui «bruciamenti in effigie», né le confessioni sotto gl ' in terrogator i . Però anche Mazzini, da giovanissimo, aveva a p p a r t e n u t o alla setta, anzi vi aveva fatto carr iera fino al g rado di Maestro. Ed era logico: fino alla «Giovane Italia», la Carboner ia fu l 'unico strumento di milizia rivoluzionaria, tutti i patrioti ci passarono, e molti di loro furono autentici mart ir i . Resta solo da vedere se il suo tirocinio fu tut to positivo pe r i valori ch'essa intendeva p r o p u g n a r e .
Come abbiamo de t to , l 'organizzazione e ra r i g idamen te gerarchica . Ogn i Vendita o Baracca e ra costi tuita da vent i
275
Buoni Cugini. U n o solo, il Maestro, conosceva il pa r ig rado delle altre diciannove Vendite che componevano la Vendita Cent ra le , la quale con lo stesso m e t o d o comunicava - solo ora lmente , mai pe r iscritto - con la Vendita Suprema. Questo o rgan ig ramma, come oggi si dice, e ra imposto dalle condizioni di clandestinità in cui la setta doveva agire. Ma introduceva, o meglio ribadiva, un criterio autor i tar io che pur t r o p p o in Italia trovava il p iù congeniale dei te r reni . Tutto veniva dall 'alto. Gli Apprendis t i , che poi e rano la massa di manovra , non par tecipavano min imamente alla formazione della volontà politica, e ne e rano tenut i comple tamente all 'oscuro. Nelle Vendite n o n c 'era un dibat t i to ideologico. Questo era riservato agli alti dignitari della Vendita Suprema, che considerava la r ivoluzione u n a sua privativa, ammin i s t r a n d o n e i pr inc ìp i come a l t re t t an te verità r ivelate di cui essa restava l 'unica depositaria. Ciò ne faceva, nel migliore dei casi, u n a casta sacerdotale coi suoi alti problemi ideologici; nel peggiore , u n a consorter ia coi suoi interessi corporativi che con t r apponeva a un ' I ta l ia autor i tar ia e «di vertice» un'I tal ia al tret tanto autori taria e «di vertice» sosti tuendo a u n a mafia di nobili u n a mafia di borghesi . Infatti la Carboner ia fu a volte l 'una, a volte l'altra cosa, s t rumento - secondo gli uomin i che l 'amminis t ravano - di alti ideali, o di arrivismi, e anche di basse vendet te . C o m u n q u e , n o n fu certo u n a scuola di educazione politica, e probabi lmente è anche al suo esempio e modello che sono dovute le malformazioni della nostra democrazia e la sua intrinseca debolezza. Figli e n ipot i de i Ca rbona r i furono quei «notabili» che gove rna rono l'Italia fino alla p r ima gue r ra mondiale e che, insieme a innegabili virtù, ebbero anche il vizio di considerare il Paese una «clientela» di Apprendis t i esclusi dai «sacri travagli». E anche la democraz ia a t tua le segui ta ad essere p ro fondamen te carbonara nei suoi partiti organizzati come Supreme Vendite e gestiti da ristretti g r u p p i di professionisti che agiscono n o n da «delegati» del popolo, ma da «pastori» del «gregge».
276
Questo fu il vero lato negativo della Carboner ia che più tardi indusse Mazzini a divorziarne e a combatterla. E risaliva al l ' insegnamento e all 'esempio di un uomo che ne fu insieme il g r a n d e i sp i ra tore e il g r a n d e c o r r u t t o r e : Fi l ippo Buonarro t i .
CAPITOLO VENTISETTESIMO
B U O N A R R O T I
Quello che Bakunin ha chiamato «il più g r ande cospiratore del secolo» fino a pochi anni fa era conosciuto quasi esclusivamente come uno dei protagonist i del complot to e del processo di Babeuf. Oggi esiste su di lui un in te ro scaffale di o p e r e , fra cui fanno spicco quel le del Saitta e di Galante Gar rone .
Appar teneva alla famiglia fiorentina di Michelangelo, ma e ra na to a Pisa nel 1761, e lì fece i suoi s tudi che a quan to p a r e furono p iu t tos to d i so rd ina t i p e r c h é a n d a v a n o dalla matematica alla musica, di cui fu pe r tutta la vita un appassionato cultore. Tuttavia u n a laurea in legge la prese , sposò u n a ragazza nobile di Firenze, en t rò come paggio alla Corte del g r a n d u c a Pie t ro L e o p o l d o , fu fatto cavaliere di Santo Stefano, e insomma sembrava avviato a occupare un posto di tutto comodo e rispetto in quella piccola ma civile società di provincia . Anche la sua iscrizione alla Massoner ia n o n aveva nulla di rivoluzionario: la Massoneria era lo s t rumento dell ' I l luminismo, di cui lo stesso Sovrano era un adepto .
Ma lì fece conoscenza con le ope re di Rousseau, che agir o n o su di lui come un t r auma. Alla loro luce Pietro Leopoldo, che aveva abolito la to r tu ra e la pena di mor t e e che tutta la cul tura eu ropea salutava come il monarca più progressista d ' E u r o p a , gli a p p a r v e «un despota» e il suo reg ime un'infamia. Per combatterl i in nome della Democrazia e dell 'Eguaglianza, fondò u n a Gazzetta universale che fece molto r u m o r e , ma suscitò poca eco. La polizia del «despota» si limitò a qualche perquisizione. Ma q u a n d o da Parigi giunsero le notizie della Bastiglia, Buonar ro t i non ebbe esitazioni'.
278
piantò la moglie e le quat t ro figlie ch'essa gli aveva dato pe r trasferirsi in Corsica e mettersi al servizio della Rivoluzione. 11 gesto era rivelatore di una certa scelta: Buonarro t i si sentiva legato a un ' idea più che a una patria, e pe r tutta la vita seguiterà a considerare la patria u n o s t rumento dell ' idea.
A Bastia il suo zelo rivoluzionario gli valse un posto di dir igente, ma anche l'ostilità dei benpensant i che alla fine insorsero con t ro di lui e lo cost r insero alla fuga. A Livorno, dove riparò a b o r d o d 'un peschereccio, la polizia lo arrestò per espatrio clandestino, ma il «despota» lo fece subito liber a r e p e r res t i tui r lo alle au tor i t à còrse che lo rec lamavano tra loro. Probabi lmente ricevette l'incarico di costituire delle «cellule» rivoluzionarie in Toscana perché , malgrado l'incidente , poco d o p o to rnò di nascosto a Firenze, dove fu di nuovo arrestato. Ma evase, scampò a Genova, ne fu espulso e tornò in Corsica a r iprendervi il suo posto di agitatore.
Questo pe r iodo fu pe r lui molto impor tan te pe r d u e ragioni. Anzitutto perché le sue mansioni lo misero in contatto coi Bonapa r t e e con Saliceti. Eppo i pe rché in quel l 'ambiente so t tosvi luppato le sue idee assunsero un indir izzo massimalista che di lì a poco lo avrebbe messo in contrasto con la politica del regime. Fu qui ch'egli elaborò la sua utopia di u n a società egalitaria e dispotica molto più vicina al modello di Sparta e degli Esseni che a quello borghese perseguito dai Girondini allora al po tere .
Q u a n d o questi c adde ro nel '93, Buonar ro t i e ra a Parigi per sollecitare la natural izzazione. La sua intimità con Robespierre fa par te più del mito di Buonar ro t i che della sua storia. Ma che frequentasse i circoli giacobini, vi fosse considerato di casa e tr ipudiasse del loro trionfo, è certo. Furono essi a dargli la cit tadinanza e a mandar lo in qualità di «commissario» a Oneglia che le t r u p p e francesi avevano strappato al P iemonte . Vi trovò molti r ivoluzionari italiani in fuga dai loro rispettivi Stati e stabilì con loro dei rappor t i che ebbero il loro peso sulla nascita delle p r ime società segrete nel nostro Paese e sul loro iniziale or ien tamento ideologico. Ma
279
come politico n o n diede b u o n a prova a causa del suo estremismo. Come già a Bastia, istaurò il t e r ro re provocando anche la reazione dei simpatizzanti. E finché il Te r ro re vinceva anche a Parigi, gli a n d ò bene . Ma q u a n d o Robesp ie r re cadde , fu denunz ia to pe r abuso di po te re e - come oggi si direbbe - «deviazionismo di sinistra», r ichiamato nella capitale e r inchiuso in prigione.
Fu qui che i ncon t rò Babeuf, i l r ivoluzionar io francese che portava le idee rousseauiane fino alle loro es t reme conseguenze comuniste . Buonar ro t i n o n arrivava alle medesime conclusioni: egli restava fermo al Vangelo giacobino. Ma anche se divergevano sul piano ideologico, i d u e uomini sald a r o n o su quel lo u m a n o un vero e p r o p r i o gemel laggio . E n t r a m b i cons ide ravano l 'attività r ivoluzionar ia l 'unica compat ib i le con la d ign i tà de l l ' uomo , un sacerdozio che comportava il sacrificio di qualsiasi interesse e diletto personale. Nelle loro utopie la Virtù doveva essere la gruccia della Giustizia.
Q u a n d o furono rimessi in libertà, Buonarro t i s'iscrisse al «Pantheon», la società segre ta che Babeuf aveva costituito pe r rovesciare il regime, sempre più borghese e conservatore , del Direttorio, e anzi ne diventò u n o dei principali esponenti . Sciolto dalla polizia, il g r u p p o si r iformò clandestinamen te pe r sfociare più tardi nella cosiddetta «congiura degli eguali». Ma questo n o n impedì a Buonar ro t i di ricevere nel f ra t tempo e svolgere altri incarichi governativi , p robabi lmente procurat igl i dal vecchio amico Saliceti il cui astro cresceva col crescere di quello di Bonapar te . Fra l 'altro, ora che questi si d isponeva a invadere l 'Italia, gli fu affidato il compi to di riallacciare i r a p p o r t i coi r ivoluzionar i italiani pe r farne delle «quinte colonne». Stavolta dovette da r prova di efficienza p e r c h é nel '96 i l Di re t tor io lo p r o p o s e come collaboratore a Cacault, suo agente nella penisola. Ma questi declinò l'offerta. «Buonarrot i - scrisse - è ricco d ' immaginazione e di talenti le t terar i e filosofici. Ma di p rob lemi politici concreti non sa nulla.» Non ebbe bisogno d'insistere
280
perché la scoperta della congiura condusse all 'arresto di tutti gli «eguali», compreso Buonarro t i .
Nel l 'emergenza r icomparve in scena - e fu, c redo, l'ultima volta - sua moglie, che d o p o l 'espatrio lo aveva raggiunto a Bastia dove gli aveva dato un quinto figlio. Sebbene egli l'avesse rimpiazzata con un 'amante , Teresa Poggi, la povera d o n n a fece del suo meglio pe r p rocura rg l i aiuti b u s s a n d o alla por ta dei personaggi più altolocati. E a lmeno d u e di essi lo porse ro : Napo leone e il capo della polizia Fouché, un po ' p e r c h é B u o n a r r o t i aveva sapu to res tare in b u o n i r a p por t i con loro, un po ' forse pe r a l leggeri re la posizione di Saliceti ch 'era rimasto invischiato nella vicenda per i suoi legami con l'italiano.
Fatto sta che dei t r e pr inc ipal i impu ta t i , solo Babeuf e Da r thé furono c o n d a n n a t i a m o r t e e avviati al pa t ibolo . Buonar ro t i , che nel processo si e ra compor t a to con mol to coraggio e dignità, se la cavò con la depor taz ione in u n a fortezza davant i a Cherbourg , dove gli consent i rono anche di ospitare la sua concubina. Ques to t ra t t amento di favore gli valse l 'ostilità degli altri «eguali» che n o n ci vedevano un g rande esempio di uguaglianza, ma gli permise di tenersi in c o r r i s p o n d e n z a coi vecchi amici giacobini di Parigi . N o n chiedeva aiuti. Chiedeva soltanto u n a revisione del processo nella speranza di farne una clamorosa affaire che riaccendesse nelle masse lo spirito r ivoluzionario. Credeva che ce ne fosse ancora , che bastasse u n a scintilla p e r farlo divampare : e questo conferma il giudizio che di lui aveva dato Cacault.
Diventa to P r imo Console , N a p o l e o n e lo fece t rasfer i re come semplice sorvegliato speciale nelle Alpi Marit t ime, gli assegnò un piccolo sussidio; e finalmente, da I m p e r a t o r e , gli permise di trasferirsi come libero cittadino a Ginevra, allora ridotta anch'essa a d ipar t imento francese. Fu mal ripagato p e r c h é nel '12 i l Prefet to lo in fo rmò che B u o n a r r o t i aveva monta to u n a congiura contro di lui. Ma Napoleone, o che n o n ci c redesse , o che - com'è p iù probabi le - n o n lo
281
prendesse molto sul serio, si limitò a farlo trasferire a Grenoble. E stavolta la sua generosità fu compensata . Q u a n d o , dopo la parentesi dell 'Elba, r iprese il potere , Buonarro t i gli offrì i suoi servigi. Ma forse la g r a t i t u d i n e n o n c 'en t rava . Quasi tutti gli ex-giacobini, sebbene n o n avessero cessato di complot tare contro Napoleone che li aveva messi in disparte, nei Cento Giorni s i sch ie ra rono con lui: un po ' pe rché , di fronte all 'invasione straniera, il sent imento patriottico rip r e n d e v a in loro il sopravvento sull 'avversione ideologica; un po ' pe rché , p e r q u a n t o lo esecrassero, essi prefer ivano l ' Impero alla Restaurazione.
Dopo Waterloo, Buona r ro t i r i to rnò a Ginevra restituita alla sua patria svizzera, e qui si diede anima e corpo alla tessitura della sua rete rivoluzionaria. Gli specialisti discutono ancora con accanimento a quale delle molte società segrete di allora egli attinse i criteri organizzativi. Sembra che s'ispirasse sopra t tu t to alla loggia massonica degli «Il luminati di Baviera». Ma questo c ' interessa poco. C'interessa molto di più vedere come funzionava in concreto la «macchina» che egli montò .
Per la p r o p a g a n d a e il proselitismo, creò u n a compagnia di «Sublimi Maestri Perfetti» che compor tava solo una sommaria iniziazione e l 'adesione a princìpi che, essendo di ordine più morale che politico, non esponevano gli affiliati alla persecuzione poliziesca e qu indi li a t t i ravano facilmente. Ma essa non era che lo schermo e lo s t rumento di un piccolo stato maggiore d'intellettuali avvolti nel più fitto segreto e in te ramente dedicati alla Causa, che si chiamava «Aeròpa-go», corr ispondeva pressappoco al «Pantheon» di Babeuf, e doveva r appresen ta re un vero e p ropr io ord ine monastico, di cui lo stesso Buonar ro t i ammet teva il carat tere dittatoriale. Solo i suoi membr i conoscevano i veri fini della setta, di cui av rebbe ro gu ida to l 'azione senza rivelarli n e m m e n o a coloro che la svolgevano. Era il concetto di una rivoluzione diret ta da un «vertice» d 'I l luminati , di cui le masse dovevano essere gl 'inconsapevoli s t rument i .
282
La Ca rbone r i a esisteva già, q u a n d o B u o n a r r o t i s i mise all 'opera, come esistevano gli Adelfi e tante altre società segrete. Egli cercò di r idur le sotto il suo comando infiltrandovi uomin i suoi e s t ipu lando con esse a m b i g u e al leanze. Q u a n t o ci riuscisse, è con t roverso . Secondo Saitta, il suo prestigio era immenso e lo rendeva, se n o n onnipoten te , alm e n o onn ip resen te . Ma Galante G a r r o n e , che r id imensiona a lquan to la sua inf luenza, c i p e r s u a d e di p iù . C o m u n que, egli incorse presto in un incidente che, oltre a bu t t a re all 'aria tut ta la sua opera , n o n d e p o n e molto a favore della sua oculatezza ed efficienza.
Fra gli altri giovani che riuscì a irret ire, ci fu un certo An-dryane che, venuto da lui pe r impara r l'italiano, si lasciò iniziare alla politica sebbene vi fosse del tu t to allergico. Buon a r r o t i lo sped ì a Milano con u n a valigia p i ena «di document i u n o più inutile e pericoloso dell 'altro, ma tali da compromet te re mezza Italia», fra i quali c 'erano anche le regole e gli statuti della società, i segni di r iconoscimento e le parole d 'o rd ine t ra affiliati. Inesper to ed emotivo, il ragazzo cadde subito nei tranelli della polizia ed espiò la sua storditaggine nella cupa pr igione dello Spielberg, dove lo r i t roveremo insieme a Pellico, Maroncell i , Confalonieri e tanti altri patrioti italiani. Ma la leggerezza con cui Buonar ro t i aveva manda to allo sbaraglio quel poveraccio si concilia male con la sua fama di «mago dei complott i» e ha fatto sorgere il dubb io , spe r i amo in fonda to , ch 'egli volesse que l disastro pe r a t t i ra re l 'a t tenzione sulla sua società e p rovoca re u n a repressione che gli fornisse nuovi adepti . Altra cosa curiosa è che, sebbene identificato come m a n d a n t e , n o n ebbe noie dalla polizia. Solo pe r p recauz ione si trasferì da Ginevra a Losanna, e alla fine prese stabile d imora a Bruxelles.
Bruxelles era il luogo di raccolta di quegli ultimi giacobini, che n o n po tevano r i m p a t r i a r e p e r c h é nel '93 avevano c o n d a n n a t o a m o r t e i l Re. C ' e r a n o C a m b o n , Levasseur, Sieyès, Cambacérès e tant i altri che si r i un ivano la sera al «Caffè delle Mille Colonne». Come tutti i fuorusciti, si odia-
283
vano come fratelli e passavano il t empo a scrivere memoriali pe r rinfacciarsi gli un ì agli altri il fallimento della rivoluzione. Buona r ro t i s ' imbrancò con loro, ma disprezzandol i dall 'alto della sua ortodossia robespierr iana. Per lui la Rivoluzione e ra stata i l T e r r o r e ; tu t to ciò ch ' e r a venu to d o p o non n 'era stato che il t rad imento . E fu al lume di questa tesi che compose quella che passa p e r la sua ope ra capitale: La cospirazione per l'uguaglianza detta di Babeuf.
Come pezzo polemico contro i regimi res taurat i , questa esaltazione degli eroici ideali che avevano ispirato gli uomini della Cost i tuente e della Convenz ione esercitò sui cont e m p o r a n e i u n a notevole inf luenza. Ma come scampolo ideologico, è ben povera cosa: un r imast icamento del pensiero di Rousseau condito con la retorica e la demagogia di Robespier re . Vi s'invoca «il dispotismo della l ibertà cont ro quello della tirannia», il dovere di r e n d e r libero l 'uomo anche contro la sua volontà, il culto di un vago Essere Supremo eccetera. È un r i to rno alle origini del giacobinismo più rozzo e arcaico, che dà r ag ione a Ta lmon q u a n d o allinea Buona r ro t i fra i p recurso r i di quella «democrazia totalitaria» che nel nostro secolo doveva incarnarsi nel comunismo e nel fascismo. Perfino il l inguaggio è il medes imo. Buonarroti qualifica «tradimento» ciò che oggi si chiama «deviazionismo» e p r o n u n c i a il t e rmine «hébertista» o «dantonista» come i fascisti di ieri p ronunc iavano quello di «demopluto» e i comunist i di oggi quelli di «trotzkista» e «bucharinista». Il r ichiamo che questo libro esercitò sui con t emporane i fu dovu to solo alla sua forza, d ic iamo così, di c o n t r a p p u n t o . Era il m o m e n t o in cui il ministro Guizot lanciava ai francesi la famosa pa ro la d ' o rd ine : «Arricchitevi!» Era logico che a un invito così prosaico gli uomin i della nuova generazione romant ica preferissero quello di Buonar ro t i a un eroico rilancio rivoluzionario.
Siccome l'affare A n d r y a n e aveva sconvolto tut ta la re te dei Sublimi Maestri, Buonar ro t i si d iede a tesserne un'altra sotto una nuova sigla: Le, Monde, il Mondo , che tuttavia s'i-
284
spirava ai medes imi cri teri organizzativi . Anch 'essa aveva d u e facce: quella pubblica che si at teneva a un p r o g r a m m a riformista, che anche i reg imi m o d e r a t i av rebbe ro po tu to adot tare; e quella segreta dei soliti «iniziati», pront i a impadronirsi del movimento pe r i loro fini rivoluzionari. Ancora u n a volta B u o n a r r o t i cercò d ' in f luenzare i Ca rbona r i , gli Adelfi, gli Apofasimeni e tut te le altre società segrete italiane col solito sistema delle alleanze e delle infiltrazioni. Saitta dice che quest ' influenza fu tale da far di lui il vero p a d r e del Risorgimento. Ma non ci convince pe r un motivo molto preciso: e cioè che il Risorgimento si veniva sempre più ispirando a un ' idea di patria, cui Buonar ro t i era sordo. E vero che a suo t empo aveva det to ai patrioti di Oneglia: «Spicciatevi a fare l 'unità nazionale». Ma poi aveva aggiunto: «E la condizione per is taurare in tutta la penisola u n a democrazia egalitaria». I l suo t r a g u a r d o restava ques t 'u l t ima; l 'uni tà ne rappresentava solo lo s t rumento e la scorciatoia. La Francia lo interessava molto più dell'Italia, era convinto che solo da essa potesse venire la r igenerazione del m o n d o , e pe r questo non aveva esitato a p r e n d e r n e la nazionalità. Come tanti suoi con temporane i , anche lui pensava che «l 'Europa starnu ta q u a n d o Parigi p r e n d e il raffreddore», e che qui d u n que la battaglia andasse combattuta .
Ora , tutto questo p e r l'Italia aveva un senso finché l'Italia fu francese e quindi al regime francese era d i re t tamente interessata. Ma dopo la restaurazione dei vecchi Stati, pe r i patr iot i i taliani l 'uni tà e l ' i nd ipendenza n o n furono p iù il mezzo, ma il f ine. Buonarrot i non ebbe né poteva avere più presa su di loro, e lo si e ra visto in Piemonte, dove la Federaz ione si e ra c o m p l e t a m e n t e sot t ra t ta alla sua influenza. Da allora n o n riuscì p iù a ese rc i ta rne ; e def in i t ivamente gliela s t r appe rà di m a n o Mazzini, che in te rpre tava questo «nuovo corso» con più impegno e anche - riconosciamolo -con più ingegno e coerenza e altezza morale di lui.
In u n a sola cosa B u o n a r r o t i r imase p r e c u r s o r e e mae stro: nel conio di que l l ' a rche t ipo u m a n o che la Eisenstein
285
chiama «il r ivoluzionario professionista». In questo , anche Mazzini dove t te qualcosa alla sua lezione, come mol to gli devono anche gli altri g r a n d i r ivoluzionari de l l 'Ot to e del p r i m o Novecento da Nechaev a Bakunin a Malatesta a Lenin. Si parla, r ipeto, di archet ipo umano , non di contenuto ideologico.
Ecco perché di tutti i suoi scritti il più significativo è, caso mai, quello che non ebbe il t empo - e forse neanche l 'intenzione - di d iventare un libro. Si t rat ta di una specie di taccuino di appun t i , scoperto di recente e pubblicato dal Sait-ta, che rappresen ta u n a specie di catechismo per gli «iniziati» al sacerdozio r ivoluz ionar io . Esso esige, s econdo Buonarrot i , doti di carat tere e regole di vita rigorosissime. L'iniziato dev 'essere u o m o di g r a n d e coraggio , ma riflessivo e p ruden t e , nonché paziente e perseverante . Deve tenere nel debito conto la liturgia dell 'organizzazione par tec ipando alle sue cer imonie allegoriche, r i spe t t andone i riti, le formalità e le gerarchie. Deve osservare scrupolosamente il segreto e r i f iutare qualsiasi os ten taz ione . Deve p a r l a r e poco e manteners i sobrio in tutto, specialmente in amore .
Di alcune di queste virtù, non si p u ò dire ch'egli fornisse un g r a n d e esempio . Le tes t imonianze dei c o n t e m p o r a n e i concordano nel presentarce lo come un personaggio estroverso e bollente, che colpiva l'occhio non solo pe r la bizzarria dei suoi acconciamenti, ma anche pe r lo smalto della sua conversazione infiorata di paradossi . Un giovane francese che a n d ò da lui a p r e n d e r e lezioni d ' i ta l iano, lo t rovò che «suonava il p i ano improvv i sando e cavando dal suo strum e n t o g i rando le di fuoco». Invece che alla l ingua, volle a tu t t i i costi iniziare al can to l 'allievo, sebbene quest i n o n avesse né voce né orecchio, «e c redo che ci sarebbe riuscito grazie al suo musicale a rdore e indomabile energia». Si ammantava di mistero, ma facendo in m o d o che tutti se ne accorgessero e incuriosissero. C 'era insomma in lui anche un lato ciarlatanesco che gli attirava in ugual misura simpatie e diffidenze. Aveva la pass ione degli p seudon imi , dei docu-
286
menti falsi, dei rifugi clandestini, dei segni di riconoscimento stregoneschi. Quan to all 'amore, fu tutt 'al tro che astinente. Dopo aver a b b a n d o n a t o la moglie p e r l ' amante lasciandole a carico cinque figli di cui più n o n si curò - b u o n allievo anche in ques to del maes t ro Rousseau che i figli suoi li aveva messi all'ospizio -, lasciò anche l 'amante pe rché costei si rifiutava di p renderg l i in casa un 'a l t ra aman te . Il carteggio fra lui e queste d u e d o n n e n o n è privo di comicità n o n solo perché si svolgeva fra protagonist i che avevano tutti supera to la sessantina, ma anche pe r i l candore con cui Buon a r r o t i sosteneva la per fe t ta regolar i tà del ménage a t r e . «Mio caro - gli scrisse un amico che agiva da paciere fra loro - , tu p r e t ende re s t i che u n a s ignora educa ta secondo le regole de l l 'Europa c o n t e m p o r a n e a accettasse di vivere come u n a m u s s u l m a n a del sesto secolo». La conclus ione fu che Buona r ro t i dovet te contentars i della terza aman te che lo seguì a Parigi, p u r r e s t ando con la seconda in r a p p o r t i epistolari fino alla fine dei suoi giorni, che scadde nel '37.
Il rilancio ideologico di Buonarro t i , a cui abbiamo assistito in questo d o p o g u e r r a , si p u ò capirlo. Egli è stato un asser tore di quel le is tanze sociali che oggi , specie in Italia, h a n n o preso un net to sopravvento su quelle nazionali screditate dal fascismo. Ma il tenta t ivo di farlo a p p a r i r e come un g rande innovatore e anzi un precursore del marxismo, è goffo e ridicolo. Buonar ro t i è s empre r imasto al '93 , e non se ne mosse più, convinto che la Storia si fosse fermata lì, a Robespierre . Di Robespierre aveva un tale culto, che firmava i suoi scritti col nome di lui, Massimiliano. Ma non gli somigliava affatto, anzi ne rappresentava l'antitesi umana . Era esa t tamente il cont rar io del gelido asceta della ghigliottina che chiedeva agli altri di d iventare . Come tut te le c rea ture u m a n a m e n t e ricche, lo era anche di contraddiz ioni . I l suo s a n g u e si accendeva p e r le sofferenze de l l ' umani t à , ma quelle dei singoli, anche se amici suoi, lo lasciavano indifferente . Sebbene Blanch gli attribuisca una «augusta malinconia», era rimasto giovane anche da vecchio, imparzialmente
287
p r o n t o al l 'entusiasmo e alla collera. È curioso che molti lo descrivano d ' imponen te presenza. Risulta invece che misurava poco più d 'un met ro e sessanta. Ma por tava la testa leonina con tale piglio e maestà da sembrare un gigante.
Q u a n d o mor ì , l'influsso ch'egli aveva esercitato sulle società segre te i taliane e ra f in i to , come del res to e r a logico: egli n o n aveva r appresen ta to che un m o m e n t o della storia francese, che poteva interessare solo l'Italia di Napoleone e le sue sopravvivenze. Però aveva creato una pedagogia rivoluzionaria, e n o n delle migliori. Proprio a lui la Carboner ia doveva i vizi che l'afflissero - la spregiudicatezza morale , gli a t t egg iamen t i mafiosi, le s t r u t t u r e an t i democra t i che , le buffonesche messinscene - cui Mazzini più tardi si ribellerà. Il pa r agone fra i d u e uomin i n o n regge . Anzi, n o n si p o n e n e m m e n o .
CAPITOLO VENTOTTESIMO
I C O S T I T U Z I O N A L I DI NAPOLI
I moti italiani del '21 cominciarono in Spagna. Qui , d o p o la parentesi napoleonica, il t rono era tornato ai Borbone, e su di esso sedeva F e r d i n a n d o VI I che, ol tre ad essere n ipo te dell 'altro Ferd inando , quello di Napoli , ne era anche genero perché ne aveva sposato la figlia. Per lui, la Spagna si era dissanguata e aveva dissanguato Napoleone . E Ferd inando se ne sdebitò revocando la Costituzione che i francesi le avevano concesso. Nel gennaio del '20 egli dovette m a n d a r e un corpo di spedizione nell 'America del Sud, ch 'era ancora dominio in gran par te spagnolo. Le t r u p p e concentra te a Cadice si a m m u t i n a r o n o ch iedendo la revoca della revoca, e la rivolta si p ropagò di colpo a tut to il Paese. Le Potenze della Santa Alleanza minacc iarono d ' in te rveni re . Ma pe r questo occorreva alle loro forze libero transito attraverso la Francia che lo rifiutò, e Fe rd inando dovet te acconciarsi alla limitazione dei p rop r i poteri .
L'Italia rimase contagiata dall 'esempio perché da q u a n d o era diventata u n a galassia di Stati coloniali, si e ra abituata a vivere di r ipor to . Incapace di e laborare qualcosa di suo, non faceva che copiare i modelli stranieri. Quello spagnolo era il più congeniale alle popolazioni delle Due Sicilie un po ' pe r gli strettissimi vincoli che un ivano le d u e dinastie borboni che, un po ' pe r similarità di condizioni semifeudali, un po ' p e r c h é la rivolta d i Cadice aveva u n a v e n a t u r a ana rco ide che si confaceva pe r fe t t amente agli u m o r i del nos t ro Sud. Fu Napoli infatti a dare il segnale.
Vediamola un po ' da vicino questa rivolta, poiché essa illumina come meglio n o n si po t rebbe la fragilità dei regimi
289
restaurati , ma anche i limiti, le insufficienze e la confusione mentale delle forze rivoluzionarie italiane.
Nella notte fra il 1° e il 2 luglio del 1820, un piccolo repar to di cavalleria di s tanza a Nola e c o m a n d a t o da un t e n e n t e Morelli, scese in piazza al gr ido: «Viva la libertà e la Costituzione!» e si mise in marcia su Avellino. Morelli era un carbonaro , ma aveva agito per conto suo, stanco di aspettare dalla sua setta degli ordini che n o n venivano. Dappr ima nessuno si mosse al suo appello. Ma ad Avellino qualche centinaio di «cugini» si u n i r o n o al suo p lo tone a p p u n t a n d o sui cappelli la coccarda azzurra, nera e rossa della Carboneria .
Morelli aveva scelto come meta quella città perché lì aveva il suo comando il generale Guglielmo Pepe. Pepe non era carbonaro . Ma era la personali tà più in vista di quegli ufficiali formatisi nell 'esercito di Mura t che, sebbene rimasti nei q u a d r i grazie alla politica di «amalgama» del Medici, vi si t rovavano a disagio. Egli aveva sempre avuto contatti con la Carboner ia , e negli ul t imi mesi aveva anzi cercato di concertare con essa un piano d'azione c o m u n e sul tipo di quello spagnolo . N o n c 'era r iusci to p e r c h é la Ca rbone r i a n o n aveva né un capo né un 'organizzazione capaci di u n a vera volontà politica. Come abbiamo già det to, sul suo originario t ronco giacobino, s i e ra innes ta to un po ' di tu t to , trasform a n d o l a in un deposi to di scontentezze senza u n a precisa ideologia e sopra t tu t to senza q u a d r i d i r igent i . I l magg ior contr ibuto glielo dava infatti un ceto piccolo-borghese di ufficiali subalterni , sottufficiali, artigiani, mercant i , professionisti di provincia e pret i di campagna (ce n 'e rano parecchi), tra i quali non emergeva nessuna personali tà di rilievo. Ecco perché , tratto il dado , Morelli si rivolgeva a Pepe. Cercava un capo.
Pepe n o n c'era: e ra a Napol i . Morelli pa r lò d u n q u e col colonnel lo De Concilj che lo sostituiva, m u r a t t i a n o anche lui. Non sapendo che pesci p r e n d e r e , De Concilj lo invitò a restar fuori della città in attesa del r i torno del Generale . Ma
290
l ' indomani Morelli vi en t rò e gli affidò pubbl icamente il com a n d o dei suoi uomini , come se si trattasse di cosa già concordata. Dopo aver provocato la rivolta, il carbonaro ne affidava la d i rez ione al m u r a t t i a n o r i lu t t an te che forse lo avrebbe messo agli arres t i , se le t r u p p e della gua rn ig ione non si fossero mostrate totalmente solidali con gl'insorti.
So rp reso dagli avven iment i , i l gene ra l e aust r iaco Nu-gent, che comandava l'esercito borbonico, spedì contro i ribelli un corpo d 'a rmata al comando di Carascosa. Ma anche Carascosa e ra mura t t i ano , e si limitò a p r e n d e r posizione, ma senza attaccare. Il colpo di grazia lo det te Pepe che, messo alla scelta fra sconfessare la rivolta o d iventarne il protagonista, preferì la seconda alternativa, mobilitò alcuni regg iment i della capi tale , e alla loro testa marc iò su Avellino pe r unirsi a De Concilj e Morelli.
Anche re Fe rd inando dovette scegliere: o la g u e r r a civile, o la Costituzione. Seguendo l 'esempio del suo o m o n i m o e nipote di Madrid , scelse la Costituzione, cioè s ' impegnò a concederla en t ro otto giorni. Gl'insorti r isposero che la scadenza e ra t r o p p o lunga, visto che si t rat tava di ado t t a r e il testo spagnolo , già bell 'e p r o n t o . E il Re cedet te anche su questo cont rof i rmando il decreto di suo figlio Francesco, cui frattanto aveva riaffidato poteri di Vicario. Il bello è che, da quanto risulta, quella famosa Costituzione spagnola n o n l'avevano mai letta né lui né gli altri. Tutt i sapevano soltanto ch 'era considerata la più democrat ica fra quan te ne fossero state fin allora redat te .
Il 9 luglio i Costituzionali, come ormai gl'insorti si chiamavano, sfilarono p e r le vie di Napol i fra b a n d e e b a n d i e r e . Apriva il cor teo lo s q u a d r o n e di Nola, r ibat tezzato «battaglione sacro». A cavallo seguiva Pepe coi suoi reggimenti . In coda si affollava u n a marea di civili con la coccarda azzurra, ne ra e rossa: gli stessi carbonar i dovet tero essere stupiti di quella loro improvvisa molt ipl icazione. Fra i nuovi iscritti c'era lo stesso Vicario che, con tutti i Principi reali, assisteva alla sfilata da un balcone della Reggia agi tando il cappello
291
con la coccarda. Ferd inando si e ra dato malato, ma ricevette Pepe e gli altri capi del movimento.
La rapidi tà e facilità di questo successo che n o n era costato u n a goccia di sangue, fece dfre agli osservatori stranieri nei loro rappor t i ch'esso era dovuto a una unanimità popola re d ' in tent i , di cui il pronunciamiento mil i tare era stato solo lo s t rumento . Tutto infatti sembrava a n d a r e pe r il meglio. Fu costi tuito un nuovo gove rno , n u o v o pe r m o d o di d i re pe r ché vi figuravano tutti i vecchi nomi , m e n o quello di Medici: il solito Gallo, il solito Zurlo, il solito Ricciardi, il solito Campochiaro . I nuovi e rano solo quello di Carascosa, ministro della Guer ra , e di Pepe, comandan te dell 'esercito. Tradot ta in italiano, la Costituzione spagnola venne adottata senza modifiche, e il Re giurò sul Vangelo di r ispettarla. Ma propr io a questo p u n t o cominciarono i guai.
Alla notizia della vittoria r ipor ta ta dagl ' insort i napole tani , a n c h e Pa l e rmo esplose , ma p e r tu t t ' a l t r i mot ivi . La città n o n si e ra rassegnata all 'abolizione de l l ' au tonomia siciliana e alla perd i ta del suo r ango di capitale che n o n coinvolgeva soltanto l 'orgoglio di campani le , ma si t raduceva anche in crisi economica e disoccupazione. Protagonis te della rivolta furono infatti n o n la Carboner ia , ma le maestranze, come già e r a accaduto nel ' 73 . Per p lacarne la violenza, che immerse la città in un bagno di sangue, il genera le Naselli, l uogo tenen te del Re, si affrettò a concedere la Costituzione . Ma questo n o n d isarmò affatto gl ' insorti che anzi l'obbl igarono a reimbarcarsi d o p o aver debellato e scacciato la guarn ig ione .
Fino a questo m o m e n t o c'era stata t ra loro una certa concordia perché il malcontento verso Napoli era condiviso da nobiltà, borghesia e p ro le ta r ia to . Ma ora che si t ra t tava di scegliere un p r o g r a m m a politico, si accorgevano che i loro fini e rano assai diversi e difficilmente conciliabili. La Costituzione che volevano i nobili e ra quella siciliana del ' 12 che r ibadiva i loro privilegi e li r e n d e v a p a d r o n i dell 'isola. La
292
Costituzione che volevano le maestranze era quella spagnola, che i privilegi li aboliva e il po t e r e lo affidava alla volontà popo la re . Di questo conflitto, la borghesia avrebbe po tu to diventare l 'arbitra. Ma, impaur i ta dalle violenze di piazza e abituata da sempre a vivere agli st ipendi e al r imorchio dei baroni , tentò di far fronte con loro in u n a Giunta provvisoria di governo. Le maestranze scesero di nuovo pe r le strade, massacrarono d u e dei nobili più influenti, e istituirono u n a nuova Giunta composta di nove aristocratici e nove borghesi, ma posti sotto il controllo dei p rop r i Consoli. A differenza di quella di Napoli, la rivolta di Palermo era d u n q u e di marca p o p o l a r e con forti vena tu re di radical ismo giacobino. Ma, pe r mancanza di quadr i , era costretta ad affidarsi a uomini di altri ceti.
A questo motivo di debolezza, se ne aggiunse subito un secondo: la ren i tenza delle al t re città siciliane. Con la sola eccezione di Girgenti , n o n solo esse r imasero sorde all 'appello di Palermo, ma vi si mos t ra rono ostili. Questo dissenso era dovuto anzitutto al fatto che in queste città, e specialmen te a Catania e a Messina, il ceto borghese era molto più forte che a Palermo e non si sentiva solidale con u n a rivoluzione che n o n era ope ra sua e n o n lo vedeva protagonis ta ; eppo i alla rivalità di c ampan i l e . Nessuna di esse p o t e n d o aspi rare a l r a n g o di capitale, tu t te prefer ivano che ques ta restasse a Napoli.
A d o m a r n e la resistenza, Palermo inviò delle «squadrac-ce» che r iuscirono a pene t r a re a Caltanissetta e la misero a sacco. Ma Trapani e Siracusa le respinsero, men t r e nel cont ado si accendeva la guerr ig l ia . In ques t ' emergenza , la Giunta spedì a Napoli una deputaz ione che si chiamava siciliana, ma che in realtà era soltanto pa le rmi tana , compos ta pari te t icamente di nobili, borghesi e maestranze, pe r trattare un accordo, men t r e Napoli spediva a Palermo un nuovo Luogotenente , il pr incipe Ruffo, e un Generale , Florestano Pepe, fratello di Guglielmo, che mosse su Palermo alla testa delle sue t ruppe . La Giunta decise di negoziare con lui, ma
293
il popol ino scese in armi pe r le strade, e Pepe dovette aprirsi la s t rada a suon di cannona te . Nel f ra t tempo a Napoli la delegazione trattava, e alla fine raggiunse un accordo: il gove rno centra le riconosceva a Palermo il dir i t to di e leggere un pa r l amen to separa to che p e r ò avrebbe esercitato i suoi po te r i solo se la sua au tonomia fosse stata app rova ta dalle altre città e comuni siciliani. Nobiltà e borghesia palermitane accet tarono questi termini . Le maestranze, r imaste sole, r i nunz i a rono alla lotta. E il 6 o t tobre Pepe potè fare il suo ingresso in città.
Cinque giorni p r ima a Napoli si e ra inaugura to il p r imo pa r l amento di t ipo m o d e r n o , cioè autent icamente «rappresentativo», che l'Italia abbia avuto. Gli eletti e r ano ottantanove, di cui i nobili n o n raggiungevano la diecina. Il grosso era formato da professionisti, intellettuali, magistrati , possiden t i e p re t i , cioè da borghes i . Q u a n t i fossero iscritti alla Carboneria , non si sa. Ma si trattava, dice Croce, «di vecchi o uomin i ma tu r i , che avevano cospi ra to t ra il '92 e il '99 , pa r t ec ipa to alla Repubbl ica , gue r r egg ia to e ammin i s t r a to nel Decenn io di Mura t , e o ra p r o c u r a v a n o di m a n t e n e r e quan to s'era acquistato, n o n solo dal p rop r io paese, ma dalle p ropr ie persone». Di rivoluzionario quindi avevano poco, e lo d i m o s t r a r o n o q u a n d o si t ra t tò di ratificare l 'accordo raggiunto coi siciliani. Sicuri che Palermo era ormai isolata r i spe t to alle a l t re città isolane e che anche le Maes t ranze avevano perso il morden te , lo respinsero, r ich iamarono Pepe e al suo posto m a n d a r o n o un «duro», Pietro Colletta, con al t re t r u p p e di r inforzo. La resistenza pa l e rmi t ana s'illanguidì. Ma s'illanguidì anche lo slancio rivoluzionario di tutto il Mezzogiorno, che aveva sperato di r o m p e r e il centralismo dello Stato assoluto. Assoluto, lo Stato nuovo n o n lo era più. Ma il centralismo restava.
A Vienna , Met te rn ich aveva segui to lo svolgimento di queste vicende con molta inquie tudine . Ciò che lo preoccupava n o n e rano gli at teggiamenti del nuovo regime napoletano, di cui aveva capito benissimo il carat tere «moderato»,
294
ma la forza di contagio ch'esso poteva sviluppare sugli altri Stati italiani. U n a volta impiantata a Napoli, u n a Costituzione liberale n o n vi si sarebbe fermata: l 'avrebbero voluta anche a Milano, a Torino, a Firenze; e sarebbe stata la fine del dominio austriaco sulla penisola. Bisognava quindi estirpare quella pianta velenosa con un p ron to intervento. Questo era legittimato dai trattati del '15 che riconoscevano all'Austria u n a specie di tu te la sugli Stati i taliani. Ma sul p i a n o pratico l 'operazione presentava parecchie difficoltà.
Anzi tut to , quelle di politica estera. La Francia, che oramai aveva riacquistato il suo rango di g r a n d e Potenza, n o n era favorevole al reg ime costituzionale di Napoli, ma lo era ancora m e n o a l ra f forzamento del l ' inf luenza aust r iaca in Italia. Al t re t tanto ostile, pe r gli stessi motivi, e ra la Russia. Per l ' intervento era invece l ' Inghil terra, o pe r meglio dire il suo P r imo Ministro Cas t lereagh, conserva tore a r rabb ia to . Ma poi bisognava fare i conti anche con gli Stati italiani, e soprat tut to con quello Pontificio che avrebbe dovuto conced e r e l ibero t rans i to alle t r u p p e aus t r iache . N a t u r a l m e n t e anche il governo papal ino paventava il movimento costituzionale da cui si sentiva esso stesso minacciato. Ma n o n paventava di meno l'Austria che al Congresso di Vienna aveva cercato di s t rapparg l i le Legazioni e po teva prof i t ta re di quel la spediz ione puni t iva su Napol i pe r r ioccupar le . Insomma, le opposizioni non mancavano. Per metter le a tacere, n o n c'era che un modo : far sì che fosse la stessa Napoli, cioè il suo legit t imo sovrano - visto che i reg imi res taura t i n o n riconoscevano altra r appresen tanza - a r ichiedere l'intervento pe r motivi di o rd ine in terno.
Ques ta richiesta, Met ternich n o n ebbe neanche bisogno di sollecitarla. Ferd inando gli aveva già segretamente scritto che n o n vedeva l'ora di r innegare la Costituzione e per farlo chiedeva l 'aiuto delle baionette austriache. Il Cancelliere convocò d 'urgenza pe r il 27 ot tobre (1820) i r appresen tan t i delle maggior i Potenze a Lubiana . Ci fu rono l u n g h e contrattazioni dovute alle solite reciproche diffidenze e gelosie.
295
Ma alla fine prevalse la tesi austriaca secondo cui l ' intervento era legittimo là dóve si compivano riforme «illegali» (cioè cont ro l 'o rd ine costituito degli Stati assoluti) e che ques to era propr io il caso delle Due Sicilie (un'anticipazione, come si vede, del principio di «sovranità limitata» che oggi l 'Unione Sovietica applica ai suoi Stati satelliti). E Ferd inando venne invitato a presentarsi a Lubiana pe r chiar i re se la situazione del suo Regno rispondesse al caso previsto.
Governo e par lamento napoletani si t rovarono di fronte a una scelta in realtà assai difficile. N o n avevano combinato molto, in quei mesi, né come politica estera, né come politica in t e rna . In un r a p p o r t o de l l ' ambasc ia tore inglese sta scritto: «Si occupano di tut to, fuorché del necessario. La sett imana scorsa vi fu una lunga discussione, risoltasi in disputa, pe r giudicare se Dio fosse o no il legislatore dell 'universo». Altri p rob lemi a s p r a m e n t e d iba t tu t i e r a n o se Napoli dovesse essere ribattezzata Pa r t enope e il Pa r l amen to n o n fosse da chiamare Cortes come in Spagna. Come sempre , come anche oggi, le sole rivoluzioni che gl'italiani sanno fare sono quelle dei nomi. Ora p e r ò si t rat tava di dec idere ben altro. Concedere al Re il passaporto per Lubiana significava rimettersi nelle sue mani pe rché solo alla sua parola le Potenze avrebbero creduto . Negarglielo significava la g u e r r a con esse.
Su Ferdinando, nessuno si faceva illusioni. La sua avversione a qualsiasi istituto costituzionale era nota, come lo era la sua infedeltà a qualsiasi g iu ramento . Ma n o n c'era alternativa: o fingere di credergli, o battersi. Ferd inando, già deciso al t radimento , m a n d ò al Par lamento un messaggio con cui s ' impegnava a d i fendere presso le Potenze la causa di una «Costituzione saggia e liberale», ma senza dire quale. 11 Par lamento gli chiese di precisare. E il Re precisò che alludeva alla Costituzione vigente, cioè a quella spagnola. I Carbona r i n o n e r ano persuas i , p r o p o n e v a n o di r if iutargli i l passapor to , e q u a n d o ques to invece gli fu accorda to , gli m a n d a r o n o una deputazione f in sulla nave che doveva con-
296
dur lo a Trieste pe r r icordargl i la p romessa . «Pur acca' me véneno a r omp ' e bballe!» brontolò in dialetto il Re lazzarone . E a p p e n a a r r iva to da L ivorno a F i renze , get tò la maschera rilasciando una dichiarazione in cui diceva che la Costituzione gli e ra stata estorta con la violenza e per tan to egli la sconfessava.
Per Met te rn ich , quel la d ich ia raz ione g iungeva a b u o n pun to . Francesi e russi ricominciavano a muovere obbiezioni all ' intervento, e il governo pontificio cercava a tutti i costi di sventar lo . Ma il Re lo legi t t imava col suo t r a d i m e n t o . Metternich se ne avvalse pe r lanciare al governo napoletano l'invito a sottomettersi senza condizioni ai voleri del Sovrano, sul quale tuttavia n e m m e n o lui si faceva illusioni. «E la terza volta - scriveva - che r imetto in piedi Ferd inando, il quale ha il malvezzo di r icadere s empre . Nel 1821 egli seguita a c redere che il t rono sia un seggiolone su cui potersi sdraiare e dormire .» N e m m e n o in quei frangenti il Re lazzarone aveva muta to pare re . Le uniche sue preoccupazioni anche a Lubiana, e rano la caccia di giorno e il «picchetto» a carte la sera. Non si curava n e p p u r e di sapere cosa succedeva a Napoli.
In real tà n o n vi succedeva g ranché . All 'arrivo del ministro Gallo, latore del messaggio di Metternich, i Carbonar i p r o p o s e r o la lotta a ol t ranza, ma l 'ebbero vinta sol tanto a parole . I l Principe Vicario dichiarò che suo p a d r e era stato cer tamente costretto a r innegare la Costituzione, ma che lui l 'avrebbe difesa anche con le armi, e impart ì l 'ordine di mobil i tazione. Ma si vide subi to ch 'esso cadeva nel vuo to . Il Par lamento sentiva di non «rappresentare» nulla: la g rande massa della popo laz ione e ra r imas ta del tu t to e s t r anea a l mov imen to costi tuzionale, come del resto e ra logico, visto che i ceti med i che ne avevano assunto l'iniziativa avevano mi ra to a u n a cosa sola: a costituirsi in g r u p p o di p o t e r e e casta privilegiata al posto della vecchia aristocrazia. C o m e nel '99, n e a n c h e stavolta n ien te era stato fatto pe r d a r e al nuovo regime un contenuto popolare e autent icamente de-
297
mocrat ico. L 'emergenza por tava a galla tu t te le con t radd i zioni che lo minavano dalla nascita, e soprat tut to quella fra il central ismo della capitale e l ' au tonomismo della provincia. La Costituzione aveva coper to tutti questi contrasti sociali e municipal i , ma senza p u n t o risolverli, e qu ind i n o n poteva contare su nessuna concordia di voleri.
Ques ta condiz ione si rifletteva au toma t i camen te sull 'esercito. L'azione dei Carbonar i ne aveva minato la disciplina ed era servita soltanto ad al lontanare la t r u p p a dagli ufficiali, quasi tutti murat t iani . A questo si e r ano aggiunte le rivalità personali . Filangieri scrisse al generale Carascosa: «I generali napoletani non possono mor i re che pe r m a n o dei loro soldati pe rché siamo arrivati a tal p u n t o che gli ufficiali, qua lunque grado abbiano, n o n r iusci ranno mai a vedere il nemico, neanche con un cannocchiale». Ma Carascosa non se ne diede per inteso perché il suo vero nemico n o n erano gli austr iaci , ma Pepe che aveva assun to i l c o m a n d o delle milizie provinciali reclutate pe r l'occasione.
Ciascuno di questi d u e general i redasse il suo p iano all ' insaputa e in c o n c o r r e n z a con l 'a l t ro. Carascosa assunse u n a posizione difensiva schierando p r i m a sul Garigl iano e poi sul Vol turno un esercito mut i la to dei suoi migliori re par t i , p r e c e d e n t e m e n t e m a n d a t i di gua rn ig ione in Sicilia. Pepe, u o m o di scarso carat tere ma di fervida fantasia, prese l ' iniziativa m u o v e n d o incon t ro a l gene ra l e F r i m o n t che scendeva dalla Lombard ia alla testa delle sue solide t ruppe e p e r s e g u e n d o il g randioso p r o g r a m m a di r agg iunge re la Romagna , sollevarla e accendere la g u e r r a in tu t ta l 'Italia settentrionale. O pe r lo m e n o così scrisse nelle sue Memorie. Ma già a Rieti fu bloccato dalle avanguard ie austriache che con pochi colpi di fucile misero in fuga i suoi raccogliticci repar t i . Tentò la resistenza ad Antrodoco, ma senza migliori r isultat i . Carascosa, dal can to suo, p e r evi tare la disfatta, evitò il combat t imento. E il 20 marzo gli austriaci en t ra rono a Capua quasi senza colpo ferire.
Il giorno p r ima il Par lamento, contagiato a sua volta dal-
298
la diserzione e r ido t to a ventisei depu ta t i , votò la p ro tes ta redat ta da Poerio cont ro il r ipud io della Costituzione e decise il p r o p r i o agg io rnamen to , soave eufemismo di scioglimen to . I lazzaroni appese ro sulla po r t a un cartello con la scritta «Affittasi», e corsero in piazza ad acclamare le t r u p p e austriache che en t r a rono in città il 23 .
CAPITOLO VENTINOVESIMO
I FEDERATI DI T O R I N O
Q u a n d o Metternich decise a Lubiana la spedizione punit iva contro Napoli, si p reoccupò del Piemonte. Per quel l ' impresa, le t r u p p e austriache avrebbero sguarni to la Lombardia , e questo poteva rappresen ta re pe r Torino una grossa tentazione. Non che diffidasse di Vittorio Emanue le che sapeva di sen t iment i ant iaustr iaci , ma legato c o r p o e a n i m a alla causa legittimista di cui l 'Austria era l'alta pa t rona . Ma anche a lui poteva succedere ciò ch 'era successo a Ferd inando: di trovarsi pr igioniero di un movimento patriottico e libertario.
Ricevette informazioni rassicuranti, ma sbagliate. Il moto cost i tuzionale napo le t ano aveva acceso g rand i entus iasmi fra i Federat i che smaniavano d ' imitare i Costituzionali napoletani e di cor re re in loro aiuto occupando la Val Padana e p r e n d e n d o gli austriaci fra d u e fuochi. I patrioti milanesi, con cui avevano strettissimi contatti , si dicevano pront i a insorgere pe r far causa c o m u n e con loro.
La p r ima avvisaglia del l 'uragano fu del tutto casuale. La sera dell ' I 1 gennaio (1821), molti s tudent i affollavano il teatro in cui recitava Carlotta Marchionni , una delle più famose attrici del t empo che r i t roveremo mescolata alla vicenda di Silvio Pellico. Qua t t ro di essi por tavano berret t i rossi con fiocco nero , i colori della Carboneria . All'uscita, la polizia li fermò. I giovani resistettero, altri ne accorsero, e ne nacque un grosso tafferuglio che si concluse con alcuni feriti e parecchi arresti.
L'indomani tutti gli s tudent i di Torino e molti professori espressero il loro sdegno p e r l 'accaduto, rec lamarono l'im-
300
mediata scarcerazione dei fermati e, non avendola o t tenuta n e m m e n o con l ' intercessione del min is t ro de l l ' i s t ruz ione Balbo - il p a d r e di Cesare -, chiusero l 'Università e vi si barr icarono. Per sloggiarli, b isognò m a n d a r e la t r u p p a all'assalto dell'edificio. Morti non ce ne furono perché gli ufficiali avevano saggiamente fatto scaricare i fucili; ma le corsie dell 'ospedale si r i empi rono di feriti.
La polizia era r icorsa a quella d u r a repress ione pe r ché era convinta che gli s tudent i avessero agito, d ' accordo coi patrioti, in base a un piano rivoluzionario ben definito. Non era vero. Fra gli uni e gli altri n o n c'era nessuna collusione, ma l 'episodio la creò e con t r ibu ì a p rec ip i t a re gli avveniment i . Nei confronti delle vittime ci furono molte manifestazioni di simpatia, e la più vistosa fu quella di Carlo Alberto che m a n d ò loro dolci e dena ro e anzi, s tando a Brofferio, a n d ò addir i t tura a visitarli.
Tra i Federati, i pare r i e rano divisi. I più p ruden t i , come Balbo e Sclopis, sostenevano che non valeva la pena r icorrere a l l ' insurrezione: p r i m a di tu t to pe r ché difficilmente sarebbe riuscita; eppoi pe rché , anche se fosse riuscita, avrebbe messo in crisi lo Stato r e n d e n d o g l i impossibile quel la gue r ra all'Austria che tutti invocavano. Fra poco, dicevano, Carlo Alber to sarebbe salito au tomat i camen te sul t r ono , e quella rivoluzione l 'avrebbe fatta lui, nel l 'ordine.
Leali monarchici , Santarosa e i suoi amici n o n e rano insensibili a questi a rgoment i , ma nello stesso t e m p o n o n volevano p e r d e r e la g r a n d e occasione del la spediz ione austriaca con t ro Napoli . Da Milano g iungevano appell i semp r e più pressant i , e lo stesso Carlo Alberto si mostrava impaziente. Egli si era messo d i re t tamente in contat to coi patrioti di quella città, che gli avevano manda to un loro emissario, il conte Pecchio, pe r p r e n d e r e accordi. Non si è mai saputo con precisione quali furono i reciproci impegni ; ma che ce ne fossero e che a Milano se ne parlasse abbastanza l iberamente, sembra accertato. C o m u n q u e , era tut to un susseguirsi d ' incontr i , un intrecciarsi d i proget t i , un parlot t ìo
301
che teneva Tor ino in stato di t ens ione e r e n d e v a incomprensibile l'apatia del Re.
Si e ra anco ra in ques ta fase, q u a n d o il caso ci mise lo zampino . Il 3 marzo, in seguito a u n a delazione, venne arrestato alla frontiera il pr incipe Pozzo della Cisterna, un liberale che si era stabilito a Parigi pe r sottrarsi all'asfissia della Restaurazione. In tasca gli furono trovati document i che compromet tevano molti Federati con cui era r imasto in contat to e lo stesso Carlo Alberto. La cosa fu subito r i saputa e anche i più esitanti, p e r sottrarsi al pericolo di venire coinvolti in quella faccenda che si annunziava clamorosa, si decisero all 'azione.
La sera del 6, Santarosa, Collegno, San Marzano e Lisio a n d a r o n o a palazzo Ca r ignano , dove li aspet tava Rober to D'Azeglio. Al Principe che li ricevette nella sua biblioteca, i congiurat i dissero che, fatta salva l ' incolumità personale del Re e della sua famiglia che n o n era n e m m e n o in discussione , l ' indomani (o il dopodomani ) avrebbero sollevato i reggimenti di artiglieria e di cavalleria di stanza a Fossano, alla loro testa av rebbe ro marc ia to su Moncal ier i dove il Re si trovava con la Corte e che, approf i t tando anche dell'assenza di Car lo Felice, mol to p iù d u r o e r isoluto de l fratello, ma che in quei giorni si trovava con la moglie a Modena, avrebb e r o impos to a Vit torio E m a n u e l e la Cost i tuzione e la dichiarazione di gue r ra all'Austria.
Sulla risposta del Principe, la polemica n o n è ancora finita fra gli storici del Risorgimento. Secondo Santarosa, egli a p p r o v ò il p roge t to e si d ichiarò p r o n t o a secondar lo . Secondo Carlo Alberto e i suoi agiografi, egli dichiarò in tono indignato che non solo se ne dissociava, ma era fermamente deciso a schiacciare con le sue t r u p p e la ribellione, visto che di altro n o n si trattava.
Fra le d u e versioni, è molto più attendibile la pr ima, che gli altri qua t t ro par tec ipan t i n o n smen t i rono mai e che fu resa da Santarosa q u a n d o era già all 'estero e fuor di pericolo, m e n t r e Carlo Alberto rese la sua nei p a n n i del l ' imputa-
302
to, q u a n d o il Re lo accusò di fellonìa. Ma forse il referto più esatto è quello che si trova negli appun t i di Santarosa, stesi subito dopo l'intervista, e in cui è det to che il Principe «si riservò, come i l compi to p iù ada t to al suo r a n g o , quel lo di media tore fra gl'insorti e il Re». Questo non smentisce il suo consenso, ma lo sfuma e anche pe r questo somiglia molto di p iù al pe rsonaggio . Ch'egl i avesse d i sapprova to , come poi pretese e i suoi agiografi seguitano a p re t ende re , lo smentisce il seguito dei fatti.
Rimasto solo e resosi conto della terribile responsabili tà che aveva assunto , fu colto dallo sgomen to , t rascorse u n a notte insonne, e l ' indomani chiamò il Collegno e il San Mar-zano pe r dirgli che ritirava la sua parola (che d u n q u e aveva dato) e ingiungergl i di revocare gli o rd in i . Poi si pen t ì del p e n t i m e n t o , si l a m e n t ò che i cong iura t i lo avessero p reso sul serio e r ich iamò Santarosa e San Marzano . Costoro gli confermarono il p iano della sollevazione ma, avendo capito con che t ipo avevano a che fare, gliene t enne ro nascosta la data d icendo che n o n l 'avevano ancora stabilita. Invece l'avevano già fissata al 10; ma, viste le contraddizioni del Principe, decisero di r imandare .
Anche stavolta il caso fu più forte delle loro intenzioni . La matt ina del 10 giunse la notizia che il colonnello Moroz-zo di San Michele, n o n avendo ricevuto il con t ro rd ine , e ra par t i to da Fossano alla testa del suo r e g g i m e n t o . N o n e ra vero. Morozzo stava pe r farlo, q u a n d o ricevette il contrordi ne , ed era r imasto in caserma. Ma Santarosa e i suoi amici, c redendolo o rmai pe r strada, s i sent i rono mora lmen te impegnat i a n o n lasciarlo solo, e d iedero il via. Alessandria, capitale della rivolta, issò sulla cittadella la band ie ra tricolore e insediò u n a «Giunta di Governo», m e n t r e Lisio e San Marzano sollevavano le guarnigioni di Pinerolo e di Vercelli.
Secondo i pat t i , Car lo Alberto avrebbe dovu to essere a Moncalieri pe r svolgervi la sua par te di media tore . E infatti c'era, ma pros te rna to ai piedi del Re pe r confessargli la sua tresca coi ribelli e chiedergliene p e r d o n o . Disorientato e at-
303
terr i to, il Re r ient rò precipi tosamente a Torino, dove lo attendevano notizie peggiori : alle por te della capitale era già attestato un battaglione che sventolava u n a bandiera coi colori carbonar i e la scritta: «Viva il Re, gue r r a all'Austria!» Il Re a d u n ò un Consiglio che si mos t rò più i r resoluto di lui. Ma, dopo parecchie ore di t en tennament i e sotto l'incalzare di r appor t i sempre più al larmanti dalla provincia, si delineò u n a maggioranza favorevole alla concessione della Costituzione. E il Re stava pe r decidervisi q u a n d o sopraggiunse, di r i to rno da Lubiana, i l minis t ro degli esteri, con l 'annunzio che le Potenze alleate avevano affidato all'Austria il mandato di ristabilire l 'ordine, cioè il r eg ime assolutistico in qualunque Stato italiano esso si trovasse in pericolo. La Costituzione quindi significava g u e r r a all'Austria, e ciò la rendeva impossibile.
D i spe ra t amen te , i l Re cercò un accordo coi ribelli, che dal canto loro vi si rifiutavano, convinti di avere la part i ta in p u g n o . I l mo to si e ra p r o p a g a t o p e r contagio e le t r u p p e costituzionali e rano ormai p a d r o n e di Vercelli, di Biella, d'Ivrea, di Vigevano. E p p u r e , c 'era qualcosa che avrebbe dovuto metter l i sull 'avviso: la lati tanza delle masse opera ie e contadine. Gli entusiasmi libertari e rano condivisi solo dalla borghesia di città. Le fabbriche e le c ampagne vi restavano indifferenti, quando n o n addir i t tura ostili.
Tuttavia il moto, fra le t ruppe , si estendeva sotto l 'impulso degli ufficiali, specie da capitano in giù. Il 12 d u e di essi, di stanza nella cittadella di Torino, ne sollevarono la guarnigione, ucc idendo i l c o m a n d a n t e che o p p o n e v a resistenza. Anche sulla massiccia roccaforte dei Savoia sventolò il tricolore. Smarr i to , il Re m a n d ò a pa r lamenta re con gl'insorti lo stesso Car lo Alberto, o ra p i eno di zelo assolutistico. Ma gl ' insort i gli ch iuse ro la po r t a in faccia, facendogli capire che ormai non avevano più in lui nessuna fiducia.
Sopraffatto dagli avvenimenti , Vittorio Emanue le riconvocò il Consiglio e gli a n n u n z i ò che in tendeva abdicare in favore del fratello tut tora a Modena, lasciando la Reggenza
304
a Carlo Alberto. Quest i lo supplicò p i a n g e n d o di r ecedere dalla sua decis ione: la Reggenza in quei f rangent i lo sgomentava, e forse ancora di più era at terr i to dalla prospet t i va di trovarsi a t u p p e r t ù con Carlo Felice, di cui conosceva la durezza . Ma tu t to fu inutile. È probabi le che all 'abdicazione Vit torio E m a n u e l e , che il Re n o n lo aveva mai fatto con entusiasmo, pensasse da un pezzo e che gli ultimi avveniment i fossero stati solo la spinta decisiva. C o m u n q u e , diede o r d i n e di p r e p a r a r subi to bagagl i e car rozze , e sul far della notte si avviò alla volta di Nizza. Prima pe rò volle rivede re il bambinello che portava il suo nome , lo prese in braccio e disse alla m a d r e : «Spero che sia più fortunato di me». I vecchi gen t i luomin i , inginocchiat i , gli bac iavano la m a n o inondandog l i e l a di lacr ime, e n o n avevano tut t i i tort i . Di poca intel l igenza, d i p u n t a cu l tu ra , d i scarsa personal i tà , Vittorio E m a n u e l e n o n e ra stato un g r a n Re. Ma un g r a n ga lan tuomo, sì. Aveva assunto la corona senza desiderar la , l'aveva por ta ta come un pesante fardello, ligio ai doveri che gliene derivavano e che avevano fatto della sua vita u n a perpe tua quaresima. Era stato, come quasi tutti i Savoia, un Re mal inconico, ma che s i e ra o n e s t a m e n t e p r o p o s t o i l b e n e dei suoi suddi t i , o p e r megl io d i r e quel lo ch 'egl i r i t eneva che fosse i l loro bene , e o ra se n ' andava a p p u n t o p e r n o n fargli del male o scatenando contro di loro una repressione violenta o i n g a n n a n d o l i con u n a Cost i tuz ione che n o n avrebbe po tu to m a n t e n e r e . Alla bassezza cui era sceso Ferd inando di fingere di largirla pe r poi affidarne la revoca all'Austria, si rifiutò di arr ivare. Santarosa, che tanto lo aveva criticato, scrisse: «I nostr i cuor i identificavano t r o n o e patria, anzi Vittorio Emanuele e patria. E i giovani p romotor i della rivolta avevano r i p e t u t a m e n t e esclamato. "Ci p e r d o nerà bene di averlo fatto Re di sei milioni d'italiani!"»
Per la rivolta quell 'abdicazione era un colpo mortale . Essa apriva una crisi dinastica di cui le Potenze n o n potevano disinteressarsi e gettava lo scompiglio del r imorso in molte coscienze soprat tut to degli ufficiali, ch 'e rano i veri protago-
305
nisti del movimento. Jl p r imo a r isent i rne fu lo stesso Carlo Alber to che o ra , come Reggen te , avrebbe p o t u t o fare ciò che aveva sempre r improvera to a Vittorio Emanuele di non fare. Ai congiurati che lo assediavano badava a dire che non ne aveva i poteri . In realtà non ne aveva il coraggio. La notizia della par tenza del Re aveva r ichiamato davanti a palazzo Car ignano una g ran folla che reclamava la Costituzione forse senza ben sapere di cosa si trattasse. E siccome il Principe r ispondeva che ci voleva un voto formalmente espresso, a fargliene esplicita r ichiesta v e n n e r o i Decur ion i che c o r r i s p o n d e v a n o p r e s s a p p o c o agli assessori del C o m u n e . Carlo Alberto chiamò a consulto i vecchi dignitari della Corona non t an to pe r ud i re la loro opin ione quan to p e r condividere con essi, legatissimi alla Corte , le p ropr i e responsabilità. Ma tutti convennero che bisognava inchinarsi alla volontà popolare .
La sera del 13 Carlo Alberto firmò la carta costituzionale, e d u e g iorni d o p o p r o n u n z i ò su di essa il suo g i u r a m e n t o davanti a un' improvvisata Giunta Nazionale. Costituì anche un governo in cui Santarosa ent rò come ministro della guerra. Ma di gue r ra si rifiutò di discutere anche con gli emissari dei patrioti milanesi che subito e rano accorsi pe r concertare un'azione comune . Essi t rovarono un u o m o assai diverso da quello, infiammabile e gàrrulo , che avevano conosciuto fino a pochi mesi pr ima, si sent irono dire che con un Paese diviso e un esercito in pezzi alle gue r r e n o n c'era neanche da pensare, e furono bruscamente congedati . Il Principe era in preda a un profondo scoraggiamento, e Metternich dice di aver saputo che, q u a n d o era solo, era colto da crisi di pianto. Viveva nel t e r ro re di Carlo Felice, a cui aveva scritto u n a lunga le t tera pe r informar lo degli avveniment i e darg l iene una versione che metteva in risalto la sua innocenza. Ma, conoscendo l 'uomo, non si faceva illusioni.
Dei c inque figli di Vittorio Amedeo , Carlo Felice e ra forse quel lo che p iù aveva stoffa di Re, ma n e m m e n o lui aveva
306
mai aspirato a diventarlo. La sua lealtà nei confronti dei d u e fratelli che lo avevano p recedu to sul t rono era stata assoluta. A quattr 'occhi con loro e nel ristretto cerchio di famiglia, li aveva spesso criticati pe rché li trovava t r o p p o a r rendevoli, ma aveva sempre scrupolosamente obbedito ai loro ordini, anche q u a n d o gli andavano cont raggenio . Nel governo della Sa rdegna , che Vit tor io E m a n u e l e gli aveva affidato, aveva spiegato un t rat to ruvido, ma anche u n a notevole eff icienza. Nel suo assolutismo manicheo, n o n c'era posto pe r s fumature : pe r lui chi n o n era suddi to e ra fellone, e come tale andava trat tato. Nella repressione del br igantaggio sardo , aveva avu to l a m a n o pesan te ; ma mol to p iù pe san t e avrebbe voluto averla coi piemontesi che avevano solidarizzato con la Francia. Verso di essi nutr iva un rancore profondo , che d iventava a d d i r i t t u r a ossessivo nei confront i de gl ' intellettuali. «Tutti quelli che h a n n o s tudiato all 'Università sono corrott i» scriveva al fratello nel suo francese lardellato di pittoreschi oltraggi all 'ortografia e alla sintassi. «I cattivi sono tutti pe r sone colte, e i buon i son tutti ignoranti». Aveva preso in uggia anche De Maistre, il fedelissimo savoia rdo , p e r c h é - diceva - «ha la testa confusa da t r o p p e idee». Inflessibile con tutti , a cominciare da se stesso, aveva avuto u n a sola debolezza sentimentale: quella pe r il suo più giovane fratello, i l Con te di Mor iana , pe r i l qua le nu t r iva un t r e p i d o a m o r e p a t e r n o . La m o r t e del ragazzo, ucciso dalla malaria in Sardegna, era stata pe r lui u n a tragedia, di cui le sue sgrammaticate let tere forniscono un patetico documento . Al mat r imonio con Maria Cristina di Borbone , f iglia del Re di Napoli, si era piegato pe rché gliel 'avevano imposto nella speranza - poi delusa - di fornire un cont inuatore alla dinastia; ma un po ' di resistenza l'aveva fatta dicendo che non aveva soldi pe r man tene re u n a famiglia, ed era vero. N o n aveva soldi anche perché n o n li desiderava: i suoi gusti e r a n o quelli di un fattore di c a m p a g n a o di un guar dacaccia, ma p e r fo r tuna Maria Cris t ina li condivideva , e questo fu il cemento della loro felice un ione . Q u a n d o torna-
307
r o n o a Torino ci vissero appar ta t i un po ' pe r allergia alla vita di Corte e alle sue cerimonie, ma forse ancora di p iù pe r il rancore che Carlo Felice seguitava a nu t r i re nei confronti di un m o n d o che, salvo ra re eccezioni, si e ra macchiato del del i t to , ai suoi occhi inespiabi le , di col laborazionismo coi francesi.
È facile capi re qua le avvers ione provasse p e r Car lo Alber to , che il collaborazionismo lo aveva nel sangue a titolo, diciamo così, ereditar io, come figlio di un Principe che aveva r i nnega to le p r o p r i e ascendenze sabaude f ino a l p u n t o di arruolarsi sotto le band ie re del nemico della dinastia. E il c o n t e g n o del ragazzo n o n e ra stato c e r t a m e n t e tale da smontare le sue prevenzioni . Da un u o m o educato in collegi svizzeri e francesi e che preferiva gl'intellettuali ai sergenti e ai marescialli d'alloggio, n o n c'era da aspettarsi nulla di b u o n o . E forse il vero motivo della sua par tenza da Torino alla vigilia della rivolta non era stato il desiderio d ' incontrare a M o d e n a i l suocero Fe rd inando che to rnava da Lubiana, ma quello di allontanarsi da una Corte in cui i l suo naso avvertiva sempre più un gran puzzo di zolfo liberale. Se fosse al cor ren te di ciò che si preparava, n o n si sa. Ma che qualcosa si p repa ras se doveva averlo senti to, e n o n voleva t ro-varcisi mescolato.
O r a i fatti gli d a v a n o rag ione . Egli ne sapeva già abbastanza, q u a n d o lo scudiere Costa venne a recapitargli la lettera di Carlo Alberto. Dopo averla letta, Carlo Felice gliela lanciò sul viso ing iungendog l i di n o n ch iamar lo «Maestà» p e r c h é l 'abdicazione di suo fratello, disse, e s sendo stata estorta con la violenza, era da considerare nulla. Poi aggiunse: «Riferite al Principe che, se nelle sue vene c'è ancora una goccia del nos t ro sangue reale , p a r t a subi to pe r Novara e a t tenda là i miei ordini». Come risposta alla sua lettera, stilò un p roc lama ai suddi t i in cui diceva che la Reggenza non aveva fondamento in quan to il Re era tu t tora in carica. Ma da Modena non si mosse.
Nel leggere quel bando , Carlo Alberto fece al povero Co-
308
sta la stessa scenata che poco p r ima gli aveva fatto Carlo Felice. Il Pr inc ipe i m p r e c ò con t ro il Re, minacciò di passare nel c a m p o dei ribelli; ma poi , come sempre gli capitava, si lasciò soverchiare dallo s co ramen to , e decise di obbed i re , ma con la consueta doppiezza . T e n n e nascosti agl ' insort i i preparat ivi pe r la par tenza, anzi convocò pe r l ' indomani un consiglio dei ministri , e d u r a n t e la not te , alla testa di un reggimento di cavalleria, si avviò verso Novara, una città destinata a segnare le t appe più d rammat iche della sua carriera. Di lì e m a n ò un proclama con cui r inunziava alla Reggenza, invitava tutti a sottomettersi senza riserve al nuovo Re, e ne det te l 'esempio p a r t e n d o pe r Firenze, dove frattanto Carlo Felice gli aveva ing iun to di r i t irarsi . Passando da Modena , chiese di vede re i l Re, ma quest i si rifiutò di r iceverlo. In quel m o m e n t o sembrava che mai più egli sarebbe salito sul t rono dei Savoia.
A Torino, la diserzione di Carlo Alberto aveva get tato lo sgomento tra i Federati , che frattanto avevano costituita u n a Giunta . L'unico a reagirvi e r a Santarosa con energ ia e coraggio ammirevoli . L'insurrezione dava ancora segni di vitalità. A Genova il popo lo t u m u l t u a n t e aveva cacciato il Governatore e istallato un nuovo governo. Perfino la conservatrice e fedelissima Savoia si muoveva. Ma a raggelare questi entus iasmi g iunse ro le catastrofiche notizie di Napol i : l 'esercito in rotta, il regime costituzionale abbattuto, l'assolutismo r ipr is t inato . E c 'era anche di peggio: il genera le de la Tour, cui Car lo Felice aveva conferi to i p ieni po te r i , stava raccogliendo a Novara i repar t i fedeli.
N e m m e n o questo bastò a scoraggiare Santarosa, che all'offerta fattagli di un certo n u m e r o di passaport i p e r lui e i suoi c o m p a g n i p iù compromess i , r i spose a d u n a n d o a sua volta le t r u p p e federa te , p r o n t o a n c h e alla g u e r r a civile. Egli ignorava che Carlo Felice aveva fatto appello ag l ' Imperatori d 'Austria e di Russia pe rché , d o p o Napoli , venissero a r imet tere l 'ordine anche a Torino: non credeva che un Savoia potesse scendere al livello di un Borbone.
309
Le t r u p p e federa te a v a n z a r o n o su Nova ra col fucile in spalla p e r c h é Santa rosa aveva o rd ina to di fare i l possibile p e r evitare i l sangue . Stavano p e r occupare pacificamente San Mart ino, q u a n d o si videro p iombare addosso la cavalleria austriaca. La sorpresa si t rasformò in panico, e il panico in rotta.
Il 9 apri le Santarosa r iun ì pe r l 'ult ima volta la Giunta e le p r o p o s e il t ras fer imento a Genova p e r ten tarv i l 'ul t ima resistenza. Ma la Giunta si rifiutò e preferì sciogliersi. I p ro motor i della rivolta cercarono scampo sui valichi alpini, chi verso la Svizzera, chi verso la Francia. I p iù prefer i rono passare l 'Appenn ino nella spe ranza che Genova fosse ancora nelle man i dei loro amici. Invece la città aveva già r inunziato alla lot ta e p r e g a t o il G o v e r n a t o r e di r i p r e n d e r e il suo posto. Costui si most rò comprensivo verso i profughi e rilasciò loro i passapor t i p e r e m i g r a r e . Anche la popolaz ione indisse ques tue pe r aiutarli. A da re il suo obolo ci fu anche un ragazzo dal volto pallido e dallo sguardo triste: Giuseppe Mazzini.
In Piemonte gli austriaci di lagavano, e il Re n o n si faceva vede re . Era r imas to a M o d e n a di dove aveva m a n d a t o un proc lama minaccioso e a r rogan te : «Nessuna indulgenza pe r le cose passate, nessuna speranza di meglio pe r l'avvenire , e guai a quel suddi to che si p e r m e t t a p u r soltanto di mormora re» . Gli stessi austriaci ne furono costernati , proib i r o n o ai lo ro giornal i di r i p r o d u r r e que l b a n d o e fecero pressioni su Vittorio Emanue le , rifugiatosi a Nizza, pe rché tornasse sul t rono . Anche Carlo Alberto gli scrisse in questo senso, ma Vit tor io E m a n u e l e fu i r removib i le e confe rmò l 'abdicazione.
Carlo Felice aveva delegato tutti i poter i al conte T h a o n di Revel e affidato il castigo a un t r ibunale speciale, che in t renta torna te p ronunc iò settanta condanne a mor te - di cui d u e sole eseguite perché gli altri e rano già in salvo -, e molte a l t re alla p r ig ione . Ol t r e t r ecen to ufficiali e a l t re t tan t i funzionari civili venne ro epura t i , le Universi tà di Tor ino e
310
Genova chiuse p e r un a n n o , mol te ca t t ed re aboli te. I l Re era ta lmente indignato che n o n voleva n e m m e n o r ien t ra re a Torino. Vi to rnò controvoglia solo a metà ot tobre , ma né allora né mai volle più m e t t e r e p i ede n e l l ' a p p a r t a m e n t o reale, dove si era compiuto «l'orribile crimine» dell 'attentato alla «piena possanza» del Re, e ai Decurioni che gli por gevano il ben to rna to rispose che i torinesi si p reparasse ro «a r i pa r a r e col loro perfe t to suddit izio a t t accamento e col loro zelo pe r il servizio del Re allo scandalo che p u r t r o p p o un n u m e r o di scellerati h a n n o commesso fra le sue mura». Dopod iché par t ì p e r Genova e vi si t r a t t e n n e t an to da far cor re re la voce che intendesse trasferirvi la capitale.
Con Carlo Alberto n o n volle aver più r appor t i . N o n rispose alle sue implorant i let tere e p ropose a Metternich di escluderlo dalla successione, des ignandovi d i r e t t amen te i l figlioletto. Sembra che questo disegno gli sia stato suggerito dal Duca di Modena che, come mar i to della f igl ia di Vittorio Emanue le , n o n aveva mai cessato di aspirare al t rono di Torino e forse sperava di trovare con u n a Reggenza la strada pe r arrivarci. Ma Metternich che di Francesco, p e r quanto di sangue austr iaco, diffidava p iù che di Car lo Alber to , forse perché lo sapeva più intelligente e spregiudicato, declinò. Al Congresso di Verona, dove le g rand i Potenze torn a r o n o a r iunirs i l ' anno d o p o , fu rono decisi i l r i t i ro delle t r u p p e austr iache dal Piemonte e la conferma dei diritti di Carlo Alberto alla successione.
Pochi mesi pr ima, Napoleone era mor to a S. Elena.
CAPITOLO TRENTESIMO
Q U E L L I DELLO SPIELBERG
Sullo scorcio del '20, q u a n d o la polizia del Lombardo-Veneto a b b a n d o n ò i criteri di tolleranza che aveva fin allora seguito, un n o m e cominciò a circolare su tut te le bocche, p ro nunciato con un misto di rispetto, di p a u r a e di odio: quello del l ' Inquis i tore Antonio Salvotti. I patr iot i lo d ip ingevano come un r innega to senza scrupoli , che so t toponeva gl 'imputa t i a ogni sorta di t o r tu re pe r s t rappargl i le confessioni al solo scopo di mettersi in b u o n a luce presso il governo imperiale e di far carriera.
I documenti non lasciano dubbi sull'infondatezza di queste voci. Salvotti e ra un magistrato t rent ino che si e ra messo al servizio dell 'Austr ia pe rché nell 'Austria ci c redeva , cioè credeva nei sistema politico di cui l'Austria rappresentava il puntel lo e la garanzia. Secondo qualcuno vi spiegò zelo per farsi p e r d o n a r e di essere stato massone. Ma Salvotti aveva a p p a r t e n u t o alla Massoner ia q u a n d o ques ta era g u a r d a t a con favore anche dai regimi assolutisti, molti dei loro coronati titolari vi e rano iscritti, e come costoro l'aveva abbandonata quando era diventata s t rumento delle ideologie r ivoluzionarie. Il suo vero torto era di assolvere i suoi compiti con grandiss ima compe tenza e accortezza; il che tut tavia n o n gl ' impediva di mostrare i dent i anche ai suoi colleghi e super iori austriaci q u a n d o cadevano in qualche eccesso o arbitrio. Bell 'uomo, gran signore e dotato di poderose armi dialettiche, non rinunzia va a dire il fatto suo a chiunque, anche a l l ' Impera to re , q u a n d o gli capitava a t i ro. Molte delle sue stesse vittime gli tes t imoniarono la loro ammiraz ione riman e n d o dal carcere in affettuosi rappor t i epistolari con lui.
312
Il processo che lo mise in luce fu quello a carico di t rentaquat t ro carbonari , fra cui alcuni nobili e t re sacerdoti, arrestati nel '19. A fare i loro nomi era stato il capo della vendita a cui appar tenevano , Villa. Costui n o n era un t radi tore; 10 diventò pe r debolezza sotto l ' interrogatorio, in cui spiattellò tut to e giunse perfino a offrirsi come informatore della polizia. Dal carcere in cui si t rovarono rinchiusi, ma da cui po t evano c o m u n i c a r e con l ' es te rno , gli altri r iusc i rono a fabbricarsi degli alibi con le t te re r e t r o d a t a t e . Ma Salvotti glieli s m o n t ò , e l i condusse u n o p e r u n o alla confessione. Non si p u ò infierire contro questi uomini che pagarono con la galera le loro colpe. Ma n o n si p u ò n e m m e n o dissentire dal giudizio poco benevolo che, forse anche pe r aiutarli, ne dette il Salvotti scrivendo nel suo r appor to finale che di quei cong iura t i l ì n o n c 'era r ag ione di aver p a u r a . I l t r ibuna le tuttavia n o n ne t enne conto e p ronunc iò ben otto c o n d a n n e a mor te , che poi l ' Impera tore commutò in carcere d u r o . Pochi mesi d o p o , un dec re to p r o c l a m ò l ' a p p a r t e n e n z a alla Carboner ia reato di alto t rad imento passibile della pena capitale.
Nel l 'o t tobre di quello stesso a n n o 1820, la polizia trasse in a r r e s to un a l t ro indiziato, lo s t u d e n t e di musica Pie t ro Maroncelli. Costui aveva già conosciuto la pr igione nella sua Forlì che appar teneva agli Stati della Chiesa, e se l 'era cavata con l'esilio perché le autori tà papal ine si e rano fatte di lui la stessa op in ione che Salvotti si e ra fatta di Villa e compagni. Sebbene t raumatizzato da quel l 'avventura , a p p e n a arrivato a Milano n o n solo si era rimesso a cospirare, ma aveva a t t ra t to nella Carboner i a anche un al t ro giovane di cui era diventato g r a n d e amico: Silvio Pellico.
Silvio Pellico e ra un intel le t tuale p i emon tese che aveva abbandona to Tor ino pe r sottrarsi alla sua asfissiante a tmosfera. A Milano aveva conosciuto Foscolo, di cui era da sempre un fervente ammira tore e n 'era diventato pra t icamente 11 segretar io . Un g iorno gli aveva dato in visione il testo di u n a sua t ragedia , la Francesca da Rimini, in cui c ' e rano an-
313
che, stivatici un po ' a forza, degli altisonanti appelli alla patria. Foscolo l i aveva apprezzat i , ma n o n aveva apprezza to tut to il resto, e gli aveva consigliato di met te re quel d r a m m a nel cassetto e di n o n pensarci più.
Mortificato nelle sue ambizioni, ch 'e rano sproporzionate ai suoi talenti, e convinto di aver scritto un capolavoro, Pellico vi aveva appor ta to qualche ritocco e poi lo aveva dato in l e t tu ra alla p iù g r a n d e at t r ice del t e m p o , Car lo t ta Mar-ch ionni , che lo aveva r a p p r e s e n t a t o . C o n t r a r i a m e n t e alle previsioni di Foscolo, ma senza che questo infirmi il suo giudizio, e ra stato un g r a n d e successo, che aveva dato all 'autore un ' improvvisa notorietà.
Carlotta conviveva con u n a cugina, Teresa, che pe r questo tutti c redevano sua sorella e che era corteggiata da Pellico, m e n t r e Carlot ta e ra cor teggiata da Maroncell i . Fu così che i d u e s ' incontrarono e l 'uno attrasse l 'altro nella cospiraz ione . Pellico, che vi e r a p red i spos to dalla sua fede patriottica e democratica, vi si bu t tò a capofitto con piena fiducia nel suo inizia tore che n o n ne mer i tava mol ta : n o n già pe r la sua disonestà - anche se in seguito gliene fu attribuita -, ma pe r la sua avventatezza e faciloneria. Lo dimostra il fatto che, q u a n d o lo a r res tarono, gli t rovarono addosso delle car te che comprome t t evano i r r epa rab i lmen te parecchie altre persone , fra cui anche il Pellico.
Questi , nei pr imi in terrogator i , si difese bene . Ammise di conoscere Maroncelli, ma negò di aver parlato con lui di politica. Q u a n d o gli ch iesero p e r c h é fra loro si ch i amavano «cugini», ch 'era la qualifica con cui ci si riconosceva tra carbona r i , r ispose che s i t ra t tava di un ant ic ipo di pa ren te la , visto che in t endevano sposare d u e cugine . P u r t r o p p o , dal canto suo, Maroncelli aveva ceduto e confessato la sua affil iazione alla setta, i m p e r n i a n d o la p r o p r i a difesa sul fatto che la Carboner ia romagnola non solo non e ra ostile all'Austria, ma anzi auspicava l ' anness ione del la R o m a g n a al Lombardo-Veneto austriaco.
Tuttavia, grazie alla sua ferma condotta, Pellico stava pe r
314
cavarsela, q u a n d o l ' Impera tore , che quelle vicende le seguiva di persona, o rd inò che l ' istruttoria fosse affidata a Salvotti. In d u e in t e r roga to r i , quest i fece capi to la re Maroncel l i che f inì con l ' ammet te re tut te le p rop r i e colpe coinvolgendovi un certo Canova che, a sua volta in terrogato , confermò la complicità del Pellico. Costui, messo di fronte alle deposizioni firmate dagli altri due , si perse d 'an imo, r iconobbe di aver agi to da emissario della setta in Liguria , e fece anche altri nomi . Fu u n a frana. Maroncelli , nel leggere quelle dichiarazioni , ve ne agg iunse d i n u o v e . Sicché, in m e n che n o n si dica, Salvotti ebbe in m a n o tut t i gli e sponen t i della cospirazione. Alcuni, avvertiti in t e m p o , si misero in salvo con la fuga, come il conte Porro Lamber tenghi , g r a n d e amico e pro te t tore di Pellico che fino all 'ultimo ne tacque il nome. Ma tutti gli altri vennero arrestati , fra cui, nonostante il suo alto prestigio e la vene randa età, il p iù g r a n d e giurista del t empo , Domenico Romagnosi . Questi tuttavia, a p p u n t o p e r c h é giur is ta e n o n o s t a n t e gli acciacchi, fu l 'unico che seppe tener testa a Salvotti n e g a n d o tut to e o p p o n e n d o arg o m e n t o ad a rgomen to . Siccome a denunz ia r lo era stato il Pellico, chiese un confronto con questo «chiacchierone autore di cattive tragedie». E Pellico, inorr idi to all 'idea di t rovarsi di fronte alla sua vittima, r i t rat tò. Un altro che riuscì a cavarsela fu l 'Arr ivabene, nel cui cassetto era stata t rovata u n a let tera che diceva: «Monti ha scritto un inno p e r l ' Impera tore , che è sotto i torchi. Bada bene: è sotto i torchi l'inno, n o n l ' Impera tore , pe r nostra sventura».
Il processo si concluse con la condanna a mor te del Pellico, del Maroncelli e del Canova, con quella al carcere per p e t u o di altri d u e impu ta t i e con l 'assoluzione del Roma-gnosi e de l l 'Arr ivabene . Poi, come al solito, i n t e r v e n n e la grazia e la pena capitale fu commuta ta nel carcere a vita nella fortezza dello Spielberg. Prima del trasferimento, Maroncelli invocò da Salvotti un attestato che lo dichiarasse «puro d 'ogni infamia», e Salvotti glielo rilasciò «per quan to v'è di p iù sacrosanto». Voleva giustificarsi presso i compagn i che
315
10 consideravano u n o spregevole delatore. E Pellico, ch 'era quel lo che più aveva di che dolersi di lui, d iede l 'esempio del p e r d o n o anche p e r c h é aveva anch 'egl i parecchie cose da farsi pe rdona re .
Fra le p i eghe di ques to processo era compar so a un cer to pun to , in qualità di agente provocatore, un certo Carlo Ca-stillia che, oltre alle attività carbonare , aveva segnalato in un suo r appor to alla polizia quelle dei patrioti lombardi che nel '21 avevano sollecitato l ' intervento p iemontese in Lombar dia. Fra i denunziat i c 'era anche il fratello del denunzia tore , Gaetano.
A quel r appo r to lì pe r lì le autori tà austr iache non avevano da to mol ta i m p o r t a n z a forse p e r c h é ne conoscevano l 'autore e, p u r servendosene, lo disprezzavano. Ma poi dovettero esserci altre segnalazioni che condussero all 'arresto di Gae tano . Forse su di lui n o n p e n d e v a n o che gener iche accuse di liberalismo. Ma il marchese Pallavicino-Trivulzio, suo g rande amico, si precipitò alla polizia e, per scagionare 11 Castillia, dichiarò ch 'era stato lui a condur lo seco nella sua missione in Piemonte pe r recapi tare a Carlo Alberto la lettera del conte Confalonieri.
Impetuoso , avventato e anche un po ' esibizionista, è probabile che Pallavicino avesse agito così solo pe r generosità e cavalleria. Ma il suo odio pe r Confalonieri p u ò anche autorizzare ipotesi meno benevole. C o m u n q u e , le sue dichiarazioni fornirono alla polizia il bandolo di u n a matassa che fin allora si era sforzata invano di d ipana re . Dei r appo r t i fra i pa t r io t i l omba rd i e p i emon tes i e del le loro collusioni nei moti del ' 2 1 , essa aveva subodora to qualcosa, e p r o p r i o su Confalonieri i suoi sospetti si appun tavano ; ma n o n era mai riuscita ad a p p u r a r e nulla di preciso. La spontanea confessione di Pallavicino le offriva u n a insperata traccia.
Lasciato l ibero lì p e r lì, Pallavicino fu a r r e s t a to la sera dopo a teatro, e sotto gl ' interrogatori si dimostrò u o m o ben diverso da come si e ra p re sen ta to con quella spavalda au-
316
toaccusa. Crollò subito, disse tut to quel che sapeva, e pu r t r o p p o sapeva mol to . In d u e giorni l ' inquirente po tè ricos t ruire tu t ta la t r a m a della cospirazione, di cui da mesi ricercava inut i lmente le fila. E queste fila r iconducevano tut te allo stesso protagonista: Federico Confalonieri.
Confalonier i a p p a r t e n e v a a quell 'ar is tocrazia mi lanese che da t e m p o si e ra alleata alla borghesia cond iv idendone lo spirito imprendi tor ia le . Ins ieme a Porro Lamber t engh i , aveva dato avvìo ad alcune fra le migliori iniziative agricole e industriali lombarde , e si era dimostrato anche un abilissimo u o m o d'affari. Pol i t icamente , e ra s e m p r e stato d ' idee avanzate ma piuttosto instabili e talvolta avventurose. I nemici lo accusavano di aver istigato la folla al massacro di Prina, tanto ch'egli si e ra visto costretto a scrivere un memoriale in p ropr i a difesa. In realtà si trattava di responsabilità indiret ta . Confalonieri aveva capeggiato i d isordini con t ro il viceré Eugen io con cui n o n aveva mai voluto col laborare : sperava di conservare il Regno Italico senza di lui, e ra andato a Parigi a pe ro ra re questa causa presso i r appresen tanti delle Grand i Potenze, e q u a n d o si era accorto che questa era ormai pregiudicata , se l 'era r ipresa con coloro che avevano r i tardato la missione, dimenticandosi che a boicottarla e ra stato p r o p r i o lui pe r t imore che andasse a profit to del Viceré . Ma lg rado il g r a n n o m e , la bella p re senza e le alte qualità intellettuali, n o n era amato. Gli r improveravano un ca ra t t e re altezzoso, u n a l ingua tagl iente e un ' ambiz ione smodata. Ad amar lo riusciva soltanto sua moglie, Teresa Casati, ch'egli t rascurava pe r co r re r d ie t ro alle sue avventure galant i . Forse ai cangevoli u m o r i che r e n d e v a n o difficili i r appor t i con lui contribuiva anche il male da cui era affetto fin dalla nascita: l'epilessia.
Dei sospett i che g ravavano su di lui e dei pericoli che correva, lo avevano avvertito. La sera che precedet te il suo ar res to , i l Feldmaresciallo austr iaco Bubna, incon t rando lo pe r strada, gli disse: «Conte Confalonieri, avevo sognato che foste in Svizzera». Ma Federico si era rifiutato di mettersi in
317
salvo c o n s i d e r a n d o la fuga un gesto i n d e g n o d i un u o m o come lui. La ten tò solo q u a n d o i g e n d a r m i bussa rono alla sua porta , ma ormai era t roppo tardi.
Fin dal p r i m o in te r roga to r io capì che Pallavicino e Ca-stillia avevano ormai fornito tutti gli e lement i della congiura ordi ta coi Federati piemontesi , molto più grave di quelle ca rbona re . Ma negò tu t to con sdegnosa fermezza d icendo che Castillia e ra «plagiato» da Pallavicino, che a sua volta era soltanto un visionario i rresponsabile . E grazie a questo fermo contegno, l ' istruttoria s'insabbiò. Ma a questo p u n t o l ' Impera tore , che come al solito seguiva il caso di persona e si e ra convinto ch'esso «fosse pe r diffondere sui moti rivoluzionari in Italia u n a luce ben maggiore di quan to avevano fatto le inconcludent i inquisizioni delle autor i tà p i emon te si», affidò il pr ig ioniero a Salvotti. E le cose p rese ro subito u n a diversa piega.
Dalla negat iva assoluta, Confalonier i passò alle ammis sioni che in questi casi sono come le ciliegie: u n a tira l'altra. Dalla sua bocca cominciarono a uscire i nomi di alcune persone, che na tu ra lmente vennero subito arrestate, si t rovarono fra loro in flagrante contraddizione e fecero a loro volta altri nomi . Fra tut ta questa gente ci fu chi seppe tacere, come il Mompian i e il Felber. Ma ce ne furono anche che, in p r e d a al t e r ro re , vuo ta rono il sacco e forn i rono all'abilissimo inquisi tore tut te le connessioni di u n a tresca che aveva messo profonde radici anche a Brescia e a Mantova.
L 'a t teggiamento di Confa lonier i lascia perpless i . Forse nel t imore che altri lo avesse già det to , confessò di aver rivolto a Car lo Alberto l 'invito d ' in te rveni re a Milano e anzi fornì tut t i i det tagl i dei colloqui che aveva avu to con San Marzano. Cercò di spiegare che lo aveva fatto non pe r scacciare gli austriaci, ma anzi pe r d a r loro u n a m a n o a ristabilire l 'o rd ine . Ma in tan to lo ammise , co involgendo nelle sue rivelazioni u n a tal massa di persone - il fior fiore della nobiltà e della borghesia l o m b a r d e - che a un cer to p u n t o lo stesso Salvotti si p reoccupò delle dimensioni che la faccenda
318
stava p r e n d e n d o e p ropose a l l ' Impera tore di porvi un fermo r e s t r i ngendo l 'accusa ai maggior i indiziati e l iberando gli altri con un atto di clemenza. E, come al solito, il suo consiglio fu accolto.
Propr io allora cadde nelle reti della polizia un altro per sonaggio che pe r un m o m e n t o parve da re ai fatti già accertati un tutt 'al tro risvolto e significato. Si trattava di quell 'An-dryane, di cui abbiamo già det to a proposi to di Buonarro t i . La polizia lì p e r lì credet te che i nomi e gl'indirizzi di cui il malcapitato era in possesso fossero di Federati , e ne dedusse che costoro fossero collegati coi Sublimi Maestri Perfetti di cui Andryane era emissario. Ma Salvotti, nelle cui grinfie anche l 'Andryane capitò, fece pres to a renders i conto che il giovane n o n diceva nulla dei Federati pe r i l semplice motivo che n o n aveva nulla da dire , n o n ne conosceva neanche i nomi, come n o n li conosceva n e p p u r e il suo m a n d a n t e Buonarrot i . Gl'indirizzi che costui gli aveva dato e rano quelli di cospiratori di vent 'anni pr ima, pe r la maggior par te affiliati a u n a setta di cui o rmai n o n restava quasi p iù traccia, l'A-delfia. E ciò d imost ra quan to Buona r ro t i o rmai fosse fuori del g iuoco. Ques to n o n salvò i l p o v e r o A n d r y a n e dallo Spielberg, ma smentisce l'accusa che alcuni storici gli h a n n o fatto di aver aggravato con le sue rivelazioni la sorte degli altri imputa t i . Sia p u r e pe r ignoranza , A n d r y a n e n o n fece altri nomi che quelli che gli avevano trovato addosso e che con la Federazione avevano ben poco a che fare, e solo pe r casuale coincidenza si trovò coinvolto in quel processo.
La sentenza fu dura . Dei sedici condannat i a mor te , nove e r a n o con tumac i . Gli altri sette e r a n o : Confalonier i , Andryane , Borsieri , Castillia, Arese, Tonelli e quel Pallavicino che con la sua inutile spavalderia aveva messo in moto l'ingranaggio. La moglie e il p a d r e di Federico si precipi tarono a Vienna pe r impe t ra re grazia. Con l'aiuto di Bubna, Teresa o t t e n n e un col loquio con l ' Impe ra t r i ce che , commossa dal suo dolore, le promise aiuto e glielo diede. In suo favore anche Maria Luigia scrisse da Pa rma al pad re , che tuttavia
319
parve irremovibile. Teresa r ient rò a Milano a briglia sciolta col t imore di non fare in t e m p o a r ivedere il mari to. Mandò a Vienna u n a petizione con centinaia di firme. L ' Imperatore aveva chiesto ai suoi fiduciari che effetto avevano fatto le c o n d a n n e sulla pubblica opin ione . I l governa tore Strassol-do gli aveva risposto che la costernazione era generale e tutti a t tendevano la grazia. L ' Imperatore la concesse.
II 21 gennaio del '24, m e n t r e a Brescia continuava il p ro cesso a carico degli altri imputat i , me t t endo in luce il coraggio di alcuni - il Moretti , il Mompiani , il Mazzoldi - e la fragilità mora l e di al tr i , i c o n d a n n a t i fu rono condot t i su un palco e legati con le catene al m u r o del palazzo di Giustizia pe r la let tura della sentenza. «Il Confalonieri - scrive D'Ancona - scorse nella folla molti volti amici e occhi pieni di lacr ime, e insieme sorrisi e ghigni.» Andryane , che lo vedeva p e r la p r i m a volta, scrisse più ta rd i : «Avevo b e n visto re e g rand i della terra; ma la p o m p a che li circondava, ma i p re stigi della gloria e del regale d iadema non avevano mai p ro do t to in me un ' impress ione così p r o f o n d a di s tupore e di ammirazione come quel mar t i re della libertà». Ed è un fatto che tutti gli altri condannat i , m e n o il Pallavicino, gli cedevano il passo e lo t rat tavano come il loro capo.
Pr ima di essere avviato con loro oltre confine, gli permisero di r iabbracciare il p a d r e e la moglie . In viaggio ebbe u n a delle sue crisi che l 'obbligò a u n a sosta di dieci giorni . Poi, inaspet ta tamente , si vide dirot tato a Vienna. Fu ospitato in g ran segreto nella direzione di Polizia, e qui u n a sera v e n n e a t rovar lo Met te rn ich in p e r s o n a . Su ques to colloquio, q u a n d o lo si r iseppe, fu costruito tutto un romanzo . Si disse che il Cancelliere aveva chiesto al condanna to altri dettagli sui suoi rappor t i con Carlo Alberto pe r completare un dossier di accuse contro il Principe, scartarlo dalla successione al t rono e innalzarvi al suo posto Francesco di Modena .
Fatti e document i d imos t rano che il Cancelliere n o n carezzò mai questo proget to , e quindi n o n c'è motivo di dubita re del resoconto ch 'egli stesso de t t e di quel lo s t r ano in-
320
cont ro . In un salotto sp l end idamen te addobba to e sorseggiando il tè in squisite porcellane, il Cancelliere disse al patrizio lombardo che l ' Impera to re era p r o n t o a riceverlo, se aveva qualche confidenza da fargli, ma che in ogni caso egli n o n e ra l ì pe r es torcergl iene. Voleva sol tanto conoscere le sue op in ioni sui moviment i liberali n o n nella sola Milano, ma in tu t t 'Europa e come si potevano conciliare con l 'ordine costituito della Restaurazione. Questa assicurazione aveva recato «un evidente sollievo» al Conte che «molto difficilm e n t e avrebbe accondisceso a r ivelare colpe e responsabilità altrui» e che, d u r a n t e tut to il colloquio du ra to oltre d u e ore, n o n p ronunc iò parola in p ropr i a difesa né chiese mitigazioni di pena . Alla fine il Cancelliere disse: «Be', o ra debbo anda re a un ballo». E Confalonieri a n d ò allo Spielberg.
Lo Spielberg e ra u n a vecchia e tetra fortezza appollaiata in vetta a un 'a l tu ra che domina Brno . A popolar la pe r primi e rano stati i condanna t i del processo di Villa: Foresti, Solerà, O r o b o n i , Fort ini , M u n a r i , Bacchiega. Poco d o p o vi e r a n o g iunt i Maroncell i e Pellico, cui dobb iamo la m i n u t a descr iz ione d i que l p l u m b e o carcere . Le celle e r a n o ant r i sot terranei , stillanti umidi tà e senz'altro mobilio che un tavolaccio e u n a brocca d 'acqua. Regola e dieta e rano così du re che, se i guardiani avessero dovuto applicarle alla lettera, nessun p r ig ion i e ro vi avrebbe sopravvissuto . Per fo r tuna e rano gente del posto, buon i diavoli che in fondo simpatizzavano con le loro vit t ime e il poco che po tevano pe r alleviargli la p e n a e ar ro tondargl i il rancio, lo facevano. I detenuti li secondavano arrangiandosi , da buon i italiani, in mille modi . Alcuni si specializzarono in lavori di maglieria pe r r ipararsi alla meglio dal f reddo. Maroncelli riuscì a ricavare mater ia le p e r scr ivere i n g o m m a n d o con mollica d i p a n e sciolta nell 'acqua i fogli di carta igienica, fabbricando penni ni con lische di pesce e inchiostro con residui di medicinali.
Dapprincipio i prigionieri vennero tenuti in stretto isolam e n t o , senza contat t i fra loro . Ma poi fu rono messi d u e a d u e p e r mancanza d i spazio. Confalonier i ebbe un t ra t ta-
321
mento speciale: gli furono concesse d u e celle, le migliori, e il d i r i t to di scegliersi il c o m p a g n o . Scelse A n d r y a n e forse pe r ché aveva bisogno di ammiraz ione e quel g iovane n o n gl iene lesinava. C o m e capi ta spesso fra reclusi , i r a p p o r t i n o n e rano sempre di affettuosa fratellanza e solidarietà. L'odio di Pallavicino pe r Confalonieri non si e ra a t tenuato. Foresti e ra detestato da tutti pe r il contegno tenuto al processo in cui si e ra offerto come agente provocatore . Moret t i , che invece si era condot to con magnifico coraggio, ora dava segni di squilibrio, in tutti vedeva t radi tor i e delatori , e ogni poco p iombava in c u p e crisi d i d i speraz ione . Col m o n d o esterno, nessuno aveva rappor t i . Solo a Confalonieri la moglie riusciva, grazie ai suoi soldi e alle sue aderenze , a far arr ivare qua lche let tera . Le g io rna te si sg r anavano vuote e uguali: a r iempirle c'era solo la disperata lotta pe r sopravvivere alla fame e al freddo. Ma non tutti ci r iuscirono: d o p o soli tre anni , Oroboni e Villa mor i rono .
Alla fine del '27, si accese un raggio di speranza: Fortini, Solerà e Ducco e r a n o stati graziat i , e tut t i p e n s a r o n o che u n o alla volta sarebbe venu to anche i l loro t u r n o . Ma n o n fu così. Pellico e Maroncelli furono liberati solo d o p o nove ann i , q u a n d o o rma i e r a n o r idot t i a ro t tami . L'ultimo a lasciare lo Spielberg fu Confa lonier i cui l ' I m p e r a t o r e n o n perdonava «di aver guastato lo spirito della classe più elevata». Teresa , che p e r lui aveva c o m p i u t o autent ic i eroismi , era morta .
CAPITOLO TRENTUNESIMO
NEGLI STATI CENTRALI
Nel dire a Salvotti che la Carboner ia romagnola cui era affiliato avrebbe preferito un governo austriaco a quello papalino, Maroncel l i aveva un po ' esagera to , ma n o n ment i to . Effettivamente c 'era nelle Vendite r o m a g n o l e u n a co r r en t e favorevole a questa tesi, e Salvotti lo sapeva, e lo sapeva anche Metternich. A tal p u n t o d ' impopolar i tà era giunto il regime pontificio.
I l cardinale Consalvi aveva fatto del suo meglio pe r dar gli un m i n i m o di efficienza, e Pio VII aveva cercato di secondar lo . Ma en t r ambi avevano u r t a to nella resistenza degli Zelanti che d o m i n a v a n o la Cur ia . Vecchio e ma landa to , i l Papa che aveva affrontato Napo leone n o n aveva più abbas tanza energ ia p e r sos tenere Consalvi ch ' e r a sos tenu to solo da lui. E il r isultato era un «comandare assoluto, cieco e variabile a capriccio» di par roc i e mons ignor i avidi e inc o m p e t e n t i che s i c o m p o r t a v a n o c o m e feuda ta r i del p iù buio Medio Evo. Lo scontento era genera le , ma le sue manifestazioni var iavano da reg ione a reg ione . In quelle più d e p r e s s e , Lazio e U m b r i a , la r eaz ione e ra i l b a n d i t i s m o . I n t e r e zone e r ano sotto i l control lo di br igant i che spingevano la loro audac ia f ino a p r e n d e r e c o m e ostaggi in te r i collegi di seminarist i , come fecero a Terrac ina , pe r farsene paga re i l r iscatto con u n a grossa taglia. Agivano in somma c o m e tupamaros avant i le t te ra , e u n a volta s e q u e s t r a r o n o pers ino un colonnello austr iaco. N o n avevano p r o g r a m m i politici. Era solo la pro tes ta con t ro la fame e i soprusi che li spingeva al saccheggio. Nelle loro b a n d e mil i tavano anche dei p r e t i che d o p o le razzie ce l eb ravano Te Deum di
323
r i n g r a z i a m e n t o cui i p r e d o n i facevano coro b i a sc i ando p regh ie re .
In Romagna la rivolta aveva un contenuto ideologico ed era condot ta dalle società segrete, fra cui na tu ra lmen te spiccava la Carboner ia , cui il reg ime opponeva altre società segre te d ' ispirazione sanfedista. Dal l 'una pa r t e e dall 'a l tra si moriva di pugnale , e nessuno parlava, neanche i gendarmi , pe r pau ra delle rappresaglie . Per met te re fine a questo stillicidio d i cadaver i , fu rono m a n d a t i d u e Cardinal i -Legat i , c o m e si ch i amavano i gove rna to r i , Rusconi a Ravenna , e Sanseverino a Forlì, i quali n o n seppero far altro che retate alla cieca. Alcuni pr igionier i accusati di Carboner ia furono consegnat i a Salvotti, che cercava di r icost ruire il mosaico dei mot i del '21 in tu t ta Italia. Risultò che fra le cong iu re del Lombardo-Veneto e quelle degli Stati pontifici, a lcune connessioni c 'erano, ma poche . I l p iano d 'azione nazionale che Met te rn ich paventava , n o n esisteva, o c o m u n q u e n o n operava. In ogni reg ione le Vendite agivano p e r conto p ro p r io , e spesso in con t radd iz ione fra loro . Accanto a quelle che auspicavano il passaggio della Romagna all'Austria, c'er ano quelle che auspicavano la sua annessione al Granducato di Toscana. Con le consorelle napole tane e i loro moti costituzionali, collegamenti non ce n ' e rano stati o risultavano molto aleatori.
In questa esplosiva situazione, volgeva al t e rmine il pontificato di Pio VII , che c o m u n q u e un po ' di prestigio personale tu t tora lo conservava E con lui, che mor ì nel luglio del ' 23 , finiva anche il po tere di Consalvi, immedia tamente accantonato. Il Conclave rimase a lungo incerto ma alla fine si risolse in favore del Della G e n g a che salì al Soglio c o m e Leone XII e, dice l'Anelli, «rinnovò i vi tuperi che il Consalvi aveva saviamente frenati, e pose Io Stato in mano del Ca-leffi, del Pacca, del Cavalchini e del Rivarola, prelati di vecchia infamia». Fu un diluvio di leggi e regolamenti , u n o più oltraggioso dell 'altro: proibizione assoluta del l ' insegnamento laico, obbligo del p r ece t t o pasqua le , divieto del le vesti
324
femminili attillate e del l 'uso della l ingua italiana nei tribunali, abolito il diritto di p ropr ie tà pe r gli ebrei che vennero ricacciati nei ghet t i , cons idera ta rea to la vaccinazione che aveva salvato tanta gente dal vaiolo. In compenso fu bandito un Giubileo s t raordinar io pe r il 1825, che por tò a Roma qua t t rocen tomi l a pe l legr in i con g r a n sollievo de l l ' e ra r io sempre più dissestato, ma anche dei briganti che imposero robusti pedaggi nelle zone di loro competenza.
A Ravenna, con poter i s t raordinari , venne manda to il Ri-varola con largo seguito di genda rmi e predicator i . Il regime ch'egli istaurò era di stato d'assedio: chiusura anticipata delle t averne , pro ib iz ione di qualsiasi giuoco di car te o di dad i , divieto di circolazione d o p o il t r a m o n t o senza salvacondot to della polizia, incoraggiamento alle denunz ie anon ime . C o n quest i me tod i fu istruito un colossale processo contro oltre cinquecento indiziati, di cui, dice Farini, «trenta nobili, centocinquantasei possidenti o commerciant i , d u e pret i , se t tantaquat t ro impiegati, t rentot to militari, sessantad u e fra medici, avvocati, ingegneri e uomini di let tere, il resto artigiani». Quest i ultimi r appresen tavano u n a significativa novità . Fin a l lora la cospi raz ione politica e r a r imas ta un'esclusiva della nobiltà e della borghesia. Per la p r ima volta faceva capol ino il popo lo . Ma secondo il c a rbona ro La-derchi , si trattava solo di u n a «turba» di accoltellatori assoldati dai caporioni pe rché non andassero a ingrossare la fazione opposta .
II ve rde t to fu d u r o . Ci fu rono sette c o n d a n n e a mor t e , anche se d u e colpivano imputat i contumaci e le altre c inque - fra cui quella del Laderchi - furono commuta te nel carcere a vita; c inquan taqua t t ro ai lavori forzati pe r per iodi dai v e n t ' a n n i in giù; al tr i c i nquan ta alla p r i g ione in fortezza, pe rpe tua pe r sei; duecen to t ren ta al domicilio coatto con obbligo di confessione e di esercizi spir i tual i . Sicuro di aver da to prova di clemenza, il Cardinale volle completar la con un 'ope ra di distensione i m p o n e n d o d 'autori tà alcuni matr im o n i fra giovani e ragazze delle o p p o s t e fazioni e con t r i -
325
b u e n d o perf ino di tasca sua, cioè di tasca dello Stato, alle doti delle spose. Quest i e rano i criteri con cui la Chiesa credeva di r ipor ta re il suddi to sulla ret ta via: obbl igandolo ad anda re in chiesa anche se non credeva e dandogl i perfino la mogl ie d i p r o p r i a scelta. Inu t i le d i re che que i m a t r i m o n i forzosi, invece di uni re , divisero ancora di p iù i «cani» - come i codini chiamavano i liberali - dai «gatti» - come i liberali chiamavano i codini - agg iungendo ai contrasti ideologici quelli familiari.
Al t e m p o di Consalvi, Goe the aveva definito i l gove rno papa l ino con u n a frase del card ina le Albani: «A m e n o che voi n o n mont ia te su una sedia in piazza di Spagna pe r dire che il Papa è l 'anticristo, potete fare e d i re quel che volete»; Era il r i tratto di un dispotismo stanco che spesso è la migliore garanzia di liberalismo. Ma ora n o n era più così. Con gli Zelanti, il d ispot ismo aveva p e r d u t o la s tanchezza senz'acquis tare l'efficienza. «Quel vestire di toga l ' inquisi tore e il giudice di cocolla - scriveva Farini -, quel mescolare la religione alla politica, gli ecclesiastici coi birri , e quel collocare il t rono sopra l 'altare, r endevano odioso il governo e il partito clericale.» Lo stesso Metternich si p reoccupava del suo autori tar ismo mescolato d'insipienza.
Q u e s t o e ra i l r e g i m e papa l ino : un r e g i m e in cui la re pressione rappresentava non l 'emergenza, ma la regola.
Da Parma, e rano s empre arr ivate a Vienna notizie rassicurant i . «Il paese e gli abitanti sono tranquillissimi, quan to a società segrete, n o n ne abbiamo traccia, e oserei aggiungere che n o n ne ammet to la possibilità neanche nel resto d'Italia, dove c redo pe r lunga esper ienza che n i u n a cosa possa restar segreta pe r molto t empo: le genti sono soverchiamente incl inate a d i sco r re re , e i caffè e i luoghi di r i t rovo sono pubblici par la tor i , dove tu t to si dice e tu t to si sa», scriveva Neipperg , d a n d o prova della sua perspicacia.
A g o v e r n a r e e ra s e m p r e stato lui. Ma se p r i m a doveva contentarsi di farlo sotto banco, ora poteva farlo anche uffi-
326
cialmente perché dopo la mor te di Napoleone - «il Serenissimo Consor te dell 'Augusta Sovrana» l'aveva chiamato con squisito tatto La Gazzetta di Parma nel da re notizia della sua scomparsa a Sant 'Elena nel maggio del '21 - aveva sposato Maria Luigia, che già gli aveva dato u n a figlia ed era di nuovo incinta. Pur segui tando a res tare ne l l 'ombra , Ne ippe rg conduceva la barca con mano ferma den t ro il guanto di velluto. Aveva por ta to a t e rmine molte impor tant i opere pub bl iche, a l t re ne aveva messe in can t ie re , s i d imos t rava un oculato amminis t ra tore e non aveva sentito il bisogno di appesan t i r e i control l i polizieschi n e m m e n o d o p o i mot i di Napol i e di Tor ino e la scoper ta delle cong iu re ca rbona re nel Lombardo-Veneto.
Furono le denunce di Francesco IV di Modena che l'obb l iga rono a misu re repress ive . Ques t i aveva segnala to a Vienna u n a rete di Sublimi Maestri Perfetti che dal suo Ducato si d i ramava in quello di Parma, e ne dava anche i nominat ivi . V ienna t rasmise l 'elenco a N e i p p e r g , che ne fu molto contrar ia to . A quan to pare , egli sapeva benissimo di queste conventicole, ma n o n le p r endeva sul serio considerandole un 'accademia di dilettanti della politica destinata a esaurirsi in chiacchiere. N o n po tendo oppors i agli ordin i di Met ternich che gl ' ingiungeva un energico in tervento , fece d i sc re t amen te avver t i re i magg io r i indiziati p e r c h é p r e n dessero i l largo, t an to che in segui to qua l cuno l 'accusò di cercare i favori dei set tari p e r rafforzare il suo Stato e ingrandir lo : il che risulta assolutamente infondato. Ma è sintomatico che gl'indiziati trascurassero l 'avvertimento e si lasciassero t ranqui l lamente arrestare .
Al processo, che fu condot to nel p ieno rispetto di tut te le formalità e garanzie legali, risultò che effettivamente a Parma c'era stata u n a chiesa di Sublimi Maestri buonar ro t i an i , la quale aveva cercato di stabilire collegamenti con le Vendite c a r b o n a r e emi l iane p e r un ' az ione a r m a t a in a p p o g g i o a i Cost i tuzionali di Napol i , che poi p e r ò si e r a risolta nella s tampa e nel lancio di alcuni manifesti in latino da distribui-
327
re alle t r u p p e austriache e ungheres i di passaggio nella zona p e r la spedizione contro il Reame.
Il Presidente del t r ibunale si rifiutò di leggere la sentenza pe rché gli parve t r o p p o dura , e bisognò chiamare il minis t ro della g u e r r a . C ' e r a n o d u e c o n d a n n e a m o r t e : u n a con t ro l ' i sp i ra tore della tresca, Micali, e l 'al tra con t ro un certo Martini che vi aveva par tecipato n o n già pe r sovvertire lo Stato, ma pe r impadronirs i della Duchessa di cui s'era i nnamora to q u a n d o la serviva come guard ia d 'onore . A lui Ne ipperg non voleva p e r d o n a r e , ma gli p e r d o n ò con femminile indulgenza Maria Luigia c o m m u t a n d o sia a lui che a Micali la p e n a capitale in quella del carcere a vita.
Pagato questo t r ibuto al delirio repressivo che si e ra impadron i to di Vienna, Parma to rnò al suo abituale reg ime di relativa tolleranza. Come la descrive Lamar t ine , Maria Luigia «era u n a bella figlia del T i ro lo , dagli occhi cilestri, dai capelli biondi , dal volto che rifletteva la bianchezza delle nevi e le rose delle sue vallate, dal l 'a t teggiamento languido e stanco di quelle tedesche che sembrano aver bisogno di appoggiarsi sul cuore di un uomo». Infatti q u a n d o Ne ippe rg mor ì , nel ' 29 , si affrettò a sosti tuir lo con un al t ro p e r c h é senza u o m o n o n sapeva stare: e ra l 'unica cosa che la interessasse. Il suo liberalismo veniva dalla disappetenza del potere che a sua volta veniva da l l ' appagamento dei suoi sensi e s en t imen t i di d o n n a . A P a r m a c'è ancora chi r i m p i a n g e questa Sovrana affettuosa e m a t e r n a che ispirava ai rivoluzionari il proposi to di rovesciarla dal t rono , ma solo pe r rovesciarla sul letto e che, invece che persegui tare i suoi sudditi, avrebbe preferi to allattarli.
È molto probabi le che Francesco IV avesse sfoggiato tanto zelo nel d e n u n c i a r e anche i cospira tor i di P a r m a p e r fare b u o n a impress ione su Car lo Felice, zio di sua mogl ie e in quel momen to suo ospite a Modena. Abbiamo già det to che alla speranza di accaparrars i il t r o n o sabaudo o a lmeno la Sa rdegna non r inunciava, anche se nel cont ra t to di matr i-
328
m o n i o e r a specificato che la figlia di Vit tor io E m a n u e l e I n o n aveva diritti da avanzare sugli Stati del p a d r e , che ora stavano a p p u n t o pe r toccare a Carlo Felice. Per con t rappor re la p r o p r i a severità ai ced iment i di Car lo Alber to , si e ra addi r i t tu ra scatenato cont ro le «sètte infernali» che volevano sovvertire l 'ordine costituito dell 'assolutismo di cui si ergeva a inflessibile campione . E i suoi tr ibunali e r ano già all 'opera.
Il corpo del rea to era, come a Parma, un volantino in latino distribuito ai soldati ungheres i di passaggio nel Ducato p e r la spediz ione su Napol i , che li esortava a far causa com u n e con gl'insorti. E molto dubbio che i destinatari il latino lo capissero. Ma il tentativo di sovversione c'era, e quindi doveva esserci anche il castigo. Il capo della polizia m o d e nese non era un Salvotti. Era soltanto un certo Besini, efficiente solo c o m e seviziatore. P rocede t t e alla cieca con t ro tutti i sospetti oppositori , e ce n ' e rano . I più sospetti di tutti e r a n o i r e d u c i del R e g n o Italico, ai cui q u a d r i d i r igen t i i modenes i avevano dato un fortissimo contr ibuto di uomini : Luosi, Venturi , Tassoni al l 'amministrazione; Zucchi, Fonta-nelli, Manares i all 'esercito, pe r limitarci a pochi nomi . Era logico che costoro si sentissero a disagio e guardassero con d isprezzo i l r e g i m e re t r ivo di que l piccolo Duca to che la p re tendeva a mosca cocchiera dell 'assolutismo reazionario. Di u n a loro cospirazione non c'era altra traccia che l ' incauta lettera di un giovane, Manzini. Ma bastò a de te rmina re l'arresto di tutt i coloro che n o n fecero in t e m p o a fuggire, seguito da brutal i in terrogator i .
Pochi giorni d o p o il Besini fu raccolto pe r s t rada in fin di vita pe r un colpo di stiletto infertogli da un passante; e invece che un g iorno di lutto, fu pe r Modena un g iorno di festa. Ma l ' istruttoria del processo r imase in mano a uomini ligi ai voleri del Duca, che n o n voleva giustizia, ma vendet ta contro «questi nemici di Dio e della religione», fra cui c'era anche un giovane e dot to pre te , Andreoli . Fu condanna to a mor te , e il Duca respinse la sua d o m a n d a di grazia il giorno
329
stesso in cui la concedeva a un pa r r i c ida p e r d i m o s t r a r e ch'egli cons iderava l 'anelito di l ibertà un deli t to più grave di qualsiasi assassinio.
Nei suoi r a p p o r t i a Vienna , Francesco si van tò di aver «sradicato la mala pianta». Era vero pe rché tutti coloro che n o n e r a n o f in i t i in galera avevano dovu to cercare scampo nella fuga, e r a p p r e s e n t a v a n o q u a n t o c 'era di megl io nel Ducato, che ne r imase i r reparabi lmente impoveri to . Anche Met tern ich lo capì, e n o n ne fu p u n t o gra to a quel suo zelante vassallo.
CAPITOLO TRENTADUESIMO
DA FERDINANDO A FRANCESCO
Dopo aver tradito a Lubiana l ' impegno preso col suo governo ch i amando gli austriaci, Fe rd inando n o n mostrava nessuna fretta di t o r n a r e a Napol i . Vi m a n d ò sol tanto la lista dei nuovi ministr i , e A Cour t , q u a n d o la vide, esclamò cos ternato: «Non ce n'è u n o che abbia m e n o di se t tant 'anni e la capacità di gove rna re un villaggio!» Medici ne e r a stato d e p e n n a t o , e il suo a l lon tanamento aveva consenti to al Re di reinsediare nel ministero di polizia il Canosa, la cui furia vendicat r ice si abba t té anzi tu t to sui suoi stessi funzionar i . Gran par te di essi, rei di essere rimasti ai loro posti nell 'intermezzo costituzionale, vennero epurat i e sostituiti con capi -camorra e «picciuotti di sgarro» illustratisi con delazioni e violenze.
Furono istituite «giunte di scrutinio», nuova edizione di quelle «d'inconfidenza» pe r la caccia al «costituzionale», sinon imo di «giacobino», e i castighi fioccarono. A mor t e furono condannat i i generali Pepe e Rossaroll, pe r for tuna già fuggiti. Altri sei generali - Colletta, Pedrinelli, Colonna, Costa, Arcovito, Russo - finirono in carcere a far compagnia ai deputa t i p iù in vista, Poerio, Borrelli , Gabriele Pepe. Contro i minor i esponent i , Canosa escogitò punizioni più raffina te intese sopra t tu t to a discreditarl i . Li faceva sfilare pe r via Toledo a b o r d o di asini e vestiti da pagliacci sotto gli sberleffi e gli sputi della plebaglia.
Gli stessi austriaci si met tevano le mani nei capelli, e avevano rag ione p e r c h é quei t r a t t amen t i n o n facevano che spingere alla disperazione e alla rivolta. Piuttosto che rasse-gnarvisi, parecchi ufficiali fino al g rado di colonnello prefe-
331
r i rono buttarsi alla macchia e darsi al br igantaggio, che infatti ebbe immedia tamente un notevole rilancio. Fra i protagonisti della guerriglia ci fu quel tenente Morelli, che a Nola aveva dato avvìo alla rivolta costituzionale e che ora cercava di r i a n i m a r n e il fuoco. Dopo la d is t ruz ione della sua banda , riuscì a ragg iungere l'Adriatico e a imbarcarsi per la Grecia. Ma una tempesta lo sospinse invece sulle coste albanesi. Gli austriaci che lo ca t tu ra rono , e ai quali aveva det to di essere un suddito papal ino, lo spedi rono a Ancona dove, r iconosciuto, fu consegnato ai borbonici . Fuggì ancora , arr ivò in Puglia , fu di n u o v o r iconosciu to e a r re s t a to , e finì sulla forca. Ma intanto altri ufficiali, il colonnello Vallante, il magg io re Poerio, i capi tani C o r r a d o e Venite, assaltavano paesi, tentavano agguati e vi cadevano. Un grosso contributo a questa guerr igl ia , lo dava il clero. In u n a sola diocesi, centovent iquat t ro pret i r isul tarono iscritti alla Carboneria .
Finalmente il 15 maggio (del '21), il Re si decise a tornare , e i napoletani lo accolsero con bande e luminar ie , come se fosse reduce da chissà quale gloriosa impresa. Canosa gli fece subito un dettagliato resoconto delle p u r g h e che aveva inflitto, ma anche delle difficoltà che incontrava presso gli austriaci, i quali p re t endevano fermargli la m a n o e reclamavano un 'amnis t i a . I l Re, d o p o averli ch iamat i , t rovò che «questi tedeschi si vogliono in t rome t t e r e e p r e n d e r e ingerenza in tutto», e n o n esitò a mettersi in u r to col loro ambasciatore q u a n d o questi gli d imost rò , documen t i alla mano , che Canosa appaltava gran par te delle sue vendet te n o n alla polizia e ai tr ibunali , ma a quell 'associazione a de l inquere ch ' e rano i Calderari , da lui apposta r ianimata.
Gli austriaci pe rò avevano il coltello dalla par te del manico. Per avere l 'aiuto del loro esercito, Fe rd inando a Lubiana si e ra impegna to a mantener lo . Ed esso costava caro perché e r a n o circa c inquan tami la uomin i . Per far f ronte a quella spesa, aveva dovuto contra t tare un prestito con Rothschildt, ch ' e r a venu to a n c h e lui a Napol i ins ieme al gene ra l e Fri-mont . Ora quel prestito bisognava r innovarlo pe rché lo Sta-
332
to n o n e ra asso lu tamente in g r a d o d i r imborsa r lo . Roth-schildt vi si mostrò disposto, ma a una condizione: che fosse r ich iamato Medici, unico minis t ro che forniva garanzia di un riassestamento del bilancio. E Medici significava l 'estromissione di Canosa . Il Re rifiutò, e segui tò a farlo finché potè, ma non lo potè a lungo perché aveva l 'acqua alla gola. Alla fine dovet te a r r ender s i e licenziare il suo zelante poliziotto, che pe r la seconda volta abbandonò il Reame, unico esule per amor di t i rannide in quell 'Italia di esuli per amor di libertà.
Con la consueta accortezza, ma in u n a situazione gravemen te de ter iora ta , Medici cercava di t a m p o n a r e le falle di quella sconquassata barca. Coi costi dell 'occupazione, il debito pubblico saliva ver t iginosamente , e l 'epurazione aveva but ta to sul lastrico to rme di funzionari e ufficiali. Questi ultimi e r a n o stati radiat i anche p e r c h é i l Re aveva deciso di sciogliere g r a n pa r t e dell 'eserci to di cui più n o n si f idava, per sostituirlo con t r u p p e mercenar ie s traniere, soprat tut to svizzere. Al Congresso di Verona egli o t t enne che l'Austria richiamasse par te di quelle sue. Ma il grosso dovet te continua re a tenerlo e a mantener lo fino al '26.
F e r d i n a n d o n o n fece in t e m p o a v e d e r n e lo s g o m b e r o pe rché mor ì l ' anno pr ima . Fino all'antivigilia e ra anda to a caccia, come s e m p r e , con g ran disperazione di sua moglie che poi e ra costre t ta a m a n g i a r la selvaggina, catastrofica pe r il suo fegato. Il 3 gennaio dovette restarsene a casa pe r un forte raffreddore, e il medico, no tando che aveva il volto congestionato e la parola inceppata, gli p ropose un salasso, ma il Re rifiutò. La matt ina d o p o lo t rovarono cadavere, fulminato da un colpo apoplettico, come Maria Carolina. Aveva settantasei anni e ne aveva regnat i sessantacinque.
Tutte le test imonianze, anche quelle a lui più ostili, concordano nel dire che il cordoglio fu g r ande da par te del popolo, che pe r tre giorni affollò il palazzo pe r r e n d e r e l'estremo omaggio al Re lazzarone. «Era cer tamente un gran buon uomo» scrisse Lady Blessington. Ques to buon u o m o aveva
333
sulla coscienza la vita di migliaia d'infelici, mort i sulla forca e nelle galere solo pe r aver voluto un po ' di libertà. Era stato spe rg iu ro . N o n aveva conosciuto che disfatte e fughe ignominiose di fronte al nemico. Politicamente, era rimasto fermo alla concezione settecentesca del più retrivo assolutismo. Non aveva fatto che i p r o p r i interessi, e più ancora i p rop r i comodi, della regalità p rendendos i soltanto i piaceri. Non aveva saputo inc rementa re che l ' ignoranza, di cui era egli stesso un campione . E p p u r e , i l cordoglio popola re pe r la sua mor te n o n ci stupisce, perché un dono lo aveva avuto: la genuini tà . Ques to Re fellone e fannul lone n o n aveva mai cercato d i a p p a r i r e diverso da quel che era: u n o scugnizzo dei «bassi», p r e p o t e n t e , r idanciano e sboccato, nato pe r caso con u n a corona in testa, e che aveva sempre concepi to la sua p a r t e come quel la d i un b u o n capo-camor ra . Non aveva in te rpre ta to che i caratteri deter ior i del popolo napole tano, ma anche i più appariscenti e riconoscibili.
Il successore Francesco era forse un po ' meglio di lui, ma più opaco. Ridusse di parecchio le p e n e inflitte ai condannati politici, ed ebbe il b u o n senso di secondare l 'opera distensiva di Medici. Ma in tutto il resto fu figlio di suo padre . Come lui e ra neghit toso, sordo a ogni r ichiamo di libertà, e grossolano. Uno dei suoi divert imenti preferiti era di sgocciolare la cera delle candele sul naso del suo cameriere che, p re s t andos i a quest i scherzi , riuscì ad acquis tare su di lui un ' inf luenza decisiva e la usò p e r dis t r ibuire cariche e impieghi. Bacchettone e domina to da una moglie spagnola più bacchettona di lui, d iede ai pret i il monopol io della scuola e bandì una crociata senza quar t iere contro ogni forma di cultu ra laica: proibì pers ino le ope re del Beccaria, le t ragedie dell'Alfieri e le poesie del Foscolo.
Ora che con la pa r t enza delle t r u p p e austr iache Medici poteva ricucire alla meglio le dissestate finanze, il problema p iù grosso restava quel lo del band i t i smo . G a s p a r o n e in Abruzzo aveva un vero e p r o p r i o esercito. Ma più che dal n u m e r o dei seguaci, la forza dei br igant i veniva dalla loro
334
aureola di campioni della giustizia e di vindici del sopruso. «S'intitolavano amici dei poveri - dice Nisco -, d igiunavano il mercoledì, por tavano al collo lo scapolare della Madonna , p ronunz iavano o r r e n d e bestemmie, ma la sera recitavano il rosario». Secondata dal basso clero che faceva da t ramite, la Ca rbone r i a cercava di s t rumenta l izzar l i , e in molti casi ci riuscì, anche a costo di poco onorevol i compromess i . Per non screditare il p ropr io nome, essa assunse vari pseudonimi, i Pellegrini bianchi, i Sette dormienti, la Gioventù ravveduta, i Veri patrioti. Era u n o stillicidio di azioni guerr ig l ie re in cui era difficile dist inguere il movente politico da quello del saccheggio.
Nel '28 queste sparpagliate iniziative si fusero in una vera e p ropr ia congiura che ebbe il suo epicentro nel Cilento, la zona collinosa che si s tende fra il golfo di Salerno e quello di Policastro, e il suo animatore nel canonico De Luca, ch'era forse l 'ultimo rappresen tan te di quella vecchia società Filadelfia di cui da un pezzo n o n si sentiva più par la re . Ma i quad r i glieli p res tò la Carboner ia , che raccolse circa settecen to uomin i , fra cui anche vari ufficiali. I l mo to doveva coincidere con l 'attacco dell 'esercito francese a quel lo austriaco in Italia, di cui non si sa come si era sparso l ' annunzio. Si diceva anche ch 'e rano in arrivo, pe r appoggiare i ribelli, diecimila russi . E il c redi to che r i scuotevano ques te panzane dimostra quanto poco informati e immatur i fossero i dirigenti .
Come al solito, in mezzo ai congiurati c'era la spia, il p re te Moccia, che riferì alla polizia tu t to il p i ano . Alla vigilia de l l ' insur rez ione , i capi v e n n e r o ar res ta t i alla chetichella, m e n o De Luca ch 'era riuscito a sfuggire alla cat tura, e che coi pochi rimasti decise ugua lmente di agire con la collaborazione di alcuni briganti che l 'avevano offerta. Riuscirono a impadronirs i del forte di Palinuro in cui speravano di t rovare armi e munizioni. Invece non ci t rovarono quasi nulla.
Cont ro di loro, ridotti a centotrenta , marciava un intero corpo d 'armata, comandato da Del Carret to , un ex-costitu-
335
zionale che si e ra g u a d a g n a t o la conferma nel g r ado abiur ando e ora smaniava di riabilitarsi comple tamente con u n a prova di zelo. Non r iuscendo ad annien ta re gl'insorti che si e rano dileguati nei boschi, il generale rase al suolo il villaggio di Bosco p e r c h é aveva solidarizzato con loro e ne de p o r t ò gli abi tant i p e r c h é n o n lo r icost ruissero . Di ques ta prodezza fu r icompensato col titolo di marchese.
Ad u n o ad uno , i congiurat i finirono nelle reti della polizia. I p r imi a cade re sotto il p lo tone di esecuzione furono De Luca, un suo nipote anche lui par roco , e otto loro compagni, le cui teste mozze furono infisse su pilastri ad ammon i m e n t o della popo laz ione . Un al t ro g r u p p o r icevet te lo stesso t ra t tamento a Salerno, un altro a Napoli . Gli unici che r iuscirono a cavarsela furono i briganti che, molto più allenati alla caccia a l l 'uomo, t rovarono il m o d o di scivolare tra le maglie dei g e n d a r m i e di r agg iunge re gli Stati pontifici, la Toscana e infine la Corsica. Ma non t rovando pace neanche qui perché la polizia francese voleva arrestarli e riconsegnarl i a quel la borbonica , r i t o r n a r o n o a v v e n t u r o s a m e n t e nel Cilento, dove caddero combat tendo o fucilati. U no solo, che n o n era un bandi to , ma un vero rivoluzionario, i l Gai-lotti, r imase in Corsica, lasciandosi cat turare ed es t radare a Napol i . Ma il d e p u t a t o l iberale Cons tan t d e n u n z i ò il fatto nel pa r lamento di Parigi facendone un caso clamoroso, che costrinse il governo a in te rven i re su quello di Napol i per ché il pr igioniero avesse salva la vita. E così fu. Anzi, pe r levarselo di torno, gli de t tero un foglio di via.
Liquidata anche quella rivolta, «nient'altro si vide che fiera e bassa t i rannide, sempre operoso il governo pe r uccisioni e castighi, sempre immobile il popolo nella paura». Così scriveva il Collet ta che , d o p o alcuni mesi di p r ig ione , era stato scarcerato insieme agli altri e sponent i del reg ime costituzionale - il Borrelli, il Poerio ecc. -, ma anche lui aveva avuto come gli altri il foglio di via, e dopo molto girovagare aveva t rovato stabile rifugio a F i renze , la Mecca di tut t i i perseguitati .
CAPITOLO TRENTATREESIMO
IL «PAESE DI BENGODI»
Dall 'ondata di repressioni un solo Stato r imase i m m u n e per il semplice mot ivo che lo e ra stato anche dalle cong iu re e dai conati insurrezionali: la Toscana.
Abbiamo lasciato il g r a n d u c a F e r d i n a n d o alle p rese coi p rob lemi della successione dinastica, gli unici di cui aveva qualche ragione di essere preoccupato . Gli era anda ta male. Risposatosi contro voglia a c inquan tadue anni con la sorella di sua n u o r a , non aveva avuto l ' e rede che suo f igl io aveva cercato invano di dargli con la col laborazione della p r ima moglie, e non fece in t e m p o a vedere quello che gli avrebbe dato con la seconda. Q u a n d o morì , nel '24, ucciso dalla malaria che aveva cercato di debellare con la bonifica della Mar e m m a , i fiorentini p ianse ro s ince ramente il «dolce sovrano», titolo che si era p ienamente meri ta to .
Il Tommaseo, gran linguaccia, scrisse ch 'era stato «un uomo corto, che nel suo gabinetto di studio trovava agio a contare le stelle del soppalco». È probabile. Ma di tutti i Sovrani della Restaurazione era stato di g ran lunga il migliore, il più l iberale e u m a n o , il più al ieno da vendet te e rancor i . Non aveva rivelato grandi qualità di u o m o di Stato, ma aveva sapu to scegliere un collaboratore che ne aveva: il Fossombro-ni. Giuseppe Montanelli r improverava a questo Ministro un certo spirito conservatore dovuto , secondo lui, a un fondamen ta l e scetticismo nei confront i delle g r a n d i idee e dei g rand i p rog rammi . C'è del vero. Spirito pragmat ico di formaz ione il luminista, Fossombroni diffidava dei vasti p iani di r i forma, ma fu un eccellente ammin i s t r a to re . In quel lo stesso anno 1824, nonostante i capitali che la M a r e m m a se-
337
guitava ad assorbire, il bilancio segnava un avanzo net to di t r en t a milioni - cifra r a g g u a r d e v o l e , pe r quei t empi - e il cens imento diede, pe r tut to i l Granduca to , u n a popolazione di un milione e 250 mila abitanti con un inc remento di oltre il 7 per cento negli ultimi dieci anni . Ma oltre a queste statistiche che d o c u m e n t a v a n o i l benesse re mate r ia le , ce n ' e r a un 'a l t ra che d o c u m e n t a v a quel lo mora le : quella dei processi politici. Non ce n 'e rano stati quasi punt i . Quelli fiorentini e rano gli unici tr ibunali disoccupati d'Italia, e le galere non ospitavano che comuni malfattori.
L'unica città che dava qualche grat tacapo alla polizia era Livorno, nonostante il suo boom economico, o forse p ropr io per questo. Livorno era passata quasi d ' un balzo da quaranta a settantamila abitanti, grazie al r ipristinato regime liberi-stico che aveva rilanciato il por to facendovi fiorire «banchi» n o n sol tanto toscani e italiani, ma francesi, inglesi, greci, ebrei . Era p ropr io questo ambiente cosmopolita che faceva di Livorno u n a città vivacissima anche cu l tu ra lmente , sebbene di questo pa re re n o n fosse il suo figlio più illustre, Domenico Guerrazz i , che scagliava invettive rovent i con t ro i suoi compatrioti , «gente alla quale mai è brillata una luce di bellezza e di sapere , che ha avvoltolato il corpo e lo spirito nei tu rp i piaceri del senso, nella lussuria, nell 'avarizia, nel sangue». Ma p r o p r i o in ques te i n t e m p e r a n z e po lemiche Guerrazzi si mostrava anche lui b u o n livornese e legittimo i n t e r p r e t e di u n a città t u rbo l en t a che la violenza l 'ha nel sangue, commista alla generosità. Essa non avrà avuto «luce di sapere», ma intanto dava al imento a ben nove tipografie che, in un Paese di analfabeti come l'Italia, dovevano r ap p resen ta re un p r ima to nazionale o poco meno , e t ra poco, p e r iniziativa dello stesso Guerrazz i , avrebbe da to avviò a u n o dei più impor tant i e battaglieri giornali della penisola, ^Indicatore livornese.
Natura lmente Guerrazzi condivideva l 'opinione di Tommaseo che «in Toscana si sbadigliava». Ma n o n la condivideva Met te rn ich che nella Toscana vedeva, al cont ra r io , u n a
338
pericolosa centrale d ' idee rivoluzionarie, n o n si stancava di far pressioni sul governo pe rché inasprisse i controlli della censura e della polizia, e q u a n d o Ferd inando morì fece, att raverso il suo ambasciatore a Firenze, un tentativo pe r legare p iù s t r e t t amen te i l successore L e o p o l d o al c a r ro di Vienna. Ma Fossombroni capì al volo la manovra e la bloccò, m a n d a n d o il nuovo Sovrano a p iangere il pad re in campagna e d icendo all 'ambasciatore che l 'orfano era t roppo turbato pe r poter lo ricevere.
Leopoldo, dal canto suo, era fe rmamente deciso a difende re la p r o p r i a au tonomia . I f iorentini , che da ragazzo lo avevano chiamato «Canapino» e che più tardi lo avrebbero chiamato «Canapone» sempre pe r i l colore dei capelli, ora gli avevano app ioppa to il sop rannome di «Broncio» per via della sua aria malinconica e scontrosa, sottolineata dal labbro inferiore péndu lo sul men to . Neanche lui, come suo padre , aveva g ran stoffa di u o m o di Stato. Preferiva s tarsene ad a rmegg ia re nel suo laborator io di ar t igiano, dove si divertiva a cos t ru i re ogni sorta di aggeggi . Ma, anche se lasciava fare ai suoi Ministri, ai p rop r i compiti di supervisione n o n r inunciava e voleva esercitarli in p iena ind ipendenza . Dell 'et ichetta si curava poco, e le ce r imonie l ' annoiavano. Alle poche cui era d'obbligo la sua partecipazione, n o n nascondeva il suo impaccio, specie con le signore, cui rivolgeva s e m p r e la stessa d o m a n d a : quan t i figli avevano, e gli sembravano sempre t r o p p o pochi. U n a sera, dice Bargelli-ni, lo chiese d u e volte alla stessa d a m a perché , miope com'era, n o n l 'aveva r iconosciuta. «Gli stessi di p r i m a - r ispose costei -: n o n ho avuto il t empo di farne altri!»
Forse questa ossessione dei figli gli derivava dal fatto di non averne. Le tre bambine che gli aveva dato la p r ima moglie gli e r ano mor te una d o p o l'altra. E pe r la povera Granduchessa era stato un tale s t ruggimento che ne morì anche lei, di etisia. Leopoldo la pianse d ispera tamente , ma il dovere dinast ico lo costr inse a r impiazzar la . La presce l ta fu un 'ennes ima Borbone di Napoli della inesauribile nidiata di
339
Ferd inando e Maria Carolina. Maria Antonia colpì i fiorentini pe r la sua bellezza e pe r la sua ignoranza, ugua lmen te sproposi ta te ; ma seppe anche conquistar l i con la sua vivacità e naturalezza. E i suoi compiti li assolse d a n d o al mari to il sospirato e rede che si chiamò, come il n o n n o , Ferd inando , ma che era destinato a non eredi tare nulla pe rché il t rono lo perse p r ima ancora di salirvi.
Fe rd inando Mart ini ch iamò il G r a n d u c a t o di Leopo ldo «il paese di Bengodi», e il le t terato Giordani , che vi si accasò, datava le sue lettere «Dal paradiso terrestre», sebbene p ro venisse dal Duca to d i Pa rma , che n o n e ra poi l ' inferno. Neanche a Firenze, si capisce, la libertà trionfava. Ma la tolleranza, sì. La città era diventata la Mecca dei persegui ta t i politici della penisola che vi trovavano n o n soltanto rifugio, ma anche occasioni d i lavoro. «Bastava n o n gr idar t r o p p o forte, ma con un po ' di p r u d e n z a si poteva dir tutto»; tut to quello, ben inteso, che n o n si poteva in nessun 'a l t ra pa r t e d'Italia.
Il cent ro di raccolta degl ' intellettuali sbanditi e sbandati e r a il Gabinetto scientifico-letterario, fonda to da Giampie t ro Vieusseux, il vero e rede del Caffè di Verri e Beccaria. Vieus-seux era un l igure di origine svizzera che, d o p o lunghi soggiorni all 'estero, nel '19 si e ra trasferito a Firenze, dove trovava l'aria più congeniale ai suoi polmoni . Forse non possedeva un g rande talento, ma aveva il dono di capire i talenti a l t ru i e le doti di au tor i tà e di equil ibr io necessarie a dir igerli e a orchestrarli . Rilevò la vecchia Antologia che fin allora e ra stata soltanto u n a rassegna di scritti già compars i in altri giornali e ne fece la palestra delle intelligenze italiane. «Sarebbe t e m p o - scrisse - che gli au to r i si pe r suadesse ro essere i giornali fatti p e r il pubblico e n o n pe r loro.» Sembrerebbe u n a banalità, ed era invece un 'autent ica rivoluzione pe r una pubblicistica come quella italiana, tut ta fatta per «loro» e n o n già per il pubblico. «Sarà nostra cura - scrisse anche - che le voci umanità, amor di patria, gloria n o n siano
340
negli scritti dell'Antologia pubblicati, vuoti nomi e re tor iche superflui tà.» E a n c h e questa era un ' au t en t i ca r ivoluzione pe r u n a pubblicistica come quella italiana, marcia di enfasi e d i t r ombonesca solenni tà . N a t u r a l m e n t e n e a n c h e Vieusseux riuscì a guarir la di questi o r r end i difetti, che tu t tora le avvelenano il sangue. Ma fu il p r imo a dichiarargli gue r r a e a fargliela, t enendo sotto costante controllo i suoi collaboratori.
Riuscì a r iuni re quan to in Italia c'era di meglio: da Leopard i a Capponi , da Salvagnoli a Romagnosi , da Guerrazzi a Montanel l i , da Niccolini a Mazzini, da L a m b r u s c h i n i a Mayer a Giordani a Rosellini, e qualcuno addir i t tura ne inventò come Pietro Colletta che fin allora aveva fatto soltanto l ' i ngegnere e il gene ra l e e che , g iun to esule da Napol i , nell'Antologia si rivelò come storico di vaglia. Vieusseux era un pars imonioso ammin is t ra to re ; ma q u a n d o scopriva un cervello, non esitava ad assoldarlo. Chiamò a far par te della redazione un giovane dalmata allora quasi del tut to sconosciuto, Tommaseo, dandogli un mensile di centoventi lire, e dodici scudi assegnò a un al tro t ransfuga napo le t ano , Gabriele Pepe.
^Antologia, il cui credito cresceva di giorno in giorno, era pe r Metternich un p r u n e negli occhi. Ma Vieusseux riuscì a tirarla avanti grazie al suo senso della misura. N o n era pe r mancanza di coraggio e pe r considerazioni di con t ingen te o p p o r t u n i t à , come qua lcuno ha de t to , ch'egli smussava le p u n t e eccessivamente polemiche di certi suoi collaboratori; ma perché , u o m o di formazione illuminista, alla rivoluzione non ci credeva. Come ha scritto il suo biografo Prunas , «non pensava eccitare il popolo alle armi pe r un ' idea che non capiva e alla quale non era pe r anco né ma tu ro né p repara to ; ma senza bisogno di mascherarsi o di mettersi al sicuro da ' pericoli delle polizie, voleva di g io rno in g io rno r e n d e r l o p iù s e m p r e cosciente d e ' suoi interessi e d e ' suoi dover i , perché meglio intendesse i suoi diritti». A differenza di molti suoi colleghi che dell 'Italia avevano un ' idea astratta e re -
341
tor ica e la vedevano com'essi av rebbe ro volu to che fosse, Vieusseux la vedeva senz'illusioni com'era: un Paese di poveri analfabeti insensibili a qua lunque sollecitazione ideologica finché n o n avessero avuto gli s t r umen t i p e r capir la e reagirvi, cioè un min imo di cultura; su cui galleggiava u n a piccola élite d'intellettuali, in g ran par te chiusi nei loro accademismi e incapaci di pa r l a re alle masse. Glielo confermavano le modes te dimensioni del suo stesso successo. HAnto-logia era, e pe r molti anni doveva r imanere , la rivista di gran lunga più influente e autorevole d'Italia. Eppure , la sua circolazione n o n superò mai le set tecentocinquanta copie per l ' intera penisola. Nel Lombardo-Veneto non se ne vendevano più di c inquanta , sessanta in Piemonte , venti nelle Due Sicilie. Sebbene Vieusseux facesse un giornale pe r il pubblico, ques to pubbl ico r i m a n e v a poche cent inaia d i p e r s o n e pe rché tutti gli altri n o n sapevano leggere. Tutto il segreto del Risorgimento, cioè della sua incapacità di t radursi in rivoluzione popolare , è in queste cifre, più istruttive di qualsiasi esegesi sociologica.
Nel '26 comparve sull'Antologia u n o scritto di Pepe che sembrava u n o dei tant i elogi d i Dan te , ma che nel finale con teneva , senza n o m i n a r l o , un 'a l lus ione a L a m a r t i n e , i l quale in d u e versi famosi aveva det to che in Italia non c'erano uomini , ma soltanto «polvere umana» . La censura n o n aveva capito, ma capì benissimo Lamar t ine , giunto da poco a Firenze come segre tar io dell 'Ambasciata francese. Andò da Pepe e lo sfidò a duel lo . La polizia, che coi diplomatici stranieri non voleva storie, convocò Pepe pe r l ' indomani alle undici . Pepe lo comunicò a Lamar t ine con cui si accordò pe r battersi alle sei in m o d o da preveni re il divieto. Fu una gara di cavalleria. Per n o n e spo r r e degli amici a rappresa glie, Pepe accettò come padr in i quelli francesi del suo stesso avversario e, siccome le d u e spade e rano di lunghezza disuguale, scelse pe r sé la più corta. Ferì ugua lmen te Lamar t i ne , gli fasciò il taglio col p r o p r i o fazzoletto, e andò a p ren dersi il rabbuffo della polizia. Ma il minis t ro francese n o n
342
solo chiese che il governo si astenesse da qualsiasi rappresaglia, ma m a n d ò a Pepe la sua carrozza e lo invitò a cena.
L'episodio ebbe u n a r isonanza che raggiunse vette di melodrammatica comicità. Da Milano, da Roma, da Napoli, Pepe ricevette lettere di questo tenore : «Vendetta è fatta... L'ono re è salvo... Siamo tutti ai tuoi piedi...» Si p u ò sor r iderne , e c r edo che Vieusseux ne abbia infatti mol to sorr iso . Ma e rano le reazioni abnormi di un Paese abituato alle umiliazioni.
L'anno d o p o , palazzo Buonde lmon t i , dove il Gabinetto e VAntologia avevano la loro sede, si pa rò a festa p e r il ricevimento a un ospite d'eccezione: Alessandro Manzoni che veniva a Firenze per risciacquare in Arno i panni dei suoi Promessi sposi, il romanzo che aveva messo in subbuglio l'Italia. C 'erano tutti, anche Leopardi . E anche questo avvenimento fece epoca. S e m p r e più l 'Italia si abituava a g u a r d a r e a Firenze come alla sua piccola Atene e a p r e n d e r n e il la. Nel '29 Niccolini, altro pu led ro di Vieusseux, vi fece r appresen ta re la sua tragedia Giovanni da Procida, che rievocava i Vespri Siciliani. Montanel l i scrisse che i l Niccolini, p u r n o n avendo «né la vigorìa dell'Alfieri né l'estro lirico del Manzoni, l 'uno e l'altro superò in ricchezza di a rmonie e di colore». Invece li superava soltanto in bolsaggine e c iarpame retorico. Ma il lavoro ebbe ugualmente un immenso successo per il significato patriottico che imprestava ai Vespri, i quali invece n o n ne avevano avuto nessuno . L'ambasciatore francese pro tes tò pe r le violente invettive che vi r i suonavano cont ro la Francia. Ma il suo collega austr iaco lo calmò. «Queste invettive - gli disse - sono indirizzate a voi, ma rivolte a noi.» Ed era vero. Neanche a Firenze si poteva sproloquiare di re t tamente contro l'Austria. Lo si faceva indi re t tamente , fingendo di par lare di un altro Paese; ma lo si faceva.
Per ques to , solo pe r ques to , Fi renze e ra d iventa ta e sarebbe pe r un pezzo rimasta la «capitale morale» d'Italia: pe r la sua libertà.
CAPITOLO TRENTAQUATTRESIMO
FRA CARLO FELICE E CARLO ALBERTO
Car lo Felice, i c o n t e m p o r a n e i lo c h i a m a r o n o Carlo Feroce, ma in realtà la sua ferocia si sfogò più a parole che a fatti. A giudicarlo dalle let tere, nessuno aveva la forca più facile di lui. Q u a n d o era in S a r d e g n a , scriveva al fratello nel suo sgrammat ica t i ss imo francese: «Ammazza, ammazza , p e r i l bene del genere umano». Dopo i moti del ' 2 1 , o rd inò un castigo esemplare , ma ne affidò coi pieni poter i l 'esecuzione a T h a o n di Revel n o t o r i a m e n t e p o r t a t o alla mitezza. Delle settanta condanne a mor te si compiacque, e lo disse; ma forse a l t r e t t an to si compiacque , sebbene n o n lo dicesse, che sessantotto di quei condanna t i fossero al s icuro oltre front iera , né mosse r i m p r o v e r i a l g o v e r n a t o r e di Genova che aveva dato il passaporto ai fuggiaschi.
A Torino, il Re ci stava poco. L'unica cosa che ve lo richiamava o tratteneva era il teatro. Non perdeva uno spettacolo, sia di musica che di prosa, e u n a sera che D'Azeglio e alcuni suoi amici chiacchieravano come al solito nel loro palco, si videro arrivare un ufficiale delle guardie che gli disse: «D'incarico di Sua Maestà, l'invito a tacere». Così Carlo Felice concepiva e praticava il suo mestiere di Re: che i sudditi si tenessero quieti e si astenessero dal seccarlo anche a teatro. Secondo D'Azeglio, il suo regime era «un dispotismo pieno di ret te e oneste intenzioni, ma del quale e rano rappresentant i ed arbitri quat tro vecchi ciambellani, quat tro vecchie dame d 'onore, con un formicaio di frati, preti, monache, gesuiti».
Per istaurarlo, cioè pe r res taurar lo , Carlo Felice n o n aveva esitato a ch iamare gli austriaci, e ora doveva fare i conti con loro che occupavano tu t to i l Paese e n o n mos t r avano
344
p u n t a voglia d ' andarsene . Solo dopo molte proteste, egli ott enne che le guarnigioni fossero r idotte, ma pe r il loro totale ritiro dovette aspet tare la fine del '23. Ma più che questo, il motivo dei suoi dissapori con Met te rn ich fu il p r o b l e m a della successione, da cui voleva a tutti i costi escludere Carlo Alberto. L'odiava a mor t e , lo chiamava «pollone d e g e n e r e della nos t ra famiglia», e t u t to ques to ora faceva c r e d e r e ch'egli complot tasse col Cancel l iere austr iaco pe r me t t e r e sul t rono, alla p ropr i a mor te , la n ipote Beatrice, allora moglie del duca Francesco IV di Modena .
La voce era comple tamente falsa. Metternich non pensava m i n i m a m e n t e a Francesco di cui, sebbene austr iaco e di concezioni so l idamen te reaz ionar ie , diffidava più che di Carlo Alberto, e temeva che costui, in caso di estromissione, sarebbe diventato «il Re dei Carbonari» , p ro te t to e a iutato dalla Francia. Ma n e m m e n o Carlo Felice pensò mai a Francesco. Il suo proget to era quello di p romuove re d i re t tamente al t rono il figlio di Carlo Alberto, Vittorio Emanuele , sotto u n a Reggenza dest inata a d u r a r e pe r la sua m i n o r e età. Ma Metternich respinse anche questa soluzione, vedendovi u n a fonte d'incertezze e instabilità. Al Congresso di Verona, che le Potenze della Santa Alleanza t ennero alla fine del '22, fu definitivamente stabilito che il cont inuatore della dinastia sabauda sarebbe stato Carlo Alberto.
Costui e r a a Firenze, ospite del G r a n d u c a suo suocero , che gli aveva dato un a p p a r t a m e n t o in palazzo Pitti. Aveva rischiato di pe rde re il figlio in un incendio ch 'era costato la vita, pe r salvarlo, alla sua nutrice, e ne aveva avuto un altro, Ferd inando . Non stava d a n d o u n a gran prova di carat tere . Ma lg rado il r ass icuran te v e r d e t t o di Verona , si d i sperava pe r l 'ostracismo cui era condanna to , e n o n faceva che scrivere supplici lettere a Carlo Felice, che n o n gli r ispondeva. Gli m a n d ò anche un lungo memoria le in cui, pe r scagionarsi, accusava tutti i ministri e dignitari , a t t i randosene addosso l'ira e le maldicenze. Accennò all 'idea di chiedere un com a n d o nell 'esercito russo o di emigra re in America previa
345
r inunc ia al t rono ; ma C a p p o n i lo dissuase. Scrisse al Papa p e r o t t e n e r e la sua in tercess ione, e il Papa scrisse a Car lo Felice. Quest i gli r ispose che il r avved imen to del Pr incipe sarebbe stato la sua più g r a n d e consolazione; ma che se i l S ignore aveva r e a l m e n t e c o m p i u t o miracolo , o ra doveva compie rne u n o molto più difficile: quello di pe r suade re lui che il miracolo si e ra avverato.
Carlo Alberto cercò scampo ai suoi s t ruggimenti nella fede , o a lmeno fece di tut to p e r lasciarlo credere . Chiese le fotografìe di Car lo E m a n u e l e , i l Re abdicatar io che da poco aveva concluso la sua vita in monas tero , e della sua pia moglie Clotilde, e ne imitò l 'esempio dandos i a in tense pra t i che religiose. Ma Carlo Felice, pe r quan to anche lui religiosissimo, n o n abboccò. «È u n a vipera intorpidi ta dal f reddo - scriveva a suo fratello -. A p p e n a si riscalda, t o rna a mor dere.» E infatti a quella crisi di misticismo e rano in pochi a c redere , anche pe rché contrastava con razzolamenti che vi s ' intonavano poco. A Firenze si parlava molto delle scappatelle del Principe «dietro tu t te le donnicciòle galanti». Successivamente gli agiografi di Carlo Alberto l ' hanno smentito . Ma lo stesso C a p p o n i , suo g r a n d e amico, scriveva al T o m m a s e o che «tutti r i devano a veder lo inginocchia to in chiesa», essendo noto che den t ro il libro di p regh ie re teneva la sua corr ispondenza amorosa.
Alla fine gli si p resentò l'occasione del riscatto. A Verona, le G r a n d i Potenze avevano deciso l ' in te rvento mil i tare in S p a g n a pe r res t i tu i re i l p o t e r e assoluto al re F e r d i n a n d o , o rma i p r ig ion ie ro dei Costituzionali e comp le t amen te de-sautora to . Stavolta la Francia n o n solo n o n si o p p o n e v a al transito della spedizione, ma anzi ne forniva il ne rbo e se ne accollava il comando . Carlo Alberto chiese immedia tamente di arruolarsi , e Carlo Felice si affrettò a da re il suo assenso. «Così - scrisse il Re al fratello - o si farà accoppare , e ci saremo liberati di lui; o si me t t e rà in condizioni di r i pa ra re alm e n o in pa r t e ai suoi torti . Perché n o n c'è nulla al m o n d o che mi r ipugni più di lui.»
346
Carlo Alberto par t ì nel maggio (del '23), accompagna to da un aiutante di campo incaricato di sorvegliarlo e di rifer ire. «Mi pare - questi scrisse al Re - che il Principe vorrebbe in un m o d o purchessia r ipor ta re sanguinose ferite», e il Re gli r ispose che «se la Provvidenza lo voleva salvo, t an to meglio p e r lui; ma se u n a palla gli fracassava la testa, pazienza».
Ci mancò poco che succedesse. All'assalto del Trocadero , Carlo Alberto si but tò a corpo mor to e tra i pr imi sventolando la bandiera , tanto che fu insignito sul campo della massima decorazione e i granatieri francesi della Guardia, ch'egli aveva gu ida to in quello spericolato assalto, gli offrirono le spalline di caporale . Il Pr incipe ne fu lusingato, ma il p r e mio a cui aspirava e r a un al t ro . «Spero che il Re sarà contento di me» disse all 'aiutante. L'aiutante riferì, e il Re rispose facendo sopp r imere la notizia del l 'episodio nei giornali di Torino.
Finita quel la c a m p a g n a in un 'o rg ia d ' impiccagioni , i l Principe prese la via del r i torno facendo sosta a Parigi. Il re Luigi XVII I lo ricevette e gli d imostrò tut ta la sua interessata benevolenza . Lo p r e s e n t ò alla Cor te come «l 'Eroe del Trocadero», e stavolta esigette at traverso il suo ambasciatore che la notizia fosse da ta anche dalla s tampa piemontese . Dopod iché fece ufficialmente c o m u n i c a r e a Car lo Felice ch'egli trovava es t remamente disdicevole che il Principe fosse t r a t t a to come un proscr i t to . Al la rmato da ques to gesto che rischiava di t rasformare «l 'erede del t rono di Sardegna in un grana t ie re francese», Met ternich chiese a sua volta a Carlo Felice di re in tegrare Carlo Alberto in tutti i suoi diritti. Il Re non se ne mostrò p u n t o ansioso, e p r ima di cedere volle p r e n d e r e le sue p recauz ion i . Alla fine de l l ' anno m a n d ò a Parigi il marchese Alfieri che sottopose alla firma di Car lo Alber to un so lenne i m p e g n o . I l Pr inc ipe doveva giurare di r ispet tare, u n a volta sul t rono, tut te le leggi fondamen ta l i della m o n a r c h i a , so t tomet tendos i a l l ' a rb i t ra to d ' u n Consiglio di Stato formato dai p iù alti - e perc iò dai
347
più reazionari - notabili della Corte e della Chiesa. Sia il Re che Metternich sapevano che ques t ' impegni contano poco. Ma sapevano anche che, f i rmandoli , Carlo Alberto forniva n u o v a mate r i a agli at tacchi dei l iberali , i l che lo avrebbe vieppiù allontanato da loro.
Ora alla fine gli e ra concesso di r ien t ra re a Torino. Ci arrivò p r o p r i o nel m o m e n t o in cui Feder ico Confa lonier i p r endeva la via dello Spielberg, e i liberali n o n si as tennero dal sottolineare la coincidenza. Nei loro scritti lo chiamavano «il traditore», «lo spergiuro», «l'esecrato Carignano». E il Re n o n lo aiutò di certo a supe ra re l 'amarezza di questi attacchi. Gli m a n d ò incont ro u n a staffetta con l ' ingiunzione di n o n en t ra re in città che a notte fonda e pe r viuzze traverse, cioè come ne era uscito, da ladro, t re anni pr ima. L'indomani lo ricevette, ma nessuno assistè al loro colloquio.
Subito dopo il Principe proseguì per Firenze per congedarsi dal Granduca , r ingraziarlo dell'ospitalità e r iprenders i la moglie e i figli. A Torino n o n ci fu nessun ricevimento in suo onore . Carlo Felice gli negò il titolo di Altezza Reale mentre, pe r fargli sentire ancora di più l 'umiliazione, lo r iconobbe a sua moglie, e lo escluse r igorosamente da tutti gli affari di governo. La maggior pa r te del suo t e m p o Carlo Alberto la t rascor reva nel castello di Racconigi . In città, a palazzo Car ignano, ci stava poco, anche perché n o n ci respirava che astio e rancore con tutti i nemici che si era fatto col suo memoriale. Contribuiva a procurargl iene anche la sua p ropensione alla caricatura. Come tutti gli uomini di scarsa personalità, imitava benissimo quella degli altri e nel rifare il verso alla gen te era un maes t ro . I p iemontes i n o n h a n n o mai avuto molto umor i smo, e specie quelli di Cor te ne e rano tota lmente sprovvisti. Le corbellature l'imbestialivano al pun to che Cesare Alfieri di Sostegno supplicò il Principe di astenersene .
Carlo Alberto obbedì. Era diventato docilissimo. Non vedeva che persone d ' immacolata fedina reazionaria, che tuttavia, al suo confronto, sembravano quasi rivoluzionari, tan-
348
to lui ardeva di zelo assolutistico. Un giorno si presentò fur e n t e dal Re p e r denunz ia rg l i un so t to t enen te del Genio che fin allora gli aveva fatto da paggio e che, d e p o n e n d o n e l 'uniforme, l'aveva chiamata «livrea da lacchè». Quel giovane si chiamava Camillo Benso di Cavour, e questo episodio fu il p r imo segno della profonda antipatia che sempre divise i d u e uomini .
La p r ima cer imonia ufficiale cui Carlo Alberto fu invitato a p r e n d e r e par te fu il r icevimento a l l ' Impera tore d'Austria, Francesco I, q u a n d o nel '25 venne a Genova; e l'invito aveva il suo perché . Carlo Felice sperava che i visitatori gli portassero da Vienna la copia dei document i del processo Confalonieri che coinvolgevano il Principe pe r metterglieli sotto il naso e umil iar lo davant i a l l ' I m p e r a t o r e . Siccome questi n o n si pres tò , il Re esigette che il Principe ribadisse anche di fronte agli austriaci g l ' impegni che aveva giurato a Parigi. Metternich racconta che il Principe s'inginocchiò davanti al Re, che p e r l ' ennes ima volta gli chiese p e r d o n o p iangendo , e che il Re gli disse, severamente: «È a l l ' Impera tore , non a me , che dovete la vostra riabilitazione. Non dimenticatelo mai, e n o n date occasione al vostro prote t tore di r impiangere la sua generosità».
Se v e r a m e n t e le p r o n u n c i ò , ques te pa ro le n o n fanno molto onore a Carlo Felice: nessun Savoia, pe r nessun motivo al m o n d o , aveva mai spinto un p ropr io successore a fare atto di vassallaggio, sia p u r e morale , a un Sovrano straniero . Egli respinse , come il suo predecessore , la p ropos t a di Metternich di en t ra re a far par te di una Lega Italica, natura lmente capeggiata dall 'Austria; ma n o n esitò a sollecitare ancora u n a volta la protezione di Vienna q u a n d o di lì a pochi anni la Francia fu nuovamente scossa dai fremiti rivoluzionari che provocarono la caduta dei Borbone e l 'innalzamento al t rono di Luigi Filippo d 'Orléans, il genero di Ferd i n a n d o di Napol i . La sua azione di gove rno si r idusse a ben poca cosa, e a beneficiarne fu sopra t tu t to la Sardegna , cui era r imasto attaccato da vincoli d'affetto. Vi fece costrui-
349
re un certo n u m e r o di ope re pubbliche, le det te un corpo di leggi civili e penal i p iù m o d e r n e di quelle che vigevano in Piemonte e, pe r metterla al sicuro dalle incursioni dei pirati barbareschi che con t inuamen te la tr ibolavano, m a n d ò u n a spedizione navale che a suon di cannona te r idusse alla ragione il Bey di Tripol i e lo costr inse a f i rmare un so lenne impegno .
Gran par te del t empo seguitava a passarla a Genova e in Riviera, e molt i si s tup ivano di ques ta sua p re fe renza p e r u n a città e u n a regione ape r t amen te ostili al dominio e alla dinastia sabauda. Ma Carlo Felice n o n ne era offeso perché n o n ci vedeva nessun t rad imento : i liguri e rano sempre stat i r epubbl ican i , ed e ra logico che segui tassero ad esserlo. Era ai p iemontes i che n o n p e r d o n a v a i l collaborazionismo con la Francia e la r ibel l ione del '21 pe r ché li considerava atti di fellonìa. Egli aveva della lealtà un concetto feudalesco e medieva le , e in ogn i infrazione vedeva u n ' e m p i e t à . Fin q u a n d o suo fratello fu vivo, Carlo Felice n o n perse occasioni di rendergl i omaggio come al vero Re, quasi considerando se stesso un Viceré o L u o g o t e n e n t e . Negli ul t imi a n n i l ' impegno che più lo assorbì fu il r ia t tamento di Hautecom-be, il mausoleo gotico dei Savoia, vicino a Chambéry. Le sue frequenti e lunghe visite a quel tetro e solenne ossario che si staglia in u n o dei più malinconici e funebri angoli delle Alpi, rivela tut to il suo carat tere di Sovrano m o n t a n a r o e paternalista attaccato alle sue valli e alla tradizione di famiglia.
Poli t icamente, valeva molto m e n o di Carlo Alberto che, p u r con tutte le sue ambiguità, la missione italiana della dinastia l'aveva intravista, anche se pe r calcolo o codardia era s e m p r e p r o n t o a t radir la . Ma m o r a l m e n t e e ra mol to al di sop ra di lui. Per i l t r o n o n o n br igò mai , ebbe un sacro rispetto del pubblico denaro , n o n concesse nulla alla popolarità, anzi ne rifuggì con o r ro re , n o n fece mai u n a promessa che poi n o n mantenesse e , p u r ve rgognandosene come d i debolezze, ebbe le sue generosità. Da un r a p p o r t o del D'A-glié risulta che non smise mai di passare sotto banco dei sus-
350
sidi agli esuli del '21 ch'egli aveva fatto condanna re a mor te in contumacia. E il radicale Brofferio, che lo detestava, racconta che q u a n d o Carlo Felice seppe che u n o di questi sussidi andava ai congiun t i di u n o dei d u e giustiziati, o r d i n ò che lo raddoppiassero .
Ed ora i n t e r rompiamo il p a n o r a m a politico pe r fare posto a quel lo cul tura le , esemplif icandolo nelle sue più r ap presentative figure.
CAPITOLO TRENTACINQUESIMO
FOSCOLO
La sera del 4 genna io 1796 si r a p p r e s e n t ò a Venezia u n a t ragedia di stile alfieriano, cioè «urlata» dalla p r ima all'ultima ba t tu ta , che s ' intitolava Tieste. Ur lò a n c h e il pubbl ico , d ' u n en tus iasmo n o n sapp iamo quan to sincero, evocando alla r ibalta l ' au tore , che n o n si p re sen tò . Si chiamava U go Foscolo, e aveva diciannove anni .
Era nato a Zante, figlio di un medico veneziano, che poi era mor to . E sua m a d r e aveva porta to i figli a Venezia, dove li aveva tirati su con molti sacrifici. Ugo aveva il carattere dei suoi capelli, ch 'e rano d ' un rosso a rden te . Aveva cominciato a dar grattacapi fin da bambino con la sua cagionevole salute. Una volta lo cura rono col vino, e gliene p rop ina rono tanto che non volle mai più berne . Fu la sua unica astinenza.
Aveva debut ta to come capo di squadracce scugnizze dedite a ogni sorta di vandalismi ed era stato il t e r ro re dei suoi maestri di scuola. Poi d ' improvviso gli era scoppiata in corpo u n a g ran voglia d ' impa ra re , di leggere e sopra t tu t to di scrivere. A sedici anni but tò giù un piano di lavoro da riempir la vita di dieci letterati longevi: c'era den t ro la traduzione di tu t to O m e r o , di tu t to Tacito, d i tu t to P inda ro , saggi critici, alcuni poemi, un canzoniere. Il suo professore, l'abate Dalmis t ro , diceva: «Non so se da ques to sopraffat tore ver rà fuori un genio o un avventuriero». Come se fra l 'uno e l 'altro ci fosse incompatibilità.
Si e ra i n n a m o r a t o p r ima ancora di sapere di chi. I l suo cassetto era gremi to di lettere appassionate in attesa di dest inataria, e occasioni di utilizzarle n o n gliene m a n c a r o n o mai . U n a s ignora molto ospitale, Isabella Teotochi Marin,
352
mezzo greca anche lei, e moglie di un g rande «notabile» della Serenissima, sentì par lare di questo ragazzo-prodigio, ne lesse alcuni scampoli pubblicati su u n a rivista locale, e lo invitò nel suo salotto. Privo di qualsiasi «uso di mondo», Ugo vi si sentì impacciato e a disagio. Ma la p a d r o n a di casa capì che qualcosa covava sotto quella selvatica scorza e volle scopr i r lo : a Ietto, n a t u r a l m e n t e . Fu investita da una colata di lava, sommersa non solo da baci e carezze, ma anche da sfuriate di gelosia, lettere di pen t imento , odi e sonetti. Un giorno, accorso al solito a p p u n t a m e n t o , Ugo si sentì d i re dal camer i e r e che la s ignora era par t i ta in viaggio di nozze e gli aveva lasciato u n a le t tera . In essa Isabella gli diceva che , avendo o t tenuto il divorzio dal mari to , aveva sposato un alt ro , e t e rminava con ques te pa ro le : «Cogli il favore delle d o n n e come i f iori delle stagioni. Va' mio ragazzo. Te ' un bacio: n o n mi g iurar fedeltà, ch'io né credo né lo voglio».
Ugo corse a casa, prese un pugna le , ma lo r ipose, come gli capi terà anche altre volte. Si uccise invece un suo comp a g n o di scuola fr iulano, J a c o p o Ort is , senza lasciare u n a lettera né u n a parola di spiegazione. Quell 'episodio Io colpì p ro fondamente , r e n d e n d o ancora più cupa la disperazione in cui era precipi tato. Cercò sfogo nella politica, la cui aria in quel m o m e n t o si met teva a t empes ta . Si par lava di un esercito francese in marcia su Milano al comando di un giovanissimo Genera le còrso, a rmato n o n soltanto di cannoni , ma anche d ' idee di libertà e di uguaglianza. Ugo disse subito la sua, ch 'era a p p u n t o la libertà e l 'eguaglianza, e la disse così forte che l 'a r res tarono e d o p o il rilascio gli consigliarono di anda re a p r e n d e r aria altrove. Andò sui colli Euganei , e fu lì che compose il Tieste.
Il successo n o n l 'ubriacò. Più che u o m o di teatro o di lettere , si sentiva u o m o d 'azione, e pe r agire corse là dove si poteva, nella Repubblica cispadana appena formata, pe r arruolarsi nel suo esercito come cacciatore a cavallo. In tasca aveva, pe r farne d o n o alla città di Reggio, l'Ode a Bonaparte liberatore, che ora si p repa rava a l iberare anche Venezia. Vi
353
accorse pe r collaborare all ' impresa e assumervi il suo posto, e la sua voce r isuonò n o n soltanto dal palcoscenico su cui si recitava la sua t ragedia . Il pod io del t r i buno conveniva al suo t emperamen to . Per tut ta la sua vita, Foscolo n o n seppe mai discutere e t a n t o m e n o conversare , ma solo p red ica re , anzi schiamazzare , a l t e r n a n d o i toni della p e r o r a z i o n e a quelli dell'invettiva. Ne fece le spese anche Alfieri, di cui era stato fin allora il più sperticato esaltatore e cui aveva dedicato il Tieste, ma che u l t i m a m e n t e aveva ch iamato i francesi «pidocchiume». Foscolo chiese che i suoi d r a m m i fossero bandi t i , che fossero chiusi i circoli dei nobili, che le s tatue dei Dogi reazionari venissero da te alle f iamme. Tut to questo gli valse l 'inclusione nella lista dei par lamentar i da inviare a Mombello pe r t rat tare con Bonapar te , o meglio pe r riceverne gli ordini . Ci a n d ò t r ep idando come incontro a un Messia. Ne to rnò deluso dal piglio satrapesco del Genera le e dall 'aria di baldoria che regnava in torno a lui. E gli avveniment i che segui rono n o n furono di cer to tali da farlo ric rede re . Invece di l iberarla, Napo leone aveva v e n d u t o col t ra t ta to di Campoformio Venezia all 'Austria, e i reazionar i po tevano prenders i la loro vendetta.
Per sfuggirvi, a Foscolo non rimase che la fuga a Milano. Vi trovò Monti, che aveva già incontrato e di cui era diventato amico a Venezia. Monti e ra nei guai. La sua Bassvillia-na, il ca rme in cui quat t ro anni p r ima aveva esaltato il massacro del diplomatico francese Basseville a Roma, aveva corso l'Italia e lo rendeva inviso al nuovo regime repubblicano e giacobino. Ma in compenso poteva contare su una moglie che, p u r r iempiendolo di corna, al mari to e alla sua carr iera ci teneva: Teresa Pikler. Accorta amministratr ice dei p rop r i mezzi di seduz ione , c h ' e r a n o cospicui , si e ra scelto come aman te un colonnello francese dest inato alla feluca di Maresciallo, M a r m o n t . Ma a d i fendere il poe ta minacciato di epuraz ione fu anche Foscolo, e pe r gli stessi motivi del colonnello. Appena conosciutala, anche lui si era innamora to di Teresa al suo solito m o d o tempestoso e delirante. Ma Te-
354
resa, sebbene un po ' somigliasse a Isabella, non ne aveva la vocazione di nave-scuola. Teneva Ugo a mezza co t tura coi suoi adescament i pe r r ipagar lo delle sue perorazioni in favore del mari to, ma le grazie le riservava a corteggiatori più altolocati, e quindi più utili, di quel ragazzo ventenne pieno di talento, ma senza arte né par te .
Ugo cercava consolazione nel lavoro e nella compagn ia dei let terati . Scriveva nel Monitore articoli ispirati a un patriottismo enfatico, ma non privi di qualche lucida intuizione, ed era diventato inseparabile del vecchio Parini, sebbene con lui n o n avesse p ropr io nulla in comune . Ma ogni poco tornava da Teresa a ossessionarla con d rammat iche suppliche o d i spera t i silenzi. Forse, p iù che a m o r e , e ra a m o r p ropr io ferito da quell 'ostinato rifiuto. Dopo averlo più volte minacciato, ar r ivò al suicidio i n g e r e n d o u n a dose d 'oppio abbastanza forte pe r addo rmen ta r s i , ma n o n pe r sempre . Invece di commuoversene , Teresa se ne vantò coi suoi amici che ne fecero ogge t to di e p i g r a m m i e corbe l la tu re . Era t roppo . Ugo r u p p e con tut to e con tutti, anche con Milano, e si trasferì a Bologna con armi e bagaglio, che si r iduceva a un po ' di b iancher ia , a Tacito, a Plu tarco e alla sua collezione di lettere d ' amore in attesa di destinataria.
Bologna era allora la capitale della Repubblica cispadana n o n ancora fusa con la Cisalpina. Ugo trovò un piccolo impiego in u n o dei tanti uffici in formazione, e si bu t tò a capofitto nella s tesura di un r o m a n z o che aveva già iniziato: Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Il n o m e dice quale episodio gliene avesse suggerito l'idea. Ma a fargliela ma tu ra r e era stata la let tura del Giovane Werther, che forniva il modello a quella generazione di romantici «disadattati» cui egli stesso apparteneva, o credeva di appar t ene re . Nessuno sa per quali motivi il vero Jacopo si fosse ucciso. Ma a Foscolo fu facile attribuirgli i suoi di pa t r io ta e di a m a n t e deluso. Quel J a c o p o , cavaliere e r ran te di un tradito ideale di patria e di giustizia, respinto dal l 'amore, reietto dalla società, somigliava a lui, o a ciò che lui credeva di essere.
355
Ma n o n po tè c o n d u r r e a t e r m i n e i l lavoro, r i ch iamato dall 'azione politica e militare. Partito Bonapar te pe r l'Egitto, gli austriaci e rano scesi alla controffensiva e di lagavano in Italia. Il tenente Foscolo tornò a indossare la sua divisa di Cacciatore, combat té in Romagna , cadde pr igioniero, fu libera to dai francesi, e li seguì p r ima a Firenze, poi a Genova, dove essi fecero quadra to e lui con loro. Partecipò con onore ad alcuni combat t iment i , fu p romosso cap i tano , ma ritrovò Teresa rifugiatasi lì anche lei insieme al mari to, e ci ricascò fino a t en ta re u n a seconda volta il suicidio, ma semp r e con le solite cautele di dosaggio. Di mor i re rischiò veramente nello scontro dei Due Fratelli, dove le sue gesta furono citate nel l 'ordine del g iorno dal generale Masséna. Dopo il r i torno di Napoleone a Marengo, riéccolo a Milano addetto allo stato maggiore del generale Pino, che lo spedì in missione a Firenze.
Per lui, Firenze era soprat tut to Alfieri che da molti anni vi si e ra ritirato con la D'Albany, e con cui si e ra idealmente riconciliato d o p o le invettive di Venezia. A n d ò a renderg l i omaggio, ma non fu ricevuto: «irato ai patri i numi», il vate si era chiuso nella più sdegnosa solitudine. Da ch iunque alt ro gli fosse venuto , Foscolo n o n avrebbe soppor ta to un simile affronto. Da lui lo accettò, e aveva ragione: Alfieri era il suo vero padre , il capostipite della famiglia a cui appar teneva. Per consolarsi , girovagava fra le t ombe di Machiavelli, Michelangelo e Galileo, ma in un intervallo di queste funebri scor r ibande inc iampò in Isabella Roncioni, e fu pe r lui un 'ennes ima cotta.
Di famiglia nobile e ricca, Isabella e ra a p p e n a uscita di collegio, sognava l 'amore con l'A maiuscola, e nessuno era qualificato a incarnar lo più di questo giovane ufficiale n o n bello, anzi f rancamente bru t to col suo viso un po ' scimmiesco; ma vibrante, intenso, esclamativo e d rammat ico . Tutto s i svolse in un roman t i co intreccio d ' incont r i n o t t u r n i , di mure t t i scavalcati, di travestimenti , di snervanti attese dentro le siepi del giardino, e si ridusse a qualche bacio furtivo,
356
ma conquistato a tale prezzo da appaga re più di un amplesso. Fu con un s u p r e m o sforzo che Ugo dovet te i n t e r p o r r e una pausa pe r accorrere a Bologna, dove l 'editore gli aveva pubbl icato a t r a d i m e n t o , d a n d o l o pe r concluso, l 'abbozzo dell'Ortis, e in d u e edizioni diversamente r imaneggiate: u n a pe r con ten ta re gli austriaci, q u a n d o e r ano arrivati nel '99, l'altra pe r contentare i francesi, q u a n d o e rano tornat i dopo Marengo.
I l povero edi tore si vide i r r o m p e r e addosso un energum e n o con la sciabola sguainata che gl ' ingiunse di distruggere sedu ta s tan te tu t t e le copie giacenti in magazz ino e di pubblicare nei giornali di Firenze e di Bologna u n a dichiarazione in cui riconosceva che il romanzo s tampato n o n corr i spondeva a l testo, r iman ipo la to «da un prezzola to che convert ì le le t tere calde, originali , i taliane del l 'Ort is in un centone di follie romanzesche, di frasi adul tera te e di annotazioni vigliacche». Dopodiché, col manoscri t to sotto il braccio, Foscolo r ip rese la via di F i renze , dove lo a t t endeva la notizia che Isabella era stata fidanzata d 'autori tà a un conte Bar to lommei , mol to m e n o a t t rezzato di lui alla p a r t e d i amante , ma molto di più a quella di mari to .
Era un d r a m m a del tutto d e g n o del suo sventurato eroe, con cui egli si sentì ancora più spinto a identificarsi. A Milano, dove to rnò subito dopo , si rimise al lavoro sul brogliaccio, lo disfece, lo rifece. Ma bisognava vivere, e gli s t ipendi di Capi tano n o n arr ivavano. La sua protes ta fu vibrata: «E infame che colui che contribuì in gran par te alla vittoria dei Due Fratelli, senza di che Genova era p e r d u t a né l'Italia forse liberata...», e sembrava insomma che a liberarla fosse stato lui col secondario contr ibuto di Napoleone . Ma gli a r re trati li ebbe, e con essi ebbe m o d o di r i en t ra re nel «giro» e di f requentare la Scala.
Fu qui che vide Antonie t ta Fagnani Arese, già famosa a ventitré anni n o n soltanto pe r la sua bellezza, ma anche pe r lo sfrut tamento intensivo che ne aveva fatto. Probabi lmente era u n a frigida, ma che sapeva reci tare la sua pa r t e : tutti i
357
giovani più in vista di Milano cadevano nelle reti di questa Circe, e forse fu anche questo a stimolarlo. N o n ebbe pace finché n o n le fu presentata , e a fargli questa grazia fu Teresa Pikler, forse p e r risarcirlo. Antonie t ta gradì l ' impetuosa cor te di quel lo spas imante così d iverso dagli altri , ma re spinse n e t t a m e n t e le sue p re t e se di m o n o p o l i o . U go la soffocava. Q u a n d o non era da lei, era fuori della sua por ta a spiare chi la varcava. La bombardava di let tere, fino t re al giorno gliene scriveva: «Un anno , un solo anno di solitudine insieme con te!» Antonietta ne dava pubblica le t tura agli amici che l 'aiutavano a r i spondere perché , in fatto di sintassi, e ra piut tosto malsicura. Era d iventa to la favola di Milano , ma n o n se n 'accorgeva, o n o n g l ien ' impor tava . Fu in quest 'atmosfera del tut to congeniale al suo eroe che ma tu rò la seconda edizione del romanzo che uscì nel 1802, e fu u n o s t repi toso successo. Da quel m o m e n t o egli fu, pe r tu t te le d o n n e , J acopo Ortis, e come Jacopo Ortis era giusto, tut to sommato , che soffrisse.
Antoniet ta seppe farla d u r a r e a lungo, r iat t izzando cont inuamente la passione di lui con la gelosia. Ugo era malato, o meglio più malato del solito perché un po ' lo era sempre: soffriva di qualcosa ai reni che ogni g iorno gli dava la febbre , e forse era anche questo che contribuiva a esasperare i suoi sent iment i e passioni. Anche pe r distrarsi, giuocava, e q u a n d o gli capi tava di vincere cor reva a c o m p r a r e abiti e cavalli. Data la fama che gli aveva procura to il romanzo , gli o rd ina rono l 'orazione a Bonapar te che i delegati di Milano si r ipromet tevano di leggere ai Comizi di Lione dove sarebbe stata p roc lamata la Repubbl ica i taliana. Avevano scelto male. Pur con tutti i suoi difetti, Foscolo n o n era un Monti p ron to a sciogliere inni e a scampanare elogi al p a d r o n e di t u rno . Ci si provò. Impiegò mesi, lui scrittore di vena zampillante e rullante, a redigere quel testo che gli era diventato addi r i t tu ra un incubo. Ma n o n riuscì a essere servile. La sua oraz ione a Lione n o n fu letta, ma fu letta dai milanesi che se la passavano da l l 'uno all 'altro, e tutti vi r iconobbero
358
la m a n o di un u o m o libero, quale Foscolo era, in un Paese di cort igiani . Alla fine, d o p o scenate e bu r r a sche , t rovò la forza di l iberarsi anche di Antoniet ta . Ad epitaffio, scrisse: «Fu l 'amore più laido della mia vita». Ma non aveva che venticinque anni .
Per disincagliarsi da Milano, dove n o n poteva più vedersi, chiese a Melzi d'Eril un posto di diplomatico a Parigi o a Firenze, ma non l 'ot tenne. O t t enne solo di esser r ichiamato come cap i tano e m a n d a t o col con t ingen te italico a Valenciennes, dove Napo leone stava raccogl iendo l 'esercito pe r t en ta re lo sbarco in Inghi l te r ra . N o n c 'e rano molte distrazioni, a Valenciennes . Ma c 'era u n a colonia d ' inglesi che , sorpresi in Francia dalla guer ra , e rano stati confinati lì. Foscolo diventò subito amico di u n o di loro, i l maggiore Hamilton, titolare di un comodo villino, di u n a moglie e di una figlia, Fanny. Non era bella, e ra anzi un po ' sbiadita, ma in quei paraggi n o n c 'era di meglio, e Foscolo n o n era u o m o da r inunziare a u n a donna , specie se si accorgeva di esercitare su di essa del fascino, e su Fanny egli ne esercitava visibi lmente moltissimo. Q u a n d o di lì a d u e mesi fu trasferito a Calais, la ragazza gli scrisse ch 'e ra incinta. Ugo rispose, in carat tere con la sua magnanimità , che avrebbe fatto fronte, ma poi se ne dimenticò. Fanny riuscì a r imedia re t rovando un altro mari to , e affidando la creatura a sua madre . Foscolo era le mille miglia dal l ' immaginare che nella sua vita essa avrebbe contato qualcosa.
A Calais e po i a Bou logne ebbe ancora al t re avven tu re con mogli e figlie degli ufficiali francesi. Nessuna d o n n a riusciva a passare accanto a questo bru t to u o m o senza sentirsi tu rba ta dai suoi veement i mono logh i e dai suoi procellosi silenzi. Nel 1806, q u a n d o Bonapar t e ebbe defini t ivamente r inunzia to a invadere l ' Inghil terra , r i en t rò a Milano carico di lettere e di ciocche di capelli, e corse a Venezia a salutare la mad re , che n o n vedeva da nove anni . Pianse di tenerezza fra le braccia di quel la pove ra d o n n a incanut i ta , che soppor tava con dignitoso coraggio la sua solitudine e povertà .
359
Essa gli disse che Isabella Teotochi , o r a contessa Albrizzi, aveva saputo del suo arr ivo e voleva rivederlo. Anche lui voleva r ivederla , e corse da lei, convinto di t rovare un rottame . No. Sebbene avesse già quaran taqua t t ro anni , e ra ancora bella. Le propose una visita al Terraglio, la fastosa villa di cui il nuovo mari to l'aveva fatta pad rona . Ci anda rono , passeggiarono per i vialetti tenendosi pe r m a n o e fecero l 'amore come dieci anni pr ima, su una p roda .
Ques to poscr i t to fu l 'unico suo a m o r e p lac ido e senza tempeste , e d u r ò d u e mesi. Poi dovette r i en t ra re a Milano, b e n deciso a concen t ra r s i u n i c a m e n t e sui suoi lavori e a mettervi un po ' d 'ordine. Pur in mezzo a tutti quei tramestìi aveva sempre cont inuato a p r o d u r r e , ma in maniera dispersiva e sommaria, m a n d a n d o avanti parecchie cose alla volta secondo gli estri e gli u m o r i : lavori di e rud iz ione come la Chioma di Berenice e il Didimo Chierico, di t raduzione come il Viaggio sentimentale di Sterne, l 'abbozzo di un romanzo autobiografico. Foscolo n o n aveva u n a p r e p a r a z i o n e cul tura le organica e p ro fonda . Le sue le t ture e r ano state molte , ma frettolose, e si possono desumere dal suo stile che fin allora le aveva r iecheggia te un po ' tu t te : P lu tarco , Petrarca , Ossian, Alfieri sono riconoscibilissimi. Forse egli sentiva che , pe r diventare se stesso, aveva bisogno di assimilare e decantare tutti questi e lementi . Si mise a tavolino, scrisse / Sepolcri, e corse a Brescia dallo s t ampa to re Bet toni pe r pubblicarli.
Ques t ' uomo disordinato, che scriveva q u a n d o e dove gli capitava e spesso perdeva i suoi brogliacci, q u a n d o si trattava di s tampa era meticoloso fino alla manìa, una vera disperazione pe r i tipografi. N o n aveva t empo per gli amici e gli ammira tor i locali che lo avevano festosamente accolto, non ne ebbe n e m m e n o p e r accorgersi della contessa Marzia Mart inengo, la star di Brescia. Ma, tornato a Milano d o p o la pubblicazione del carme, ci r ipensò. Il lavoro riscosse gran successo pe rché ribadiva l ' immagine ormai accreditata, e allora di gran moda , del magni loquente poeta delle tombe. E
360
sulle ali di questo successo to rnò a Brescia pe r farsi p e r d o nare da Marzia la sua distrazione. Essa non chiedeva di meglio.
Anche ques to fu un a m o r e abbastanza placido che n o n turbò il suo accresciuto impegno di lavoro. O r a gli era nata in corpo u n a nuova ambizione: la ca t tedra universi taria, e tanto fece che la o t tenne, a Pavia. Convinto che quello fosse il suo definitivo destino («Ho varcato i t rent 'anni , e bisogna ch'io pensi alla quiete e alle lettere»), s 'indebitò fino al collo p e r mettervi su una casa comoda insieme all 'amico Monte-vecchio, un ricco signore marchigiano che faceva lo s tudente di professione. Per la pro lus ione , cui aveva lavorato pe r mesi, aveva invitato tut te le maggiori personalità di Milano, meno quelle ufficiali. C'era anche Monti, che gli aveva raccomandato : «Aggiungi un cenno che ape r t amen te tocchi le laudi del Principe», cioè di Napoleone e del viceré Eugenio. Ma Foscolo ignorò vo lu tamente l 'uno e l 'altro, e forse n o n fu ques ta l 'u l t ima r ag ione de l l ' immenso successo che ripor tò . Part icolarmente entusiasti, i giovani gr idarono: «Alle s t ampe , alle stampe!» E l ' au tore consent ì . «Il Pr incipe, ti r accomando il Principe!» insistè Monti che, da vero letterato italiano, n o n poteva concepire u n o scritto senza cortigianer ie . Ma neanche stavolta Foscolo l'ascoltò. Se lo guidasse un amore di libertà o non piuttosto un'orgogliosa e proter va affermazione del p r o p r i o io di stile alfieriano, è difficile dire. C o m u n q u e , poco dopo la cat tedra venne soppressa, e lui si r i trovò ancora u n a volta sul lastrico e con tut te le spese della casa da r i fondere ai creditori.
Que i p r imi mesi del 1809 furono dur i , anche sul p i ano sen t imenta le . Ca rezzando v a g a m e n t e p ropos i t i m a t r i m o niali, aveva messo gli occhi addosso alla figlia del conte Gio-vio, Cecchina, ma nello stesso t e m p o aveva teso le reti alla bella mogl ie d ' u n banch ie re , M a d d a l e n a Bignami , che c i s'impigliò volentieri . Anche pe r un pol igamo di quella forza, e ra difficile far fronte c o n t e m p o r a n e a m e n t e a tanti impegni , molto più che non aveva ancora disdet to quelli con
361
Isabella a Venezia e con Marzia a Brescia. Per tenerle a bada, le inondava di let tere, e n o n si capisce dove trovasse il t e m p o di scr iverne tan te . Forse pescava nel vasto archivio accumulato nella p r ima adolescenza.
Ma sop ravvenne u n a compl icaz ione , cui U go n o n e ra abi tuato. Fin lì, anche se n o n aveva s empre avuto la m a n o felice nello scegliersi le amanti , l'aveva avuta sempre felicissima nello scegliersi i mariti delle amant i , che n o n lo avevano mai impor tuna to . Ma il banchiere trovò da r id i rne , e lo disse così forte che Maddalena tentò di suicidarsi. Al d ramma sent imentale si aggiunsero quelli let terari . Un diverbio di salotto con Monti sfociò in u n a violenta polemica sui giornali, in cui Foscolo riuscì a t irarsi addosso tu t ta la cu l tu ra accademica italiana. Al pericoloso a t taccabr ighe n o n e r a n r imast i fedeli che pochi giovani e sop ra t t u t t o u n o venu to apposta da Torino pe r conoscerlo e fargli g ra tu i tamente da segretario: Silvio Pellico.
L'occasione di sfogarsi, fu Ugo stesso a offrirla ai suoi nemici, m e t t e n d o in scena la sua seconda t ragedia , LAjace. L'attesa era tale che il lavoro venne rappresen ta to alla Scala e migliaia di pe r sone furono respinte pe r mancanza di posti. C 'e ra tu t to il gove rno , c 'era tu t to il senato , c 'era tu t ta l'alta società, c 'erano le falangi della gioventù foscoliana impazienti di app laud i re il loro ba rdo , ma c 'erano anche le sue vittime, Monti alla testa, che speravano in un suo passo falso. E lo aveva fatto. Alla fine dei pr imi tre atti, i fedeli trascina rono all 'applauso la platea. Ma gli altri due , lenti e prolissi, caddero fra sbadigli, r isatine e motteggi . A t rar dai guai lo sfortunato autore provvidero le autori tà vietando ulteriori rappresentazioni , e ne avevano di che: l 'unica cosa buona dell'Ajace e r a n o le scoper te e poco lus ingh ie re allusioni a N a p o l e o n e i m p e r s o n a t o in A g a m e n n o n e . E così l ' au tore , bocciato come trageda, si p rendeva la sua rivincita come vitt ima della persecuzione.
A n d ò a r i t empra r s i p e r qua lche mese a Venezia da sua m a d r e e da Isabella, poi si trasferì a Firenze sempre trasci-
362
nandosi dietro una lunga coda di litigi, di duelli e di debiti. E anche lì le d o n n e gli furono subito in torno come falene a un lume , at t rat te dalla fama n o n soltanto dei suoi libri, ma anche delle sue passioni e dei suoi scandali. Stupisce di t rovare fra di esse u n a c rea tura senza debolezze intellettuali e m o n d a n e come Qu i r ina Magiotti Mocenni , u n a tipica terr iera toscana più fattoressa che dama , avvezza a t ra t tar coi contad in i di viti e d'olivi. N o n era bella, n o n faceva nul la p e r s embra r lo , e Foscolo la cor teggiò sol tanto p e r c h é e ra amica della D'Albany, la vedova di Alfieri. Essa Io amò n o n p e r c h é e r a Foscolo, ma sebbene lo fosse: fu l 'unico u o m o della sua vita, e lo fu pe r sempre .
Firenze r app re sen tò la sua stagione alcionica, anche come poeta. Fu qui che compose il più e il meglio del suo capolavoro lirico, Le Grazie, un canto finalmente sottovoce in cui zampilla la sua vena più sincera, quella che non ha bisogno di forzare i toni e schiamazzare. Era diventato il cent ro del salotto D'Albany, che a sua volta era il cen t ro della società colta fiorentina e italiana. La p r e p o t e n t e e invadente Contessa aveva preso a protegger lo r i t rovando in lui molto del suo Alfieri. Secondava le sue debolezze di narciso facendolo r i t ra r re dal pi t tore Fabre ch 'era anche il suo amante e but tandogl i fra le braccia le più belle d o n n e di Firenze perché Qu i r i na , n a t u r a l m e n t e , n o n gli bastava. Q u i r i n a sopportava senza proteste le sue infedeltà, provvedeva alla sua biancheria, gli pagava i debiti, lo curava q u a n d o era malato - e lo era spesso -, subiva i suoi scoppi di collera e le sue cris i d ' i pocondr i a . Ugo n o n aveva un soldo, ma ques to n o n g l ' impediva di t e n e r e casa, servitù, cavallo e u n o scelto g u a r d a r o b a p e r c h é , tu t to s o m m a t o , e ra un dandy. Nelle conversazioni di salotto teneva banco, ma guai a chi disturbava i suoi monologhi . Alla min ima contraddizione, dava in escandescenze, s t rappava il fazzoletto, si mordeva le mani , imprecava, minacciava, se ne andava sbat tendo la porta . Ma i fiorentini lo avevano capi to, lo lasciavano fare e alle sue provocazioni r i spondevano con inviti. Lo lasciava fare an-
363
che la g randuchessa Elisa Baciocchi, sorella di Napo leone , sebbene egli seguitasse a fare la f ronda ai regimi francesi. Ma era Foscolo.
Si prec ip i tò a Milano q u a n d o gli g iunse notizia che la censura aveva fermato la sua nuova t ragedia Ricciardo. Era ìa più bru t ta delle t re che aveva composto, sebbene anche le altre d u e valessero poco. Ma lui era convinto che questo fosse il suo capolavoro, e tanto fece che, con qualche taglio, riuscì a farla accettare. L'opera venne data a Bologna, e cadde. Ugo to rnò a Firenze immuson i to , ma n o n soltanto del f iasco. Era la fine del '12, e dalla Russia cominciavano ad arrivare le p r ime notizie del gran disastro. Uno dei suoi più cari amici era caduto a Smolensk e, p u r con tut to il suo odio pe r Napoleone , Foscolo cominciava a sentirsi un imboscato. «Che faccio io qui? come mentirò? con chi mentirò?» scriveva a una delle sue tante amant i col suo abituale accento di sincero bug ia rdo . E più tardi , a un amico: «La mia Dulcinea è l 'Italia, e ques ta donchisciot tesca pass ione di pa t r ia n o n mi lascia tanto b u o n senso che basti a ragionar placidamente: ogni passo degli austriaci verso il Regno mi calpesta le ali del cuore».
La D'Albany, che amava Foscolo anche pe r il suo antina-poleonismo, e ra ind ignata di questo «tradimento». Ma Foscolo non l'ascoltava più. L'antinapoleonismo di coloro che, come i l Monti , f in al lora n o n avevano fatto che o s a n n a r e Napoleone trionfante e ora gii sputavano addosso perché lo vedevano sconfitto, lo nauseava. Rispose alla Contessa: «Tir a n n o era, e sarebbe in ogni evento incorreggibi lmente tir anno , questo nostro conquistatore; era, con pensieri sublimi, d ' an imo volgarissimo; bugiardo inut i lmente, gazzettiere e droghiere universale, ciarlatano anche quand ' e ra onnipotente. Ma egli aveva un altissimo meri to presso di me: aveva riuniti e educati alla gue r ra sei milioni d'italiani». E lui era e si sentiva, nel m o m e n t o del pericolo, u n o di questi.
Rientrò di furia a Milano, chiese e o t tenne l 'onore di rivestire la sua divisa di capitano e, nonostante la sua vecchia
364
ant ipat ia pe r il viceré Eugenio , spinse i suoi amici a stringersi in torno a lui pe r l 'estrema difesa del Regno Italico. Le m a n o v r e , le cong iu re , le rivalità che d i sunivano il m o n d o milanese e ne minavano la volontà di resistenza, lo disgustarono . Il 20 aprile del '14 si trovò coinvolto in u n a dimostrazione di folla imbestialita. Era quella che dava l'assalto alla casa del ministro Prina. Coraggiosamente, r ischiando il linciaggio, cercò di s t rappare la vittima dalle mani di quei forsennati , e gli a n d ò bene che si limitassero a immobilizzarlo con u n a corda . Chiamò a raccolta in to rno a sé Pellico e gli al tr i pochi su cui po teva ancora con ta re p e r o rgan izzare bande part igiane in Valtellina e nel Bergamasco, visto che il governo, invece di mobilitare l'esercito, lo aveva consegnato nelle caserme pe r lasciarlo in balìa degli austriaci. Di sua iniziativa, a n d ò a par la re col genera le Macfarlane pe r sollecit a rne l ' appoggio inglese. Non o t t enne nulla. O t t e n n e solo che il gove rno provvisorio, pe r disfarsi di lui, gli affidasse u n a vaga missione a Bologna, d o n d e lo r ichiamò a cose fatte, cioè subito d o p o la res taurazione del dominio austriaco sul Lombardo-Veneto.
I suoi sogni d'italiano e ran finiti: Dulcinea lo aveva tradito. Si trasse in d ispar te r ifugiandosi nella le t te ra tura . Non aveva più voglia di veder nessuno, e nessuno aveva più voglia di veder lui. Nessuno , m e n o il genera le austr iaco Fic-quelmont , che un giorno lo convocò non soltanto per conoscerlo, ma anche pe r offrirgli la direzione di un nuovo giornale. Colto di sorpresa, Foscolo chiese t empo per riflettere. Era chiaro che volevano servirsi del suo n o m e pe r accreditare il nuovo regime presso la pubblica opinione; ma la proposta era allettante. Rimase in forse quan to gli bastò pe r accorgersi che già quell ' indecisione bastava a farlo passare pe r t radi tore agli occhi di molti, fra cui anche Confalonieri. Invece di to rnare da Ficquelmont, chiamò Pellico, gli affidò le sue carte, e u n a notte di marzo del 1815 traversò clandestin a m e n t e la front iera svizzera sp ingendos i avanti un mulo carico di bagaglio.
365
1
In Svizzera, dove na tu ra lmente gl'italiani dissero ch 'era stata l 'Austria a m a n d a r l o come spia, r imase un a n n o , lo impiegò a scrivere una satira, LTpercalisse, che moltiplicò i suoi nemici - e Dio sa se ne aveva bisogno -, e a impazzire diet ro u n a d o n n a ancora più pazza di lui, Veronica Ròmer, moglie del banchiere italiano Pestalozzi. Brut ta e diabolica, essa gli dava in let tura le let tere di un altro suo amante . Foscolo lo sfidò a duello. Poi, esasperato, denunziò la tresca al mari to, che non ci credette. Foscolo gli chiese pe rdono . Lo chiese a Veronica. Poi lo chiese anche a Quir ina, raccontandole pe r filo e per segno la poco edificante faccenda e foscolianamente concludendo: «La frenetica febbre del mio cieco r imorso d u r ò pe r l ' appun to ot to giorni , da u n a domenica all 'altra. O r a sono io, io in tu t ta la forza n a t u r a l e : verace e severo giudice di me stesso; non pe rò avvilito: anzi r incuorato a seguire con piede fermo il corso della mia vita».
Q u e s t o corso lo conduceva in I n g h i l t e r r a p r o p r i o nel m o m e n t o in cui dal l ' Inghi l terra partiva pe r l'Italia il suo vero fratello: Giorgio Byron . I d u e Paesi si scambiavano se n o n i loro più g rand i poeti , certo i loro più grandi «posatori», che infatti s ' incontrarono sul lago di Ginevra, ma n o n si conobbero né r iconobbero. C'era anche, in quei paraggi , la signora De Staél, ma lo scontroso Foscolo non volle vederla e p rosegu ì . Aveva chiesto a Q u i r i n a di r a g g i u n g e r l o e di sposarlo, ma la saggia fattoressa ebbe il buon senso di vincere la tentazione: «Vivi senza inquie tudine alcuna, e ad ogni tuo bisogno n o n t i d iment icare che mi hai chiamata madre , sorella, figlia e amica. Questi titoli fanno la mia gloria: sono sacri al mio cuore e ne vado superba. Addio, mio figlio, mio fratello, mio amico, addio!» Mai smise di scrivergli e di aiutarlo.
A L o n d r a ebbe subito un posto a tavola in casa Holland, il più brillante e cosmopolita convegno di tutto il Gotha politico e cul turale . C 'era Wellington, il vincitore di Napoleone , c 'era i l p r i m o min is t ro Cas t le reagh, c ' e rano Greville, Russell, Campbel l , H o b h o u s e . C 'era i l Manzon i inglese,
366
Walter Scott, che fu l 'unico a de tes t a re l 'ospite i ta l iano «brut to come un b a b b u i n o che, q u a n d o par la , s embra un porco a cui taglino la gola». Non aveva tutt i i torti pe rché , tra quei suoi flemmatici e misurati amici, Foscolo si sentì in dovere di accentuare la p ropr ia teatralità. Si dimenava, urlava, predicava nel suo pessimo inglese, e u n a volta pe r poco non p r o c u r ò un coccolone al vecchio Wordsworth afferrandolo in una discussione pe r il collo. Ma gl'inglesi, che da un inglese non avrebbero mai tollerato simili scompostezze, da un italiano le accettavano come nota di «colore». Trovavano quel forsennato «talmente or iginale che riesce ad esserlo anche q u a n d o se Io p ropone» . E na tu ra lmen te , come sempre , le più entusiaste e rano le d o n n e che però , a differenza delle italiane, si scaldavano al suo fuoco senza lasciarsene incendiare .
Ma bisognava anche vivere, e questo era meno facile. Fin lì, gli aiuti dall ' I talia n o n gli e r a n o mancat i . Suo fratello si e ra r idot to al verde pe r rifornirlo e anche gli amici più poveri gli avevano m a n d a t o il loro obolo. Foscolo n o n era un parassita, ma n o n aveva nessun senso del d e n a r o e n o n si dava nessun pens iero neanche di quello degli altri. «In Inghil terra - scriveva - la povertà è vergogna che nessun merito lava». E lui, per n o n macchiarsene, arricchiva il guardaroba e si man teneva anche un cavallo con cui r incorreva le car rozze delle s ignore . U n ' i m p o r t a n t e rivista gli commissionò una serie di lettere, ora conosciuta come Gazzettino del bel mondo, u n o dei suoi migliori scampoli di p rosa pe r t rasparenza e levità. Ma at tendeva anche ad opere più serie come i saggi su Dante, Petrarca e Boccaccio e quello sulla lett e ra tu ra italiana c o n t e m p o r a n e a , che comparve con la f i rma di Hobhouse , ma in cui tutti r iconobbero la sua furia polemica, i suoi amor i e sop ra t t u t t o i suoi odi , che na tu ra l mente gliene valsero molti anche a lui. Sulle proposte di altri lavori che gli piovvero da tutte le parti , egli n o n si limitò a costruire un castello di sogni, volle anche realizzarlo affittando addir i t tura una villa, r iempiendola di mobili pregiati
367
1 e oggetti d 'ar te , e tenendovi mensa imbandi ta pe r tutti gl'italiani di passaggio. Ci venne Capponi , cui Foscolo d iede il p i ano del g iorna le che avrebbe dovu to fare con Ficquel-m o n t e che poi, por ta to a Firenze, servì di modello all'Antologia di Vieusseux. E ci venne anche Confalonieri fingendosi pent i to dei sospetti nutr i t i su di lui. In realtà seguitava a detestarlo e, r ient ra to a Milano, contr ibuì a diffondere malevoli voci sul suo conto. Il t e r r eno era ricettivo perché , nel suo saggio sulla le t te ra tura c o n t e m p o r a n e a , Foscolo aveva offeso tut t i e specia lmente il Mont i che lo accusava di «di-sprezzantropia». Non p o t e n d o più dire ch 'era al soldo dell'Austria, dicevano che si era venduto al governo inglese, lo attaccavano su tutti i giornali, e Ugo non r ispondeva. Aveva da pensare a ben altro: alle cambiali in scadenza.
Fu a questa svolta che s ' imbattè in u n a vecchia s ignora che viveva in u n a villetta poco dis tante dalla sua insieme a u n a nipot ina , e il cui n o m e gli r icordava qualcosa: Hamil ton. Era la m a d r e della ragazza ch'egli aveva lasciato incinta a Valenciennes, e quel la n ipo t ina , Flor iana, e ra sua figlia. La n o n n a che aveva provveduto ad allevarla doveva essere p ropr io di b u o n carat tere pe rché non solo n o n gli t enne i l b ronc io , ma anzi lo accolse af fe t tuosamente e, siccome si sentiva vicina alla fine, accettò la sua p ropos ta di affidargli la bambina con la relativa dote: tremila sterline.
N o n era , n e a n c h e a quei t empi , un g ran capitale. Ma a Foscolo parve immenso . E q u a n d o , di lì a poco, ne ebbe la disponibi l i tà , decise d i mol t ipl icar lo con un b u o n investim e n t o immobiliare. C o m p r ò un t e r reno in u n a zona che gli sembrava di sicuro avvenire, e ci costruì n o n u n a villa, ma tre: u n a pe r viverci con Floriana, le altre d u e pe r affittarle. Disse che a lui bastavano tredici stanze e tre cameriste, che furono u n a d o p o l'altra anche sue amant i . Ma ai mobili p re giati e alle ope re d 'ar te non r inunciò. Q u a n d o Floriana venne a insediarvisi, trovò la casa già assediata dai creditori .
Cominciò, pe r Foscolo, una disperata ed eroica lotta contro la miseria. Gli editori, che se n 'erano accorti, lo prendeva-
368
no alla gola ord inandogl i le fatiche più ingrate e dimezzandogliene la retribuzione. Per Foscolo, che non aveva mai saputo lavorare su ordinativo, era u n a dannazione rovinosa per i suoi nervi. A scrivere di cose che non lo interessavano faticava, e si sentiva. Più la sua prosa si faceva rugginosa , p iù le commissioni si d i radavano, più si appesant ivano i debiti. Gli por ta rono via il ter reno, le case, i mobili. Riuscì a salvare solo i suoi libri e il pianoforte di Floriana, diventata la sua unica consolazione. La povera ragazza si era affezionata a quel pad re tormenta to e tormentoso, lo seguiva senza protestare da un trasferimento all'altro in appar tament i sempre più squallidi in quartieri sempre più miserabili. Gl'italiani che venivano a visitarlo dovevano faticare pe r scovarlo, e spesso lo trovavano a letto o su u n a poltrona che seguiva con sguardo assente i motivi che Floriana gli suonava. Aveva passato di poco la quaran t ina , ma già aveva perso quasi tutti i dent i , l'oftalmia lo rendeva mezzo cieco, e ai disturbi renali che lo avevano sempre afflitto se n 'e rano aggiunti altri di fegato e di vescica. Andavano a tenergli compagnia i d u e protagonisti dei moti del ' 21 , il napoletano Pepe e il torinese Santarosa insieme agli altri scampati: Pecchio, Ugoni, Scalvini. Sebbene tutti in miseria, por t avano a Floriana cibi e piccoli sussidi p e r le medicine. Qualche volta Foscolo n o n si accorgeva n e m m e n o della loro presenza, qualche altra li ar r ingava nei soliti toni concitati b r a n d e n d o , alla min ima obbiezione, la pistola che teneva sempre, carica, sul comodino da notte. Q u a n d o le forze glielo consentivano, ridiventava prepoten te . Trovò modo di sfidare un giornalista inglese a un duello che poteva essere mortale: pistola, venendosi incontro a volontà. Sparò pr ima il suo avversario, e fallì. Foscolo gli andò sotto il viso, e sparò in aria: un gesto in tutto degno di lui.
Ma coi c redi tor i n o n poteva fare a l t re t tan to . Dopo u n a not te passata a tavolino, Floriana lo vedeva par t i r e all'alba coi suoi scartafacci alla r icerca di qualche r edaz ione in cui collocarli. Un g iorno n o n to rnò : e ra finito in p r ig ione pe r debiti. Gli amici italiani venne ro a t u r n o a po r t a re scodelle
369
di minestra alla ragazza, che sfioriva a vista d'occhio. Un alt ro g iorno apparve su un giornale un annunz io pubblicitario: il s ignor Foscolo offriva lezioni d ' i tal iano, anche fuori Londra , a due scellini l 'ora. A questo si era r idotto. Eppure , seguitava a litigare con tutti: anche con Byron, pe r lettera. Ma q u a n d o questi morì in Grecia, Foscolo fu sopraffatto dal r imorso e propose a un edi tore un saggio apologetico su di lui. Q u a n d o ebbe consumato gli ultimi vestiti e le ultime calze di seta, fece p e r d e r e a tutti le sue tracce nascondendos i in un tugur io e iscrivendo sulla por ta un n o m e falso.
Trascorse gli ultimi mesi a descrivere a Floriana il meraviglioso viaggio che insieme avrebbero fatto a Venezia, a Firenze, a Zante, e la bella casa che li aspettava in riva al mare, ombra t a di pini e di cipressi. Ci sarebbero state camere pe r tutti gli amici: p e r Santarosa (ch 'era mor to in Grecia), per Pellico (che languiva nello Spielberg). Il colpo di grazia glielo det te la proposta , poi ritrattata, di u n a cat tedra d'italiano all 'Università. Si mise a letto, e i medici dissero: «Idropisia». Fino al l 'u l t imo segui tò a p a r l a r e del meravigl ioso viaggio, e q u a n d o capì ch ' e ra la fine chiese a Flor iana di ap r i re la finestra per lasciar en t ra re un raggio di sole. Sulla scrivania c'era un tes tamento di sei r ighe: «Cara figlia, il dena ro è pagato. Lasciane L. 50 al nostro amico, sig. Roberts, pe rché r imborsi se stesso e pagh i qualche conto dovuto . E conserva i l reso p e r te. Tuo padre» . Era i l 16 se t t embre 1827. Foscolo n o n aveva ancora c o m p i u t o c inquan t ' ann i . Della bri l lante società m o n d a n a e intellettuale che lo aveva così festosamente accolto al suo arrivo, nessuno seguì la sua bara che fu sepolta sotto una n u d a pietra nel piccolo cimitero di Chiswick. Solo un paio di set t imane dopo , la Litlerary chronicle gli dedicò questa necrologia: «Mentre l 'Europa ammira le opere dell 'esule, la sua tomba mostri che nel nostro Paese vi sono alcuni che riverivano il suo ingegno, anche se dep loravano gli e r ror i della sua vita privata. Ora tali error i n o n sono più , e solo al suo genio noi i n t e n d i a m o offrire questo tenue segno di rispetto».
370
In Italia i segni furono ancora più tenui , tant 'è vero che Quir ina seppe della morte di Ugo solo d o p o qualche mese. Essa aveva s e m p r e con t inua to a scrivergli, ma lui da ann i n o n le r ispondeva. Solo all 'ult imo aveva scarabocchiato un biglietto per lei, ma non gliel'aveva manda to . Essa si rivolse al canonico spagnolo Riego, che si era preso cura di Floriana , p e r c h é le affidasse la ragazza. Ma anche Flor iana era morta , consunta dall'etisìa.
L'oblìo di Foscolo d u r ò quanto la rassegnazione degl'italiani alla situazione, politica e letteraria, contro cui Foscolo si e ra d i s o r d i n a t a m e n t e , ma v igorosamente ba t tu to . La gene ra zione che ridiscese nelle catacombe della congiura pe r p re p a r a r e il '48 e il '59, lo r iscopr ì . Lo r iscopr ì a m o d o suo p r e n d e n d o n e ciò che più le serviva e che non era di certo il suo meglio: l'enfatiche Odi, il melenso e convenzionale Ortis, le t ragedie alfieriane, insomma Io s tentoreo vate, il magniloquente e retorico t r ibuno. E logico. Era questo il Foscolo di cui gl'italiani avevano bisogno, ed è a questo che Mazzini rese omaggio q u a n d o , g iunto esule a Lond r a , corse a inginocchiarsi sulla sua tomba.
I l poe ta , pe r r ivivere, dovet te aspe t ta re che le passioni decantassero. Esso è tutto o soprat tut to nelle Grazie, dove il suo urlo si smorza, t ra t tenuto dal p u d o r e . E questo il segreto della loro perfezione tecnica e stilistica. Qui tutti i motivi della sua composita ispirazione, n o n sempre originali e autentici, t rovano una misura perfetta e ragg iungono u n a tersità e castigatezza di l inguaggio cui, nelle sue ope re giovanili, Foscolo non ci aveva abi tuato . La sua vera g r a n d e lirica comincia dove finiscono le sue «pose».
Q u a n t o al prosatore , Foscolo lascia un solo romanzo, natu ra lmente autobiografico: l 'epistolario. C'è di tut to - l 'oro e il similoro, il d r a m m a e il me lodramma, il vero e il falso, la sincerità e la ciarlataneria - perché di tutto c'era in Foscolo. Ma Foscolo c'è.
CAPITOLO TRENTASEIESIMO
LEOPARDI
«Nacqui di famiglia nobile in una città ignobile» scrisse Leopard i . Oggi questa città ignobile, Recanati, r igurgita di targhe dedicate a lui. Ne h a n n o messe dovunque sia passato o si sia seduto, e forse in questa pos tuma devozione c'è anche del r imor so : la provincia i tal iana p r o d i g a s e m p r e ai figli mort i gli omaggi che gli nega da vivi. Finché ci r imase, Leop a r d i a Recanat i fu conosciuto sol tanto come «il figlio del Conte», o peggio ancora «il gobbo», anzi «il gobbo fottuto».
I Leopa rd i appa r t enevano a quella tipica aristocrazia di paese che faceva del n o m e e del rango un 'autent ica religione . Il loro albero genealogico era gremito soprat tut to di Vescovi, nessuno dei quali tut tavia d iventò Card ina le e tan to m e n o Papa. Il palazzo in cui nascevano e morivano, gelido e sussiegoso, sacrificava alla «rappresentanza» qualsiasi comodità: stanze solenni e piene di spifferi, servizi igienici rudimentali , n iente bagni, n iente angoli d'intimità. Di singolare , da ta l'allergia di questo ceto alla cultura, c 'era solo la biblioteca.
Vi sovr intendeva il conte Monaldo , che aveva pe r i libri u n a passione sconfinante nella mania. Ne incettava dovunque potesse, mescolando testi classici e cianfrusaglie. Era un tipico nobile del Settecento. Non si era mai mosso da Recanati, e trovava del tut to natura le che fino a diciott 'anni n o n gli avessero mai consentito di uscire di casa da solo. Vestiva ancora in parrucca , codino, polpe e spada. Alla spada teneva molt iss imo: diceva che , p o r t a n d o l a , si acquista il senso del decoro. Era stato un pessimo amminis t ra tore del suo pat r imon io , n o n p e r diss ipazione, ma p e r incur ia . Lasciava
372
anda re in malora le sue ter re , e la casa era p iena di zii arte-riosclerotici, di servitori in d isarmo e di vecchi pret i chiamati come tu tor i e sopravvissuti ai loro pupill i . Con t ro la volontà dei suoi , aveva sposato u n a ragazza della sua stessa condizione, la marchesa Adelaide Antici, che fu pe r lui «una benedizione divina e un divino castigo».
Q u a n d o si accorse in che condizioni la famiglia versava, essa p re se tu t to in m a n o d e s a u t o r a n d o c o m p l e t a m e n t e i l mari to e regolando la casa con ferrea avarizia. Non ci furono licenziamenti perché gl ' impegni del r ango lo vietavano. Ma q u a n d o i con tad in i le p o r t a v a n o le uova, le misu rava con un anello: se ci passavano, le faceva sostituire con altre p iù grosse . I m p o n e v a a tut t i u n a dieta spa r t ana , calzava scarpe da soldato e por tava s e m p r e lo stesso vestito con le tasche gonfie di chiavi perché in dispensa e in cantina c'entrava solo lei. Tut to era misurato e lesinato, anche la legna per i l caminetto. I l mari to , q u a n d o voleva procurars i un po ' di spiccioli, e ra costret to a r u b a r e e a vende re di soppiat to qualche fiasco di vino o di olio. Non c 'erano eccezioni neanche pe r i figli, che n o n possedet tero mai un balocco e si passavano da l l ' uno all 'al tro gli abiti rivoltati . Giacomo scrisse p iù t a rd i che , q u a n d o u n o di essi s i ammalava (su dodici , gliene mor i rono sette), Adelaide era contenta perché pensava di regalare un angelo a Dio. Per u n o solo si addolorò perché n o n aveva fatto in t e m p o a ricevere il battesimo, e perciò aveva perso il diritto alle ali.
Giacomo nacque nel '98, a sei anni lo vestirono da abatino, e q u a n d o lo po r t a rono in chiesa pe r la p r ima comunione , sua m a d r e en t rò anche lei nel confessionale pe r condivide re col p re te i suoi segreti. Come pr imogeni to , egli sedeva a tavola alla destra del p a d r e che gli tagliava il cibo nel piatto e cont inuò a farlo anche q u a n d o Giacomo aveva venticinque ann i e l 'Italia già lo considerava un g r a n d e poeta . Gli aveva da to come tu to r e quel lo suo, un gesui ta spagnolo , sebbene lo avesse qualificato «assassino dei miei studi». Ma in real tà i l vero tu to re e ra lui che , da q u a n d o e ra stato ri-
373
dotto dalla moglie all ' indigenza, non osava più uscir di casa, e passava la sua giornata in biblioteca. Qui crebbe Giacomo, sotto il vigile sguardo di quel p a d r e a suo m o d o affettuoso, che non dubi tò mai di po te r e di dover fare di lui un altro se stesso: un pedan te e rudi to , zelante suddito del Papa, insomma un vero conte Leopard i .
Il ragazzo lesse di tut to, avidamente e d isordinatamente , anche perché altro non gli era consentito fare: neanche lui, fino alla maggiore età, ebbe il permesso di uscire di casa da solo. Non sapeva nulla di let teratura m o d e r n a perché la biblioteca si fermava al p r imo Settecento. Ma diventò un maestro di metrica latina e greca, sino a compor r e perfette imitazioni dei poeti classici. Unici suoi amici e r a n o il fratello Carlo e la sorella Paolina, venut i al m o n d o subito d o p o di lui. Con la m a d r e n o n aveva che rappor t i disciplinari. Essa n o n s ' interessò mai ai suoi s tudi , che d i sapprovava , né ai suoi successi che sempre le parvero futili. Q u a n d o , d o p o la m o r t e di Giacomo, un a m m i r a t o r e venne a visitarne il palazzo e la compl imentò pe r aver da to alla poesia un tale figlio, essa rispose soltanto: «Dio lo perdoni».
Con le ginocchia coper te da uno scialle di lana per difenders i dal f reddo , curvo su un piccolo desco in un ango lo buio che metteva a d u r a prova i suoi occhi, Giacomo cercava nei libri un'evasione. Del m o n d o esterno, non conosceva che le piccole fette inquadra te dalle finestre di quella casa-p r ig ione . Un g io rno ci vide stagliato un volto di ragazza, Nerina; un altro, quello di Silvia. Ner ina era probabi lmente u n a piccola popolana che in realtà si chiamava Maria Belar-dinelìi; Silvia era cer tamente Teresa, la figlia del cocchiere; ed e n t r a m b e m o r i r o n o giovanissime. Ma nessuno in famiglia ebbe il sospetto che quel ragazzo, ormai in là nell 'adolescenza, covasse sotto la sua aria mansueta , t imorosa e silenziosa, degl ' impulsi . La mora le delle famiglie alla Leopa rd i consisteva ne l l ' ignorare le cose disdicevoli o imbarazzant i . I gno ra rono anche, p u r avendolo tutto il giorno sotto gli occhi, che a furia di stare reclinata sul desco, la spina dorsale
374
del ragazzo si e ra deformata. E q u a n d o lo zio Antici, fratello di Adelaide, scrisse a Monaldo di mandargl i Giacomo a Roma per fargli curare la malformazione, Monaldo rispose indignato che il figlio stava benissimo, era un fiore, e con sublime egoismo aggiungeva che, essendo il suo unico amico, non intendeva privarsene.
Fu u n a t raduzione dell'Eneide che permise a Giacomo di t rovare un contat to col m o n d o . Ne m a n d ò copia, con ossequiose dediche , a t re dei letterati più in vista. Monti e Mai gli r isposero con u n a degnazione n o n priva di riserve; Giordani con u n a lettera piena di calorosi elogi. Giacomo si agg rappò a lui come il naufrago a u n a zattera, lo sommerse di le t tere- f iume, e alla fine lo costr inse a ven i re a Recanat i . Pre te con t ro voglia, d i convinzioni liberali, un po ' r e to re , un po ' enfatico, ma gene roso e p i eno di calore u m a n o , Giordani capì subito la t ragedia di quel ragazzo, e lo istigò a evadere dal suo sordido ambien te familiare. Più tardi Mona ldo accusò G i o r d a n i di aver abusa to dell 'ospital i tà «rubandogl i» il figlio e lo t ra t tò di «miserabile apostata». Dal suo p u n t o di vista, non aveva tutti i torti. Giordani aveva dischiuso a Giacomo insospettati orizzonti facendogli sent ire ancora di p iù la sua condizione di pr igioniero, e lo aveva a tal p u n t o contagia to dei suoi en tus iasmi da ispirargli d u e odi pa t r io t t iche: u n a All'Italia, l 'altra Sopra il monumento di Dante. De Sanctis dice che sotto lo stile artificioso palpita un sen t imento genu ino , ma noi ci p e r m e t t i a m o di dub i t a rne : anzitutto perché al sent imento genuino qualsiasi artificio ripugna , eppoi perché al patr iot t ismo Giacomo si era mostrato fin allora refrattario. Anzi, due anni p r ima aveva composto una dotta orazione sulla «liberazione» delle Marche, cioè sulla res taurazione del dominio papale . Era farina n o n del sacco suo, ma di Monaldo, d 'accordo. Ma, se l 'orecchio non ci tradisce, anche queste due odi e rano farina n o n del sacco suo, ma di Giordani . Tuttavia quelle d u e poesie, pubblicate con l'imprimatur del Papa, corsero l'Italia, esaltarono e furono esaltate da tutti, pe r un pezzo. Carducci dice di esserne
375
stato, da ragazzo, travolto; e i volontari del '59 si arruolavano al gr ido: «In chiesa col Manzoni, alla gue r ra con Leopardi». L'unico che di quegli en tus iasmi n o n si en tus iasmò fu Monaldo, pe r i l quale l'Italia era u n a bestemmia.
Il successo rese Giacomo ancora più impaziente. Nel '19 - e aveva ormai ventun anni - scrisse di nascosto a un amico di casa, a Macerata, di procurargl i un passapor to . Ma questo fu intercettato da Monaldo, che ne fu quasi più sorpreso che costernato. Non riusciva a capacitarsi come un figlio, a cui seguitava a tagliare la ca rne nel pia t to , des iderasse allontanarsi da lui e - peggio ancora - glielo avesse nascosto. Per sua fortuna, non lesse la lettera che Giacomo aveva già scritto pe r congedarsi da lui. Condita delle solite formule di ossequio, e ra una t r e m e n d a requisitoria che ci r icorda quella di Kafka contro suo pad re .
La delus ione lo immerse ancora di p iù nelle sue mestizie, e u n a crisi di oftalmia gliele rese ancora più acute imped e n d o g l i di ce rcare scampo nel lavoro. Ma fu p r o p r i o in questi mesi di disperazione ch'egli m a t u r ò i suoi pr imi autentici componimen t i poetici, gl'Idilli. Egli stesso riconosce di averne derivato e filtrato l 'ispirazione più dalla letteratura che dall 'esperienza diret ta , e Tommaseo paragonava velenosamente quelle poesie a palinsesti screpolati e r imanipolati in cui, sotto la scrit tura fresca, affiora l'antica. C'è del vero. Dagl'Idilli affiora la lirica greca, ma con u n a tersità e lievità degne di Teocrito. Più tardi Leopard i scrisse che aveva mira to esclusivamente alla semplicità e naturalezza, e lo confermano i tormentatissimi manoscrit t i che recano i segni di u n a lotta a oltranza contro il superfluo. Giustamente Momigliano par la della «sublime povertà» del suo vocabolario, r idot to all'essenziale.
Dopo quella p r ima f ior i tura , seguì un altro a n n o di macerazione e di silenzio, ch'egli impiegò a r iempire oltre mille pag ine dello Zibaldone, che ne conta qua t t romi lac inquecento. C r e d o che siano in pochi ad averle lette tu t te senza saltarne nessuna, e noi n o n siamo di questi. Ma chi n o n ne
376
conosce a lmeno le part i essenziali, non p u ò conoscere Leopardi . Più che un diario, lo Zibaldone è una specie di magazzino in cui p e r quindic i a n n i egli stivò di tu t to : i piccoli eventi della sua vita povera di eventi, le fantasie, i proget t i , i sogni, i comment i critici alle ope re sue e altrui, i r icordi , le confessioni, i r impiant i , le cose più g rand i e le cose più misere che gli passavano pe r la testa.
Q u a n d o fu pubblicato, i con temporane i ammi ra rono sopra t tu t to le annotazioni filologiche e filosofiche che lo gremiscono, e ancora u n a volta a dir igere il coro delle lodi fur o n o i pedan t i . Sainte-Beuve, che se n ' in tendeva un po ' di più, vedeva nello Zibaldone il documen to del «gusto» di Leopa rd i , e aveva r ag ione . L e o p a r d i e ra effet t ivamente un g r a n d e f i lo logo , ma n o n fu g r a n d e p e r c h é e ra f i lo logo . Quan to alla filosofia, n o n era il suo pane . Il suo pane era la let teratura. E intendiamoci bene: n o n è che quella dello Zibaldone sia tutta di alto interesse e qualità. In questo monumentale bric-à-brac si t rovano preziose notazioni, scoperte, f r amment i d i genio , i l luminazioni , scintille, pep i t e d ' o ro , ma anche uggiose r ipetizioni , lungaggini , a rgomentaz ion i rugg inose e involu te , goffo l c t t e r a tume , p iagnucol i i , mal riusciti tentativi di satira. Insomma, ci si trova tutto Leopardi: quel lo g r a n d e dei futuri Canti e quel lo med ioc re delle Operette morali, che vi son già tut te con tenu te in nuce, e che avrebbe fatto meglio a lasciare a questo stato embrionale .
L'evasione venne alla fine, nel '22, col consenso di Monaldo, che si rassegnò a lasciarlo anda re a Roma insieme al cognato Antici. Il viaggio in carrozza d u r ò sei giorni. Era la p r ima volta che Giacomo usciva da Recanati e poteva vedere quel m o n d o di cui si sentiva e si mostrava così airsioso. E p p u r e , non lo gua rdò . Mai una volta mise la testa fuor del finestrino p e r scopr i re un paesaggio o a m m i r a r e u n a chiesa. La t e n n e s e m p r e recl inata su un testo greco , d i cui andava chiosando le pagine , del tut to sordo al mistico incanto dell 'Umbria e alla solennità dell 'Agro.
377
Pochi giorni d o p o l 'arr ivo, scrisse al fratello u n a let tera intrisa di delusione. Roma non gli piaceva. In realtà era lui che non era piaciuto a Roma, dove aveva spera to di essere accolto a braccia aper te , adot ta to nei salotti e nelle accademie, e dove invece si era avvisto che pochi lo conoscevano e quei pochi non gli davano molto peso. Voleva incontrar Canova, cui Giordani lo aveva presentato pe r lettera, ma scoprì ch 'era mor to pochi giorni pr ima. Angelo Mai, cui aveva dedicato un ' ode , lo accolse con cortesia, ma n ien te di p iù . II più ospitale fu Cancellieri, «il bell'abate» come lo chiamavano, e rudi to e m o n d a n o , che lo invitò alle sue serate, dove il piccolo provinciale timido, impacciato e deforme, senza punto a l lenamento alla conversazione e alla bat tuta spiritosa, si sentì e mise tutti a disagio. Egli r imase completamente estraneo alla Roma dei grandi palazzi, delle grandi feste e anche della pittoresca plebe, che descriveva Stendhal , il quale vi si trovava anche lui p ropr io nello stesso per iodo. L'unico amico che vi si fece fu u n o s t raniero , l 'ambasciatore di Prussia Niebuhr, il quale a tal pun to lo stimava e amava che ne p ro pose l 'assunzione alla Corte del Papa. Ma per entrarci bisognava o p r e n d e r e i voti, o a l m e n o indossare quella cappa clericale che si chiamava mantelletta. E Giacomo non ne volle sapere . Forse, tut to sommato , cercava solo un pretes to pe r t o rna r sene a Recanati di cui, d o p o averla tanto maledet ta , o ra sentiva la nostalgia: lì, a lmeno , era p u r sempre il conte Leopardi . E infatti, dopo cinque mesi, vi si riaccasò.
Fu allora che scrisse quelle Operette morali in cui si sente benissimo lo sforzo di r iconsiderare la vita e le sue amarezze con sor r iden te distaccò. Ma a p p u n t o pe r ché questo sforzo si sente , n o n è r iusci to. S o r r i d e r e , L e o p a r d i n o n sapeva. Spirito, ironia e scetticismo n o n sono motivi del suo reper torio; e q u a n d o li tenta, ci fa magre figure. Egli n o n conobbe il suo coetaneo Schopenhauer . Ma Schopenhauer conobbe lui, sia p u r e da mor to , e ne d iede la giusta definizione: il poeta del dolore, così come egli stesso ne era il filosofo. Leopard i è tutto lì, e fuori di lì n o n è nulla.
378
A Recanati r imase d u e anni , quant i gli bas tarono pe r rime t t e r s i a covare p ropos i t i di evas ione. A forn i rg l iene il pretes to fu il suo edi tore milanese Stella, che gli p ropose di cu ra re l'Opera omnia di Cicerone. Sebbene il compenso fosse assai m o d e s t o , Giacomo accet tò subi to e p e r s t r ada si fermò a Bologna, che gli p iacque molto pe r la festosità con cui lo accolsero G i o r d a n i e Br ighen t i . Milano invece n o n gli p iacque p u n t o pe rché vi trovò la stessa indifferenza che lo aveva ferito a Roma, tanto che persuase Stella a lasciargli c o n t i n u a r e i l l avoro a Bologna , dove t o r n ò subi to d o p o . N o n sapeva come t i rare avanti pe rché il salario n o n gli bastava n e a n c h e p e r la p e n s i o n e , ma ebbe la v e n t u r a (una delle p o c h e della sua d isavventura t i ss ima vita) di t rova re u n a ex-camer iera di casa sposata a un oste che gli offrì un posto p e r m a n e n t e alla loro mensa . Mona ldo avrebbe rabbrividito all ' idea di un conte Leopard i sfamato dalla cameriera. Ma Giacomo n o n aveva scelta, e il conto lo saldò comp o n e n d o p e r lei u n a poesia , l 'unica poes ia d i L e o p a r d i scritta, diciamo così, «su ordinazione», e p u r t r o p p o anda ta persa. Per combat tere il f reddo, lui che il f reddo lo soffriva molt issimo, lavorava d e n t r o un sacco imbot t i to d i p i u m e , ma a r iscaldarlo e ra sopra t tu t to i l calore u m a n o dei bolognesi. Diede pubblica le t tura di un suo p o e m a all'Accademia dei Felsinei, e d iven tò ospite abi tuale del salotto della contessa Malvezzi, u n a fiorentina diventata «prima signora» di Bologna n o n grazie alle sue b ru t t e poesie - com'essa credeva -, ma al n o m e che por tava e alla vivacità della sua conversazione.
Non era bella. N o n era più neanche molto giovane. Ma era, alla f ine, u n a donna , cosa pe r lui assolutamente nuova. Non si sa se ne fu veramente innamora to . Si sa soltanto che spinse la sua galanteria fino a elogiare pubbl icamente i suoi poemi . Poi, un g iorno , ne fu messo alla por ta . Corse voce che si fosse gettato ai piedi della Contessa e che costei avesse ch iamato i l c amer i e r e p e r o rd ina rg l i un bicchier d ' acqua pe r il signor Conte che si sentiva male. Fatto sta che, t empo
379
dopo , Giacomo scrisse a un amico: «Ho visto il poema della Malvezzi. Povera donna!»
Ancora u n a volta tornò a Recanati, e ancora u n a volta ne fuggì, diretto a Firenze, oramai capitale della cul tura italiana. Vieusseux, che da un pezzo lo aveva scoperto e invitato a collaborare all'Antologia, lo accolse con molta cordialità nel suo Gabinetto, dove tutti s ' incontravano come in un club, senza cerimonie né formalismi.
Ma propr io pe r questo Giacomo si trovò a disagio anche lì. Non era abituato a questo t ipo di rappor t i semplici e diretti fra uomini che si compor tavano come se si conoscessero da s empre anche se e ra la p r ima volta che si vedevano, alle conversazioni franche e aper te , alla schermaglia spiritosa, alle bot te e r isposte. E pe r di p iù c 'era fra di essi il suo morta le nemico Tommaseo che non pe rdeva occasione pe r met tere a d u r a prova la sua impacciata timidezza e suscettibilità. Non perdonava a Leopard i le critiche che questi aveva mosso a una sua t raduzione di Cicerone q u a n d o ne curava le opere da Stella. E ora se ne vendicava accanendosi sulle Operette morali, p r o p r i o allora pubbl icate e che, a d i re il ve ro , ne offrivano mate r ia . Anche d o p o m o r t o segui tò a pe r segu i t a r lo , c o n i a n d o p e r lui ques to epitaffio: «Na tu ra con un p u g n o lo sgobbò - "Canta" , gli disse i rata; ed ei cantò» che d imos t ra quan t a poca miser icordia covasse nel cuore di questo bacchet tone. Ma anche gli altri frequentatori del Gabinetto, come Capponi e Colletta, lo trovavano poco simpatico e inferiore alla sua fama. Q u a n d o venne Manzoni, anche Leopa rd i fu invitato al r icevimento. E rano i d u e più g rand i geni italiani di quel secolo, ma non si r iconobbero e non t rovarono nulla da dirsi. Tanti anni dopo , Manzoni confessò a De Sanctis che n o n riusciva a capire come Leopard i fosse considerato un gran poeta.
Scacciato dalla t r a m o n t a n a e dai sarcasmi di F i renze , Giacomo si trasferì a Pisa dove gode t te u n o dei rar i intermezzi di relativa quiete . Il clima era dolce, e pe r una re t ta di pochi soldi aveva u n a c a m e r a decen te , discreto cibo, e
380
perfino il letto scaldato col «prete». Quella piccola città era molto meglio tagliata sulla sua misura di provinciale, e pe r di più ci trovò una ragazza, Teresa Lucignani, di p u n t a cultura, ma fresca e allegra, che n o n gli concesse nulla, salvo la simpatia. Ancora nella sua tardissima età (campò fin oltre i novant 'anni) , Teresa ricordava con tenerezza quel giovanotto pal l ido e de fo rme , s e m p r e vestito di n e r o , che n o n si cambiava quasi mai la camicia, se la sbrodolava con la cioccolata, e che solo q u a n d o guardava lei riusciva a sorr idere . Fu Teresa a ispirargli // Risorgimento, che non ha nulla a che fare con quel lo del l ' I ta l ia . A r i sorgere e r a il suo cuo re , a contatto di quella creatura piena di gioia di vivere. Sono fra i pochissimi versi n o n dolorosi di Leopard i , e n o n valgono molto.
Tornò a Firenze in estate, e vi fece conoscenza di un giovane p r e t e p i emon tese con cui t rovò i m m e d i a t a m e n t e un cer to conta t to u m a n o : Vincenzo Giobert i . R ipa r t i rono insieme, Gioberti pe r Torino, lui pe r Recanati, dove aveva deciso di ristabilirsi, forse p e r s e m p r e . Ci r i t rovò tu t to come pr ima, Monaldo ansioso di recuperar lo , Adelaide con le sue chiavi, Paolina nella vana attesa di un mari to. Mancava solo quello ch 'e ra stato il suo unico amico, il fratello Carlo, che aveva a b b a n d o n a t o i l te t to pe r fare un ma t r imon io di sua testa. In compenso, ormai poteva uscir di casa da solo, e ne approfit tò pe r fare lunghe passeggiate sui poggi circostanti. Ma sebbene scegliesse i sentieri solitari, qualcuno che gli gridasse dietro: «Gobbo fottuto!» lo trovava sempre , e alla fine si r ifugiò, come p r i m a , fra le solite m u r a della biblioteca. Anzi, a tal p u n t o di misantropia si era r idotto che preferiva p r e n d e r e i pasti da solo, salvo a scrivere nello Zibaldone che questa abi tudine, presso i Greci e i Romani , era considerata segno di «inumanità».
Fu in questo pe r iodo che compose i suoi più bei poemi: Il passero solitario, Le rimembranze, Il canto notturno, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, le ope re insomma che d a n n o la sua vera misura. Ma il successo seguitava a sperar-
381
lo dalle Operette, con cui aveva concorso a un premio bandito dalla Crusca, che fu invece assegnato a un saggio storico del Botta. In compenso gli giunse da Firenze una lettera di Collet ta con u n a p r o p o s t a gene rosa e p iena di ta t to : e ra p ron to pe r lui un assegno mensile che gli avrebbe consentito di vivere d e c e n t e m e n t e . Non avrebbe avuto di che r ingraziarne nessuno perché nessuno sapeva da chi veniva, ed egli stesso ne sarebbe stato l ' inconsapevole t ramite . Giacomo decise di lasciare Recanati , e stavolta pe r s empre . Suo p a d r e n o n era sulla p o r t a a salutarlo, come alle al t re par tenze: aveva capi to ch ' e r a un add io , n o n un a r r ivederc i . Q u e s t ' u o m o che aveva d i s t ru t to suo figlio, e ra a sua volta distrutto dall 'angoscia di pe rder lo .
A Firenze, oltre l 'assegno, trovò Antonio Ranieri , o meglio lo ritrovò, perché già si e r ano incontrati tre anni pr ima, ma solo di sfuggita. Ranier i e ra un giovane napo le t ano di bella p resenza e di b u o n e m a n i e r e , ga r ru lo , e s u b e r a n t e , pass ionale e superficiale, che il g o v e r n o borbon ico aveva m a n d a t o in esilio p e r le sue professioni di fede l iberale. Avendo la for tuna di un babbo ricco, ne aveva approfi t tato pe r compiere lunghi viaggi in Francia, Svizzera e Inghil terra, frequentarvi gente di cul tura e assumerne a lmeno la pàtina. Le condizioni in cui vide L e o p a r d i , più ma landa to e disperato di pr ima, lo commossero al p u n t o che, cedendo a u n o dei suoi soliti slanci, decise di met ter casa con lui p rendendoselo a carico. Così cominciò quella simbiosi che doveva d u r a r e fino alla m o r t e del poe ta e che d i ede la s tura a molte voci malevole.
I l soccorso di Ranier i arr ivava, p e r L e o p a r d i , in b u o n p u n t o . L'assegno che Colletta diceva di r icevere pe r lui da ignoti benefat tor i , veniva invece dalle sue p r o p r i e tasche. Ma egli si aspettava che il poeta a lmeno un po ' se ne sdebitasse aiutandolo a cor reggere la sua Storia di Napoli. Leopardi gliene restituì le bozze senza varianti e dimenticò perfino di mandarg l i in omaggio u n a copia dei suoi Canti che p ro pr io al lora e r a n o stati pubblicat i . E Colletta, il qua le n o n
382
aveva di che scialare e ol t retut to era ser iamente ammalato , cessò il finanziamento. Per Leopard i sarebbe stata una tragedia, se in quel m o m e n t o non si fosse trovato coinvolto in una t ragedia ancora più grossa: l 'amore.
A presen ta r lo a Fanny Targioni Tozzetti era stato un alt ro esule napole tano, Poerio, il quale diceva in u n a lettera a Ranieri che solo delle male l ingue come i fiorentini potevano p r e s t a r e a quel la s ignora qua t t r o a m a n t i c o n t e m p o r a neamente , men t re in realtà e rano solo due . Questo non impediva a Fanny di essere un'eccellente m a d r e e anche, a suo modo , u n a b u o n a moglie, che sapeva secondare le for tune del mar i to , medico e botanico di alto pres t ig io . Era u n a d o n n a piacevole, a t t raente , pe r nulla intellettuale, ma piena di sesso e di gagliardi appetiti , u n a femmina vera, insomma. Leopard i ne fu sconvolto al p u n t o da n o n saper n e m m e n o reggere il segreto della sua passione, e da darla in pasto alla malignità fiorentina. Carducci dice di aver sentito raccontare, tanti anni dopo la mor te del poeta, che questi noleggiava un ragazzo molto somigliante a Fanny, lo vestiva come lei e gli diceva tut to quello che a lei n o n trovava il coraggio di dire. Fu lei la famosa Aspasia. Fu per lei che compose II pensiero dominante, Amore e morte, Consalvo. Essa si mostrò lusingata più della sua passione che dei suoi versi. Lo aizzava, lo teneva a bada, lo chiamava affettuosamente «il mio gobbet-to» e andava a far l ' amore con u n o dei suoi d u e o qua t t ro amant i . A quan to pa re , lo fece anche con Ranieri , sebbene costui fosse in quel m o m e n t o innamora t i s s imo di un ' a l t r a donna , un'at tr ice. Poi, non si sa cosa successe. Forse fu Ranier i che, pe r t r a r r e l 'amico da quello sconvolgimento, gli disse che Fanny si era solo burla ta di lui. Forse fu lei che, alla fine anno ia ta dai pet tegolezzi , lo congedò . Cer to , è che da un g io rno al l 'a l t ro L e o p a r d i cessò nelle sue le t te re d i pa r la r di lei, e alla vicenda pose fine con u n o dei suoi più toccanti e concisi poemi: A se stesso. Tanti anni dopo u n a giovane giornalista, Matilde Serao, a n d ò a t rovare Fanny, ormai vecchia, e le chiese perché aveva rifiutato l 'amore di un
383
così g r ande poeta. Fanny fece una smorfia e rispose: «Puzzava».
Richiamato a Napoli dal padre , ch 'era riuscito a fargli revocare il b a n d o di esilio, Ranier i si condusse app res so il poeta e si accasò con lui e con la p ropr ia sorella Paolina prima a palazzo Cammarota , poi a Capodimonte . La convivenza si rivelò a rdua . Il vecchio Ranieri , che n o n l 'approvava, stringeva i cordoni della borsa, e Leopard i versava in condizioni di nervi da met tere a d u r a prova anche l'amico più devoto. I l d r a m m a sent imentale l'aveva defini t ivamente p ro strato. Soffriva d ' insonnia, di colite e di asma, e viveva insieme nella speranza e nel t e r ro re della mor t e . Cont inuava a far del g iorno not te , com'e ra abi tuato o rmai da tanti anni , p r endeva la p r ima colazione alle c inque del pomer iggio , a buio fuggiva di casa e, siccome n o n aveva mai fame ma era ghio t to , si r i empiva lo s tomaco di sfogliatelle e di gelati . Lanciato al suo inseguimento , Ranier i lo trovava in mezzo al popol ino dei bassi con cui amava mescolarsi forse perché a Napol i , invece di schernir l i , i gobbi li r iver iscono c o m e por tafor tuna . Solo gl 'intellettuali lo corbellavano chiamandolo «O ranavuòt to lo» , il r anocch ie t to , e a p p u n t o perc iò n o n l i f requentava . Ebbe r a p p o r t i solo col vecchio amico Poerio, anche lui to rna to in patria, e col poe ta tedesco von Platen.
Nell 'estate del '36 andò ospite del cognato di Ranieri nella sua Villa della Gines t ra a T o r r e del Greco . C r e d e t t e di aver trovato l 'Eden, si rimise a lavorare e scrisse i suoi d u e ultimi grandi poemi, La ginestra e II tramonto della luna. Poi, come sempre , prese in uggia i suoi ospiti, cominciò a odiarli, volle r ipart i re . Rientrò a Napoli p ropr io q u a n d o vi scoppiava il colera. Le scene che vide p e r le s t rade , i l l u g u b r e grido dei monat t i che le pe rco r revano con le loro carriole: «Chi ha mor t i , li cavi!», lo a t t e r r i rono . L'asma n o n gli dava t r egua . N o n si è mai sapu to se a p rocura rg l ie la fosse la deformazione del torace che p remeva sui bronchi o una forma di allergia dovuta ai suoi devastati nervi. O r a a tutti que-
384
sti ma lann i si a g g i u n g e v a n o un gonfiore di g a m b e che il medico diagnostico come idropisia e le cateratte. Ranieri lo convinse a to rna re a Torre del Greco. Ma q u a n d o la carrozza arr ivò, i l mala to non riuscì ad alzarsi da letto pe r mancanza di fiato. Il poco che gli restava lo usò pe r de t tare all'orecchio di Ranieri , con quella sua voce ch 'e ra s empre stata un bisbiglio, gii ultimi sei versi del Tramonto della luna ancora i ncompiu to . Poi m o r m o r ò : «Non ti vedo più», e il suo cuore cessò di bat tere. Aveva t rentanove anni .
Neanche da mor to ebbe pace. Per far fronte al l 'emergenza di quella spaventosa morìa , l 'ordine era di bruciare i cadaveri. Ranieri dovette mettercela tutta per d imost rare che il suo amico non era mor to di colera e o t tenere il permesso di seppellirlo. I doganier i di Piedigrotta fermarono il funerale, scoperchiarono la bara e, t rovando sul corpo d u e incisioni, a p r i r o n o un ' inchiesta pe r assassinio. Solo grazie alla testimonianza del medico e del pre te , si potè p rocedere alla sepoltura. All'inizio del Novecento l'Italia volle da re al poeta una degna tomba, ma scoprì che l 'umidità si era mangiata la cassa r iducendo in poltiglia legno e ossa. Anche il cranio vi si era sfatto. Anni dopo un p a d r e filippino, Taglialate-la, pubblicò un libro in cui diceva che le esequie di Leopardi e rano state u n a macabra farsa inscenata da Ranieri , che il feretro conteneva solo alcuni vecchi vestiti del poeta, il quale p r ima di mor i re si era confessato e poi era stato bruciato. Questo è comple tamente falso. Di confessarsi, Leopard i non aveva avuto il t empo e n e m m e n o la voglia. Poco t empo prima aveva scritto nello Zibaldone: «Dopo la m o r t e , n o n c'è nulla da sperare».
Ranier i aveva fatto il suo dovere d 'amico sino in fondo. Della mor te del poeta si era affrettato a dar subito notizia a Fanny, a Capponi , a Giordani e a Monaldo. Fanny gli rispose compiangendo non il morto , ma lui. Di Capponi n o n conosciamo la replica. Quel la di Giordan i era p iena di commozione e di r impianto . Q u a n t o a Monaldo, l ' annunzio gli g iunse nel m o m e n t o m e n o o p p o r t u n o : p r o p r i o in quel
385
giorno il figlio Pier Francesco gli era scappato di casa con la f igl ia del cuoco, e pe r u n a se t t imana n o n po tè pensa re ad altro. Poi ord inò dieci messe in sua memor ia e fece divieto a tutti di p ronunc ia rne mai più il nome .
Passarono gli anni . E via via che cresceva la fama di Leopard i , cresceva quella di Ranieri , considerato il suo angelo pro te t tore e consolatore. Ma le cose cambiarono q u a n d o fu pubblicato tut to l'epistolario del poeta. Le lettere degli ultimi anni da Napoli e r ano piene di taglienti critiche ai napoletani e allo stesso Ranieri che appariva in tutt 'al tra luce: fatuo, vanitoso, incapace di affetti profondi . Ranieri , che aveva quasi o t t an t ' ann i , r ispose infuriato con un l ibro di m e morie sul loro sodalizio, da cui vien fuori un Leopard i odioso: querulo , esigente, ipocrita, ingrato e maligno.
Curiosa fine di un'amicizia che aveva perfino autorizzato sospetti di omosessualità, tanto era stata intima. Ma questo e r a il des t ino di Leopa rd i e la condiz ione della sua infelicità: di aver spasimato per tutta la vita d ' amore e di n o n trovarne neanche da mor to . Il p rob lema s'egli sia stato un classico o un romant ico lo lasciamo ai critici, che a quanto pa re n o n lo h a n n o anco ra r isolto. U n a cosa è cer ta : che al suo t e m p o n o n fu c o m p r e s o p e r c h é e ra fuori del suo t e m p o , n o n ne condivise nulla e in nulla se ne lasciò condizionare. Che il Risorgimento lo strumentalizzasse approf i t tando delle sue poesie «d'occasione», le uniche b ru t t e del suo reper torio, composte in un vano sforzo di partecipazione, era logico e perf ino giusto. Ma o rma i ques t ' i nganno n o n ha più ragione d'essere. Leopard i a p p a r t e n n e al Risorgimento solo pe r ragioni anagrafiche. La sua fu u n a costante evasione dalla realtà, u n a fuga nel cielo, del quale egli fu, d o p o Lucrezio, i l p iù g r a n d e can to re , e che n o n ha né pa t r ia , né t empo , né storia.
CAPITOLO TRENTASETTESIMO
I PROMESSI SPOSI
A r i ta rdare il mat r imonio fra Renzo e Lucia non furono soltanto Don Rodr igo e Don Abbondio ; fu anche Alessandro Manzoni, che a dare u n a definitiva conclusione alla loro storia impiegò quasi vent 'anni , dal '21 al '40. Nessun romanzo, c redo, fu mai tan to tribolato. Ma un motivo c'era. L'autore non dovette inventare soltanto una vicenda. Dovette inventare u n a lingua. Questo fu il g rande dono che Manzoni fece agl ' i tal iani . Ecco p e r c h é la pubbl icaz ione del libro fu un g rande evento nazionale che trascendeva il p u r o fatto lettera r io . Ed ecco p e r c h é gli s t ranier i n o n sono mai riusciti a c o m p r e n d e r n e l ' impor tanza e , anche q u a n d o n o n lo dicono, si stupiscono di quella che noi gli a t t r ibuiamo.
Nella vita, Manzoni debut tò con u n a involontaria bugia. All 'anagrafe di Milano, egli venne registrato il 7 marzo 1785 come figlio di Pietro e di Giulia Beccaria. Non poteva essere al t r imenti , visto che Pietro e Giulia e rano mar i to e moglie. Ma dalle t es t imonianze dei c o n t e m p o r a n e i risulta chiaram e n t e che il suo vero p a d r e era Giovanni Verri, i l fratello minore del famoso illuminista, fondatore del Caffè insieme a Cesare Beccaria, p a d r e di Giulia. La re laz ione fra i d u e giovani da tava da p r i m a del m a t r i m o n i o di lei col conte Manzoni. A quanto pare , essi avevano intenzione di legalizzarla, e sarebbe stata la saldatura di d u e dinastie già legate da u n a comunanza di blasone nobiliare, di cul tura e d ' idee. Ma fu p r o p r i o il famoso illuminista, Pietro, che si oppose . Come capo della famiglia, egli si p reoccupava che suo fratello, piuttosto scapestrato e p ieno di debiti, sposasse soprattutto una buona dote, e quella di Giulia non lo era. Così es-
387
sa ripiegò sul conte Manzoni, ma senza i n t e r rompere i suoi rappor t i con Giovanni, e senza che questo provocasse scandalo: la società milanese e ra p iena di tali «combinazioni». Qua t t r ' ann i dopo , q u a n d o Giulia si fece r i t ra r re col bambino dal p i t tore di moda , l 'Appiani, i l q u a d r o finì nella casa del l 'amante, e nessuno trovò da r idirne.
La coppia Manzoni n o n poteva essere peggio assortita: lui gran ga lan tuomo, ma severo, misant ropo, conservatore e bacchet tone, succubo del fratello Monsignore e di cinque sorelle zitelle coi quali conviveva; lei socievole, frivola, curiosa del nuovo, tut ta femminilità e civetteria. E incerto se Pietro sapesse delle sue infedeltà e della vera pa tern i tà del b a m b i n o . C o m u n q u e , n o n ne lasciò mai nul la t r ape l a re . Q u a n d o morì , sebbene lei avesse da un pezzo abbandona to il tetto coniugale, la r icordò nel testamento con parole affettuose e le lasciò d u e collane di d iamant i «in con t rassegno della mia stima e memor ia che le porto».
Giulia n o n lo aveva lasciato pe r Giovanni, ma pe r Carlo Imbonat i , un ricco, raffinato e colto patrizio milanese, con cui era andata a vivere a Parigi. Non si mostrava molto sollecita del b a m b i n o che , d o p o u n a triste infanzia t rascorsa quasi tutta in quel di Lecco - cornice del suo futuro romanzo -, fu messo in un collegio di padr i somaschi p r ima a Me-ra te e poi a L u g a n o . Non dove t t e ro essere a n n i felici p e r Alessandro , de t to L i sandr ino . Sensibilissimo e afflitto da una timidezza che si manifestava in u n a pronunc ia ta balbuzie, il ragazzo si adattava male alla vita gregaria, alle grossolanità e canaglierie dei suoi compagni . L'unico b u o n ricordo che serbò di quei tempi fu quello di un insegnante , Padre Soave, che faceva onore al suo nome , contraddicendovi solo q u a n d o Lisandr ino si ostinava a scrivere con le iniziali minuscole re , impera tore e papa.
Era un riflesso della situazione politica, la cui eco giungeva, sia p u r e attutita, anche in collegio. Mentre Lisandrino si c imentava, senza t r o p p o bril larvi, con Tacito e Virgilio, Napoleone era en t ra to a Milano scacciandone gli austriaci.
388
Quest i cambiament i n o n e r a n o ben visti in casa Manzoni , dove il ragazzo t o r n ò t r e d i c e n n e nel ' 98 . Ma i giovani ne e rano entusiasti, e Lisandrino ne subiva il contagio, pu r senza scaldarsi. Finì gli studi secondari presso i padr i barnabit i del collegio Longone , e s'iscrisse all 'Università di Pavia, ma con poco profitto e senza nulla concludervi.
A vent 'anni , Manzoni era un classico «giovin signore» di s t ampo pa r in i ano . Di media s ta tura , p iut tos to fragile, con un volto delicato e un po ' cavallino, il suo carat tere sembrava scritto negli occhi pa l l idamente cilestri e freddi. F redde e rano le sue maniere , e freddi e rano anche i versi che componeva, come allora era di m o d a fra i giovani, metr icamente ineccepibili, ma in cui c'era più Monti e Parini che Manzoni. A Parini non fece in t e m p o a mostrarl i perché era già mor to . Ma a Monti ne m a n d ò u n o scampolo, e il maestro se ne compiacque, sia p u r e con la solita sufficienza. Frequentava il bel m o n d o accet tandone tutte le convenzioni e uniformandosi al suo costume, meno quello della galanteria. Tutti lo credevano un frigido, ed era invece un sensuale represso, che dal l 'amore si teneva alla larga pe r p a u r a di esserne travolto. I m p e g n i che po tessero c o m p r o m e t t e r l o con d a m e della società n o n ne volle mai . La p r i m a avven tu ra l 'ebbe infatti con un'attrice di giro incontrata sulla strada di Pavia, e fu un amico che dovette cacciarlo a spintoni nella camera della ragazza pe r ché lui n o n osava. La seconda fu u n a camer iera di casa, di cui divise le grazie con un altro amico, e che rimase incinta non si sa bene di chi. Secondo i suoi apologeti, p e r Manzoni fu un terribile caso di coscienza da cui sarebbe na to , pe r espiazione, il poetico personaggio di Lucia. Ma non so da cosa lo d e d u c a n o . Nei fatti, Manzoni fu ben con ten to che la ragazza andasse a nozze con un magg i o r d o m o , né r isulta che si sia mai cu ra to della c r ea tu ra ch'essa mise al m o n d o poco dopo . Era del resto natura le in un 'epoca in cui nelle case della buona società le domestiche venivano scri t turate anche pe r r e n d e r e servigi di alcova ai figli di papà e divezzarli. Di questa vocazione agli amor i an-
389
ciliari e mercenar i , Manzoni fu castigato di lì a poco a Venezia, dove a n d ò da turis ta con u n a sua zia e dove contrasse u n a «ciprigna», cioè u n a malattia venerea a quei tempi molto diffusa. Apprensivo e salutista com'era , ne fu spaventatis-simo; e se n o n amò mai Venezia, è pe rché il r icordo gliene rimase p u r sempre legato a quello dell ' incidente.
Il suo esordio ufficiale di poeta lo fece nel 1802, q u a n d o in un 'antologia di Lomonaco comparve il suo Sonetto per la vita di Dante. O r m a i faceva p a r t e dei circoli le t terar i di cui Milano si era arricchita da q u a n d o vi e rano piovuti gli esuli di tutte le altre par t i d'Italia, ma Alessandro ci stava a m o d o suo, cioè con u n a certa riserva, senza lasciarsi coinvolgere dalle rivalità, risse e polemiche che li dividevano. Come in politica, così anche in let teratura, egli riusciva a non par teggiare, e questo gli permet teva di restare b u o n amico di tutti senza esserlo fino in fondo di nessuno. L'unico con cui spinse p iù a fondo i rappor t i fu Vincenzo Cuoco, cui Melzi aveva affidato la direzione del p iù impor tan te giornale.
Un giorno del 1805 lo raggiunse una lettera di Carlo Im-bonati che lo invitava a Parigi. Alessandro lo aveva visto una volta sola, ma ogni t an to ne riceveva qualche pa ro la affettuosa in calce alle r a re lettere di sua m a d r e . La propos ta lo mise in stato d 'orgasmo. Fin allora aveva sempre vissuto col p a d r e legale che lo trattava, sia p u r e al suo bu rbe ro modo , come un f igl io vero. Ma fra quei tetri Manzoni , lui sangue di Verri e Beccaria n o n si sentiva a suo agio, m e n t r e Parigi gli sorrideva. Disse ch 'era Giulia a invitarvelo, e Pietro n o n mosse obbiezioni . M e n t r e p r e p a r a v a i l bagagl io , r icevette un 'a l t ra le t tera , stavolta di sua m a d r e , che con frasi sconnesse lo supplicava di far presto: Carlo era improvvisamente mor to .
A Parigi trovò u n a povera d o n n a mezzo impazzita di dolore che gli si aggrappò come il naufrago alla zattera. E fra i due cominciò una strana simbiosi al limite del morboso. Rimasta vedova dell 'unico u o m o che avesse veramente amato e a un 'e tà che n o n era ancora la vecchiaia, ma che n o n era
390
n e m m e n o p iù la giovinezza, essa p u n t ò tu t to su quel r i t rovato figliuolo, che a sua volta scopriva in lei n o n soltanto la m a m m a , ma anche la femminili tà. «Io n o n vivo che p e r la mia Giulia» scrisse a un amico, volle ado t t a rne anche il cog n o m e firmandosi Manzon i Beccaria, e compose l 'ode In morte dì Carlo Imbonatì, in cui la commozione p r e n d e finalmen te il sopravvento sullo scrupolo formale dei precedent i accademici componiment i . Preoccupazioni materiali non ne avevano perché Carlo aveva lasciato a Giulia tut to il suo cospicuo pat r imonio , compresa la villa di Brusuglio. I d u e and a r o n o a p r e n d e r n e possesso, ma senza met ter p iede a Milano pe r n o n rinfocolare i pettegolezzi che quel tes tamento aveva suscitato in u n a società che agli adul ter i n o n dava peso, ma all 'eredità sì. E to rnarono subito a Parigi.
Fra gli amici che Carlo vi aveva lasciato c 'erano persone di tut to rispetto come la vedova Condorcet , il poeta Lebrun , il saggista Fauriel, il filosofo Destutt de Tracy. Essi accolsero con mol ta cordial i tà Alessandro e ne a p p r e z z a r o n o l ' ingegno. Per il giovane quei salotti e quelle conversazioni, in cui la cul tura e il garbo si sposavano perfe t tamente , furono u n a scoperta . Con Giulia l'idillio n o n aveva pause . N o n usciva che con lei, n o n frequentava che le persone che lei frequentava, e ra a lei che leggeva le sue poesie via via che le componeva. Del p a d r e si e ra comple tamente dimenticato. A ricordargliene l'esistenza fu soltanto la notizia ch 'era in fin di vita. Alessandro si t rovava in que l m o m e n t o a Brusug l io . M a n d ò a Pie t ro u n a le t te r ina p ro toco l l a re con gli a u g u r i pe r la guar ig ione e la p romessa di u n a visita. C o m e r isposta, ricevette l 'annunzio della sua mor te . Non a n d ò n e m m e no al funerale. E fu il notaio che dovette scomodarsi fino alla villa pe r leggergli il tes tamento di Pietro che lo nominava e rede universale, salvo un piccolo legato alla superst i te sorella.
Anche ad ammogl iar lo provvide Giulia. Essa aveva pensato d a p p r i m a alla figlia dei Destutt, ma poi ebbe notizia di un «partito» ancora più al let tante: u n a s ignor ina Blondel ,
391
figlia di un ricchissimo banch ie re ginevr ino ch 'era stato in r a p p o r t i d'affari con Carlo. Era d 'estrazione borghese e di re l ig ione p ro t e s t an t e . Ma la do te e ra tale da c o m p e n s a r e questi difetti e non si esauriva nel conto in banca: la ragazza, che si chiamava Enrichetta e aveva sedici anni , era anche una collezione di virtù. L'incontro fu combinato a Blevio, in u n a villa della sorella de l l ' Imbona t i . Disc ip l ina tamente , i d u e giovani s ' i nnamora rono subito, e i l f idanzamento n o n d u r ò che tre mesi.
Stavolta Milano reagì . C h e Manzon i n o n fosse f ig l io di suo p a d r e , che n o n fosse a n d a t o n e a n c h e a l suo funera le p u r avendone eredi ta to i l pa t r imonio , che approfit tasse di quello lasciato dal l 'amante di sua madre , passi; ma che sposasse una borghese calvinista secondo il rito evangelico, scegliendosi come test imone un certo Zinammi, ch 'era un p re te sp re ta to : ques to era t r o p p o . Gli sposi ev i t a rono la città che ronzava di chiacchiere come un b u g n o d 'api impazzite, e pa r t i rono pe r il viaggio di nozze p r ima sul lago di Como, poi a Brusuglio, na tu ra lmen te in tre.
Enrichet ta lasciò docilmente nelle man i di Giulia la regìa e accettò, senz 'ombra di gelosia, ch'essa conservasse il suo pr imato nel cuore del f igl io . Non mosse obbiezioni q u a n d o Giulia decise di to rna re a Parigi, e non risulta che mai abbia avuto un moto d ' impazienza pe r quel suo compagno che seguitava a sentirsi p iù figlio di sua m a d r e che mar i to di sua moglie . Tut to questo è più da d o n n a devota che da d o n n a innamora ta . Ma forse pe r Enrichetta, educata secondo la rigida regola calvinista, l ' amore n o n era che devozione. U n a sola volta si ribellò, o p e r meglio dire avrebbe voluto ribellarsi: e fu quando , d o p o la nascita della p r ima bambina , che na tu ra lmente si chiamò Giulia, questa decise di farla battezzare secondo il ri to cattolico. Si rassegnò anche pe rché suo p a d r e la spinse a n o n fa rne un p o m o di discordia , ma ne soffrì.
Sui motivi che spinsero Giulia a insistere tanto p e r quel battesimo, noi abbiamo opinioni un po ' diverse da quelle di
392
quasi tutti i biografi del Manzoni, che li attribuiscono a u n a sua p ro fonda crisi di coscienza. Di p rofondo , in Giulia n o n c'era nulla, salvo l ' amor ma te rno , che del resto le si era risvegliato in corpo solo q u a n d o n o n ne aveva più avuti altri da coltivare. O r a n o n vedeva che pe r gli occhi del figlio, capiva che pe r cu ra r e i suoi interessi n o n soltanto economici ma anche let terar i egli doveva p r ima o poi t o rna re a Milano , e voleva prepararglici un ambiente favorevole r imet tendolo in pace con la Chiesa. Ma p e r ques to ci volevano la consacrazione cattolica del ma t r imonio e la convers ione di Enrichetta.
Na tu r a lmen te Giulia si g u a r d ò bene dal dirglielo. Ma si t irò in casa d u e nuovi amici: u n a vedova svizzera che si e ra a p p u n t o convertita, Angelica Geymuller, e il suo converti tore , l 'abate Degola, pa r t i co la rmente tagliato alla b isogna in q u a n t o giansenis ta , cioè abbas tanza vicino ai p ro tes t an t i . Sottoposta a un vero e p ropr io «lavaggio del cervello», Enrichet ta en t rò nel loro giuoco senz 'avvedersene e ne r imase p ro fondamente turbata . A differenza della suocera, una coscienza religiosa essa l'aveva davvero, da b u o n a calvinista, e l 'abiura le pesava. Ma u n a volta che l'ebbe decisa, essa por tò nella n u o v a fede l ' impegno , lo zelo e il r igore m o r a l e di quella vecchia. Il ma t r imonio r ipa ra to re fu celebrato quasi c o n t e m p o r a n e a m e n t e a quel lo di N a p o l e o n e con Maria Luigia d'Austria nel 1810; e come test imone, Giulia volle il Marescalchi, ambasciatore del Regno Italico a Parigi e sicura garanzia che Milano ne sarebbe stata informata. Le pecorelle smarr i te r ient ravano nel gregge.
A tu t te ques te m a n o v r e si d i rebbe che Alessandro fosse r imasto dappr inc ip io es t raneo , o quasi. Sul p r o b l e m a religioso n o n aveva mai assunto posizioni definite, che del resto n o n s ' intonavano al suo carat tere evasivo. Ma poco alla volta si e ra lasciato anche lui coinvolgere nelle conversazioni fra sua mogl ie e il Degola. Costui p re sen tava la Chiesa in u n a luce assai diversa da quella in cui la presentava monsignor Manzoni, e molto più congeniale a u n o spirito antiset-
393
tario come il suo. Quasi più severe che contro i protestanti , le requisitorie dell 'abate giansenista contro i Gesuiti, le loro teorie sul probabilismo e la riserva mentale e le loro capziose distinzioni fra attritio e contrìtio, a poco a poco cominciarono a interessarlo e infine a turbar lo . Forse cominciava a sent ire la scontentezza di un i m p e g n o poet ico che si esauriva soltanto in p rob lemi di stile e di metrica. Dico «forse» perché siamo nel campo delle m e r e supposizioni. Ma sta di fatto che r i l eggendo il suo ul t imo lavoro, VUrania, se ne spazientì e si r ipromise di n o n scrivere mai più versi come quelli, sebbene il suo consulente e confessore letterario, Fauriel, li avesse molto lodati. Fu a questo p u n t o che a sconvolgerlo sopraggiunse un t rauma.
Un giorno andò con Enrichetta a vedere uno spettacolo p i ro tecn ico all'Etoile. A un cer to p u n t o ci fu u n o scoppio fuori p r o g r a m m a , accompagnato da u n o spaventoso boato e da u n a nuvola di fumo che seminò il panico in mezzo alla folla. Enrichet ta che, di nuovo incinta, e ra in precarie condizioni di salute, fu spazzata via. E Alessandro, anche lui travolto, solo a malapena riuscì a mettersi in salvo den t ro u n a chiesa deser ta . Era quella di San Rocco, in cui ora è affissa u n a lapide che r icorda quell 'episodio «provvidenziale» che avrebbe de te rmina to la conversione di Manzoni. Ma siamo di n u o v o nel campo delle ipotesi, p e r c h é egli n o n confidò mai a nessuno cosa accadde nel suo animo q u a n d o si r i trovò lì den t ro , a t u p p e r t ù col Crocefisso. Solo molti ann i d o p o , alla figlia Vittoria che gliene chiedeva con insistenza, rispose: «Fu la grazia del Signore, ch 'ebbe pietà di me», ma n o n volle a g g i u n g e r e a l t ro . Impress ionab i le com 'e ra , è mol to probabi le che in quel l 'ora di sgomento al Signore si sia rivolto p e r impe t ra rne la salvezza di Enrichetta. Ma credo che sarebbe ingiusto e d iminu t ivo a t t r ibu i re la sua crisi di coscienza a ques to inc idente , che con tu t ta probabi l i tà servì solo a precipitarla. C o m u n q u e , esso r appresen tò , nella sua vita, u n o spartiacque.
Da allora, egli a b b a n d o n ò o t rascurò le vecchie amicizie
394
salottiere, meno Fauriel, pe r sprofondare nella let tura degli autori che Degola gli p roponeva : Kemp , Arnaud , Quesnel , Pascal. Manzoni n o n sapeva molto di f i losofia. Credo che di veri filosofi n o n conoscesse che Kant e Locke. Tuttavia era r imasto influenzato dalle p r e d o m i n a n t i co r ren t i razionalistiche, e il p rob lema che lo assillava era quello di conciliare la ragione con la fede. N o n so se ci sia mai riuscito, e a farm e n e dub i ta re è il fatto ch'egli n o n raggiunse mai la serenità del vero credente . Più che l 'amore, si direbbe che lo dominasse il t imor di Dio. E se n o n trovò la fede, trovò di certo una morale , come d imost rano le r igorose regole del catechismo tu t tora depositato nella cappella di Brusuglio. E non i m p o r t a che n o n le abbia s e m p r e pra t ica te . I m p o r t a solo che n o n smise mai d'ispirarvisi.
Senza sforzo si staccò da Parigi che non gli piaceva più e che soprat tut to più non piaceva né a Giulia né a Enrichetta. Non stava b e n e . Soffriva di u n a di quel le crisi depress ive che pe r tutta la vita n o n smisero mai di tribolarlo. Gli si manifestavano con forme acute di agorafobia che lo r endevano t i tubante davanti al l 'a t traversamento di u n a strada o di una piazza, specie se e rano bagnate, e gli facevano des iderare la quiete della campagna . Forse nelle sue vene riciclava un po ' i l s angue del n o n n o m a t e r n o , Cesare Beccaria. C o m e lui, era attaccatissimo alle gonnelle delle sue donne , casalingo e sensuale: la povera Enrichetta, sebbene fosse u n o scricciolo, passava senza in te r ruz ione da un al la t tamento a u n a gravidanza e ne era ta lmente spossata che a un certo p u n t o dovette in tervenire il confessore pe r r ichiamare Alessandro a un po ' di moderaz ione .
Sulla via del r i torno la coppia rese visita ai suoceri in preda a u n a «smoderatissima collera» pe r l 'abiura della loro figlia. Ma fu un fallimento. L'accoglienza dei Blondel fu agghiacciante, e ad Alessandro non rivolsero neanche la parola. Poi i d u e raggiunsero Brusuglio, dove li avevano precedut i Giulia e u n a lettera di Degola al pa r roco locale, p a d r e Tosi, con tutte le istruzioni pe r il t ra t tamento di quei neòfiti,
395
e specialmente di Alessandro, che si e ra impegna to a mettere la sua p e n n a al servizio della Chiesa. Ci si provò infatti, e pose m a n o a quelle che poi sarebbero diventate le Osservazioni sulla morale cattolica. Ma ci lavorava contro voglia. «Pregate il Signore - scriveva a Degola - che gli piaccia di scuotermi dal mio tepore nel servirlo.» Il fatto è che il suo vero interesse restava la poesia. E fu pe r accordarlo coi suoi nuo vi doveri di converti to che si mise a c o m p o r r e gl'Inni Sacri, a t t i ngendone l ' ispirazione ai g r a n d i Misteri cristiani. Purt r o p p o n o n ce la t rovò e si sente . In ques te poesie ci sono m o k e pregevoli cose: anche un coraggioso rifiuto della mitologia pagana coi suoi convenzionali Dei e le sue rifritte pastorel le . Ma n o n c'è la Poesia, m a l a m e n t e s u r r o g a t a dalla solenni tà o ra tor ia . N o n ebbe ro nessun successo, ma piacquero a Goethe, e non era poco.
O r a la vita dei Manzon i si svolgeva q u i e t a m e n t e , m e t à de l l ' anno a Brusugl io , m e t à a Milano dove finirono p e r compra re la casa di Via Morone . Ma quieti n o n e rano i tempi in quel crepuscolo del dominio napoleonico, e quindi anche del R e g n o Italico. I l B e a u h a r n a i s , t o r n a t o dalla disastrosa c a m p a g n a di Russia, cercava di o rganizzare la resistenza agli austriaci. Ma invece di unirsi in to rno a lui come Foscolo, p u r detestandolo, avrebbe voluto, Milano si era divisa in u n a mir iade di parti t i che si paralizzavano a vicenda e che finirono pe r fare il giuoco dell ' invasore austriaco.
Un po ' pe r p rudenza , un po ' pe r indifferenza, Manzoni si t eneva come al solito in d i spar te . Un g io rno vide scatenarsi , sotto le sue finestre, il putiferio. Era u n ' o r d a di scalm a n a t i che fra g r ida , lazzi e be s t emmie t r a sc inavano p e r s t r ada i rest i s angu ino len t i de l min i s t ro P r ina . Sconvolto da quel la vista, Alessandro c a d d e svenu to sulla po l t rona , pe r parecchi giorni r imase semincosciente, e da quello spaven to n o n riuscì a r iavers i p iù del t u t to . A p p e n a po tè , t o r n ò a rifugiarsi in villa. N o n soppor t ava la violenza, ne aveva o r ro re .
A Milano rimise p iede solo dopo che l'Austria vi ebbe re-
396
s taura to l 'o rd ine , un o rd ine che sapeva di caserma e di cimitero. Per at t i rare le simpatie della città, il maresciallo Bel-l ega rde cercò di r i a n i m a r n e la vita sociale e m o n d a n a , ch 'ebbe i suoi centr i p iù vivi nelle case Belgioioso e Balza-ret t i . Ma la vita cu l tura le appass ì di colpo p e r i l d i r ada r s i degl ' intellettuali che n o n vi t rovavano più ossigeno. Gli austriaci avrebbero preferito assoldarli, e ci r iuscirono col solito Monti e alcuni altri. Ma i meglio, Foscolo in testa, preferir o n o l 'espatrio. Per i l m o m e n t o , l 'unico g r u p p o che r imase uni to fu quello della Cameretta, che faceva capo al poeta dialettale Car lo Porta, e la polizia lo lasciò fare p e r c h é n o n si trattava che di un 'accademia paesana, la cui f ronda n o n andava al di là di qualche bonar ia scurrilità vernacola. Gli altri, i p iù seri (Pellico, Di Breme , Berchet , Borsieri, Gioia) si raccoglievano in to rno ai conti Por ro e Confalonieri , già riconosciuti come i veri capi dell 'opposizione liberale, in attesa di fondare un giornale che fu poi // Conciliatore.
Manzon i pa r t ec ipò a qua lche r i u n i o n e del la Cameretta, ma n o n si legò né a questo né all'altro g r u p p o . N o n sfuggiva tuttavia alle grandi emozioni collettive, anzi il suo fragile sistema nervoso le registrava ampl iandole come un sensibilissimo sismografo, e quella suscitata dalla fuga di Napoleone dal l 'Elba lo contagiò p r o f o n d a m e n t e . Più p e r ragioni u m a n e che politiche, e ra s empre stato un g r a n d e ammira tore del Condot t iero , forse pe rché rappresentava ciò ch'egli avrebbe voluto essere , e quel suo avven tu roso r i t o r n o sul t r ono lo emozionò. Fu in questo stato d ' an imo che seguì le vicende di Mura t in marcia verso la Lombard ia e ne lesse il g lad ia tor io appel lo agl ' i tal iani. I n t e r r o m p e n d o la s tesura del la t r aged ia cui stava l avo rando , Il Conte di Carmagnola, but tò giù, al t ret tanto gladiatorio, un inno di plauso a quell ' impresa: // proclama di Rimini. Ma alla notizia che Mura t , ba t tu to , e ra fuggito e che il tentativo di Napoleone era naufragato a Waterloo, n o n solo r inunziò a pubblicarlo, ma n o n volle neanche tenerselo in casa e lo affidò in busta chiusa all'amico Visconti che lo tenesse in cassaforte. Poco dopo , fos-
397
se effetto del t u r b a m e n t o od al t ro , ebbe u n o sven imen to m e n t r e visitava u n a libreria, e cadde picchiando malamente la testa. N o n e ra la p r i m a volta che gli capitava, e non si è mai saputo con esattezza di che male si trat tasse: probabi l men te e rano lievi attacchi di epilessia dovuti alla sifilide ereditata dal padre .
Si appa r tò ancora di p iù . N o n volle n e m m e n o a n d a r e a sentire la Francesca da Rimini del Pellico che fu il g r ande avven imen to teatrale di quella stagione, forse pe r ché sapeva ch ' e r a sgradi ta , p e r i suoi patr iot t ic i accenti , alle au to r i t à austr iache ormai sa ldamente p a d r o n e del Lombardo-Veneto, e rifiutò di col laborare al Conciliatore f inalmente na to e già alle p rese con la censura . A to rmen ta r lo c 'era anche , e s empre di più, il p a d r e Tosi, che ogni poco gli si presentava col cipiglio del credi tore , a reclamare il promesso lavoro sulla mora le cattolica, che n o n gli riusciva po r t a r e a t e rmine . Lungi dal r i spondere pe r le r ime a quel rozzo pre te , Manzoni tergiversava e cercava scuse, come se si riconoscesse in colpa. E forse fu anche pe r sfuggire a quella persecuzione che decise di t o r n a r e a Parigi con la m a d r e , la mogl ie e i quat t ro figlioletti.
A quan to pa re , la sua intenzione era di stabilircisi definit ivamente , m a l g r a d o le difficoltà che si f r apponevano alla sistemazione di u n a famiglia così numerosa , tant 'è vero che aveva avviato pra t iche p e r la vendi ta sia della casa di città che di Brusuglio. Rivide i vecchi amici, se ne fece di nuovi, soprat tut to giansenisti. Ma d o p o qualche mese fu colto dalla nostalgia e tornò, giusto in t e m p o per trovarsi in mezzo a un altro di quei subbugli che tanto paventava.
Si avvicinavano i moti del ' 2 1 , e la polizia si e ra fatta ancora più sospettosa e vessatoria. // Conciliatore era stato soppresso d o p o pochi mesi di vita, e la città era tutta un rincorrersi di voci. Si diceva ch 'era alle viste u n a rivoluzione organizzata da u n a potent iss ima e misteriosa società segreta, la Carboneria , che pe rò n o n doveva essere tanto segreta e misteriosa, sé tutti ne conoscevano i capi. Si diceva che Confa-
398
lonieri fosse in r a p p o r t i col Pr incipe di Car ignano e che le t r u p p e p iemontes i sarebbero venu te a d a r m a n forte ai r ibelli lombard i . Nel l 'ambiente patr iot t ico molte speranze si e r a n o accese, e come al solito anche Manzoni ne fu contagiato. Q u a n d o gli a n n u n z i a r o n o che Tor ino e r a in m a n o agl'insorti, che il re Vittorio Emanue le aveva abdicato e che il Viceré austriaco di Milano aveva abbandona to di not te la città, la c o m m o z i o n e lo t ravolse e gli de t tò un a l t ro i nno , Marzo 1821, che nei suoi scalpitanti versi riflette la schiettezza dell ' ispirazione. Anzi, stavolta fece anche di più: andò da un Monsignore p e r pe r suader lo a en t r a r e in un fronte patriottico di cui gli aveva parlato Visconti.
Il fallimento del moto , il r i to rno in forze degli austriaci, gli a r res t i de l Maroncel l i , del Pellico, del Confa lonier i , lo p i o m b a r o n o in u n a nuova crisi di panico e di convulsioni. C o n quegli uomin i n o n aveva avuto r appor t i , anzi verso i l Confalonieri n o n nascondeva una profonda antipatia pe r la sua nobilesca alterigia mescolata di a t teggiament i d e m a g o gici e piazzaioli. Ma aveva letto il suo inno ad alcuni amici, qua lcuno dei quali poteva denunz ia r lo ; e già si vedeva anche lui nelle grinfie del Salvotti. Corse di nuovo a Brusuglio e vi si r inchiuse.
L'opera che aveva in lavorazione era u n a nuova tragedia, Adelchi. La in t e r ruppe pe r compor re il famoso 5 Maggio, l'inno in mor t e d i Napo leone , personaggio o rmai t rasmigra to nella Storia; poi to rnò aliAdelchi. Trat tandosi di una tragedia storica, aveva bisogno di documen taz ione , e in ques to egli e r a scrupolosissimo. Sfogliando gli Annali del Mura to r i , trovò u n a sentenza di tr ibunale del Seicento che comminava pene severe a un parroco che si era rifiutato di celebrare un matr imonio. L'episodio era così banale che cer tamente gli sarebbe subito passato di memor ia , se in quel m o m e n t o n o n gli fosse capitato di leggere (o di r i leggere, pe rché forse l'aveva già letto a Parigi) Ylvanoe di Walter Scott, il p ro to t ipo del cosiddet to «romanzo storico». Manzoni n o n aveva mai mostrato predilezione pe r i romanzi , ma quello lo aveva en-
399
tusiasmato. Tuttavia l'idea di scriverne uno anche lui gli mat u r ò in co rpo l en t amen te e p e r successive provocazioni . Sempre pe r documentars i sull'Adelchi, consultò le Cronache milanesi del Ripamonti dove trovò le vicende di suor Virginia di Lejda, la famosa «monaca di Monza». Scrisse d u e capitoli, II curato e Fermo, ch ' e r ano r i spe t t ivamente i r i t rat t i di Don Abbondio e di Renzo Tramagl ino , più un ' in t roduz ione . Riprese e concluse la tragedia. Poi tornò a quei suoi personaggi del Seicento e alle loro vicende, ma con l ' intenzione di farne u n a «cantafavola». Non si ri teneva tagliato pe r il romanzo: «Io sono un uomo impacciato nel cervello e nella lingua» confessava in u n a lettera. Era incerto su tutto, anche sul titolo. Il p r imo abbozzo si chiamò Fermo e Lucia, ed era piuttosto sconnesso pe r ché il p r i m o capitolo, dedica to a un famoso processo con t ro dei pover i diavoli to r tu ra t i e uccisi come «untori», cioè come p ropaga to r i di peste nel l ' ep idemia del 1630, faceva pa r t e a sé, senza fondersi col resto. Ci vollero c inque ann i pe rché il Fermo e Lucia diventasse Gli sposi promessi e poi {promessi sposi.
Ma, se Manzon i s tentava tan to a i m p a d r o n i r s i del ro m a n z o , i l r o m a n z o n o n s tentò p u n t o a i m p a d r o n i r s i di Manzoni, che per la pr ima volta conosceva l 'ebbrezza di un totale abbandono al l 'opera creativa. In questo per iodo egli visse in te ramente calato nei suoi personaggi e nelle loro vicende , e di ogni capitolo che portava a te rmine dava let tura la sera alla madre , alla moglie, al canonico Tosi, al Visconti e al Fauriel, venuto ospite a Brusuglio, anno t ando in margine le loro osservazioni, sugger iment i e censure. Fu rono Tosi e Fauriel che per esempio lo indussero a r i d u r r e e a t t enuare l 'episodio della monaca di Monza, sia p u r e pe r diverse ragioni: l 'uno pe r salvare la Chiesa, l'altro pe r salvare l'equilibrio narrat ivo.
Il romanzo fu pubblicato, come oggi si dice; «a puntate»: i pr imi d u e tomi nel '25 , il terzo nel '27. Manzoni n o n finiva mai di appor t a rv i correz ioni anche sulle bozze di s tampa, che rivelano le sue incertezze, perplessi tà e to rment i . A la-
400
sciarlo insoddisfatto e ra la l ingua che aveva usato. E qui si p o n e un problema su cui ancora n o n si è smesso di litigare, ma spesso con a rgoment i suggeri t i dal campani l i smo, cioè dall'idiozia.
Da secoli, è stato de t to , gl ' i taliani n o n fanno che guar darsi la l ingua. Ma ne h a n n o qualche motivo, e più ancora lo avevano ai t empi di Manzoni . Se la g u a r d a v a n o p e r c h é n o n l 'avevano e ne andavano in cerca. Le ragioni sono abbas tanza ch ia re . L'affermazione del «volgare», cioè del la l ingua parlata , in Italia era stata par t ico larmente difficile e contrastata dal latino, r imasto fino al Seicento la l ingua della Chiesa de l l ' ammin i s t r az ione e del la Giustizia. A n c h e q u a n d o ebbe finalmente vinto la sua battaglia, l 'italiano restò, r i spe t to al la t ino, in u n a posizione suba l t e rna e come afflitto da un complesso d'inferiorità nei suoi confronti: veniva infatti insegnato secondo le regole del lat ino, cioè come u n a l ingua mor t a , e i suoi u t en t i ce rcavano di farselo p e r d o n a r e «latineggiando». Per di più, Paese policentrico, l 'Italia n o n aveva mai avuto u n a capitale come Parigi, che dava il la a tu t to , anche alla l ingua, d e t t a n d o n e il model lo al resto della Francia. Gl'intellettuali che avrebbero dovuto a s sumersene i l compi to e r a n o sparpagl ia t i nelle Cor t i dei vari Comuni , Signorie e Principati , o g n u n a delle quali aveva un suo gergo. Ma, ol tre a questo, e rano manca te le pales t re . Il francese aveva avuto i «salotti», dove cu l tu ra e società s ' incontravano facendo della l ingua colta u n a l ingua di conversaz ione e del la l ingua di conversaz ione u n a lingua colta: ed era questo che la r endeva così esatta, chiara, e legante e na tura le . L'inglese aveva avuto il Par lamento e i clubs: ed era questo che lo r endeva così concreto e prat ico. Gl'italiani n o n avevano avuto che l 'Accademia, dove il dotto pa r lava a l do t to in u n a l ingua convenz iona le , che n o n aveva più nulla a che fare con quella dell 'uso c o m u n e e che cercava di somigliare il più possibile al latino pe rché si vergognava di essere italiano.
Forti della loro super iore tradizione letteraria, i fiorenti
n i
ni cercarono di dare a questa l ingua una specie di Cor te di Cassazione o di Sant'Uffizio: il Vocabolario della Crusca che, iniziato nel 1612 e prosegui to fra roventi polemiche e contestazioni, dopo duecent ' ann i n o n era ancora arrivato a termine . N o n e ra un d iz ionar io , ma u n a cr ip ta d i m u m m i e , che accoglieva i te rmini più arcaici e in disuso solo p e r c h é e rano avallati da qualche f i rma accreditata, r i f iutando con o r r o r e tutti gli appor t i della l ingua vera, quella che si parlava nelle s trade e nelle piazze: il codice insomma di u n a lingua n o n m e n o mor ta del latino. Questo divorzio fra le d u e l ingue n o n era che il riflesso di quello, s empre esistito, fra cul tura e società. La cultura in Italia n o n si è mai considerata al servizio della società, ma solo del po te re e di se stessa.
Facciamo grazia al lettore di tut te le diatribe che ne erano scaturite. Queste d iventarono par t icolarmente aspre fra la fine del Sette e i p r imi del l 'Ottocento, grazie alla nascita di un concorrente : quell'Istituto nazionale di Scienze, Lettere e Arti che, fondato da Bonapar te a Milano come corrispettivo i tal iano dell'Accademia di Francia, si p r o p o n e v a fra gli altri compiti anche quello di met tere ord ine nella l ingua. I letterat i si divisero: da u n a pa r t e i cosiddett i puristi, fedeli alla Crusca, e capi tanat i dal l ' abate veronese Cesari , secondo il quale la l ingua italiana era quella degli scrittori del Trecento e tutto ciò ch 'era venuto d o p o era da but tar via; dall 'altra gl ' innovatori capitanati dal Monti, il quale p re tendeva innovare a d o t t a n d o n o n la l ingua successiva al T recen to , ma quella p receden te , cioè quell '«italiano illustre» che, diceva, era stato pat r imonio di tutto il Paese e non monopol io della Toscana. Era u n a tesi che bat teva p e r r idicolaggine quella del Cesari, cui forniva buon i argoment i pe r r i spondere con ironia che restava tuttavia da spiegare come mai di questa bellissima l ingua non restassero document i e nessuno si ricordasse di averla mai scritta e parlata . In realtà Monti intendeva un 'al t ra cosa: intendeva che l'italiano dovesse restare una lingua non di popolo e per il popolo, ma di dotti per dotti , fabbricata in «aula» e imposta dalla cattedra: ch 'era la
402
posizione tipica del letterato cortigiano come lui, al servizio non del pubblico, ma della «casta».
Ques te pedan tesche risse, che d imos t rano il miserevole livello dei nost r i le t terat i e q u a n t o lon tan i essi fossero da ogni concezione d ' i m p e g n o civile, invece di affrettarla, rita rdavano la nascita di una lingua italiana che tutti gl'italiani potessero scrivere come si parlava e par lare come si scriveva. La signora De Staél, che il nostro Paese l'aveva capito bene , annotava nel suo diario: «Scrivono di storia, di scienza e di filosofia servendosi di una lingua mor ta e artificiale, men t r e i poeti si a t tengono a un gergo classico e classicheggiante, sicché le loro opere non valicano i confini del piccolo g r u p p o di eruditi».
Ma della stessa opin ione era Manzoni che, per aver vissuto lungamente a Parigi e partecipato alla sua «civiltà di salotto», poteva stabilire dei raffronti. Dove trovarla, confidava a Fauriel, una lingua italiana semplice, piana, discorsiva, che tutti potessero capire? Gua rda t e che d o m a n d e doveva porsi un povero scrittore italiano che volesse rivolgersi non più al Pr inc ipe e al l 'Accademia, ma al pubbl ico . Infatt i la sua p r ima idea fu di scrivere il suo r o m a n z o in francese, e fu lo stesso Fauriel a sconsigliarlo pe r for tuna sua e nostra. Ma c e r t a m e n t e sarebbe stata u n a fatica m e n o i m p r o b a d i q u a n t o gli costò i l doverse la inven ta re , quel la l ingua, pescandone e cont ro l landone i vari ingredient i . Fu un autentico t o r m e n t o , di cui offrono u n a patet ica tes t imonianza i tribolatissimi manoscritt i e le minute postille segnate a margine del famoso - e artificioso - vocabolario. Nelle le t ture che sera lmente dava agli amici, ogni pagina, ogni per iodo , ogni pa ro la veniva frugata, r ivol tata e d iba t tu ta , t an to da d a r e l ' impress ione , come ha scritto Cecchi, «che Manzon i abbia lavorato in pubblico, con un mon te di consiglieri, refe-randar i ecc.». Finita la p r ima stesura, essa gli parve infiorata di tali e tant i m o d i gergali l ombard i , che fu colto dalla t en taz ione di disfare tu t to e di rifarlo in dia le t to . Ancora u n a volta fu Fauriel a sconsigliarlo. Ma il p rob lema restava:
403
dove t rovar la , quel la b e n e d e t t a l ingua, che fosse ins ieme tan to co r re t t a e popo la resca da p o t e r s tare , nei d ia loghi , tanto sulla bocca del Cardina l B o r r o m e o che su quella del contadino Renzo?
Fu al lora che Manzon i p e n s ò di «sciacquare i p a n n i in Arno», cioè di a n d a r e a cercarsi quella l ingua a Firenze. È ques to che molti le t terat i l omba rd i n o n gli p e r d o n a n o , e n o n senza qua lche fondatezza. Effet t ivamente, cert i vezzi della parlata toscana (e n o n sempre Manzoni ebbe mano felice nello sceglierli) in bocca agli umili personaggi brianzoli del romanzo , s tonano e fanno r idere : i pann i di Agnese e di Lucia, pe r esempio, si prestavano poco a quel bucato. Ma il p rob lema , p e r Manzoni , n o n era d i t rovare un lessico più p u r o , quale c r e d o n o di pa r l a r e i campanil is t i toscani, che non sono più intelligenti di quelli lombardi . Ciò che Firenze offriva e fornì al Manzon i e ra b e n al t ro , e p r o p r i o quel lo che più gli abbisognava e di cui andava affannosamente in cerca: il model lo di u n a l ingua che aveva abolito, o p e r lo m e n o di gran lunga r idot to il divario fra il vocabolario delle pe r sone colte e quello del popolo . E pe r un motivo semplicissimo: che ques ta l ingua n o n era na ta nella Cor te o nell 'Accademia, come in tut to il resto d'Italia, ma nella «fattoria», cioè dal dialogo fra il s ignore e il contad ino . I toscani n o n par lavano e n o n pa r l ano un italiano migliore degli altri; ma quello che par lano, lo par lano tutti, il colto e l'incolto, il nobile, il borghese e l 'artigiano. Fra i vari ceti sociali, a Firenze, c'è sempre stata lotta, ma mai incomunicabilità. Il ca rd ina le B o r r o m e o f iorent ino s ' in tendeva col suo Renzo n o n pe rché parlava il suo dialetto, come a Milano, ma perché Renzo parlava la sua l ingua. E siccome Manzoni aveva bisogno p ropr io di questo, di u n a l ingua che fosse nello stesso t empo del Cardinale e di Renzo, e ne rendesse plausibile la conversaz ione , e r a logico che andasse a cercarsela a Firenze . Lo capì beniss imo i l C a p p o n i che , sc r ivendone al Vieusseux, gli diceva, a proposi to del romanzo: «La g rande quest ione è di sapere se sarà letto: ne dubito un poco, dopo
404
sbollita la p r ima effervescenza; e n o n tanto p e r difetto del Manzoni , quan to pe r difetto della l ingua ch'egli manegg ia s tupendamen te , ma n o n ha ancora (l'avrà) quello stile con-versativo che possa r e n d e r e la l e t tu ra d ' u n l ibro i tal iano agevole quanto quella d ' un libro francese».
L'osservazione era esatta, ma la predizione sbagliata perché l 'effervescenza n o n accennava affatto a sbollire. E se n 'accorse lo stesso Manzon i via via che scendeva verso Firenze in compagn ia della m a d r e , della moglie e di c inque dei suoi sei figlioli. Dovunque si fermassero, veniva r iconosciuto e festeggiato. Alla frontiera del Granduca to un doganiere, d o p o aver visitato il suo passaporto, si mise a recitare a memor ia : «Quel r a m o del lago di Como...» Spogliandosi la sera, Manzoni confidava al cameriere: «Ma chi lo avrebbe det to, q u a n d o mi affaticavo il cervello sopra quella cantafavola, che avrebbe fatto tanto rumore?» Della p r ima edizione si e r ano esaurite in pochi mesi ben nove r is tampe. E questo s t raordinario successo di pubblico dimostra quale sete ci fosse in Italia di libri scritti non più soltanto pe r i dotti , ma pe r tutti i lettori.
A Firenze l'accoglienza fu calorosa. Tutti p resero d'assalto i locali dell'Antologia dove Manzoni fu ricevuto e presentato. Firenze era in quel m o m e n t o la vera capitale culturale d'Italia, e n o n perché alla cul tura desse il maggior contributo. Anzi. Esausta di geni , d o p o Galileo n o n ne aveva p iù prodot t i . Ma il tol lerante reg ime dei Lo rena ne aveva fatto il rifugio di tutti gl'intellettuali che la repressione poliziesca metteva in fuga dagli altri Stati della penisola, consentendole così di s t r appare quel p r imato a Milano che solo d o p o il '60 lo avrebbe recupera to . C 'e rano Mamiani , Niccolini, Ri-dolfi, Ricasoli, Lambrusch in i , T o m m a s e o , Collet ta, Pepe . C 'era anche, in un angolo, Leopard i che andava borbot tando : «Non capisco p e r c h é l ' au to re d i un r o m a n z o che vale così poco debba suscitare tan to interesse». Manzoni , senza borbot ta r lo , pensava lo stesso delle sue poesie. Si s tr insero la m a n o con una cortesia priva di cordialità.
405
Furono , pe r Manzoni , giorni , set t imane, mesi di allegra operos i tà . Mai lo si e ra visto così espansivo e socievole. Si fermava a par lare con tutti pe r far l 'orecchio a certe parole che la Crusca n o n registrava e a certi mod i di d i re che con gioiosa sorpresa coglieva in bocca sia al professore che al fiaccheraio. Voleva sapere di dove venivazro, e segnava tutto sul taccuino. Scriveva Enrichetta a un'amica: «I cambiamenti di l ingua che si p r o p o n e di fare ai Promessi sposi consistono nel l ' inser i re pa ro le e espress ioni che p r o v e n g o n o dal linguaggio vivo dei toscani. Egli è convinto che n o n c'è nessun luogo in Italia dove si p u ò t rovare quello che è la sostanza di tutte le l ingue, ossia l'uso». Manzoni aveva ben capito che ques ta l ingua n o n sa rebbe ro stati i pur is t i della Crusca, e neanche quelli dell'anti-Crusca, a crearla.
Torna to a Milano coi suoi a p p u n t i , si mise a disfare e a rifare il suo testo per le successive edizioni, che seguitavano a esaurirsi u n a d o p o l'altra. E n o n smet terà più fino al '40. Lasciamolo a questo lavoro, e lasciamo agli esperti il compito di valutarne i risultati, raffrontando l 'una all 'altra le varie stesure. Di questi risultati a noi ne interessa u n o solo: gl'italiani finalmente avevano un libro, che tutti coloro che sapevano leggere potevano leggere e in cui t rovavano il modello di u n a l ingua che ancora n o n c'era, ma che i l g iorno in cui ci fosse stata, n o n avrebbe p o t u t o essere che così p e r c h é r a p p r e s e n t a v a i l p iù per fe t to p u n t o di fusione, f in al lora mai raggiunto, fra quella scritta e quella parlata. Ma il libro aveva anche un altro immenso meri to: quello di essersi dato a p ro tagonis ta n o n più l 'Eroe, i l pe rsonaggio d 'eccezione, ma il popolo, il vero popolo, nei suoi scampoli più realistici e consueti. Se siano tutti riusciti e quali lo siano meglio degli altri, anche questo è un giudizio che r imet t iamo ai competenti, tu t tora discordi. Ma pe r la p r ima volta il c o m u n e lettore , che fin allora la l e t t e ra tu ra aulica e cor t ig iana aveva sdegnosamen te escluso, r iconosceva se stesso e i p r o p r i simili negli attori di u n a vicenda, di cui in tal m o d o si sentiva partecipe. Se Manzoni a questo mirasse in coerenza con una
406
sua ben precisa concezione politica, n o n lo sappiamo e non lo crediamo. Oggi c'è chi vuol farlo passare pe r una specie di democrist iano di sinistra, e questo ci sembra ridicolo, anzi lo è senz'altro. Io credo che su questa s t rada l'abbia condotto la sua morale. Manzoni non si proclamò mai giansenista pe rché ciò avrebbe significato u n a ro t tu ra con la Gerarchia, e Manzon i n o n e ra u o m o di r o t t u r e . Ma giansenis ta era, e lo era p ropr io per ragioni morali: basta leggere certe lettere scritte da Parigi al Tosi contro i Gesuiti e il clero faccendiere . La sua «poesia degli umili» nasceva da questa esigenza di evangelico r igore che gl'ispirava, nei confronti della Chiesa t empora le , a t teggiament i più eterodossi di quelli della sua moglie ex-calvinista.
Ecco p e r c h é I promessi sposi furono il p iù g r a n d e evento di questo per iodo, e non soltanto sul p iano letterario. Ottuse come lo sono s e m p r e tu t te le c ensu re , quel la aus t r iaca credet te che il romanzo fosse innocuo perché si svolgeva al t empo della Milano spagnola. Non capì quanto rivoluzionario fosse questo p r imo esempio di una le t teratura che rompeva l 'antica «incomunicabilità» delle regioni e delle classi sociali. N o n crediamo affatto che esageri chi pone Manzoni fra i grandi «padri della patria». Ques t ' uomo pavido, questo ren i ten te alla leva, fu u n o dei maggiori artefici del Risorgimento .
Dopo di allora n o n scrisse quasi p iù nulla, forse pe rché sentiva di non poter anda re più in là di dov 'era arrivato. Ma dove t te ro contr ibuirvi anche le dolorose vicende familiari che pun tegg ia rono il seguito della sua lunga vita. La pr ima a lasciarlo, nel ' 35 , fu Enr ichet ta , d is t ru t ta dalla tisi, e p iù anco ra dalle g rav idanze : gli o t to figli e i t r e abor t i e r a n o t roppi , pe r una d o n n a fragile come lei. I biografi dicono che fu, p e r Manzoni , un colpo mor ta le . E un ' ipotes i lecita, ma che non trova conforto in alcuna testimonianza. Non esistono let tere di Manzoni a sua moglie , sebbene si fosse in un secolo in cui tutti si scrivevano tutto anche vivendo fianco a fianco, né confidenze di lui su di lei. L'unico pubblico omag-
407
gio che le rese fu la dedica dell'Adelchi «alla diletta e venerata sua mogl ie Enr iche t ta Luigia Blondel , la quale ins ieme con le affezioni coniugal i e con la sapienza m a t e r n a po tè serbare un animo verginale»: parole ta lmente convenzionali e di circostanza che non ci pa re di po te rne d e d u r r e nulla, se non a p p u n t o un eccessivo rispetto delle convenzioni. Finito il lutto, si risposò con u n a vedova, Teresa Stampa, quindici a n n i p iù g iovane di lui, c o m e aveva fatto suo n o n n o Beccaria di cui, q u a n d o rimase vedovo, tutti avevano temuto il suicidio.
Della profondità dei suoi affetti, dubi t iamo molto. Sentim e n t a l m e n t e , Manzon i e r a p iu t tos to frigido, c o m e quasi s empre lo sono, anche pe r difesa, i malati di nervi. Ciò ch'egli e i biografi c h i a m a n o «rassegnazione ai voleri di Dio», n o n era forse che un istintivo rifiuto delle commozioni . Una d o p o l 'al tra gli m o r i r o n o q u a t t r o figlie, tu t te s t ronca te a ventisei anni dallo stesso male della madre . I maschi n o n gli de t te ro che dispiaceri e dovet tero con t inuamente r icor rere pe r a iu to di d e n a r o a lui, che quasi s e m p r e glielo negò . Manzoni n o n era avaro, ma e ra convinto di essere sull 'orlo del dissesto e r idot to alla fame con tut t i quei figlioli scapestrati e il mezzo plotone di nipoti che si ritrovava sulle spalle. In realtà avrebbe po tu to benissimo, v e n d e n d o un po ' del suo cospicuo pa t r imonio te r r ie ro , sanare la si tuazione. Ma n o n capiva nul la d i ques te cose, anzi prefer iva ignora r l e , sempre pe r salvaguardare la p ropr ia tranquillità. Per s t rano che oggi possa p a r e r e , I promessi sposi, n o n o s t a n t e il loro e n o r m e successo, n o n gli avevano reso un soldo. La seconda moglie lo convinse ad assumerne in p ropr io la s tampa e la diffusione, e ci rimise ot tantamila lire, cifra pe r quei tempi colossale. N o n l i r e c u p e r ò mai p iù . Solo molt i ann i più tardi , e d o p o u n a lunga causa in t r ibuna le , r iuscirà a farsi da re dall 'editore Lemonn ie r t rentacinquemila lire.
Umanamen te , l 'uomo n o n ispira molte simpatie. Non gli si conoscono bassezze né acredini nei confronti di nessuno, ma neanche slanci di amicizia e di solidarietà. Era dotato di
408
umorismo, ma ne faceva un uso molto modera to pe r la paura di offendere e di crearsi inimicizie. Tutta la sua vita di relazione anche con gl'intimi, forse perfino con la moglie, e ra impron ta ta a u n a cauta diplomazia. E sotto i suoi modi gentili e un po ' untuos i c'era sopra t tu t to la preoccupaz ione di non lasciarsi coinvolgere nelle vicende di quei tempi calamitosi né trascinare in amicizie che potessero met te re in pericolo la sua pace. Per l'Italia e la libertà, fu tra gli uomini che più fecero, ma anche tra quelli che m e n o r ischiarono.
N o n si p u ò fargliene colpa pe rché tut to questo aveva orig ine nel la sua fisiologia, o nella sua pa to logia . Ma n o n si p u ò n e m m e n o esimersi dal constatarlo, anche p e r capire i suoi a t t egg iamen t i nelle successive e m e r g e n z e nazional i . Ques to poe ta che de t te p iù di Alfieri e di Foscolo, e senza mai assumerne le pose gladiatorie e i toni declamatori , fu il vero Vate dell ' I tal ia, lo r i t r o v e r e m o s e m p r e a r ruo l a to nei servizi «ausiliari».
CAPITOLO TRENTOTTESIMO
DE MAISTRE
N o n abb iamo mai capi to p e r c h é nella nos t ra storiografia, sia politica che le t terar ia , i l n o m e di Giuseppe De Maistre n o n figuri, o vi figuri solo di r a d o e di straforo. Forse pe r ché scrisse in francese? Ma in francese scrisse anche Casanova, e p p u r e i diritti di c i t tadinanza n o n gli sono contestat i . Cred iamo quindi che a De Maistre l 'indice sia stato commina to n o n pe r come scrisse, ma pe r ciò che scrisse. Egli r ap presenta l'antitesi dell 'Italia giacobina e carbonara . Ma n o n ci sembra un b u o n motivo pe r epurar lo . Possiamo deplorare ch'egli abbia messo il suo pat r imonio d'intelligenza al servizio d ' u n a causa sbagliata. Ma quel pa t r imon io resta, de gno della più alta ammirazione. L'avesse avuto la Rivoluzione , u n o scrittore come lui! Pu r t roppo , nessuno dei suoi bardi e avvocati seppe mai a rgomenta re le sue verità col vigore polemico, l 'empito lirico, la forza icastica, la tagliente ironia, la m o d e r n i t à di stile e di l inguaggio con cui il reaz ionar io De Maistre a rgomentò i suoi inganni , se tali sono.
Era nato nel '53 a Chambéry, p r i m o di dieci fratelli, ma la sua famiglia era nizzarda. Suo pad re , un magistrato severo in cui s ' incarnavano le migliori quali tà del funzionar io p i emontese , e ra stato fatto Con te e p r e s i d e n t e del Senato della Savoia in r icompensa dei servigi resi. Giuseppe appar teneva qu ind i a quel la n u o v a nobil tà «di toga» che via via r insanguava quella di origine feudale e le impediva di chiudersi in casta. Crebbe in un ambiente mon tana ro e patr iarcale, p r o f o n d a m e n t e legato alle tradizioni, e l ' istruzione la ricevette da dei padr i Gesuiti che dovevano essere di b u o n a qualità perché , invece di covare un anticlericale come molto
410
spesso capita ai preti , formarono in lui u n a coscienza cattolica a prova di bomba . Egli r imase sempre con loro in r ap port i filiali, tanto da contestare con violenza la Bolla con cui Clemente XV soppresse l 'Ordine: e non fu l 'unica volta che si sentì più cattolico del Papa.
A quindici anni en t rò a far pa r te di u n a curiosa associazione det ta dei «penitenti neri», il cui compito era di accomp a g n a r e al pat ibolo, sostenendoli e incoraggiandol i , i condanna t i a mor t e . N o n c'è dubbio che fu questo tirocinio di l u g u b r e fi lantropia a ispirargli p iù t a rd i quel l 'e logio del boia che res ta forse la p iù bella «pagina de l l 'o r rore» della saggistica mondiale .
Gli s tudi li finì, e sempla rmente , a Tor ino, e senza dubbi sulla p r o p r i a vocazione. A differenza di quasi tutti gli altri suoi coetanei , n o n era stato m i n i m a m e n t e tenta to né dalla poesia né dalla politica. Per un nobi le come lui, di nobile n o n c'era che il servizio di Stato: avrebbe ricalcato le o r m e di suo padre , e infatti en t rò in magis t ra tura come assistente del p rocu ra to re genera le di Chambéry . La sua cu l tura era solida, ma limitata alla teologia, al diritto e all 'economia. Fu solo pe r effetto di contagio che nella sua men te si svegliarono altri interessi. La rivoluzione francese si avvicinava, e anche lì in Savoia g iungeva qua lche riflesso del g r a n movimento d ' idee ch'essa scatenava. Il loro veicolo era la Massoneria, a cui anche De Maistre s'iscrisse.
Ques to è il capitolo più cont roverso della sua rett i l inea vita, l 'unico che gli venga rinfacciato come un ' incoerenza . Ma si t r a t t a di un equivoco. C o m e abb iamo già de t to , la Massoneria di quel t e m p o era divisa in parecchi filoni di diversissima ispirazione ideologica che, r iportat i al vocabolar io d 'oggi, si po t rebbero anche ch iamare di destra , di cent ro e di sinistra. Di sinistra e r ano pe r esempio le logge dei cosiddett i «Illuminati di Baviera», f rancamente massimalisti e rivoluzionari . Di centro e rano le logge di ri to scozzese, ispirate ai pr incìpi illuministi, cioè r iformatori , di cui facevano par te anche molti Sovrani. Di destra era u n a cor ren te
411
r igorosamente cattolica, domina ta in g ran par te dai Gesuiti che in essa cercavano un sur roga to del loro soppresso Ordine .
N o n sapp iamo con esattezza a quale di questi t re filoni a p p a r t e n e s s e r o la loggia dei «Tre Mortai» e quel la della «Perfetta-Sincerità» cui De Maistre successivamente si affiliò. L'ora della verità sarebbe venu ta solo con la Rivoluzione, che le avrebbe messe alla scelta - o p r ò o contro - determ i n a n d o n e la spaccatura. Per il m o m e n t o esse e rano soltanto delle conventicole di «notabili» che prat icavano il segreto solo pe r d i le t tant ismo, visto che la polizia le tollerava e in qualche caso addir i t tura le proteggeva.
E probabile che De Maistre vi s'iscrivesse pe rché in u n a città intel let tualmente sonnolenta come Chambéry n o n c'era altra palestra pe r uomini che volessero tenere in esercizio il loro cervello. C o m u n q u e , fu qui ch 'egl i cominciò a p r e n d e r e dimest ichezza coi p rob lemi politici e sociali che sempre più appassionavano la pubblica opinione. Degli autori francesi che li agitavano, l 'unico che gli andasse a sangue e ra Montesquieu , e Io si e ra senti to dal suo p r i m o discorso p ronunc ia to p e r la venuta di Vittorio Amedeo I I I a Chambéry, in cui auspicava un par lamento all'inglese come correttivo del regime assolutistico. Il fatto che questo bastasse a farlo passare pe r sovversivo agli occhi dei dignitari dimostra solo quanto costoro fossero ottusi.
Q u a n d o la Rivoluzione scoppiò, anche pe r lui si pose il d i l emma della scelta. Convin to che tut te le logge massoniche n o n fossero che veicoli d ' infezione, i l gove rno mise al b a n d o anche quella di De Maistre, che disciplinatamente se ne ri t irò, ma confutando la motivazione della c o n d a n n a in u n a Memoria al Duca di Brunswick in cui rifiutava energicamente la tesi che le logge fossero covi di complott i rivoluzionari . Può darsi, diceva, che alcuni massoni si siano fatti strum e n t o del diavolo, ma la Massoner ia n o n è che la scienza de l l ' uomo, lo s tudio della sua or ig ine e del suo des t ino , il quale conduce non alla Rivoluzione, ma alla Rivelazione. A
412
questa tesi r imase sempre fedele, ed era senza dubbio sincero . Ma ciò d imos t ra quan to arbi t rar io sia ogni tentat ivo di at tr ibuire alla Massoneria un preciso s tampo ideologico.
Nel '92, q u a n d o la Rivoluzione si p resen tò non più nella veste di un ' idea, ma in quella di un esercito che s t rappava la Savoia al P i e m o n t e e l ' anne t teva alla Francia, De Maistre aveva già mogl ie e d u e figli . Con loro fuggì ad Aosta, ma p e r evi tare la confisca dei ben i fu cos t re t to a t o r n a r e e a iscriversi alla guard ia civica. La coscienza glielo r improverò come un gesto di fellonìa, e pe r tacitarla n o n gli r imase che un 'al t ra fuga, stavolta a Ginevra. Fu qui che iniziò la imprevista e n o n des ide ra ta attività di scr i t tore . Ma n o n lo fece p e r procacciars i fama: t an t ' è vero che le p r i m e o p e r e le pubblicò anon ime . «Scrivere, pe r lui, e ra agire - dice il suo biografo Cogorden - . N o n essendo u o m o di spada, prese la penna.» Ma per brandir la come una spada.
Il quadr i enn io ginevr ino fu decisivo p e r lo svi luppo del suo pens i e ro . Nel f ragore delle po l emiche p rovoca te dal gran r ivolgimento, De Maistre fece pres to a orientarsi . Dotato di u n a salute di ferro, egli aveva u n a capacità di lavoro eccezionale. Poteva restare a tavolino anche quindici o re di seguito. «Ho raccolto - scriveva a un amico - u n a massa incredibile di testi pe r r idurl i a un discorso sistematico.»
Q u e s t o discorso sistematico, p e r d i p a n a r n e la matassa, bisogna rifarsi al m o m e n t o . C o m ' e r a logico che accadesse, la rivoluzione aveva provocato un contraccolpo ideologico, che trovò la sua espressione più compiuta in u n o storico inglese: Burke . Non s i trattava di un conservatore , ma di un liberale che dieci anni p r ima aveva parteggiato pe r gli americani insorti cont ro l ' Inghil terra. Non era quindi un part igiano dell 'assolutismo, ma n o n lo era n e m m e n o dell ' ideologia giacobina, di cui contestava tut te le premesse . Vediamo d i ch iar i re ques to p u n t o che n o n ha pe rso nul la della sua attualità.
Figli di Rousseau, i r ivoluzionari francesi par t ivano dal p resuppos to che lo Stato potesse e dovesse adeguare le sue
413
s t r u t t u r e al mode l lo di u n a Rag ione assoluta e universa l men te valida. Figlio di H u m e - un filosofo che lo aveva preceduto di qualche decennio - , Burke rifiutava questa posizione. Una verità assoluta e un iversa lmente valida, diceva, esiste solo nel c a m p o delle scienze as t ra t te , come la mate matica, sulle cui regole si possono impostare delle operazioni che valgono sempre e dovunque . Ma in u n a realtà composita e concreta, qual è u n a società, i r appor t i n o n sono affatto «necessari», cioè a u n a d e t e r m i n a t a causa n o n corr i sponde sempre quel de te rmina to effetto, perché u n a società vi r i sponde in un m o d o e un 'al t ra in un altro. Sia det to pe r inciso, ques ta tesi, che H u m e estese anche alla rel igione e alla morale , influenzò tut ta la filosofia successiva, compresa quella di Kant. Ma questo è un discorso che n o n ci r iguarda.
Burke l 'applicò alla politica, ma svi luppandola fino alle conseguenze es t reme. Quel la che orgogl iosamente si chiama «la ragione», egli dice, n o n sono che le opinioni , sempre soggett ive e a rb i t ra r ie , di a lcuni pensa to r i che r iescono a impor le in un cer to e p e r un cer to m o m e n t o : m o d e , infatuazioni . La vera rag ione della società è ben al t ro: è quell 'insieme di «pregiudizi», cioè di sentimenti , di convinzioni, e anche di convenzioni, di miti e di tabù che formano il pat r imonio di u n a comunità , sia essa la famiglia, o la classe sociale, o la nazione . Ques to pa t r imon io n o n è né e t e r no né universale. Varia da Paese a Paese e si trasforma nel t empo per adeguarsi ad esigenze sempre nuove e diverse, ma non soppor ta t raumi che ne r o m p a n o la «continuità». E il lettore , a ques to p u n t o , avrà capito l 'antitesi. Da u n a p a r t e l'ideologia r ivoluzionaria francese che inventa, o c rede d ' inventare , un m o n d o assolutamente nuovo, che r innega tut to il suo passato, e qu ind i anche la sua storia, i m p o n e n d o all ' uomo di vivere secondo u n a rag ione astratta, immobile e assoluta. Dall'altra l 'ideologia storicistica inglese, che postula un sistema in cui alla società è consentito di svilupparsi e p r o g r e d i r e , ma s e m p r e in a r m o n i a coi suoi «pregiudizi»,
414
cioè con la sua t radizione. Rivoluzione cont ro r i formismo, insomma: l 'e terno di lemma.
Burke sviluppò queste sue tesi nelle Riflessioni sulla Rivoluzione francese che uscì nel '90. E fu questo, nella «massa incredibile di testi» raccolti da De Maistre, quel lo che più lo impress ionò e inf luenzò nel suo rifugio g inevr ino . Aveva q u a r a n t a n n i q u a n d o b rand ì la p e n n a per gettarsi nella mischia. Ma trovò immed ia t amen te il suo stile - forse pe rché non lo cercò -, e fu subito scrittore, e g r ande scrittore: fenomeno unico - c redo - nella storia della let teratura.
Quella che uscì dalla sua p e n n a fu d a p p r i m a una proflu-vie di libelli che cominciò con le Lettere di un monarchico savoiardo e culminò nelle Considerazioni sulla Francia, di cui anche il titolo riecheggia l 'ispirazione burkiana . Qua lcuno dice che c'è den t ro anche del Bonald, il g rande campione del legittimismo francese. Ma l'ipotesi è smentita dall 'anagrafe. L'opera del Bonald, Teoria del potere civile e religioso, uscì nello stesso anno '96 in cui apparve quella di De Maistre. Sebbene vivessero en t rambi in Svizzera, i d u e n o n si conoscevano. Si r iconobbero solo più tardi , q u a n d o si lessero a vicenda, e De Maistre scrisse a Bonald: «E mai possibile che la natu ra si sia divertita a t ende re d u e corde così per fe t tamente assonanti come il vostro spirito e il mio? Si t ra t ta della più rigorosa somiglianza». Ed era vero, ma fino a un certo pun to: anche se dicevano le stesse cose, le dicevano in manie ra assai diversa: la rapidi tà , l 'asciuttezza, la rabbia, il patos di De Maistre, Bonald se li sognava.
Forse anche pe r impedirgli di cont inuare a scrivere cose che ferivano a m o r t e i francesi, Car lo E m a n u e l e lo invitò nel '97 a r i en t r a r e a Tor ino. Que l povero Re travicello re gnava p e r grazia di Dio, ma pe r volontà di Napo leone che aveva occupato tut to il Piemonte e solo a titolo t emporaneo lo lasciava sul t r o n o . De Mais t re , in cui la fedeltà n o n si confondeva con la cortigianeria, r imase disgustato dalla pavidità del Sovrano e dall ' imbecill i tà dei suoi minis t r i . «De Maistre - si legge in u n a lettera di questi t empi - ha visto i
415
potenti , e si è già trovato che parlava t roppo , ch 'era t roppo franco. Sarà s e m p r e lo stesso: ricco di b u o n e qual i tà , ma n o n adat to per riuscire qui, dove non si sa nulla, ma in compenso le schiene h a n n o la flessibilità del vinco.»
Poi successe quel che il l e t tore già sa. Car lo E m a n u e l e firmò l'atto di abdicazione e part ì . Partì anche De Maistre al seguito del suo Re, ma part ì anche Napoleone pe r la sua avventura egiziana, e gli austriaci ne approf i t tarono pe r scend e r e coi russi al contra t tacco e r iconquis ta re l 'Italia, scacc iandone i francesi. Breve illusorio intermezzo. Poco d o p o Napoleone tornò , schiacciò gli austro-russi a Marengo e riprese il P iemonte non lasciando ai Savoia che la Sardegna . Oui il nuovo sovrano Vittorio Emanuele I nominò come Vi-cere il fratello Carlo Felice e come capo della magis t ra tura De Maistre.
L'isola gli fece un ' impress ione disastrosa. «Il sardo - scrisse - è più selvaggio del selvaggio, perché il selvaggio ignora la luce, il sardo la odia. Esso è sprovvisto del miglior attributo de l l ' uomo, la perfettibilità. In q u a l u n q u e mest iere si ciment i , lo fa come lo faceva ieri, come la rond ine fa il suo nido e il castoro la sua casa. G u a r d a s tup idamente una pompa asp i ran te e va ad a t t ingere l 'acqua col secchio. Gli si fa vedere l 'agricoltura del Piemonte, della Savoia, della Svizzera, e to rna in patr ia senza saper innestare un albero. Ignora il fieno come ignora le scoperte di Newton. Non si p u ò trattarlo che al m o d o dei Romani inviandogli un p re to re e d u e legioni, cos t ruendo delle s trade e cercando di fare il suo bene n o n solo senza di lui, ma anche contro di lui. Questo popolo n o n a m a n ien te . Ho più volte cons ta ta to che ciò che più gli r i pugna è di dover a p p r o v a r e qualcosa. Tutti i suoi vizi sono leggi e tut te le sue leggi sono vizi. Ques to disgraziato Paese n o n p u ò essere r igene ra to che da u n a po tenza opulenta , saggia e in t r ap renden te : sarebbe un 'opera , faccio pe r dire , da inglesi.» Come si vede, il p roblema del Mezzogiorno n o n è di oggi.
Ma, p u r con queste negative idee sui sardi, De Maistre si
416
oppose ai metod i spicciativi con cui li t rat tava Carlo Felice che intendeva combat tere il bandit ismo violando il codice e sa l tando i t r ibunal i . Fu il p r i m o motivo dei dissapori fra i d u e uomini , ma non il solo. Que l Principe rozzo e sommario che diffidava degl'intellettuali e ne vedeva u n o in chiunque maneggiasse la sintassi un po ' meglio di lui che la maneggiava malissimo, n o n poteva amare quel magistrato devoto al Re, ma p iù ancora alla Legge , e con t ro i cui a rgoment i egli n o n poteva far ricorso che all 'autorità. E questo fu il vero motivo p e r cui, q u a n d o nel 1803 si rese vacante l 'ambasciata del Regno di Sardegna a Pietroburgo, egli stesso p ropose al fratello di nominarvi De Maistre.
Questi par t ì da solo perché la moglie aveva dovuto rient r a re coi figli in Savoia a d i fendervi il p a t r i m o n i o nuova mente minacciato di confisca: pe r dodici anni n o n li avrebbe più rivisti. Arrivò a Pietroburgo d o p o un viaggio di d u e mesi, con un camer i e r e e pochi qua t t r in i , p e r c h é , con la pe rd i t a del P iemonte , le casse dello Stato e r ano in secco e gli stessi Reali a r rancavano fra grosse difficoltà di bilancio. Dovet te a r r ang ia r s i anche lui come poteva senz 'a iu to d i personale (solo d o p o d u e anni gli m a n d a r o n o come segretario il figlio Rodolfo) e con l'obbligo di far fronte agl ' impegni di rappresentanza . «E il secondo inverno - scriveva a un amico - che passo senza pelliccia, ed è come non avere una camicia costà a Cagliari. Poiché il servizio di un solo cameriere è qui r i tenuto impossibile pe r la fatica e il clima, ho ingaggiato come secondo un ladro che stava pe r cadere nelle mani della Giustizia. Gli ho proposto di diventare un uomo onesto al r iparo del mio privilegio di ministro. E dopo alcuni mesi, pa re che vada bene. Poiché l'oste che mi nutriva, o meglio mi avvelenava, ha traslocato, ora non posso più raggiungerlo: così ho deciso di dividere la minestra del ladro.»
Ma, nonostante la povertà dei mezzi, aveva r ipor ta to un grosso successo pe r sona le presso la società moscovita, la Corte e lo stesso zar Alessandro grazie al suo calore umano , alla sua cultura e alla sua brillantissima conversazione. Ave-
417
va rap idamente impara to il russo, e col suo acuto spirito di osservazione si e ra a tal p u n t o impadroni to della situazione di quel Paese che lo Zar e i suoi ministri spesso r icorrevano ai suoi lumi sulle r iforme da in t rodur re . Fu a p p u n t o in questa qualità di consulente che compose le Cinque lettere sulla pubblica istruzione in Russia che r e s t ano u n o dei suoi saggi megl io riusciti . Ma n o n solo Alessandro si r ivolgeva a lui. Come il suo arcinemico Voltaire, egli teneva cor r i spondenza con tutti i g randi d 'Europa nel campo del pensiero e della politica, col Conte di Provenza - futuro Luigi X V I I I - e con lo stesso Napoleone che, p u r non essendo u o m o di lettere, sapeva dis t inguere quelle buone e pe r De Maistre, p u r sapendo quanto gli fosse avverso, aveva un debole. Anzi, fu p ropr io questo che lo indusse a un passo falso. Approfittando della simpatia che Napoleone gli dimostrava, gli p ropose un rego lamento a pa r t e della quest ione del P iemonte . Napo leone , che dalle s impatie n o n si lasciava t rascinare , n o n r ispose. E Vit torio E m a n u e l e , q u a n d o ne fu in formato , m a n d ò al suo ambasciatore u n a strigliata in cui s ' insinuava perfino una velata accusa di t rad imento .
C o m e trovasse i l t e m p o , fra t an te attività, di p o r t a r e avanti i suoi libri, lo spiega solo la sua mostruosa resistenza al lavoro. N o n usciva mai pe r uscire soltanto. Q u a n d o n o n era a Corte , e ra davant i alla sua scrivania dove t rascorreva intere giornate e talvolta nottate. Per n o n doversene alzare neanche ai pasti, si era fatta costruire u n a sedia girevole che r u o t a n d o su se stessa lo met teva di f ronte al desco. Fu in questo per iodo ch'egli scrisse le sue ope re più impegnative: gli undici dialoghi delle Serate di Pietroburgo, che rappresentano la sua summa filosofica, il Saggio sul principio generatore delle costituzioni politiche, l'Esame della filosofia di Bacone, i Quattro capitoli sulla Russia, e infine quello ch'egli forse cons iderava il te t to della sua concezione poli t ico-teologica: il saggio Sul Papa. Ma tut to questo intramezzato da una miriade di lettere a tutti: ai Re, ai ministri, ai diplomatici, agl'intellettuali d 'Europa , ma anche alla moglie e alle figlie di cui
418
pre t endeva dir igere da Piet roburgo l 'educazione. A u n a di esse che assumeva pose di suffragetta, r icordava che «una d o n n a a t t r a en t e e graziosa si sposa più faci lmente di u n a dotta, pe rché pe r sposare u n a dot ta basta essere senza orgoglio, qualità molto rara, m e n t r e pe r sposare una d o n n a graziosa basta essere pazzo, qualità molto comune» e che «una d o n n a non p u ò essere super iore che come donna ; dal mom e n t o in cui vuole e m u l a r e l ' uomo, n o n è che u n a scimmia».
De Maistre assistè all ' invasione della Russia da pa r t e di Napoleone nel '12, e i suoi rappor t i su quei drammatici avvenimenti costituiscono tut tora un documento di palpi tante interesse che getta qualche dubbio sulla ricostruzione fattane a posteriori dagli storici. A sentir lui, le ritirate di Kutuzov, p iù che a un calcolato p i ano strategico, furon dovu te alle esitazioni dello Zar, che finì pe r ba t tere il nemico solo perché n o n trovò mai il coraggio di affrontarlo.
La Restaurazione lo deluse p ro fondamen te . La Costituzione concessa da Luigi XVII I ai francesi gli parve un vero e p r o p r i o t r a d i m e n t o . «Ci s ' i nganne rebbe inf in i tamente - scrisse - a c redere che il Re di Francia è risalito sul t rono dei suoi antenat i . Egli è salito solo sul t r ono di Bonapa r t e , ed è già u n a gran fortuna pe r l 'umanità. Ma siamo ben lontani dal r iposo . La Rivoluzione fu d a p p r i m a democra t ica , po i ol igarchica. Ogg i è monarch ica ; ma con t i nua a fare il suo corso.» Q u a n t o alla Santa Alleanza, ci vide solo «l 'ennesimo most ro par tor i to dall ' i l luminismo»; e se quella s t rana combinazione fu qualcosa, fu p ropr io questo.
A tali motivi di scontentezza, si a g g i u n g e v a n o anche quelli personali . Per i servigi che aveva reso e pe r il credito di cui godeva ne l l ' ambien te d ip lomat ico , De Maistre si aspet tava che il Re lo mandasse a Vienna , dove si s tavano negoziando i trattati di pace, come plenipotenziario del Piemonte . Invece fu lasciato in disparte e poi r ichiamato a Tor ino. Vi giunse nel '17, d o p o u n a sosta a Parigi dove fu accolto come il capo-scuola dai cosiddetti ultras, gli oltranzisti
419
del pens iero cattolico e monarchico , e ricevuto dallo stesso Re. A C h a m b é r y potè finalmente r iabbracciare i suoi cari . Ma a Torino si sentì spaesato. Egli aveva sognato la restaurazione di certi valori morali, e lì n o n trovava che quella delle pa r rucche e dei privilegi. La Corte lo trat tò con freddezza e lo esiliò nella carica p u r a m e n t e onorifica di ministro di Stato senza portafoglio. Alla figlia che lo complimentava, rispose: «Non vi è niente di più nullo del mio posto. Contavo di più q u a n d o facevo il sostituto p rocura to re a Chambéry». Poteva tuttavia intervenire alle r iunioni di Gabinetto, ma ci andava di r ado e quasi mai vi p rendeva la parola, scoraggiato dai discorsi che vi udiva. Que i fantasmi del passato, a cominciare dal Re, credevano che il regime fosse solo u n a questione di polizia. All'ultimo consiglio cui assiste, gli scappò la pazienza: «Signori - disse -, cosa volete costruire su un suolo che trema?» Era il genna io del '21 : pochi mesi dopo , sar e b b e r o scoppiat i i famosi mot i che av rebbe ro p rovoca to l 'abdicazione del Re e l 'invasione austriaca. Ma a presentir l i e ra solo lui, che non fece in t empo a vederli.
Aveva seguitato a lavorare con alacrità. Lamar t ine , ch 'era venuto a visitarlo, lo descrive come «un u o m o di alta statura, u n a bella e virile figura militare con u n a fronte spaziosa su cui ondeggiavano, come i resti di u n a corona, a lcune ciocche di capelli a rgenta t i . I l suo occhio e ra vivo, p u r o , franco. La sua bocca aveva l 'espressione di f ine i ronia che caratterizzava tutta la famiglia». Conservò il suo intelletto fino all 'ul t imo: neanche la paralisi r iuscì ad appannarg l ie lo . La sua ultima lettera fu a Bonald: «Muoio con l 'Europa» gli scrisse.
E veniamo al suo lascito. In Francia esso è ormai valutato e catalogato. In Italia, i pochi che n o n lo i gno rano lo esaltano , ma dal verso sbagliato. Dicono che De Maistre fu un g r a n d e pensatore , e n o n è vero. Il suo pensiero è quello di Montesquieu e di Burke , sopra t tu t to di Burke . Ciò ch'egli vi agg iunge è un empi to lirico e un furore apocalittico che
420
gli altri d u e non possedevano e che lo conducono non a un «sistema», ma a u n a «visione» diversa dal la loro . M e n t r e Burke r imane il p a d r e del pensiero liberale dell 'Ottocento e ne p revede tutta l 'evoluzione, De Maistre pe rcor re a ri troso il cammino della Storia e risuscita la concezione medievale-sca di un impero universale del Papa, Rex Regum, Re dei Re, ch 'era stata quella di Gregorio VII , d ' Innocenzo I I I e di Bonifacio V i l i . De Maistre non è un filosofo. E un profeta che sbaglia profezia, ma ne azzecca gli accenti. Questi toccano la vetta più alta nel famoso «elogio del boia» in cui si r iassume, pa radossa lmen te , tu t ta la sua u top ia teocratica. «La spada della giustizia n o n ha fodero. Dalla formidabile prerogat iva dei Re di p u n i r e i colpevoli, risulta l 'esigenza necessaria di un u o m o des t ina to a infl iggere ai delit t i i castighi. Ogn i g randezza , ogn i po tenza , ogn i subo rd inaz ione r iposa sul boia. Esso è l 'orrore e il vincolo della società umana . Togliete dal m o n d o quest 'agente fatale, e nello stesso istante l'ordine farà posto al caos, i t roni s ' inabisseranno, la società spar i rà . Dio, che è l ' au tore della sovranità lo è d u n q u e anche del castigo. Il patibolo è un altare.»
Lo stesso carat tere espiatorio, e quindi sacrale ch'egli attribuisce al carnefice, lo impresta anche alla carneficina, cioè alla guer ra . «Non udi te voi la t e r r a che gr ida e chiede sangue? La g u e r r a d ivampa . Invaso da un divino fu rore , che n o n è odio né collera, l 'uomo s'avanza sul c a m p o di battaglia senza sapere né ciò che vuole, né ciò che fa. Che cosa è d u n q u e questo orribile enigma? Nulla è più contrar io della g u e r r a alla n a t u r a de l l ' uomo, e nul la tut tavia gli r e p u g n a meno . Egli fa con entusiasmo quella stessa cosa di cui ha orrore . Q u a n d o i delitti si sono accumulati fino al limite stabilito, l ' angelo s t e rmina to re accelera il suo infaticabile volo a n n e g a n d o le nazioni nel s angue . Si d i r ebbe che ques te grandi colpevoli, i l luminate a un trat to dalla loro coscienza, d o m a n d i n o il supplizio e l 'accettino pe r trovarvi l'espiazione . Fino a che resterà loro u n a goccia di sangue, ve r r anno a offrirla; e ben presto una gioventù d i rada ta si farà n a r r a r e
421
questi sacrifici ch 'ebbero origine dai misfatti dei loro padr i . La gue r r a è d u n q u e in se stessa divina...»
Ques to n o n è pens ie ro . E, nella sua poetica t ruculenza , visione da g rande quaresimalista molto più cattolico che cristiano, quale De Maistre fu. Per metà.
L'altra metà è il g rande , il grandissimo giornalista, il pun tuale fotografo di situazioni e di uomini , ora l'affabile e arguto conversa tore delle let tere familiari, o ra l 'aggressivo e tagliente provocatore dei libelli polemici: l 'unico che abbia sapu to d i re i l con t ra r io di Voltaire col br io , coi paradoss i , col m o r d e n t e , col «diavolo in corpo», con la m o d e r n i t à di Voltaire.
Bisogna infatti intenderci sul «reazionarismo» di De Maistre. Esso non era affatto ispirato da un ottuso at taccamento al vecchio regime concepito come trincea d'interessi e privilegi di casta. E infatti questo fedelissimo legittimista fu sempre in lotta col Re e coi suoi cortigiani che così, rozzamente , lo in tendevano e prat icavano. Il suo reazionarismo attingeva a u n a certa visione, pessimistica e sfiduciata, del l 'uomo e del suo destino. Questo povero idiota «pieno di urla e di furore», come dice Shakespeare (altro g r ande reazionario) crede di fare la Storia. La Storia la fa Dio; l 'uomo p u ò collaborarvi soltanto r iconoscendo gli e terni e immutabil i pr incìpi che la regolano, e attenendovisi . Non p u ò cambiarne il corso, p u ò soltanto «descriverlo» come fa Balzac, g r a n d e reazionario anche lui. Guai q u a n d o l 'uomo, monta to in superbia, p r e t e n d e sovvertire le leggi della vita con le sue rivoluzioni: raggiunge sempre il fine oppos to a quello che persegue. Guai q u a n d o s'illude d ' is taurare la libertà: abbandonato a se stesso, egli n o n è che un animale nella jungla . La sua salvezza sta ne l l 'umi l tà di r iconoscere ques ta sua miser ia . «L'uomo n o n è g r a n d e che in ginocchio» di rà un allievo di De Maistre.
E vero ch'egli n o n appar t iene alla cul tura italiana di questo pe r iodo (ma con Dante , p e r esempio , ci sta benissimo) né come formazione, né come spirito, né come stile, né co-
422
me lingua. È vero che i suoi più rispettabili discepoli e cont inuator i fu rono s t ranier i e sopra t tu t to francesi: i L a m e n -nais (prima dell 'apostasia), i Barbey d'Aurevilly, i Veuillot, i Bloy. Ma se in Italia il t e rmine «reazionario» è diventato sin o n i m o di «forcaiòlo», è a p p u n t o pe rché , invece che ai De Maistre, i reazionari italiani preferiscono ispirarsi ai Principi di Canosa. E così è avvenuto che m e n t r e i francesi possono essere intelligenti, spregiudicati e modern i anche da reazionari , i reazionar i italiani sono condanna t i a res tare solo degli squallidi e sgrammaticati caporali.
CAPITOLO TRENTANOVESIMO
ROSSINI
Il fatto che nessun letterato, n e m m e n o Manzoni nonostante il clamoroso successo del suo romanzo, riuscisse a vivere dei p r o v e n t i della sua attività, dice abbas tanza c h i a r a m e n t e quan to poco di let teratura gl'italiani si nutr issero. Di chi ne fosse la colpa, lo abbiamo già fin t r o p p e volte r ipe tu to pe r dovervi insistere. C o m u n q u e , quest'allergia faceva sì che l'unica manifestazione cul tura le che r ea lmen te interessava il g r a n d e pubblico fosse la musica, o pe r meglio dire l 'opera. Era anzi una vera febbre che teneva l'Italia immersa nell'atmosfera di una perpe tua San Remo. Ogni g rande città aveva il suo tea t ro che , ol tre al sussidio governat ivo, godeva dei proventi della sala da giuoco che vi era annessa - il Ridotto -e che servivano a finanziare le sue t re o quat t ro stagioni all ' anno. In quelle piccole provvedeva a tut to il mecenate , e Stendhal ci ha lasciato la descrizione dei suoi metodi:
«Per p r ima cosa met te insieme u n a compagnia , composta invariabilmente di u n a p r imadonna , un tenore , un basso cantante , un basso buffo e una o d u e persone di minore importanza. Poi incarica un compositore di scrivere un 'opera t enendo conto delle voci a sua disposizione e offre a u n o scrittore del luogo da sessanta a ot tanta franchi pe r il libretto. Immancab i lmente egli s ' innamora della p r i m a d o n n a , e tut ta la città è in agi tazione pe r sapere se le offrirà o no il braccio in pubblico. Così organizzata, la compagnia dà finalmen te i l suo p r imo spettacolo d o p o un mese d ' intr ighi che sono stati fonte d'infiniti pettegolezzi. Lo spettacolo è il più g r ande avvenimento del l 'anno, e nessun avvenimento parigino p u ò esservi paragonato . Per t re set t imane otto o dieci-
424
mila persone discutono i merit i e i demeri t i del l 'opera e dei cantanti con tut to l 'acume che il cielo ha loro concesso e sopra t tu t to con tutta la forza dei loro polmoni . La p r ima rapp resen taz ione , se n o n è stata fischiata, è segui ta da a l t re t renta o quaranta , dopodiché la compagnia si scioglie». Solo i memorialisti stranieri riescono a dirci com'era fatta l'Italia.
Siccome i compos i tor i di ta lento e r a n o ovviamente pochi, i teatri se li d isputavano e le folle ne facevano oggetto di un vero e p r o p r i o culto. Q u a n d o arr ivavano, di solito con un lungo codazzo di accompagnator i , la gente staccava i cavalli dalla carrozza pe r trainarla a braccia, evocava l'idolo al balcone e gli faceva serenate. Essi pe rò dovevano vedersela coi cantant i che, n o n m e n o divi e capricciosi di loro, esigevano che le p a r t i t u r e venissero ada t ta te alle loro ùgole , e talvolta anche alle loro manìe . Il soprano Crivelli pe r esempio si rifiutava di ap r i r bocca se la sua p r i m a ar ia n o n cominciava con le parole «Felice ognora», e il tenore Marchesi n o n accettava altre en t ra te in palcoscenico se non a cavallo e con un elmo g rondan te di p iume bianche. Inol t re , ognuno di essi si r iservava il d i r i t to di a p p o r t a r e var iant i con acrobazie canore n o n previste dal testo, le cosiddette «fioriture». E su un solo p u n t o e r a n o concord i : che l 'orchestra dovesse restare al suo posto, cioè occuparne il m e n o possibile, l imitandosi al p u r o a c c o m p a g n a m e n t o . Il che basta a farci cap i re a qua le pa r t e , in quest i spettacoli musicali , la musica fosse r idot ta e come mai Glùck e Mozart n o n ebbero in Italia dirit to di cittadinanza.
A contenders i il p r imato nazionale e r ano la Scala di Milano, che t ra poco se lo sarebbe definit ivamente aggiudicato, e il San Carlo di Napoli , che p rop r io in questo inizio di secolo toccava l 'acme del suo prestigio grazie a un impresario d'eccezione, Barbaja. Misto di genio e di ciarlatano, Bar-baja aveva debut ta to come sguat tero, aveva fatto i pr imi soldi i nven tando un dolce di p a n n a e cioccolato, la «barbaja-da», li aveva moltiplicati con la gestione del Ridotto da giuoco della Scala, e ormai tanti ne aveva che q u a n d o il San Car-
425
lo andò distrutto da un incendio, lo ricostruì a p ropr i e spese. Era semianalfabeta, e di musica n o n conosceva u n a nota, ma conosceva il pubblico, e ra un infallibile scopritore di talenti, e nel 1815 si assicurò quello di un composi tore ventit r e e n n e , in cui già aveva identificato la f igura p iù r a p p r e sentativa della lirica con temporanea : Gioacchino Rossini.
Rossini era nato a Pesaro, ma l 'origine della famiglia era romagnola . Suo pad re era chiamato «Vivazza» per la sua rumorosa esuberanza, si professava «giacobino» (il che gli valse anche la prigione) e faceva il suonatore di corno nelle girovaghe compagnie in cui sua moglie cantava. Non potendo por ta rs i d ie t ro i l b amb ino , lo misero a pens ione da un salumiere di Bologna e a scuola di musica da un vinaio che suonava la spinetta con d u e dita sole e la not te dormiva sotto i por t ic i p e r c h é soffriva di claustrofobia. Fu grazie a un ' inna ta disposizione che Gioacchino imparò il cembalo e la viola, e a quat tordici ann i già si guadagnava t re lire p e r sera come maestro dei cori in teatro. Non gli mancava nulla pe r p iacere a tutt i : e ra bello, al legro, spir i toso, amabi le , e delle s impat ie che suscitava approf i t tò l a rgamente , specie con le d o n n e .
Il suo d e b u t t o di compos i to re lo fece a sedici a n n i con u n a «cantata» commiss ionatagl i dal Liceo Musicale. Ma il suo vero battesimo fu, d u e anni dopo , un 'opera , la Cambiale di matrimonio. N o n fu un g r a n successo un po ' p e r c h é il lib re t to e ra un accozzo d i scemenze, un po ' p e r c h é dovet te scendere a patti coi cantanti che lo accusavano di aver sacrificato le voci alla musica. Ma il pubblico r imase colpito dal r i tmo indiavolato e applaudì . Molto di p iù applaudì quello del San Moisè di Venezia dove fu r a p p r e s e n t a t o Einganno felice, il suo p r imo trionfo. E da allora fu tut to un susseguirsi di scrit ture fino a quella, decisiva, di Barbaja.
Sobillati dal vecchio Paisiello o rma i in d i sa rmo e orgogliosi del loro p r imato musicale, i napole tani n o n r iconobbe ro gli allori già raccolti nelle a l t re città dal ven t i t r eenne composi tore e lo accolsero con riserva. Ma Rossini li conqui-
426
sto subi to b u t t a n d o giù in poch i g iorn i u n a n u o v a o p e r a , Elisabetta regina d'Inghilterra, tagliata sulla misura del soprano che la i n t e rp re tò : Isabella Colbran , u n a spagnola tu t ta ùgola e sesso, ch ' e ra l ' amante de l l ' impresar io . Rossini che l'aveva già sentita a Bologna e ammira ta n o n soltanto pe r la s t u p e n d a voce, se ne i n n a m o r ò subi to, sebbene lei avesse sette anni più di lui. Barbaja, a quan to pare , n o n sollevò difficoltà. Pr ima accettò il menage a t re, poi si trasse in disparte lasciando che i d u e si sposassero e res tando con loro in eccellenti rappor t i .
N o n a v e n d o f i rmato con lui nes suna esclusiva, Rossini accolse l'invito di compor r e due ope re anche pe r i l duca Cesarmi Sforza, impresar io del teat ro Argent ina di Roma. La p r ima fu un 'ope ra seria, e cadde. Per la seconda, fu Rossini stesso a ch iedere che il l ibretto fosse trat to dalla commedia di Beaumarchais , // barbiere di Siviglia. Sulla nascita di questo lavoro cor rono molte leggende. Si è det to che ci furono delle ingerenze da par te della censura papale , e n o n è vero. Si è det to che Rossini chiese il permesso di usare quel libretto a Paisiello, che lo aveva musicato venticinque anni pr ima. E n e m m e n o questo è vero perché a quei tempi tutti at t ingevano agli stessi libretti, che poi e rano quasi sempre quelli di Metastasio. Si è det to anche che Rossini ficcò nella par t i tura b ran i di musica al t rui ; e ques to è vero, ma solo a metà , in q u a n t o fu sol tanto parecch io t e m p o d o p o ch 'egl i sostituì un 'ar ia con un 'al t ra composta da Romani (il famoso «Manca un foglio» di Don Bartolo). Ma il lettore n o n trasalga: allora le o p e r e si «montavano» così, p r e n d e n d o n e di qua e di là pezzi pescati nel magazzino p r o p r i o o in quello degli altri. Q u a n t o al t e m p o che gli occorse p e r la composiz ione, egli disse a Wagner di averci impiegato dodici giorni, ma secondo il t enore Garcìa furono solo ot to. Come compenso ricevette mi l leduecen to franchi e un vestito con bo t ton i d 'o ro pe r far bella figura nel l 'orchestra dove usava che il compositore sedesse al cembalo.
L'opera a n d ò in scena il 20 febbraio del '16 e fu, come
427
tutti sanno, un colossale fiasco. Ma era un fiasco prefabbricato da u n a claque di nemici del Cesarini. La seconda sera i fischi furono rintuzzati dagli applausi, e da allora in poi non fu che un «crescendo» di s tampo t ipicamente rossiniano. Da tutte le par t i d'Italia e d 'Europa venne ro gl ' intenditori pe r r e n d e r s i con to di quel con t rove r so lavoro, e a n c h e quelli più ostili, come Brahms e Berlioz, convennero che la cosiddet ta «opera buffa» n o n aveva mai raggiunto , quanto a ricchezza inventiva, vivacità, brio, freschezza e movimento , simili altezze. Probabi lmente vi contr ibuì anche l'affinità fra Rossini e Beaumarchais , en t rambi portat i più allo spirito e all ' ironia che al sen t imento . Que i pe r sonagg i sembravano fatti appos ta p e r quella musica, fortuna che a Rossini n o n capiterà mai più.
A ventisei ann i Rossini era se non il p iù g r ande , certo il più popo la re composi tore d 'Eu ropa . C h i u n q u e altro forse si sarebbe sentito schiacciato dalle responsabilità che ne der ivavano. Lui, no . Per nulla spaur i to dall 'attesa che creava nel pubblico ogni sua nuova opera , seguitava a comporne a getto con t inuo con u n a dis involtura che spesso sconfinava nell ' incuria. Accettava qualsiasi libretto, anche il più idiota e a s su rdo : «Datemi il con to del la lavandaia - diceva -, e vi me t to in musica anche quello». Ma n o n e ra p r e s u n z i o n e : anche al colmo del suo successo, Rossini restava un u o m o semplice, affabile, e di u n a modest ia che qualche volta, nei confronti dei suoi rivali, d iventava add i r i t t u ra umiltà. Era giovane, era sano, era allegro, tut to gli era facile, compreso i l lavoro pe rché di musica era turg ido come u n a mucca di latte. Come disse più tardi , n o n aveva bisogno di a n d a r e a cercar le melodie p e r c h é e r a n o le melodie che venivano a cercare lui. Q u a n d o Barbaja gli p r o p o s e d i mus ica re un Otello, n o n mosse obbiezioni: neanche Shakespeare gli faceva pau ra , e Byron scrisse che nessuno lo aveva servito meglio di lui e disservito peggio del librettista Berio che infatti aveva fatto del testo un o r r e n d o scempio.
Basta scor re re l ' anagrafe delle sue o p e r e p e r r e n d e r s i
428
conto della sua mostruosa vena. In tre anni ne produsse dodici fra farse, d r ammi , m e l o d r a m m i e perfino azioni sacre. Non tut te furono successi perché qualche volta il pubblico si spazientiva di quel suo eccessivo tirar via. Ma gl'insuccessi, di cui dava rego la rmente notizia alla m a d r e m a n d a n d o l e il d i segno di un f iasco , n o n t u r b a v a n o m i n i m a m e n t e i l suo b u o n u m o r e e tanto m e n o i l suo robusto appet i to . Non era un ghiot tone, come lo h a n n o descritto, ma un raffinato epicureo , e non sol tanto a tavola. Gli p iacevano i bei vestiti, i begli ogget t i , e n o n pa r l i amo delle belle d o n n e , di cui la Colbran ebbe il buon senso di accettare la concorrenza. Oltre tutto, era anche spiritosissimo, ma senza cattiveria e, nonostante la modest ia delle sue origini, sapeva stare, tra i signori , da signore.
Q u a n d o , ch iamatovi da Barbaja che ne aveva p re so in appa l to l 'opera , a n d ò a Vienna , la città gli c adde ai p iedi , d iment icando pe r lui i suoi Mozart e i suoi Haydn . Fu Rossini a r icordargl iel i d i c h i a r a n d o con mol ta cavalleria che gran par te di quel che era egli lo doveva a p p u n t o a quei d u e maestri che riconosceva molto più grandi di se stesso. Natura lmente questo non fece che aizzare l 'entusiasmo dei viennesi , n o n o s t a n t e la so rda g u e r r a fattagli da Weber che lo considerava «il Lucifero della musica, il quale p u ò fare qualsiasi cosa, anche il bene , ma non sempre lo vuole». Ma Rossini riuscì a conquistare anche lui. Riuscì a conquistare perfino Beethoven che, comple tamente sordo e chiuso in selvatica solitudine, non si lasciava avvicinare da nessuno, ma pe r Rossini fece eccezione. Quest i ha lasciato del l ' incontro u n a patetica testimonianza che gli fa molto onore . Beethoven lo felicitò pe r il Barbiere e gli raccomandò di restare nel l 'opera buffa. «Quella seria - gli disse - mal si ada t t a agl ' i tal iani . N o n avete abbas tanza conoscenza musicale p e r t r a t t a re i l dramma.. .» Q u a n d o Rossini si provò a espr imere l 'ammirazione che provava pe r lui, Bee thoven lo fermò con un gesto: «Oh, un infelice!» disse, ben lon tano da l l ' immagina re che i l suo in t e r locu to re lo sarebbe d iven ta to un g io rno
429
quanto e forse più di lui. Coi suoi amici viennesi, Rossini fece il diavolo a quat t ro pe r convincerli a da re al g r a n d e maestro u n a casa decente e di che vivere c o m o d a m e n t e . «Venderebbe tutto - gli dissero - e t roverebbe il m o d o di r ipiombare nella sua miseria.»
Conf ron tando la alla sua sol i tudine, Rossini si sentiva a disagio pe r l 'ammirazione di cui era bersaglio. Non sapeva come far fronte agl'inviti, e di notte la folla gli faceva la serena ta cantandogli sotto le finestre i motivi del Barbiere, della Cenerentola, della Gazza ladra. Per sdebitarsi, p r ima di partire, dedicò ai viennesi un Addio e u n a marcia pe r banda militare, che più tardi pe rò si r iprese inserendola nella famosa ouverture del Guglielmo Teli.
«La gloria di ques t 'uomo è limitata solo dai confini della civiltà» scrisse S tendha l d o p o il tr ionfo della Semiramide, compos ta a Venezia in t r e n t a t r é g iorn i . A n d ò a L o n d r a ch iamato da Giorgio IV, che volle can ta re un due t to della Cenerentola con lui. Andò a Madr id , ospi te di F e r d i n a n d o VII . Andò a Parigi dove gli p ropose ro la direzione del p re stigioso Teatro Italiano. Poteva ormai avere quel che voleva, ma cominciava a n o n volerlo più con l ' ingordigia e la gioia di vivere di u n a volta. Gli e ra mor ta la madre , cui era legatissimo. Viveva ormai separato dalla Colbran ch 'era rimasta a Bologna e n o n andava p u n t o d 'accordo col vecchio «Vi-vazza». E la sua salute, fin allora a prova di bomba, d e n u n ziava qua lche scompenso : forse e r a n o i p r i m i s in tomi del male che doveva di lì a poco r idur lo a ro t tame. Questo n o n gli aveva imped i to di d iven ta re la «vedetta» n o n solo del palcoscenico, ma anche dei salotti di Parigi. In teatro pe rò il successo era dovuto più alle vecchie che alle nuove opere , le quali non avevano suscitato grandi entusiasmi, salvo l'Assedio di Corinto, che tuttavia piacque pe r ragioni più politiche che artistiche, la Grecia essendo in quel m o m e n t o di m o d a pe r la sua rivolta contro i Turchi. Più genuino fu il successo del Mose, che Balzac qualificò «un immenso poema musicale». Ma n o n erano i trionfi del Barbiere, e soprat tut to gli co-
430
stavano di p iù perché era lui, ora, che doveva anda re a cercarsi le melodie.
A compor r e il Guglielmo Teli gli ci vollero sei mesi, du ran te i quali a Parigi n o n si par lò d'altro. L'opera fu data nell'agosto del '29 in un teatro gremito come un uovo e teso allo spasimo. Non era un soggetto che gli si addicesse e il librettista Jouy lo aveva reso ancora più accademico e inamidato. L'esito fu incer to . Il pubblico t rovò l 'opera fredda, noiosa, sop ra t tu t to t r o p p o lunga , e ne r imase de luso . I critici e gl ' intenditori ne furono entusiasti e dissero che quello, non il Barbiere, era il suo vero capolavoro. Perfino Wagner ne riconobbe gli altissimi p reg i . E a c e n t o c i n q u a n t ' a n n i di distanza il dissenso cont inua. Secondo i competent i , qui Rossini ha toccato vette che Verdi n o n ha mai r agg iun to . Ma pe r il pubblico, egli resta quello del Barbiere.
Q u e s t o p r i m o soggiorno pa r ig ino f i n ì nel '30 , q u a n d o scoppiarono i moti che condussero all 'abdicazione di Carlo X e alla successione di Luigi Filippo. La vista delle barricate sgomentò Rossini che negli ultimi tempi era diventato estrem a m e n t e emotivo e impressionabile. Per di più il nuovo regime invalidò il vantaggiosissimo contra t to che lo legava al Tea t ro I ta l iano, a n n u l l a n d o a n c h e la sua pens ione . Gli ci vollero sei anni di processo pe r far r iconoscere i suoi diritti. Ma pe r intanto preferì trasferirsi a Madr id e poi a Baiona al seguito del ricchissimo banch ie re spagnolo A g u a d o che lo adorava e sovrintendeva con molta accortezza e generosi tà ai suoi interessi.
Fu in queste scorr ibande che incontrò Olimpia Pélissier, u l t ima d i scenden te di quella g r a n d e famiglia di demi-mon-daines francesi cui a p p a r t e n g o n o le Du Barry, le Pompa-dour, le Margher i te Gauthier. Era di bassissima estrazione: sua m a d r e l'aveva venduta m i n o r e n n e a un Duca. Ma la ragazza aveva saputo bene amministrarsi , restare in un «giro» di amant i altolocati e infine scegliersi come mari to un ricco agente di cambio che subito d o p o l'aveva lasciata vedova ed e rede della sua fortuna. Ora che poteva d isporre di se stes-
431
sa, voleva seguire la sua vocazione, anche questa t ipicamente francese, d'ispiratrice e impresaria d ' un genio. Forse Rossini credet te di averla sedotta. In realtà fu lei a sedurlo, ma non glielo fece r impiangere . Nessuna d o n n a avrebbe potuto essergli più devota nelle d u r e prove che lo aspet tavano. Isabella non oppose molte resistenze alla separazione. Anzi, q u a n d o Olimpia andò a Bologna, la invitò a colazione, e con Gioacchino rimase sempre in amichevoli rappor t i .
Alcuni biografi dicono che a scatenare la malattia nervosa di Rossini fu il t r a u m a di spavento ch 'egli subì q u a n d o volle provare l 'emozione del nuovo aggeggio che la tecnica aveva inventato: il t reno. Ma evidentemente confondono la causa con l'effetto. Se quel l ' innocua esperienza lo sconvolse al p u n t o che n o n riuscì a r imet tersene mai più del tut to, fu perché era già profondamente malato, e del resto si vedeva: a trentasei anni aveva perso quasi tutti i denti , era diventato obeso e flaccido, e pe r nascondere il cranio comple tamente calvo doveva r icorrere alle par rucche , di cui possedeva u n a collezione. Secondo alcuni clinici che h a n n o studiato il suo caso, doveva t ra t tars i di u n a malat t ia vene rea di cui forse non si era accorto. Certo, gli effetti si rivelavano devastatori, e non soltanto nel fisico. Dopo il Guglielmo Teli, che già gli era costato uno sforzo per lui abnorme, non gli era riuscito comp o r r e quasi più nulla, e agli amici che lo sollecitavano dava risposte evasive e contraddi t tor ie . A Pacini scrisse che un 'epoca dominata dalla rapina, dalle barricate e dalle macchine a vapo re (quel malede t to t reno!) n o n offriva motivi a u n a musica come la sua ispirata al sent imento e all 'ideale, che a dire il vero non erano le sue note dominant i . A Wagner disse che quaranta ope re in m e n o di venti anni d a n n o un certo diritto alla stanchezza. Forse la confessione più sincera fu quella che fece al t enore Donzelli: «La musica vuol freschezza d ' idee, io non ho che l anguore e idrofobia». La meravigliosa vena di cui i l m o n d o n o n aveva mai conosciuto l'uguale, si era improvvisamente inaridita.
Con t ro quel disfacimento che d u r ò oltre q u a r a n t a n n i e
432
si concluse q u a n d o lui ne aveva settantasei, Rossini badò a salvate a l m e n o il pe r sonagg io , e in ques to fu a d d i r i t t u r a eroico. Lombroso dice che la sua nevrastenia degene rò a un certo p u n t o in vera e p ropr ia follia, ma forse esagera, e com u n q u e nessuno se ne accorse perché , secondato dalla vigile Olimpia, egli riuscì sempre a copr i re i suoi to rment i con una maschera di amabilità e perfino di b u o n u m o r e . Un nulla bastava a sconvolgerlo, l ' insonnia lo rodeva, spesso n o n trovava la forza di alzarsi e restava a covarsi nel letto le sue angosce. Ma in pubblico rimetteva, con la par rucca , la maschera del Rossini g a u d e n t e . Mai un accenno alle p r o p r i e condizioni, mai una concessione al compat imento di se stesso, mai - sembrava - un r impian to pe r quello ch ' e ra stato. I l g r ande maest ro del l 'opera buffa sentiva di n o n poter diventare, come Beethoven, un personaggio di tragedia, e restò fedele al p ropr io reper tor io . Cosa provasse, q u a n d o sedeva a l p i ano pe r cercarvi i nu t i lmen te qua lche melodia , nessuno Io sa, pe rché a nessuno mai lo confidò. Agli occhi del m o n d o , pe r p u d o r e e coerenza, r imase come i l m o n d o lo vedeva e lo voleva: il pad re di Figaro, il re dell'allegria.
Q u a n d o nel '55 si r iaccasarono definit ivamente a Parigi, egli vi r ip rese la sua pa r t e di «vedetta» e, sotto la sapiente regìa di Olimpia, i «sabati musicali» di casa Rossini d ivennero u n a delle grandi attrazioni della città. Rossini vi si p reparava come un at tore a u n a «prima», s tud iando le «battute» da s fornare nel la conversaz ione . U n a volta, a l n ipo te di Meyerbeer che gli chiedeva un pa re re sulla marcia funebre composta pe r la mor t e dello zio, rispose: «Graziosa, graziosa. Ma sarebbe stata migl iore se l 'avesse compos ta tuo zio pe r la mor t e tua». Di Wagner : «Eh, certo, ci fa passare dei g ran bei moment i , ma anche dei g ran brut t i quar t i d 'ora». Degli altri g r and i del suo t e m p o : «Prendo Bee thoven d u e volte la se t t imana, H a y d n qua t t ro , e Mozar t tut t ' i giorni». Delle p ropr ie opere : «Quella che preferisco resta il Don Giovanni di Mozart». Q u a n d o gli ch iedevano come mai n o n componeva più nulla, r i spondeva con un sospiro: «Che vo-
433
lete, da giovani si lavora p e r la gloria, da vecchi p e r i figli. Io, figli n o n ne ho...», avallando così la menzogna del Rossini pigro, vocato all'ozio e ai piaceri della vita: la buona tavola (i famosi Toumedos-Rossini), i buoni vini, la bella conversazione: lui che, partiti gli ospiti, passava il resto della settimana a lottare contro l 'insonnia, l ' inappetenza e le angosce.
Morì alla fine del '68, Cavaliere della Corona d'Italia, di un'Italia di cui egli aveva seguito la nascita solo sui giornali, e forse senza mol to interesse. B u o n a g u a r d i a n a anche del suo cadavere, Olimpia lo fece seppellire al Pére Lachaise vicino a Cherubini , Chopin e Bellini, del quale era stato amico e pro te t to re . Il suo ul t imo «sabato musicale» si svolse lì, davanti a u n ' e n o r m e folla, ed ebbe a protagoniste le più belle ùgole del m o m e n t o : la Patti, Alboni, Nilson, Tambur in i , Faure. Olimpia si era riservata un lòculo accanto al suo. Ma q u a n d o Firenze chiese le sue spoglie pe r tumular le accanto a quelle di Machiavelli, Michelangelo e Galileo, consentì alla traslazione, r imandando la pe rò alla p ropr ia mor te .
La valutazione de l l 'opera artistica di Rossini la r imet t iamo ai competent i . Sulla ricchezza, freschezza e spontanei tà della sua vena n o n ci sono controversie, come non ce ne sono sulla sua abilità tecnica. La sua «presa» sul pubblico è documenta ta dai parer i di uomini che n o n e rano di certo facili a subirla. Stendhal era pazzo di lui. Hegel scriveva alla moglie che n o n si sarebbe mosso da Vienna finché avesse avuto i soldi p e r a n d a r e a tea t ro a sent i re Rossini. S c h o p e n h a u e r curava le p rop r i e crisi d ' ipocondr ia s u o n a n d o sul flauto le arie di Rossini. Di queste entusiastiche test imonianze si pot rebbero r iempire pagine su pagine.
Le opinioni discordano quanto all 'influenza ch'egli esercitò sugl'indirizzi fondamental i della musica del suo t empo . Qua lcuno dice ch'egli aprì nuove strade, che pe r esempio la Gazza ladra precorse il verismo di Puccini e di Mascagni, che senza il Guglielmo Teli Meyerbeer n o n sarebbe esistito o sarebbe stato diverso da quello che fu. Può darsi . A noi sem-
434
bra tuttavia che Rossini segni più la chiusura di un per iodo che l'inizio di un al tro. Egli appa r t i ene più al Sette che all 'Ottocento anche pe r ragioni anagrafiche in quan to la sua ca r r ie ra si concluse p ra t i camente nel '30, cioè p r ima della g r a n d e venta ta romant ica: lo d imost ra i l culto che nut r iva per Mozart. Anche la sua musica di maggiore impegno conserva qualcosa di rococò e resta inseparabi le dalla cipria e dalle par rucche . Aveva o r ro re della rapina, delle barricate e del vapore perché turbavano la sua musa ch 'era la «grazia», e la grazia era u n a musa settecentesca.
Qualche riforma la introdusse. Per esempio la tradizione esigeva u n a net ta separazione di stili fra l 'opera buffa e l'ope ra seria: la p r ima doveva essere tut ta car icature e risate, la seconda tutta solennità e lacrime. Rossini cercò di fonderli con molti accorgimenti, fra cui quello di affidare in un 'ope ra seria come il Mose la pa r te di protagonista a un basso, che secondo la convenzione poteva farla solo nel l 'opera buffa. Fu lui che col Guglielmo Teli per la p r ima volta introdusse nell 'orchestra la cornetta. Fu lui il p r imo che riuscì a imbrigliare i capricci vocali dei cantanti scrivendo le «fioriture» e quindi impedendogl i d ' improvvisarle, cosa che Stendhal gli r improverò come un at tentato all 'estro e alla fantasia del bel can to i ta l iano. Fu lui a d a r e magg io r spazio a l l 'orches t ra chiamandola ad accompagnare anche i recitativi e allargando la par te degli s t rumenti a fiato.
Ma si t ra t tava di migl ior ìe , n o n di r ivoluzione. Rossini n o n fu un innovatore perché il nuovo n o n lo sentiva, né nell 'arte né nella vita. La sua lira non vibrò alle grandi emozioni e alle g rand i passioni del suo t empo perché a queste era refrat tar io egli stesso. Con la s tupidi tà che accomuna tutt i gli squadristi di qualsiasi epoca e di qua lunque professione ideologica, anche la più sacrosanta, alcuni volontari del '49, pa s sando sot to le sue finestre a Bologna, lo insu l t a rono ch i amando lo «reazionario». Nel significato ch'essi le at tr ibu ivano , l 'accusa e ra insensata. Ma u n a sua veri tà l 'aveva. Volendogli da re a tutti i costi u n a qualifica storica, possiamo
435
dire che Rossini fu il mùsico della Restaurazione. Non lo sapeva , e n e m m e n o sapeva che cosa la Res tauraz ione fosse, perché alla politica era comple tamente estraneo, la considerava u n a fonte di squilli assordant i e di b ru t t i inni , cioè di cacofonìe. Ma c e r t a m e n t e egli a p p a r t e n e v a a l m o n d o dei Re, dei Principi, delle par rucche , dei merlett i e dei teatri di Cor te che Met tern ich aveva r i e sumato , e pe r ques to si e ra t rovato tanto bene a Vienna e Vienna aveva spasimato pe r lui.
I l Risorgimento insomma non p u ò annoverar lo n e m m e no fra i suoi p r ecu r so r i : n o n lo p rev ide , n o n lo p resen t ì , n o n lo sentì . Nessun c a r b o n a r o a n d ò sulla forca e ne s sun garibaldino all'assalto canticchiando o fischiettando u n a sua aria. I l Risorg imento a p p a r t i e n e tu t to in te ro a Verdi , alle sue t rombe, alle sue marce, e anche al suo me lodramma.
CAPITOLO QUARANTESIMO
IL «GIALLO» DI MODENA
Se i moti italiani del '20-'21 cominciarono in Spagna, quelli del '31 cominciarono in Francia.
Grazie alle sue r isorse mater ia l i e mora l i , ques to Paese aveva fatto presto a risollevarsi dal salasso di sangue che Napoleone gli aveva inflitto con le sue cont inue g u e r r e e dalla batosta di Water loo che le aveva concluse. E via via che le sue energie si r ides tavano, cresceva i l ma lcon ten to p e r un regime che, oltre tut to, aveva il grave tor to di essergli stato imposto dal nemico trionfante. I l re Luigi X V I I I n o n aveva fatto nulla pe r preveni re questo disagio. Aveva res taurato il vecchio r eg ime come se la r ivoluzione n o n fosse mai avvenuta , e suo fratello che gli e ra successo col n o m e di Carlo X batteva la stessa strada, u n a s trada che n o n poteva condurre che alla crisi. Q u a n d o questa scoppiò, nel luglio del '30, Carlo credet te di poter la risolvere con un i r r ig idimento dell 'assolutismo e misure di polizia. Il popolo di Parigi rispose con le barricate, e a Carlo n o n rimase che l 'abdicazione.
Dominata dal l 'e lemento borghese che aveva molto da riguadagnare , ma anche parecchio da pe rde re , la rivoluzione n o n volle c o r r e r e t r o p p i rischi, e alla Repubbl ica prefer ì u n a m o n a r c h i a cost i tuzionale inca rna ta in quel Fi l ippo d 'Or léans , che abbiamo già incont ra to a Pa lermo, q u a n d o c'era anda to pe r impa lmare Amalia, f igl ia di Fe rd inando e di Maria Carolina. Issato sul t rono dalla g r ande onda ta liberale, egli dovette soddisfarne le più pressanti esigenze: u n a Costi tuzione che istituiva un reg ime rappresenta t ivo di cara t tere par lamentare , il r iprist ino del vecchio glorioso tricolore al posto del vessillo bianco crociato dei Borbone, e una
437
politica estera in net ta antitesi con quella delle Potenze reazionarie della Santa Alleanza. Ques t 'u l t ima si t radusse nel principio del non- intervento , con cui la Francia s ' impegnava a impedire , anche con la forza, le interferenze di u n o Stato nelle faccende in terne di un altro Stato. Era insomma la sconfessione della politica che Met te rn ich aveva pra t ica to dieci anni p r ima contro Napoli e il Piemonte.
Gli effetti di ques ta presa di posizione, che faceva della Francia l'alta pa t rona dei moviment i rivoluzionari europei , s i v idero subito. Insu r rez ion i scopp ia rono un po ' d a p p e r tu t to , ma specia lmente in Belgio e in Polonia. Per coordi narl i , a Parigi s 'era formato un Comi ta to Cosmopol i ta , in cui gli esuli i taliani avevano g r a n p a r t e anche p e r c h é e ra domina to dal l ' indomabile Buonar ro t i , di cui esso fu anzi il canto del cigno. Il vecchio t r ibuno n o n perse t e m p o a redigere un proc lama e un p iano d 'azione. I l p roc lama diceva: «Cadano i t iranni, s ' infrangano le corone, e sulle m i n e loro sorga la Repubblica italiana u n a e indivisibile dalle Alpi al mare» . I l p i ano e ra che u n a legione di esuli pene t rasse in Savoia dove, secondo Buonar ro t i , i l popolo sarebbe immedia tamente sorto in armi appiccando un incendio che si sarebbe p ropaga to fino alla Sicilia. I francesi avevano dato la loro adesione, anzi s ' impegnavano a cedere a questa Italia uni ta e repubbl icana la Corsica in cambio di Nizza e Savoia.
In realtà questi francesi e rano soltanto il vecchio generale Lafayette, carico di gloria, ma anche di arteriosclerosi, e ormai r idot to a u n a pa r t e di «venerabile». Egli n o n sapeva nulla delle cose nostre, ma non molto di più ne sapeva Buona r ro t i , d i cui ques to p i ano d imos t r a n o n la «generosità» - come dicono alcuni storici -, ma la faciloneria e il retorico massimalismo. Ad esso tentò invano di oppors i il Poerio, reduce dalla galera e dalle esperienze napole tane del ' 21 . Via via che parlava - e parlava benissimo -, Buonar ro t i lo guatava con occhi carichi d 'odio m o r m o r a n d o : «E lui, tut to lui, anche nei gesti e nella voce: quella canaglia di Mirabeau». Erano trascorsi quasi quaran t ' ann i , ma l 'inguaribile giacobi-
438
no era r imasto a Mirabeau, i l g r a n d e antagonis ta di Robesp ie r re . La r ivoluzione italiana, pe r lui, n o n poteva essere che un poscritto di quella francese dell '89.
Senonché le notizie dall 'Italia n o n e rano affatto incoraggianti. Cha teaubr i and , che vi si trovava come diplomatico, scriveva: «C'è un diffuso malcontento , che pe rò n o n arr iva fino alla cospirazione». Il giudizio n o n è del tut to esatto perché di cospirazione ce n 'era . Ma la drastica repress ione seguita ai moti del '21 l'aveva r idot ta al lumicino, m a n d a n d o sulle forche i più attivi protagonisti , o relegandoli in galera, o cos t r ingendol i al l 'espatr io. Più che sulle p r o p r i e forze, i patrioti contavano sul solito Messia o demiu rgo . Si parlava con insistenza dei discendenti di Napoleone . Ce n ' e rano parecchi a giro pe r l'Italia pe rché quasi tutta la famiglia Bonapar te vi si e ra accasata e partecipava at t ivamente alle vicende politiche locali. Elisa Baciocchi, l 'ex-regina di Etruria , riponeva le sue speranze nel figlio stesso de l l ' Impera to re , il Duca di Reichstadt, tu t tora ostaggio di Vienna, e a n d ò addir i t tura a par largl iene. Ma quel giovane di scarsa grinta e di salute malferma, in cui di suo p a d r e n o n riviveva nulla, e ra cresciuto come un Principe austriaco, e ormai tale si sentiva. Sicché le attese f inirono p e r concent ra rs i su un al tro Napoleònide , Carlo Luigi, i l futuro Napoleone I I I , figlio di Luigi Bonapar te , ex-Re d 'Olanda, e di Ortensia di Beauhar-nais: un ragazzo di ven t ' ann i , da l ca ra t t e re inqu ie to e avven tu roso , ossessionato dalla gloria del g r a n d e zio e dall 'ambizione di emular lo . Alla notizia delle barr icate di Parigi, aveva sperato di po te r r ien t ra re in Francia. Ma Luigi Fil ippo si e r a affrettato a con fe rmare il b a n d o alla famiglia B o n a p a r t e , e n o n aveva to r to p e r c h é ques to n o m e stava sempre più r iacquistando fascino sui francesi, e Carlo Luigi Napo leone era alla ricerca di occasioni pe r farlo r i suonare . Perciò si e ra avvicinato ai patrioti italiani di Roma e partecipava ai loro complott i . Nel d icembre del '30 ne organizzar o n o u n o assolutamente fantapolitico: impadroni r s i d i sorpresa di Castel Sant 'Angelo, proc lamare decaduto il gover-
439
no pontificio, affidare il po te re allo stesso Carlo Luigi Napoleone come Reggente, eppoi consegnarlo al Duca di Rei-chstadt dopo averlo rapito a Vienna. Le autori tà lo r iseppero subito e sì affrettarono a sfrattare i congiurati , fra i quali c 'era anche Maroncel l i , da poco l iberato con Pellico dallo Spielberg. Luigi Napoleone fu rispedito con sua m a d r e a Firenze, ma non per questo smise di complot tare: era in contatto con la Carboneria , anzi pa re che vi fosse stato regolarmente iniziato.
Ques t i in t r igh i p iu t tos to di le t tanteschi d i m o s t r a n o la fondamentale debolezza di un rivoluzionarismo in attesa di u n a soluzione dal di fuori. Si r ivolgevano a un Napoleone un po ' nella ingenua speranza che quel fascinoso nome bastasse a compiere il miracolo, un po ' perché Santi indigeni a cui votarsi n o n ne avevano. La reazione dei Principi italiani alle bar r ica te di Parigi e ra stata d ' i r r i g id imen to . Siccome tutti , salvo forse il Granduca di Toscana, si reggevano sulle baionette austriache, si sentivano minacciati dal principio di non- intervento che li privava di quella garanzia. Ma a spingere la loro avversione al n u o v o reg ime francese sino alla furia e all'invettiva furono p ropr io i d u e Principi su cui, dopo la catastrofe napoleonica, si e rano appun ta t e le speranze dei patrioti .
Il p r imo fu Carlo Alberto che, in una lettera a Carlo Felice, auspicava una spedizione militare «contro questo scellerato, codardo e infame Orléans», e vi si prenotava. Il povero Car ignano non si era ancora riavuto dal t r a u m a del ' 2 1 , q u a n d o aveva t emuto di essersi giuocato il t rono pe r le sue connivenze coi liberali. Ma forse a fomentare in lui lo zelo assolutistico influiva la conco r r enza del Duca di M o d e n a , che aveva scritto anche lui a Carlo Felice u n a le t tera indignata, in cui gli annunziava che aveva r imanda to al nuovo Re di Francia, senza n e m m e n o aprirla, la lettera che questi gli aveva spedito; e che, siccome Metternich gli aveva consigliato maggior p r u d e n z a , lui gli aveva risposto che un Sovrano posto sul t rono da Dio n o n poteva accettarne u n o po-
440
stovi da suddit i ribelli. Diceva tut to questo come se il Re di Francia fosse stato lui, e Luigi Filippo il Duca di Modena . Ma Car lo Felice lo congra tu lò v ivamente d icendogl i che r impiangeva di n o n poter imitare il suo gesto perché la geografia n o n glielo consentiva. Ques to car teggio a t re d imostra che la part i ta per il t rono di Sardegna era ancora aperta, o a lmeno tale la consideravano il duca Francesco che non aveva cessato di aspirarvi , e Car lo Alber to che n o n aveva cessato di t emere ch'egli vi aspirasse. Ent rambi cercavano di guadagnars i i favori di Carlo Felice, mostrandosi più assolutisti di lui e l 'uno dell 'altro.
E p p u r e , fu p ropr io in nome del Duca di Modena che si annodò la congiura destinata a sfociare nei moti del ' 31 . E qui si ent ra in u n a delle vicende più misteriose del pre-Risorgimento , un autentico «giallo».
Nella pr imavera del '26 aveva fatto la sua comparsa negli ambienti degli esuli italiani di Parigi un avvocato modenese , Enrico Misley. Diceva che il movimento nazionale n o n aveva possibilità di successo se non appoggiandosi su un Principe autorevole e risoluto, disposto ad assumerne la guida, ma che questo Principe c'era: Francesco IV di Modena.
Gli esuli t rasecolarono. Su Francesco i patr iot i avevano effettivamente appun ta to gli occhi dopo il crollo del sistema napoleonico perché , p u r essendo un Principe austriaco, era di sangue mezzo italiano pe r via della m a d r e Este, in Italia era nato e cresciuto e quindi si poteva anche sperare che ne avrebbe fatto gl'interessi. Ma q u a n d o lo videro all 'opera nel suo Ducato, fecero presto a ricredersi . Era stato lui a istaur a r e il r e g i m e p iù re t r ivo . Era stato lui a p r o n u n c i a r e al Congresso di Verona del '22 la più feroce requisitoria cont ro i liberali: così feroce che lo stesso Met tern ich gli aveva dato sulla voce. Sua era stata la repressione più spietata. Suo era il mot to: «Cristo in cielo, io quaggiù», pe r dire che non accettava limiti al suo assoluto potere . Sua la massima: «Meglio un innocente sulla forca che un reo in libertà». Sua la
441
risposta a quelli di Brescello che gli ch iedevano argini pe r di fenders i dal Po in p iena: «Un n ido di ca rbonar i come il vostro paese è meglio che vada sommerso». Tutti sapevano che questo campione «d'astuta ignoranza, d u r o il viso, i modi, la voce, cupo e come convulso» faceva staffilare i sudditi che osavano impor tunar lo pe r strada con qualche supplica, e che speculava sulla loro fame incet tando il g rano nelle carestie e r ivendendolo a prezzi maggiorati . Ma Misley diceva che questa era la maschera di Francesco, il suo alibi nei confronti dell'Austria. In cuore, covava ben altro: covava l 'amore pe r l'Italia.
Nessuno saprà mai se Misley fosse in buona fede e fino a che pun to fosse autorizzato a quegli scandagli. Uomo di bella presenza e di parola facile, ma provincialmente vanitoso e ambiziosissimo, pa re che da giovane avesse f requen ta to l 'ambiente carbonaro , dove conservava parecchie amicizie. C o m e fosse en t ra to in r a p p o r t i col Duca, n o n sì sa. Il biografo di Francesco, Galvani, dice che se ne guadagnò le grazie q u a n d o gli confessò spon taneamente le sue passate propensioni liberali, vi abiurò e gii «promise d ' indagare e rifer i re i segreti dei comitati di L o n d r a e di Parigi coi loro piani sull'Italia», insomma quando gli si offrì come spia.
N o n vogl iamo e n t r a r e nei det tagl i d i ques to t enebroso affare, sul quale tut te le ipotesi sono lecite. Ci l imit iamo a enunciare quella che ci sembra la più fondata. Le cose n o n e rano anda te come dice Galvani, apologeta del Duca. Dapprincipio Misley fu un u o m o d'affari di Francesco, che di affari ne aveva molti. Piccolo borghese di provincia, era molto lusingato della fiducia che il Principe gli accordava e probabi lmente sognò di d iventa rne l 'eminenza grigia, solleticand o n e l 'ambizione, che era quella del t r ono di Sardegna . E qui, molte cose lasciano credere che ci sia stato, fra i due , un equivoco. I l Duca, n ipote di Carlo Felice pe r pa r te di moglie, pensava a quella corona come a un fine; Misley ci pensava come a un mezzo pe r unificare sotto di essa tutta l'Italia. Per realizzare quest 'ul t ima impresa, ci voleva la collabo-
442
raz ione dei pa t r io t i , e la sua missione consisteva a p p u n t o nel tastarne il polso.
Che il Duca consentisse, lo dimostra la libertà con cui Misley par lava di questi compromet t en t i contatt i nelle lettere scritte da Parigi a un suo amico di M o d e n a che dappr inc i pio, nel r iceverle, dovet te t r e m a r e p e r c h é e ra noto che la polizia le apriva. In esse l'avvocato raccontava con evidente compiacimento i suoi colloqui con Sismondi, con Constant , con Lafayette ed altre vedette della politica europea . «Di' a mia m a d r e - si legge in una di esse - che ha un figlio che la dovrà far insuperbire.» Ma c'è un episodio ancora più rivelatore. Siccome il comitato di Parigi si mostrava sempre più diffidente nei suoi confront i , Misley si rivolse a quel lo di L o n d r a attraverso un fuoruscito suo compaesano, Manzini, che aveva tutte le carte in regola, e questo in termediar io se lo condusse al seguito a Modena , dove n o n solo n o n ebbe noie, ma fu subito ricevuto dal Duca, cui riferì che il Comitato era p ron to a spalleggiarlo pe r unificare l'Italia, non già per allargare i suoi Stati. E anche qui l 'allusione al t rono dì Sardegna è evidente.
Negli ambient i liberali di M o d e n a questi contatt i e r ano r i saput i e des tavano perpless i tà e diffidenze. Il Duca n o n aveva addolcito il suo regime, anzi aveva chiamato presso di sé come consigl iere quel l ' infame Canosa che , band i t o da Napoli, era stato espulso anche dalla Toscana pe r le sue mene reazionar ie . Misley diceva che Canosa serviva a Francesco di «copertura» nei confronti dell'Austria. Ma questo era falso perché era stato p ropr io Metternich, che lo detestava, a far al lontanare Canosa da Napoli. Molto più verisimile appare che fosse Misley a servirsi della «copertura» di Manzini per accreditarsi presso i liberali. E a questo scopo cercò l'avallo di una personalità ancora più insospettabile di Manzini: Ciro Menott i , un industr iale di Carpi , che già aveva subito la pr igione pe r carbonarismo.
U o m o ones to , ma d i un c a n d o r e che sconfinava nella sprovvedutezza, Menot t i si en tus iasmò dell ' idea e si lasciò
443
c o n d u r r e dal Duca. Cosa si dissero, n o n si sa. Il Galvani afferma che anche lui accettò di fargli da spia. Questo è in antitesi n o n solo col cara t tere del personaggio , ma anche coi fatti. U n a cosa sola si p u ò di re con certezza: che da questo m o m e n t o Menotti si gettò nell ' impresa con a rdore e la condusse da u o m o convinto di avere il Duca dalla sua. Andò a Bologna , a Forlì, a R a v e n n a p e r riallacciare i conta t t i coi vecchi Cugini e stabilire un p r o g r a m m a di azione comune . Incon t rò molte difficoltà pe rché in questi centr i Francesco lo conoscevano meglio che a Parigi e a Londra , tanto che a Bologna Menot t i corse r ischio di essere assassinato come agen te provoca tore . Ma il suo entus iasmo era tale che finì pe r vincere le altrui diffidenze. Solo Firenze vi si d imost rò refrattaria: e ra diffìcile i n d u r r e i toscani a bara t ta re il loro Leopoldo con Francesco. Capponi rispose, profet icamente: «Signor Menot t i , vi a m m i r o e vi c o m p i a n g o : voi sare te la vittima del Duca di Modena». Tuttavia anche lì u n a recluta la fece: Luigi N a p o l e o n e , s e m p r e alla r icerca di occasioni pe r mettersi in vista agli occhi dei francesi.
Dopo o g n u n o di questi viaggi, tornava a Modena a rifer i r n e a Francesco, presso cui occupava o ra il posto di Misley, quasi s empre in missione all 'estero. Il Duca ascoltava, approvava, o pe r lo m e n o n o n dava segno di d isapprovare . Se si p roponesse di s trumental izzare il moto rivoluzionario pe r accrescere i p rop r i domini , o se fin d'allora mirasse solt an to a p rocu ra r s i informazioni p e r p o t e r colpi re , a l mom e n t o o p p o r t u n o , con magg io re efficacia, è difficile d i re . Ma, da to il tipo, la seconda ipotesi è più verisimile della prima. Nel '29, pe r la mor te di sua m a d r e Ricciarda, aveva arro tonda to i suoi Stati con Massa e Car rara , rinforzava i servizi di polizia e si teneva in s tret to conta t to epis tolare con Car lo Felice cui, ch iedendog l i in pres t i to alcuni c annon i , scriveva: «So che me la vogliono fare, ma essi mi t emono e io non temo affatto loro».
Secondo Misley e il suo biografo Ruffini, il Duca fu in b u o n a fede fino alla rivoluzione francese di luglio. Que l ri-
444
volgimento ne provocò u n o anche in lui e lo r isospinse in braccio al reazionarismo. Misley ne ebbe sentore, e da Parigi p iombò a Modena, dove un colloquio col Duca confermò i suoi t imori . Ne avvisò Menott i , ma questi - dice Ruffini -non c i credet te , un po ' pe rché n o n voleva crederci , un po ' p e r c h é i fatti gli d imos t ravano il cont ra r io . Ch'egl i p r epa rasse l ' insurrezione era noto a tutti, e tutti in città ne parlavano. La sua casa «parea una borsa di negozianti: chi andava, chi veniva sì di g iorno che di notte , la scuderia sembrava u n o stallatico. Tutte le armi da caccia a due , a quat t ro colpi, fucili, pistole t rovate presso i mercan t i di M o d e n a furono compra te in pochi giorni. La città tutta e i paesi circonvicini echeggiavano rivoluzione. Le d o n n e in molte case, senza riguardo , si occupavano di sciarpe tricolori e di coccarde». La polizia n o n poteva ignorarlo. Eppure , non interveniva.
La data fissata era il 5 febbraio (del '31). Gl'insorti sarebbero scesi in piazza al gr ido di: «Viva Francesco IV e mor te ai suoi ministri!», m e n t r e da tutti gli altri centr i del Ducato le colonne dei congiurat i si sarebbero messe in marcia sulla città. Il Duca sarebbe stato messo al bivio: o darsi prigioniero della r ivoluzione, o a s s u m e r n e il p a t r o n a t o e marc ia re con essa alla conquis ta degl i Stati vicini. Ma Menot t i e ra convinto che il Duca avrebbe scelto la seconda alternativa, e di questa certezza aveva contagia to tutt i gli altri . A Parigi, dov 'e ra r ien t ra to , Misley avrebbe assicurato l ' appoggio sia del Comitato, che degli ambienti liberali francesi.
Ma la matt ina del 3 ci fu un fatto nuovo e inatteso: la polizia arrestò alcuni capi della congiura ed espulse dal Ducato alcuni sospetti , fra cui i genera l i Zucchi e Fontanell i , le due personali tà di maggior prestigio. I l colpo era grave pe r gli uomini raccolti in casa Menotti - una quaran t ina -, convinti come lui di avere il Duca dalla loro. E fu forse pe r prevenire una loro diserzione che Ciro decise di precipi tare gli eventi. Stavano p r e n d e n d o gli ultimi accordi, q u a n d o i soldati bussarono alla por ta e in t imarono la resa. L'edificio era c o m p l e t a m e n t e c i rcondato e già sotto la mi ra dei cannon i
445
prestati da Carlo Felice. A dir igere l 'operazione era il Duca in persona , che aveva al suo fianco Canosa, inebriato dalla prospett iva di un massacro di «giacobini».
Persi p e r pers i , i cong iu ra t i dec isero di v e n d e r cara la pelle, e al l ' int imazione r i sposero con un nu t r i to fuoco che stese mor t i a lcuni g e n d a r m i . La fucileria d u r ò pa recch ie ore . A un certo p u n t o Menotti , n o n si sa se pe r un tentativo di scampo o di diversione, si bu t tò a co r re re pe r i tetti, ma fu ferito e cadde pe r strada. Gli altri segui tarono a spara re finché il Duca diede la parola al cannone che in d u e bordate demolì l'edifìcio e costrinse gl'insorti alla resa. Il Duca si prec ip i tò ne l l ' appa r t amen to e lo perquis ì di pe r sona . Eviden temen te , voleva impadronirs i dei carteggi.
Era convinto di aver l iquidato la rivolta, tan t ' è vero che chiese al governatore di Reggio di mandargl i subito il boia. Ma le notizie che frattanto arr ivavano a palazzo n o n e r ano mol to rassicurant i . Dai paesi circonvicini, g r u p p i d ' insort i marc iavano su Modena , e i r epa r t i regolar i , invece di fermarli, se ne lasciavano disarmare . Francesco pe rò confidava nella sua a rma segreta: le t r u p p e austriache del Lombardo -Veneto di cui aveva già sollecitato l ' in tervento . Ma l ' indom a n i il cap i tano a cui aveva affidato l 'ambascer ia t o r n ò a mani vuote: pe r strada i rivoltosi gli avevano sequestrato la risposta del generale Fr imont , che pera l t ro era negativa: i l comandan te austriaco si rifiutava di m a n d a r e t r u p p e oltre i confini senza un esplicito ord ine di Vienna. E a p p u n t o perché avevano saputo di questa risposta, gl ' insorti seguitavano a marc i a re /R i so lu to anche nella codard ìa , i l Duca n o n pose t e m p o in mezzo a mettersi in salvo oltre il Po. Ma, insieme alla famiglia, si por tò al seguito il principale ostaggio. E chiaro che aveva p a u r a dei segreti di Menott i . E p rop r io questo segnava irrevocabilmente la sorte del pr igioniero.
Così la rivoluzione, che credeva di aver perso, si trovò invece vincitrice e p a d r o n a della città. Essa liberò i compagni di Ciro e gli altri detenut i , p iantò sulla cittadella il tricolore, e is taurò un governo provvisorio di cui Reggio si d ichiarò
446
solidale, e di cui l 'avvocato Nard i fu l 'anima, ma un ' an ima e s t r e m a m e n t e incer ta e t imora ta , che di u n a cosa sola si p reoccupò: di d isarmare l'ostilità dell'Austria, d imos t randosi rispettosissimo del l 'ordine costituito e qu indi combat tendo e smorzando lo slancio patriottico e libertario.
Questi bravi rivoluzionari, in fondo, non avevano r inunziato alla speranza di far la r ivoluzione d 'accordo coi gendarmi .
CAPITOLO QUARANTUNESIMO
LA R I V O L U Z I O N E MANCATA
Il contagio fu fulmineo. Appena r isapute le notizie di Modena, quelli di Parma si
rovesciarono in piazza e vi t u m u l t u a r o n o al gr ido: «Viva la Duchessa , m o r t e a Werklein!» Werklein e r a l ' uomo che , mor to Neipperg , ne aveva assunto presso Maria Luigia tutte le funzioni, m e n o quelle coniugali, ma senza possedere le qual i tà del suo p redecesso re . Era un colonnel lo aust r iaco d u r o , freddo, sussiegoso, privo di tatto e di fiuto e, a quanto p a r e , abbas tanza dis involto in fatto di qua t t r in i . I d i m o stranti chiesero alla Duchessa di licenziarlo e di concedere u n a Costituzione. Spaventata e piangente , Maria Luigia annunz iò che sarebbe par t i ta . E allora tu t ta la città si r iversò davanti al palazzo evocandola al balcone e supplicandola di restare. Essa fìnse di a r renders i , ma d u r a n t e la not te prese la via di Piacenza, l'altra città del suo Ducato, dove l'accolsero con g rande entusiasmo pe r fare dispetto a Parma. A Parma fu istituito un governo provvisorio che ricalcò le o r m e di quello di Modena.
Ma intanto le Legazioni, da sempre ribelli al malgoverno del Papa, avevano preso fuoco. Un fuoco incruento perché , salvo che a Forlì dove ci furono alcuni mort i , tut to si risolse in accordi p iù o m e n o consensual i coi Legat i e Prolegat i , che finirono pe r accettare l'istituzione di governi laici e liberali, d ie t ro garanzia ch'essi avrebbero m a n t e n u t o l 'ordine. E infatti quasi esclusivamente a questo i nuovi regimi pensarono, sordi ai richiami dei pochi che avrebbero voluto dare al mo to un con tenu to e delle prospet t ive nazionali . Fra quest i pochi ci furono il genera le Zucchi che, sloggiato da
448
Reggio dove si e ra rifugiato d o p o l 'espulsione da Modena , e ra accorso a Pa rma , e di qui lanciò il p r o g e t t o d ' is t i tuire una milizia cittadina in difesa delle conquiste realizzate; e il colonnello Sercognani che quel proget to lo t radusse in fatti raccogliendo tremila volontari, occupando alcuni forti e cos t r ingendo alla resa la guarnig ione papal ina di Ancona.
Ma occorreva una volontà politica, e questa volontà n o n c'era. Un'assemblea di «notabili» di tut te le province insorte - Emilia, Romagna e Marche - fu convocata a Bologna, che aveva assunto la funzione di capitale. Qua le spiri to rivoluzionario animasse questi uomin i , lo d imos t ra il fatto che il de lega to des igna to da Recanat i e ra Giacomo L e o p a r d i , g ran poeta, d 'accordo, ma non u o m o da Convenzione. Essi decisero la formazione di un «Governo delle province unite italiane» e ne d e l e g a r o n o la p re s idenza al p iù t imora to di tutti loro, Vicini. Invano Sercognani sollecitava aiuti e l'autorizzazione a marciare su Roma. Bologna rispose, pe r bocca del genera le A r m a n d i , che l ' impresa e r a irrealizzabile. Che lo fosse veramente , c'è da dubi ta rne . L'esercito pontificio era u n ' o r d a di lanzichenecchi buon i soltanto a saccheggiar pollai. E lo stava d imos t rando anche in quell 'occasione. Coi suoi improvvisati manipoli , Sercognani era pene t ra to in U m b r i a senza i ncon t r a r e serie resis tenze. La popolaz ione n o n mostrava molto entusiasmo per i l nuovo regime, ma ne mostrava ancora m e n o pe r quello vecchio. E a Roma il panico dilagava. Ma, invece che ad approf i t ta rne , i rivoluzionar i di Bologna miravano a calmarlo. Pra t icamente essi tenevano i l Prolegato , cardinale Benvenut i , in condizioni di ostaggio, ma lo t rat tavano con tutti i r iguardi . Come potessero i l ludersi che i l Papa consent isse alla p e r d i t a di u n a metà dei suoi Stati, e la più ricca e popolosa, Dio solo lo sa. Ma essi agivano come se nutr issero questa certezza, la quale a sua volta si pasceva di un 'al t ra certezza: che la Francia impedisse l ' intervento dell'Austria. Perciò i loro occhi e rano rivolti a Parigi.
A Parigi gli avven iment i avevano p re so tut t i di con t ro -
449
piede, anche il Comitato. Questo, sapendo di ciò che si p re pa rava a M o d e n a , ne aveva chiesto i par t icolar i a Misley, q u a n d o e ra t o rna to d o p o l 'ul t imo colloquio col Duca. Ma Misley, forse pe r vendicarsi degli affronti fin lì ricevuti, si rifiutò di darli al legando l ' impegno del segreto. Disse soltanto che a Modena i dadi e r ano tratti e le da te fissate pe r far ben capire che la sua congiura n o n in tendeva p r e n d e r e direttive dai fuorusciti. A quan to più tardi rivelò, egli era ormai convin to che l ' insur rez ione dovesse a n d a r e avant i d i forza propr ia , senza il Duca e magari anche contro di lui. E di p r o p r i a iniziativa, si d i ede a raccogl iere a Marsiglia un carico di a rmi per t raghet tar le in Italia.
Q u a n d o giunse la notizia che il tricolore sventolava sulla cittadella di Modena , il solito Buonar ro t i stilò un proc lama che recava il sigillo della sua magniloquenza. Esso spronava gl ' i taliani a sollevarsi in massa con t ro «il t ruce A l e m a n n o che spietato t racanna il vostro sangue e si pasce delle vostre lacrime» (chissà cosa avrà de t to , leggendolo , Vieusseux), e annunziava l ' imminente sconfinamento in Savoia di u n a legione di volontari.
Questi si stavano effettivamente raccogliendo a Lione fra gl ' incoraggiamenti della popolazione e la benevola tolleranza della polizia. Il governo aveva rei terato il suo impegno a impedi re , anche con la forza, qualsiasi in tervento, cioè l'int e rven to dell 'Austria, e ancora il g io rno 24 l 'ambasciatore francese a Vienna ne aveva ammoni to Metternich. I p reparativi fervevano febbrili in un clima d 'entus iasmo, q u a n d o d ' improvviso l 'a t teggiamento delle autor i tà cambiò, anzi si capovolse. Le a rmi vennero sequestrate e i volontari espulsi con foglio di via, sebbene le loro violente proteste trovassero larga eco nella s tampa e nel pa r lamento di Parigi. Cos'era successo?
Era successo che Met ternich aveva risposto a l l ' ammonimen to dell 'ambasciatore facendo pubblicare con g rande rilievo la notizia che u n o dei principali esponent i del Governo delle Province Unite Italiane era Napoleone Bonapar te .
450
N o n era vero. Napoleone si era arruola to nel piccolo esercito di Sercognani , ma poi era stato r ich iamato a Bologna e messo in disparte a p p u n t o perché i dirigenti temevano che la sua presenza alienasse loro la simpatia di Luigi Fil ippo. Questi infatti accusò il colpo, e Metternich ne approfit tò pe r assestargliene subito un altro avanzando pe r la corona del Belgio la c a n d i d a t u r a del Duca di L e u c h t e n b e r g , che poi era il figlio di Eugenio di Beauharnais .
Luigi Filippo capì. Senza neanche informarne il suo Primo Ministro - che, q u a n d o a cose fatte lo seppe , si dimise pe r protesta - fece avvertire Metternich che il principio del non-intervento, in senso assoluto, valeva solo per il Piemonte. Sui Ducati, visto ch ' e rano austriaci, Vienna aveva mano libera. Q u a n t o agli Stati della Chiesa, la Francia auspicava la formazione di un comitato di Grandi Potenze che facesse da media tore . Insomma, era la via libera a quella spedizione punit iva che il Cancelliere aveva già deciso sin dal p r imo giorno.
Di ques to compromesso sotto banco , che n o n faceva di certo onore al nuovo regime francese, in Italia non si seppe nulla. Si cominciò solo a sospettarne quando , all'alba del 25 febbraio, u n a colonna di soldati austriaci traversò il Po e colse di so rpresa la piccola gua rn ig ione nazionale di Fioren-zuola. Il governo di Parma ne fu sgomento . Ma, invece di band i r e l ' emergenza, badò a ca lmare la pubblica op in ione d icendo che l 'atto n o n doveva essere cons idera to ostile in quan to Fiorenzuola faceva par te della provincia di Piacenza, tu t tora sotto la sovranità di Maria Luigia.
Subito d o p o un ' a l t r a co lonna austr iaca mosse su Novi, sulla strada di Modena. Bologna, che vi aveva dislocato u n a piccola gua rn ig ione , le o r d i n ò di r i t i rars i . I l c o m a n d a n t e Morandi , ex-legionario di Spagna, disobbedì e contrattaccò s u b e n d o parecch ie pe rd i t e , ma anche inf l iggendone , e fu deplora to da Bologna dove il governo fece affliggere questo bel manifesto: «Gli affari dei modenesi n o n sono i nostri. Il sano principio di non-intervenzione (sic) impone le sue leg-
451
gi sia a noi che ai nostri vicini». Da buon i italiani, i bolognesi c redevano di salvarsi separando la loro sorte da quella degl'italiani dei Ducati , ed e ra su questa miserabile d ip lomazia, n o n sulla volontà di difendersi , che fondavano le loro speranze . A teat ro si r app re sen t ava con g r a n d e fragore di applausi la Francesca da Rimini del Pellico, e il pubblico scandiva in coro il r i tornello: «Presto all 'armi, corr iamo, c'invita - Lo squillar della t romba guer r ie ra - Presto all 'armi, la nostra bandiera - De' nemici spavento sarà». Ma q u a n d o Zucchi si p re sen tò con set tecento uomin i racimolati alla bell 'e meglio, gl ' imposero di disarmarli pe rché l'Austria n o n se ne sentisse provocata.
Il 6 marzo giunse come una folgore la notizia che, sebbene n o n provocata, l'Austria aveva occupato Ferrara . Quella n o n faceva par te dei Ducati . Faceva pa r t e delle Legazioni , come Bologna. E p p u r e a Bologna dissero che n o n si trattava di atto ostile, ma dell'esercizio di un vecchio diri t to a tene re qualche guarnigione a sud del Po. Non volevano guarda re in faccia la realtà pe rché n o n avevano il coraggio di affrontarla. E r icorrevano a tut to p u r di salvare le loro illusioni, ispirate soltanto dalla irresolutezza e dalla pavidità.
Tuttavia i fatti s embra rono lì pe r lì confermarle: la marcia degli austriaci pe r qualche giorno si fermò. Essa era stata sollecitata dalla Santa Sede fin dalla me tà di febbraio, e nei te rmini più pressanti . A tal p u n t o il Papa si sentiva minacciato che aveva annunc ia to a Metternich l ' intenzione di rifugiarsi a Genova, e il Cancelliere gli aveva risposto consigliandogli, caso mai, Venezia. E ciò d imost ra quan ta ragione avesse Sercognani , che del res to , sebbene da Bologna n o n gli avessero m a n d a t o nes sun r inforzo, segui tava ad avanzare in Umbria .
Metternich n o n aveva mai dubi ta to di dover in tervenire nel le Legaz ioni . I motivi che , d o p o F e r r a r a , g l ' impose ro un r a l l en t amen to , e r a n o d u e . Anzi tut to , doveva r isolvere l 'operaz ione sul p i ano d ip lomat ico p e r c h é la Francia, p e r salvare la faccia, seguitava a sollevare difficoltà all ' interven-
452
to fuori de i Ducat i . I l s econdo e r a n o le esi tazioni di Fri-m o n t che n o n voleva indebo l i r e l e g u a r n i g i o n i del L o m bardo-Vene to dove t emeva lo scoppio d ' u n ' i n s u r r e z i o n e . Ma la Santa Sede insisteva in toni s empre più drammat ic i . Sercognani si e ra spinto fino a Rieti. E vero che n 'e ra stato scacciato da i papa l in i , ma la sua minaccia segui tava a incombere sul l 'Urbe.
Il 20 m a r z o gli austr iaci r i p re se ro la marc ia ca lando su Bologna. Il capo del governo provvisorio, Vicini, che fin allora aveva dato un 'esemplare prova d ' indecisione e incompetenza, offrì a Zucchi i pieni poter i pe r scaricarsene di dosso la responsabilità. Il Generale rispose ch 'era un po ' tardi , ma che il senso del dovere gl ' imponeva di accettare «quant u n q u e senza speranza di successo», e o rd inò il trasferimento del governo ad Ancona pe r da re a se stesso il t empo di ricongiungersi con Sercognani e tentare con lui u n a resistenza. Al m o m e n t o di par t i re lanciò ai bolognesi un proc lama in cui l 'invitava a «cedere con dignità» al l 'occupazione austriaca: invito che, salvo la dignità, si rivelò del tut to superfluo.
Zucchi condusse la sua colonna pe r Imola, Faenza e Cesena, fino a Rimini. Qui seppe che ad Ancona Sercognani , fur ibondo contro quell ' inetto governo, lo aveva destituito e r impiazzato con un t r iunvi ra to mili tare in cui f igurava anche Zucchi. Questi aveva ora ord ina to i suoi uomini su u n a b u o n a linea di difesa, e aspet tava gli austriaci, le cui avanguard ie giunsero la sera del 25. Col favore del buio, mimetizzandosi sotto berret t i tricolori e al gr ido: «Viva gl'italiani, viva la libertà!», r iuscirono a so rp rende re gli avamposti nazionali. Ma Zucchi r imediò subito facendo avanzare l 'artiglieria di cui era specialista, e pe r parecchie ore martel lò il nemico infliggendogli t recento mort i . Si ri t irò solo q u a n d o si accorse che stava pe r essere aggi ra to , ma l ' inattesa resistenza sorprese gli austriaci e r imase l 'unico glorioso episodio di quella confusa e poco esaltante vicenda.
«Ah, se avessi dieci o quindici giorni pe r addes t ra re que-
453
sti focosi ragazzi!» disse il Generale , m e n t r e si ritirava ordina tamente su Pesaro coi suoi repar t i quasi intatti. Stava ormai pe r ragg iungere Ancona e unirsi al l ' indomabile Serco-gnani , q u a n d o a Fano gli si presentò un ufficiale spedito con tan to di lasciapassare da Vicini e compagn i al quar t i e r generale austriaco con un'offerta di resa. Zucchi trasecolò anche pe rché i l messaggero non aveva nessuna comunicazione pe r lui, che credeva di essere uno dei Triunviri , e anzi il p iù autorevole. Invece, nel f ra t tempo, Vicini aveva r ipreso le p r o p r i e funzioni e, consigliato dal genera le Armand i , il qua le andava dal p r i m o g io rno p r e d i c a n d o l ' inutil i tà d i qualsiasi resistenza, aveva alla svelta firmato un armistizio col cardinale Benvenut i , che il governo si e ra por ta to al seguito da Bologna, impegnandos i alla remissione dei poter i alle autori tà pontificie e al d isarmo delle t r u p p e nazionali in cambio d i u n a genera le amnis t ia . Solo Terenz io Mamian i aveva rifiutato la p ropr i a firma su quel d o c u m e n t o qualificandolo «indegnissimo».
Per quan to avvilito e disgustato, Zucchi calmò le ire dei suoi ufficiali che p roponevano di passare pe r le armi i «traditori» di Ancona e di tentare la resistenza a oltranza. Ancora più violenta fu la reazione di Sercognani e dei suoi che p e r Te rn i risalivano verso la costa adriat ica. Ma n o n c 'era nulla da fare con t ro la mental i tà dimissionaria di quel governo.
Gli austriaci n o n r iconobbero l ' impegno preso da Benvenuti di u n a sospensione delle operazioni militari da ambo le pa r t i . Avanza rono su Ancona e l ' occuparono , m e n t r e nel por to si affollavano, in cerca d ' imbarco e di scampo, i r educi di quella disgraziata avventura, fra cui Zucchi e Mamiani. Altri si e rano avviati verso il confine della Toscana; e con essi marciavano Luigi Napoleone e sua madre Ortensia.
E t o rn i amo a Modena , ep icent ro di quel l ' e ruz ione , e al suo protagonista.
Trascinato al suo seguito dal Duca, che a nessun costo voleva farselo scappare, Menott i era stato m o m e n t a n e a m e n t e
454
affidato agli austriaci, che lo avevano rinchiuso nella fortezza di Mantova. Di lì Francesco era part i to per Vienna a sollecitarvi gli aiuti che Fr imont gli aveva nega to . Il 9 marzo , a p p e n a r ien t ra to nella sua capitale al seguito delle t r u p p e austriache, si fece subito r iconsegnare il pr igioniero, lo rinchiuse in un ergastolo sorvegliato da un intero battaglione, e affidò l ' i s t rut tor ia su di lui al p iù malfamato giudice di Modena, Zerbini. Disperata, la moglie del pr igioniero scrisse a Misley, tut tora a Parigi. Misley rispose che aveva già interessato al caso alcuni autorevoli deputa t i francesi, fra cui Lafayette, i quali a loro volta si e r ano impegna t i a interessarne il governo; e c o m u n q u e egli stesso sarebbe r ient ra to in Italia a p e r o r a r e la causa di Menott i presso il Duca «che non è crudele». Il mistero si aggroviglia sempre più. Effettivamen te , alla fine di febbraio, Misley stava p e r t o r n a r e in patr ia , ma p e r a iu ta re la r ivoluzione con un carico d ' a rmi che gli venne sequestrato a Marsiglia. Come potesse pensare di essere ancora nelle b u o n e grazie del Duca, Dio solo lo sa. Pure , gli scrisse veramente sollecitandone la clemenza, e lo fece sapere ai Menott i dicendogli che il Duca n o n avrebbe mai condanna to a mor t e Ciro pe rché pe r ben d u e volte questi gli aveva salvato la vita dalle macchinazioni dei congiurati.
Il difensore che il t r ibunale militare aveva assegnato - di p rop r i a autor i tà - a l l ' imputato era un sot totenente Ricci di scarsa esper ienza giuridica, ma leale e coraggioso. Egli impostò la causa sull ' ipotesi più pericolosa, ma che forse e ra anche la più fondata: quella della connivenza dell 'accusato col Duca. Disse che questi cer tamente n o n aveva inteso servirsi di Menott i per procurars i «un a u m e n t o di dignità e di dominio» (e l 'allusione al t rono di Sardegna era chiara); ma che Menott i invece p r o p r i o a questo mirava, e lo aveva dimost ra to c o n d u c e n d o l ' impresa «con tanta i m p r u d e n z a da n o n nasconder l a all 'occhio vigile della polizia, la quale ne conosceva già l 'origine, l ' a n d a m e n t o e le fila anche p r ima dello scoppio».
455
Le cose stavano p ropr io così. Ma a p p u n t o pe rché stavano p ropr io così, Menotti e ra spacciato. Sapeva t roppo delle intenzioni del Duca. N o n bisognava dargli i l m o d o di rivelarle, mai più. L'osservatore austriaco Marschall - che stava pe r p r e n d e r e il posto di Werklein a Parma - avvertiva Metternich che Francesco conduceva l ' inchiesta a suo arbi t r io sovrapponendosi al t r ibunale cui stava pe r impor r e un verdet to , la cui odiosità sarebbe r icaduta sull 'Austria. Ma n o n ci fu nulla da fare. Cont ro ogni consiglio e r ichiamo di Vienna, Menott i fu avviato al capestro. Mentre aspettava l'esecuzione, venne a fargli compagnia un altro condanna to a morte: Borelli. Era stato il notaio che aveva steso l'atto di decadenza del g o v e r n o ducale . Si sentiva così poco colpevole che, fuggito da Modena , dopo pochi giorni vi e ra r ient ra to di p rop r i a volontà. Invano Marschall cercò di s t r appa re la grazia per en t rambi i condannat i . «Questo non è un Principe - scrisse disgustato a Vienna -, ma un agente provocatore che istiga alla rivolta pe r divertirsi con le forche.»
I d u e infelici sal irono sul pat ibolo il 26 maggio : Borelli con compor tamento fermo e quasi spavaldo, Menott i turbato e recalcitrante. Ma i tribunali con t inuarono a lavorare fino a l '37. Coloro che avevano avuta qualche pa r t e , anche min ima , nel r ivo lg imento , c i pas sa rono tut t i . Tutt i , m e n o u n o : Misley, che n o n fu c o n d a n n a t o n e a n c h e in con tumacia.
Lo condannò viceversa l 'opinione pubblica come spia patentata, e forse non lo era. Ma bisogna dire ch'egli fece ben poco pe r liberarsi di questa taccia. Il suo biografo e avvocato difensore dice che nel '32 egli avrebbe tu t to chiar i to in un volume di memor ie , se i l governo francese, for temente a l larmato (di che?), n o n lo avesse i m m e d i a t a m e n t e sequestrato. Può anche darsi. Ma quelle memor ie avrebbe po tu to pubblicarle a Londra , dove poco dopo si trasferì, e invece se ne astenne. Riprese il proget to , pare , vent 'anni dopo , a Ginevra . Ma n e a n c h e stavolta i l l ibro vide la luce. Probabi l men te , esplicito o implicito, c 'era fra lui e il Duca un pat to
456
che lo impegnava al silenzio. «Se scroccone soltanto, o insieme t radi tore , non sai» scrisse di lui Tommaseo. Arr ivabene e r a incer to : «Mi par lò di sé e de ' suoi passati i ngann i con tanta soavità e tanta mostra di candore , ch'egli è o demonio o santo». Forse il giudizio più esatto è quello di Mazzini che scriveva a sua m a d r e : «Non v'è tan to da p r o n u n c i a r e spia quel signore, anzi noi c redo tale, ma vi è tanto da p r o n u n ciarlo imbroglione e u o m o n o n di veri p ro fondamente radicati princìpi: e basta pe r tenersene discosti».
Probabi lmente quel pasticcione n o n era che u n a vittima dei p rop r i pasticci.
CAPITOLO QUARANTADUESIMO
L'UOMO N U O V O
Immancabi le strascico di tut te le rivoluzioni mancate , un'alt ra onda ta di repressioni si abbatté sull'Italia. Ma n o n tutti, p e r fortuna, imitarono i metodi del Duca di Modena. Maria Luigia, p r ima di r ien t ra re a Parma, ci m a n d ò il suo fiduciario Melegari, un ga lan tuomo che si affrettò a provvedere di passaporto i più compromessi in m o d o che si mettessero in salvo. Nelle reti della polizia n o n caddero che persone di secondo piano, e ci r imasero poco pe rché già in agosto la Duchessa t roncò tutti i processi con un'amnistia.
Il governo pontificio invece perse anche quell 'occasione di d a r e un esempio di carità. I l nuovo pontefice Gregor io XVI, da poco succeduto a Pio V i l i , e ra comple tamente nelle mani del suo Segretario di Stato, cardinale Bernett i , u n o di quegl i «zelanti» che c redevano p iù nella forca che nella croce. Egli n o n volle r iconoscere la convenzione di Ancona stipulata dal cardinale Benvenut i che garantiva l ' immuni tà agl ' insort i in cambio della loro r inunc ia alla resistenza armata. La nave su cui essi si e rano imbarcati venne cat turata da d u e fregate aus t r i ache lanciate al suo i n s e g u i m e n t o . I fuggiaschi furono trascinati davanti a un tr ibunale d'ufficiali e sot topost i a u n o s t r ingen te i n t e r roga to r io . Cercavano Zucchi che - come r i co rde re t e - e r a u n o di quei Genera l i dell 'esercito italico ch ' e rano stati assorbiti in quello austriaco, e figurava ancora nei suoi quadr i , anche se da molti anni era spon taneamente passato nella riserva. Su di lui quindi pendeva l'accusa di t rad imento .
Sebbene provvis to di d o c u m e n t i falsi, Zucchi rif iutò la finzione. «Se cercate il generale Zucchi, eccolo!» disse facen-
458
dosi avanti , e gli ufficiali austriaci si misero sull 'at tenti . Fu spedito in Austria, processato per direttissima e condanna to a mor t e . Ma poi la p e n a fu c o m m u t a t a in quella dell 'ergastolo nella fortezza di Gratz dove rimase diciassett 'anni, fino al '48 . Gli altri furono r inchiusi nel forte di San t 'Andrea a Venezia, e minuz iosamente in ter rogat i . Met te rn ich voleva ricostruire le fila del l ' insurrezione anche pe r vedere se essa aveva avuto addentel lat i nel Lombardo-Veneto. Tutti , comp r e s o il fratello di Menot t i , f o rn i rono la stessa vers ione: ch'essi avevano c redu to di agire in p ieno accordo col Duca di Modena e che questi aveva fatto di tutto p e r incoraggiarli in questa convinzione. Per Metternich fu più u n a conferma che u n a sorpresa. Egli si rifiuto di consegnare a Francesco i pr igionieri modenesi , e u n o alla volta li l iberò.
Papa Gregor io , dal canto suo, aveva già nomina to d u e commissioni d'inchiesta pe r impart i re un castigo esemplare, ma doveva vedersela con una conferenza di ambasciatori istituita a Roma su richiesta della Francia. Violentemente attaccato dall 'opposizione liberale che l'accusava di aver tradito e manda to allo sbaraglio gl'italiani pr ima proc lamando il nonintervento e poi r imangiandoselo, il governo di Luigi Filippo reclamava da quello pontificio l'amnistia, una serie di riforme liberali, e l ' immediata evacuazione dei suoi Stati da par te delle t ruppe austriache. D'accordo con Metternich, Bernetti tergiversava. Alla fine di giugno sembrava che si fosse alla vigilia di una guer ra tra Francia e Austria. Poi Roma cedette, o pe r meglio dire Vienna le impose di cedere. L'amnistia fu concessa e le t ruppe austriache cominciarono lentamente a sgombera re . Q u a n t o alle r i forme, fu più fumo che a r ros to , anche pe rché quello Stato era ta lmente marcio che n e m m e n o volendo sarebbe riuscito a realizzarle. Ma bastò pe r consentire alla Francia di salvare la faccia e di r ip rendere la sua par te di alta pa t rona del liberalismo europeo.
Nel loro insieme, i moti del '31 avevano rappresen ta to più u n o strascico di quelli seguiti al crollo dei regimi napoleoni-
459
ci che l 'inizio di u n a n u o v a è ra r ivoluzionar ia . A ispirar l i e rano state le vecchie società segrete disseminate nella penisola dai francesi e sui modelli francesi ricalcate. Sia come organizzazione che c o m e ideologia , i l segno p iù visibile e r a quel lo impresso da B u o n a r r o t i , u l t imo ost inato r a m p o l l o del vecchio giacobinismo r o b e s p i e r r i a n o . E anche i loro pro tagonis t i come Zucchi e Sercognani e r a n o uomin i formatisi nella Cisalpina e nel Regno Italico. Si trattava insomma ancora, pe r dirla con Cuoco, di u n a rivoluzione «passiva», frutto di un t rapianto .
Ma fra le vittime della repress ione, che ora p r e n d e v a n o la via dell'esilio pe r anda re a infoltire i r angh i dei fuorusciti, c 'era un u o m o nuovo che, anche pe r ragioni di età, con quel passato aveva poco a che fare: Giuseppe Mazzini.
Era na to a Genova ne l 1805, figlio di un medico che in gioventù aveva avuto i suoi slanci patriott ici e f requenta to gli ambienti massonici e carbonari , ma poi era r ient ra to nell 'ordine costituito b a d a n d o sopra t tu t to a farcisi u n a solida posiz ione. N o n e ra affatto un u o m o spregevole : faceva la sua professione con molta coscienza e, coeren te con le sue idee democra t iche , curava gratis i poveri . Ma aveva un cara t t e re au tor i ta r io e chiuso, che resp ingeva il sensibile ragazzo, at trat to molto di p iù da sua madre , Maria Drago, che sapeva guan ta re di soavità la sua severa morale ancorata su u n a ferma fede religiosa di s tampo giansenista. E giansenisti furono anche i precet tor i cui essa affidò il piccolo «Pippo», come lo chiamavano i genitori e le t re sorelle. Il ragazzo stupì i suoi maestr i n o n solo p e r «la s o r p r e n d e n t e tenacissima memor ia , talento s t raordinar io e genio senza limiti d i app rende re» , come scrisse u n o di loro, ma anche p e r la sua p recoce ser ietà . Preferiva la c o m p a g n i a dei g r a n d i a quella dei coetanei, e le sue uniche evasioni e rano la musica e le l u n g h e passeggia te soli tarie nei boschi . N o n e ra un «mammaione» a n c h e p e r c h é sua m a d r e n o n gl ie l 'avrebbe consent i to . Ma i suoi r a p p o r t i con lei e r a n o così stret t i e p ro fond i che dovevano inf luenzare tu t t a la sua vita senti-
460
mentale . Cont ra r iamente a ciò che dicono certi suoi sciocchi apologeti, Mazzini n o n fu, in fatto di donne , un asceta. Esse contarono molto nella sua vita. Ma furono tutte o quasi tutte d o n n e m a t u r e , di cui egli sapeva sollecitare i sent iment i materni .
Il suo p r imo a m o r e fu forse un 'amica di sua madre , mad r e a sua volta dei suoi tre amici Jacopo , Giovanni e Agostino Ruffini. Si t ra t tò na tu ra lmen te di un sent imento nascosto. Mazzini fece di lei, d o n n a anch'essa di g ran carat tere, la sua confidente e guida spirituale, e dei tre figli i suoi pr imi discepoli. Ma da loro n o n ricavò che amarezze . J acopo , di g r a n l unga il migl iore e p iù do ta to , fu p iù t a rd i a r res t a to come suo seguace, si suicidò in carcere, e pe r Mazzini fu un r imorso di cui n o n si sarebbe mai più liberato. Gli altri due lo bersagliarono di meschini attacchi e maldicenze.
E molto probabile che le pr ime professioni di fede politica egli le abbia sentite in bocca a suo p a d r e nel '15, q u a n d o i trattati di Vienna sancirono l 'annessione di Genova al Piemonte . Attaccatissima alle sue vecchie istituzioni e tradizioni repubblicane, la città ne fu indignata e cer tamente lo fu anche il do t to r Mazzini. Più ta rd i P ippo trovò nel suo studio, nascosti fra i manua l i di medic ina , a lcuni vecchi g iornal i francesi del t e m p o della r ivoluzione, e li lesse con avidità, p u r senza capirci molto. Altre suggestioni dovet tero venirgli dalla scuola. Per dis t rarre i giovani dai problemi attuali, gli si dava da s tudiare la storia della Grecia e di Roma, ch 'e ra tut ta un inno a Catone, ai Bruti , alla libertà e al t irannicidio, nella convinzione che l 'antichità di questi ideali bastasse a render l i innocui e mater ia di p u r a declamazione.
A quei tempi all 'Università si arrivava molto presto. Mazzini vi s'iscrisse a quattordici anni , in medicina come voleva suo p a d r e . I suoi apologet i sment iscono che se ne r i trasse p e r c h é , a l p r i m o e s p e r i m e n t o d i necroscopia , svenne . Lo raccontò sua m a d r e a Jessie White Mario, e n o n riusciamo a vedere che male ci sarebbe. Che Mazzini abbia sempre avuto o r r o r e del sangue, è provato: l'uccisione di un to rdo ba-
461
sto a svogliarlo pe r s empre dalla caccia. Ma è p rop r io questo che r e n d e ancora più ammirevole il suo immenso coraggio morale . A sgomentar lo era il sangue altrui, n o n il suo, e si affrettò a d imostrar lo: a quindici anni aveva già fatto conoscenza delle bastonate , delle mane t te e della pr ig ione. Il pretes to era stato del tut to occasionale ed epidermico. Mazzini, che ora si era iscritto a legge, recalcitrava ai bigotti regolamenti universitari che imponevano agli s tudent i di and a r e a messa e di confessarsi, e gli proibivano i baffi come indizio di t endenze rivoluzionarie. Costret to a f requentare anche lui la chiesa, un giorno il p re te invitò lui e i suoi compagn i a lasciare i posti di p r i m a fila ai cadett i del Collegio Reale. Mazzini, che al posto n o n ci teneva, si ribellò pe rò al sopruso, e con tale furore che si fece arrestare .
Per q u a n t o m o d e s t o , l ' episodio bas tò a confer irgl i un cer to pres t ig io sui condiscepol i , ed egli ne approf i t tò pe r raccoglierne in to rno a sé alcuni, che come lui n o n sapevano ancora cosa volevano, ma già sapevano di volere qualcosa. Non diventò un alfiere della contestazione: f in d 'al lora aveva in uggia gli a t teggiament i demagogic i e le chiassate go l i a rd iche . Gli amici se li sceglieva con cu ra , e con essi conduceva vita appar ta ta , fatta d ' interminabi l i passeggiate e discussioni. Discutevano di tut to , ma specialmente di lett e ra tu ra , che fu la vera vocazione giovanile di Mazzini. Le sue l e t tu re e r a n o p iu t tos to d i so rd ina t e . Conosceva b e n e Tacito e Dante . Si e ra i n n a m o r a t o di Goe the - diceva che avrebbe dato la vita pe r passare un g iorno con lui - , ma poi gli aveva pre fe r i to Shakespea re , e infine Alfieri e Byron . Ma a folgorarlo fu il Foscolo. Rimase t a lmente colpito dal
Jacopo Ortis che da allora n o n si vesti p iù che di ne ro e sua m a d r e t eme t t e che volesse imi t a rne i l gesto suic idandosi . Quel l ' e roe n o t t u r n o fu la sua g r a n d e passione giovanile, e qualcosa gliene r imase pe r s empre addosso. Mazzini fu un Jacopo della politica, inconsciamente - o subconsciamente -vocato alla pa r t e dello sconfitto pe r ché era quella che meglio gli si attagliava. Egli avrebbe po tu to far sua l 'orgoglio-
462
sa divisa spagnola: «La disfatta è il blasone del l 'anima bennata» .
I l t r a u m a r ivela tore del suo des t ino gli capi tò nel ' 2 1 , q u a n d o a Genova a r r iva rono in cerca di scampo i Federat i p iemontesi reduci dal loro tentativo di rivolta. Per metter l i in g rado d' imbarcarsi , e ra stata indet ta pe r strada u n a questua fra i passanti, e anche Mazzini det te il suo obolo, mosso forse soltanto dalla pietà. Ma poi cominciò a r imuginare sulla loro sorte: «Quel giorno fu il p r imo in cui mi si affacciasse confusamente, n o n d i rò un pensiero di Patria e di Libertà, ma un pensiero che si poteva, e quindi si doveva, lottare per la l ibertà della Patria». La novità n o n e ra concet tuale , ma morale , e stava tutta in quel quindi si doveva. Esso r iassume il c redo di un u o m o per il quale la vita si annunziava, religiosamente , come un dovere da compiere . Mazzini aveva credu to , fin allora, di essere un ateo, e l 'unico grosso dispiacere che aveva dato alla m a d r e era stato il rifiuto di confessarsi. In realtà si era soltanto ribellato alla Chiesa, con cui n o n si riconcilierà mai. Ma già si rendeva conto che nessun ideale politico è realizzabile e degno di essere realizzato se non viene concepito e praticato come un sacerdozio. Fu questo a far di lui un e te rno straniero in un Paese come il nostro, dove la politica viene concepita e prat icata come u n a «combinazione» di contingenti oppor tuni tà .
La le t tera tura seguitò a occuparlo anche pe rché era l'unico campo in cui si potessero espr imere delle opinioni. Finiti senza entusiasmo gli studi e presa la laurea, si e ra messo a eserci tare la professione nello s tudio di un avvocato, ma l'attività che più lo impegnava era quella di giornalista. C'era a Genova un giornale, YIndicatore genovese, che la censura tol lerava p e r c h é e r a quasi esc lus ivamente un bol le t t ino commerciale . Mazzini lo persuase a pubblicare anche delle recens ion i di libri, e ciò gli de t t e il des t ro di segna la re al pubblico quelli che meglio servivano alla formazione di una coscienza civile. Era già anche quella u n a scelta: pe r Mazzini n o n c'era né ci poteva essere altra le t teratura che quella,
463
come oggi si chiama, «impegnata» e, anche se n o n lo disse, lo fece a b b o n d a n t e m e n t e cap i re t r i b u t a n d o p e r e sempio g r a n d i elogi, che p robab i lmen te n o n sentiva, alla Battaglia di Benevento del Guerrazzi : un romanzacelo, ma ricco di accenti patriottici.
La censura lasciò fare pe r un po ' , poi soppresse addiri ttu ra il giornale. Ma gli articoli di Mazzini, che si firmava con la sola iniziale del c o g n o m e , avevano a t t i ra to l ' a t tenzione de l l ' onn iveggen te Vieusseux, che scrisse al Lambrusch in i d ' indagare chi fosse quell 'M. che, sotto u n a p e n n a rugginosa e un po ' enfatica, faceva tut tavia t r ape la re delle idee. E Lambruschin i rispose: «Il mio cor r i spondente c rede di pote rmi assicurare che M. sia un cer to avvocato Mazzini che pa re abbia u n a cat tedra all 'Università, giacché lo chiama uomo di grandissimo talento e dei più liberali dell'università. Non so p e r ò conciliare questa quali tà con quella che p u r gli dà di avvocato di recente laureato. C o m u n q u e sia, egli è figlio del prof. Mazzini, medico in Genova. Aggiunge che questo suo f igl io , benché giovane, ha grandissima r iputazione. I l n o m e del Mazzini giovane è Giuseppe che a Genova, come sapete, ch iamano Pippo».
Su invito di Vieusseux, Mazzini m a n d ò all'Antologia alcuni articoli sul d r a m m a storico e altri problemi letterari , che a t t i ra rono su di lui l 'at tenzione dei circoli n o n soltanto fiorent ini , ma nazionali . Altri ne pubblicò sull'Indicatore livornese, che il Guerrazzi aveva fondato nella sua città. Ma questo n o n gli bastava, un po ' p e r tut te le r inunzie e ret icenze che la censura imponeva, un po ' pe rché sentiva l'inutilità di que l par la rs i fra «iniziati». Odiava le accademie e bollava con parole di fuoco il narcisismo e l'evasività di u n a letterat u r a intesa u n i c a m e n t e «a fo rmare lo scrit torello vanaglorioso, il sofista, il p e d a n t e , e n o n l'uomo, n o n l'utile cittadino». Perciò si p roponeva di dedicarsi a u n a storia popo la re d'Italia che, r ivolgendosi a un pubblico più vasto, ne risvegliasse la coscienza e gl'interessi. Totalmente preso da questi impegni e proget t i di apostolato, conduceva un'esistenza di
464
cenobita. Unici lussi, il caffè e il sigaro, d u e vizi di cui r imase poi s e m p r e schiavo. Un iche dis t razioni , le passeggiate preferibi lmente no t tu rne coi pochi amici che già in lui riconoscevano un capo, e la ch i ta r ra con cui si accompagnava canticchiando perché aveva molto orecchio e anche u n a discreta voce di ba r i tono leggero . Sua m a d r e lo covava. Suo p a d r e aspet tava che gli passasse, com 'e ra passata a lui. La polizia lo sorvegliava.
Nel '27 u n o dei suoi amici, Torre , gli confidò d'essere agg rega to alla C a r b o n e r i a e gli p r o p o s e d ' iniziarvelo. «Io - scrisse più tardi Mazzini - n o n ammirava gran fatto il simbolismo complesso, i misteri gerarchici e la fede politica, o piuttosto la mancanza di fede politica, della Carboner ia . Ma e ro allora impoten te a tentare cosa alcuna di mio, e mi s'affacciava u n a congrega di uomini i quali, inferiori probabilmen te al concetto, facevano ad ogni m o d o u n a cosa sola del pens i e ro e del l ' az ione, e sfidavano scomuniche e p e n e di mor te ; persistevano, distrutta u n a tela, a rifarne un 'al t ra: e bastava pe rché io mi sentissi debito di da r loro il mio n o m e e l 'opera mia.»
Gli f issarono, come al solito, un a p p u n t a m e n t o di no t te in u n a s t raduzza fuori m a n o , dove v e n n e a pre levar lo un cer to R a i m o n d o Doria , «di f i s ionomia n o n piacente» che , d o p o averlo in te r roga to , lo sot topose ai soliti riti. Inginocchiato, i l neòfita p ronunc iò con la m a n o sul pugnale , ma anche con un certo fastidio, la formula del g iuramento , ascoltò i soliti t ruculent i racconti delle terribili vendet te abbattutesi sui t radi tor i , e se ne t o rnò a casa ca rbonaro , ma completam e n t e a l l 'oscuro d i ciò che ques to significasse come p r o g r a m m a politico, e cioè se si doveva lottare pe r un'I tal ia monarchica o repubbl icana, uni tar ia o federalistica. Ne chiese a Tor re , il quale gli rispose che si contentasse di «ubbidire in silenzio» e ringraziasse Dio di aver evitato le « t remende p ro ve» che di solito il r i to r ichiedeva. C h e avrebbe fatto - gli chiese - se pe r esempio gli avessero int imato di spararsi alla tempia u n a pistola caricata davanti ai suoi occhi? Mazzini ri-
465
spose asciutto che si sarebbe rifiutato pe rché delle d u e l'uria: o la pistola era caricata solo a polvere, e in tal caso si sarebbe t ra t ta to di u n ' i n d e g n a farsa; o e ra caricata a palla, e in tal caso «era assurdo che un uomo , chiamato a combattere pe r la Patria, cominciasse dallo sparpagliarsi quel po ' di cervello che Dio gli aveva dato». Era la reazione di un u o m o t r o p p o libero e t r o p p o serio p e r accettare la s t ru t tu ra mafiosa e gli aspetti ciarlataneschi di quella organizzazione che si rifiutava di r ivelare i suoi scopi e p re t endeva t ra t ta re gli accoliti come semplici killers.
Per il m o m e n t o tuttavia r imase nei ranghi , e anzi vi fece ca r r i e ra f ino al g r a d o di G r a n Maestro che gli pe rme t t eva di affiliare a sua volta altri adept i . Si p roponeva di formare con loro u n a «base» capace «d ' infondere un po ' di giovane vita in quel corpo invecchiato», cioè in parole povere d' im-p a d r o n i r s e n e e r i formarla a m o d o suo. Ma capiva benissimo che l'Italia n o n poteva nascere dai complott i e dagli attentati di u n a società segreta. Ciò che occorreva era illumina re la pubblica opinione, o pe r meglio dire c rea rne una , e pe r questo ci volevano ben altri s t rument i .
Un giorno la Vendita lo incaricò di u n a missione a Livorno pe r farvi altri proseliti. Mazzini l'accettò, soprat tut to pe r la prospett iva d ' incontrare Guerrazzi con cui s'era scambiate mol te let tere, ma che d i pe r sona ancora n o n conosceva. Gue r r azz i n o n c 'era. Poco p r i m a , c o m m e m o r a n d o in un pubblico discorso un ufficiale livornese caduto sotto le bandiere napoleoniche, si e ra lasciato trascinare dalla foga orator ia a dichiarazioni che avevano costre t to perf ino il mi te G r a n d u c a a comminargl i il confino a Montepulc iano. Mazzini ve lo ragg iunse in compagn ia del c o m u n e amico Bini. Ma, d o p o aver un poco par la to con lui, o meglio dopo aver ascoltato la l e t tu ra ch 'egl i inflisse ai visi tatori delle p r i m e pagine del suo nuovo libro, Eassedio di Firenze, le simpatie gli s ' intiepidirono. «Il sangue gli saliva alla testa m e n t r e leggeva ed ei bagnava la fronte pe r r idursi in calma. Sentiva altamen te di sé, e quella persecuzioncella, che avrebbe dovuto
466
farlo sor r idere , gli rigonfiava l 'anima d'ira... Non aveva fede. . . Stimava poco; amava poco». Ritrat to impietoso, ma a bersaglio. Fu così deluso di lui che «partii senza parlargli a viso a p e r t o del motivo pr inc ipa le della mia gita». Mazzini n o n si rassegnava, n o n si rassegnerà mai alla retorica e alla teatralità degl'italiani. E questo fu un altro dei motivi che lo resero sempre s traniero in patria.
Ma a Genova lo a t tendeva una bru t ta sorpresa. Que l tale Doria che lo aveva iniziato e r a un marchese spianta to che viveva di espedient i , ma che ora , t rovandosi a corto anche di quest i , si e r a v e n d u t o alla polizia d e n u n z i a n d o l e tut t i i capi ca rbona r i . La polizia volle p r o c u r a r s e n e le p r o v e e m a n d ò a Mazzini d u e suoi sgher r i che si finsero aspi rant i all'affiliazione. Mazzini ci cascò, e n o n doveva essere l'ultima volta: pe r tutta la vita era destinato a r ipo r re la sua fiducia e a lasciarsi so rp rende re dalle spie che gli met tevano alle calcagna. Q u e s t o g r a n d e cosp i ra to re r imase s e m p r e u n g r a n d e ingenuo : come tutti gli uomin i onesti , c redeva che anche gli altri lo fossero.
Iniziò i d u e provocatori , e poche sere dopo , r i en t r ando a casa, ci t rovò i g e n d a r m i . Colui ch ' e ra svenuto di fronte a una necroscopia d iede prova di un sangue freddo esemplare . Sotto gii occhi degli sbirri, riuscì a far sparire gli oggetti e le ca r te p iù c o m p r o m e t t e n t i , affrontò la p r ig ione senza bat ter ciglio; e q u a n d o si trovò di fronte al Commissario inq u i r e n t e , negò tu t to . Rimase a lcuni g iorn i nella p r i g ione della caserma, e le uniche cose di cui soffrì furono il f reddo e la mancanza di sigari . Poi, u n a no t te , lo svegl iarono p e r un trasferimento. Suo pad re , che lo aveva saputo, era fuori del carcere pe r salutarlo insieme ad Agostino, il minore dei tre fratelli Ruffìni. Forse in quel m o m e n t o il povero Dottore capì che quel suo f igl io n o n sarebbe mai rinsavito. Ma n o n po t è par larg l i e dovet te con ten ta r s i d i un c e n n o di a d d i o con la mano .
Nella diligenza in cui lo caricarono, c'era un altro Cugino, e fra i più in vista, Passano: tut ta la Vendita doveva esser
467
caduta nella rete. E il pr igioniero capì anche come, q u a n d o r iconobbe fra i soldati di scorta u n o dei d u e neòfiti ch'egli aveva iniziato. Ce n 'era abbastanza pe r sgomentare anche il cospiratore più esper to e rot to a queste disavventure. Mazzini si m a n t e n n e impassibile e, r inchiuso in u n a cella della fortezza di Savona, ci trovò i suoi lati belli: la vista, oltre l'inferriata, del cielo, del m a r e e delle Alpi, «le più sublimi cose che la na tu ra ci mostri», e la compagnia di un lucher ino, che ogni g io rno veniva a becche t t a re le briciole del la sua pagnotta.
Era il d icembre del 1830. Per il pr igioniero fu u n a grossa v e n t u r a che i l suo caso fosse scoppia to p r i m a dei mot i di Modena, di Parma e degli Stati pontifici e del l 'ondata di re press ioni che quest i s tavano p e r sca tenare . Si adeguava , senza farne un d r a m m a , a quella pausa di galera. Negli ultimi t emp i , tu t to p r e s o dalla sua attività di cosp i ra to re e di giornalista, non aveva più avuto il t empo di riflettere e med i ta re . Ed e ra i l m o m e n t o di farlo. No, la Carboner i a n o n era neanche un corpo invecchiato. Era un cadavere. Da seppellire con tutti gli onori , ma da seppellire. Per u n a rivoluzione nazionale, pe r u n a Repubblica democratica, ci voleva ben altro che i complott i e gli at tentati di g rupp i terroristici guidat i dall 'alto, come robots, da uomini di volto ignoto d'ignote intenzioni, d ' ignota etichetta ideologica. Ci voleva un moto corale dal basso, u n a volontà collettiva e cosciente.
Nasceva nella sua men te l'idea della Giovane Italia.
Carlo Felice volle che il caso fosse vagliato col massimo scrupolo e con tutte le garanzie di legge. E perciò, invece che al giudice o rd inar io , preferì affidarlo a d u e dei p iù rispettat i senatori del Regno, Borio e C r o m o , che infatti si most rarono all'altezza della loro fama. Gli arrestati e r ano sette. E sebb e n e tu t t i avessero nega to , l e p r o v e c o n t r o d i lo ro e r a n o schiaccianti. Ma i d u e magistrati , s apendo da che fonte ven ivano, n o n ne t e n n e r o conto , e assolsero. I l min is t ro de gl ' interni t rovò tuttavia eccessiva questa indulgenza plena-
468
ria, e decise che Passano, essendo còrso, fosse restituito alla sua isola, e che Mazzini si scegliesse un 'a l t ra residenza, nel Regno o fuori, a esclusione di Genova e della Riviera.
Mazzini n o n esitò. Per p o r r e m a n o al suo p r o g r a m m a di azione politica, aveva bisogno di l ibertà, e in nessuna città del Regno ne avrebbe avuta. Prese coraggiosamente la via dell'esilio, e il 10 febbraio (del '31) attraversò il Moncenisio. Per s t r ada lo r a g g i u n s e r o le notizie della sollevazione nei Ducati e negli Stati pontifici e incontrò altri esuli che gli parlarono dei preparat ivi in atto a Lione pe r u n a spedizione in Savoia. Vi accorse subi to e vi r i t rovò «molti di co loro che aveva veduto dieci anni addie t ro e r ra re , con l'ira della delusione sul volto, per le vie di Genova». S' imbrancò con loro, partecipò at t ivamente all 'organizzazione dell ' impresa che si svolgeva in un entusiasmo par i soltanto alla confusione. Poi, a l l ' improvviso, v e n n e la doccia f redda: l ' in t imazione agli esuli di sciogliere il comitato e di r i en t ra re ai loro domicili. Il loro furore era al colmo. «Imprecavano - dice Mazzini -al t r a d i m e n t o e ai t r ad i to r i : vende t t a sterile di quan t i , in un ' impresa di Patria, f idano in altro che nelle p r o p r i e forze». Era la conferma di u n a convinzione già ma tu ra ta nella sua mente : che l'Italia potevano e dovevano farla gl'italiani, e da sé.
Tut tavia n o n volle p e r i l m o m e n t o dissol idar izzare dai suoi c o m p a g n i e ne seguì un g r u p p o che s i p r o p o n e v a di sbarcare dalla Corsica in Italia pe r da re m a n forte agl'insorti delle Legazioni. Attraverso i loro emissari chiesero un po ' di soldi al governo di Bologna pe r noleggiare u n a nave. Ma il p res idente Vicini, s empre pe r n o n «provocare» l'Austria, rifiutò. E anche questa fu pe r Mazzini u n a lezione. No, n o n era con uomini di quella pasta che si poteva fare l'Italia. Bisognava ricominciare tut to daccapo: dalle coscienze.
I l ve ro Risorg imento inizia di qui : da l l ' appe l lo alle coscienze. Tut to ciò che lo aveva p recedu to n o n e ra stato, come aveva det to Cuoco, che u n a cattiva imitazione d' ideologie altrui.
469
C R O N O L O G I A
1790 - Pietro Leopoldo di Toscana diventa Imperatore d'Austria.
1792 - I francesi invadono la Savoia.
1794 - 22 settembre. A Dego i piemontesi sono battuti dai francesi.
1796 - Marzo. Prima campagna di Napoleone in Italia.
1796 - 28 aprile. Armistizio di Cherasco.
1796 - Maggio. Vittorio Amedeo III cede alla Francia la Savoia e il Nizzardo.
1796 - 16 maggio. Napoleone entra in Milano.
1796 - 16 ottobre. Nasce la Repubblica Cispadana.
1797 - 7 gennaio. Il congresso Cispadano, a Reggio, adotta il tricolore bianco, rosso, verde.
1797 - 19 febbraio. A Tolentino Napoleone stipula la pace con il papa.
1797 - 15 maggio. Abdicazione del doge Manin a Venezia.
1797 - 17 ottobre. Pace di Campoformio.
1798 - 15 febbraio. Proclamazione della Repubblica Romana.
1798 - 20 febbraio. Pio VI viene tradotto a Siena.
1798 - 19 maggio. Spedizione di Bonaparte per l'Egitto.
1798 - 1-2 agosto. Nelson distrugge la flotta francese ad Abukir.
1799 - 24 gennaio. I francesi occupano Napoli.
1799 - 27 marzo. Il granduca di Toscana abbandona Firenze ai francesi.
475
1799 - 15 giugno. Il cardinale Ruffo occupa Napoli.
1799 - 29 agosto. Morte-di Pio VI.
1800 - Maggio. Seconda campagna d'Italia del Bonaparte.
1800 - 5 giugno. Napoleone ristabilisce la Repubblica Cisalpina.
1800 - 14 giugno. Battaglia di Marengo.
1800 - 16 giugno. Armistizio tra francesi e austriaci.
1801 - 19 febbraio. Trattato di Lunéville.
1801 - 15 luglio. Concordato tra Bonaparte e il papa.
1802 - 27 marzo. Trattato di Amiens fra Inghilterra e Francia.
1802 - 14 giugno. Carlo Emanuele IV abdica in favore di Vittorio Emanuele I.
1804 - 18 maggio. Bonaparte assume il titolo di imperatore con il nome di Napoleone I.
1805 - 26 maggio. Napoleone I assume la corona del Regno d'Italia. Eugenio di Beauharnais è nominato viceré.
1805 - 4 giugno. La Repubblica di Genova è annessa all'Impero francese.
1805 - 15-18 ottobre. Sconfìtta degli austriaci a Ulma.
1805 - 21 ottobre. La flotta franco-spagnola è distrutta a Trafal-gar.
1805 - 14 novembre. Napoleone entra in Vienna.
1805 - 2 dicembre. Austerlitz: Napoleone sconfigge gli
austro-russi.
1806 - 15 febbraio. Giuseppe Bonaparte è Re di Napoli.
1806 - 14 ottobre. Sconfitta dei prussiani a Jena.
1807 - Luglio. Trattati di Tilsit.
1808 - 2 febbraio. Le truppe francesi occupano Roma.
1805 - 5 maggio. Gioacchino Murat è il nuovo Re di Napoli.
476
1808 - 24 maggio. La Toscana e l'ex Granducato di Parma e Piacenza sono annessi alla Francia.
1 8 0 9 - 17 maggio. Lo Stato della Chiesa è annesso all 'Impero francese.
1809 - Luglio. Il papa è arrestato e relegato a Savona.
1812 - 12 maggio. Il papa è trasferito da Savona a Parigi.
1812 - 24 giugno. Inizio della campagna di Russia.
1812 - Ottobre. L'Armata francese sconfitta passa la Beresina.
1813 - 12 agosto. L'Austria dichiara guerra alla Francia.
1813 - 16-19 ottobre. Napoleone è sconfitto a Lipsia.
1814 - Maggio. Trattato di Parigi: l'Austria rioccupa la Lombar
dia e il Veneto.
1814 - Settembre. Congresso di Vienna.
1815 - 26 febbraio. Napoleone fugge dall'isola d'Elba.
1815 - 2 maggio. Murat è battuto dagli austriaci a Tolentino.
1815 - 18 giugno. Waterloo. 1815 - 13 ottobre. Fucilazione di Gioacchino Murat a Pizzo di Ca
labria.
1818 - Esce a Milano // Conciliatore.
1820 - 2 luglio. Nel Napoletano scoppiano i primi moti carbonari.
1820 - 15 luglio. Rivoluzione a Palermo.
1820-21 - La polizia austriaca arresta Pellico, Maroncelli ed altri.
1821 - Gennaio. Congresso di Lubiana: è deciso l'intervento austriaco nel Napoletano.
1821 - 12 marzo. Moti carbonari in Piemonte. Vittorio Emanuele I abdica a favore di Carlo Felice.
1821 - 13 marzo. Carlo Alberto concede la Costituzione.
1821 - Dicembre. Federico Confalonieri ed altri patrioti sono arrestati dalla polizia austriaca.
477
1822 - Congresso di Verona: si decide lo sgombero delle truppe
austriache dal Piemonte.
1823 - A Pio VII succede Leone XII.
1825 - A Napoli Francesco I succede al padre Ferdinando.
1827 - Giuseppe Mazzini aderisce alla Carboneria. 1831 - Febbraio. Moti insurrezionali scoppiano a Modena, Parma
e Bologna.
1831 - 25 marzo. L'esercito rivoluzionario comandato dal generale Zucchi è sconfitto dagli austriaci presso Rimini.
1831 - 26 maggio. Ciro Menotti e Vincenzo Borelli vengono giustiziati a Modena.
1831 - Ottobre. Nasce a Marsiglia la «Giovane Italia» di Mazzini.