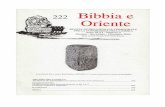Corrosioni Naturali
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Corrosioni Naturali
CORROSIONI NATURALI
È l’unione tra Oriente e Occidente
È il rapporto che l’uomo ha instaurato con la terra
È la bellezza delle cose imperfette
È l’amore per i luoghi
È l’intuizione a discapito della logica
È il fascino della deperibilità
DUE VIS IONI ESTET ICHE A
CONFRONTO: OCCIDENTE E ORIENTE
“Il guardare ad altre culture è un segno della cattiva coscienza occidentale, che si rende conto di aver usato male la ragione contribuendo a
determinare tragedie storiche e il crollo di molti valori”
CHE COS’E’ L’ESTETICA?
OCCIDENTE
L’estetica puo’ essere definita la scienza della conoscenza sensibile
Si occupa del bello
Per Kant è “Finalità senza scopo”
ORIENTE
Il termine estetica non esisteva, fu coniato per tradurre Asthetik
L’estetica è un atteggiamento nei confronti della vita.Non necessita di parole
La bellezza sta nella forma che stimola il piacere intellettuale
Bellezza è gioventù La bellezza è il sentimento di “ma” il vuoto nelle cose
Bellezza artistica = rappresentazione Bellezza è “ le qualità esistenti sotto la superficie esteriore della realtà”
"aveva distinto lo spazio geometrico dal-lo spazio antropologico, che é più precisa-mente quello esistenziale dell'esperienza col mondo"
L ’UOMO POSTMODERNO
IN RELAZIONE ALLA TERRA
L’UOMO E LA TERRA QUAL’È IL LORO RAPPORTO?
L'uomo ha abbandonato la terra
Perdendo il senso di appartenenza alla terra si è perso il rapporto con essa
Abbiamo perso il nostro centro.
L' Agorà, la piazza Greca era il luogo ove gli uomini creavano la propria identità e l'identità pubblica.
Nella modernità si perde il fulcro.
Proliferano i Non-luoghi. (Centri commerciali, campi profughi, sistemi di comunicazione accellerata)
Il luogo è Genius Loci, (identità del Luogo) è memorie, ricordi, personalità e spirito.
Con la perdità del luogo si perde l'identità
Il luogo si contrappone allo spazio. Lo spazio è libertà il luogo è attaccamento.
Lo spazio è rappresentazione dello spazio e spazio di rappresentazione:
Rappresentazione dello spazio = morfologia della città basata sui rapporti di produzione
Spazio di rappresentazione = lo spazio del vissuto
La modernità crea spazi gerarchizzati.
I luoghi spariscono e si ricostruiscono secondo l'ottica della provvisorietà
"Il nostro corpo non é nello spazio come lo sono le altre cose, ma lo abita"
È POSS IB I LE UNA
R IAPPACIF ICAZIONE CON LA TERRA?
KINTSUGI
E' possibile riparare un vaso rotto? Secondo la filosofia Giapponese acquisice un valore aggiunto
E' possibile riallacciare un rapporto con la Terra? Con un'etica della responsabilità possiamo.
Il ritorno al luogo e alla terra è fondamentale.
I confini del mondo si sono dilatati. Costruendo l'altro dentro di noi scopriamo cosa a noi manca.
Tra l'uomo e il luogo si instaura un rapporto di topophilia. Sentimento di amore ed attaccamento nei confronti del luogo
Il corpo abita lo spazio
Il camminare è conoscenza dello spazio
Fondamentale è la consapevolezza dell'altro.
Necessitiamo di un'etica della responsabilità. Guardare al futuro, vivere il nostro presente pensando alle generazioni prossime.
I L WAB I -SAB I COME F ILOSOF IA DI V ITA
"Tutto viene rifondato sull'esperienza del corpo e dei sensi."
CHE COS'È IL WABI-SABI?
Wabi sabi è uno stile di vita, un'inclinazione dell'animo, un concetto astratto.
Wabi sabi è la bellezza delle cose imperfette, umili e modeste.
Wabi sabi è la bellezza delle cose appassite, ruvide, terrose, decadenti.
Wabi sabi è una forma di bellezza che supera la dicotomia tra bellezza e bruttezza.
Le cose virano verso il nulla, da esso si generano e in esso ritornano.
Tutte le cose sono temporanee
Tutte le cose sono imperfette
Tutte le cose sono incompiute
Wabi sabi è l'hic et nunc. Ogni forma di vita condivide lo stesso destino.
Ubi sunt qui ante nos fuerent? Transitorietà della vita e importanza della morte.
Il segreto è lasciare nelle scanalature gli annerimenti del tempo. Pulire le superfici sen-za toccare le rughe degli oggetti
Se guardo lontano non vedo nè boccioli di ciliegionè foglie colorate
solo una modesta capanna sulla costaimmersa nel crepuscolo d'autunno
TOCCARE PER
SENT IRE
I luoghi dell'abbandono rappresentano lo spirito wabi sabi
Il fascino delle rovine, delle cose morte, dello scorrere del tempo e del logorio.
Luoghi ove il tempo segue una scansione ritmica lenta, opposta alla postmodernità
Toccare, vuol dire sentire la patina del tempo
La patina del tempo può essere trasmutata su tessuto
L'eterno divenire, il caso, l'imperfezione e l'usura diventano elementi fondamentali
Il textile è Oriente
I tagli netti rappresentano l'Occidente
Cerchiamo un dialogo fra mondi diamentralmente opposti
TRASMUTIAMO EMOZIONI IN AZIONI
Il vedere é un’impresa “carica di teoria.” L’osservazione di x é condizionata dall’interiore conoscenza di x
t e x t i -l eIl textile è il tessuto progettato per la collezione e che caraterizza la colle-zione stessa. Ogni capo avrà il textile come impronta grafica. È l’elemento che accomuna ogni outfit.
Nel progetto in questione, la speri-mentazione tessile è la rappresenta-zione del fenomeno corrosivo. Così la natura leggera e armonica corrode ogni edificio, così gli acidi e i metalli lacerano, modificano e tra-sformano il tessuto.
I campioni sono stati realizzati met-tendo in ammollo il tessuto con acido cloridrico, filo di stagno e ferro.
Scala 1 : 1 Scala 1 : 2
t e x t i l eU s u r at o
PRIMA DOPO
100 lavaggi
30 lavaggi
La tavola è la rappresentazione della “morte del tessu-to”.
Il tessuto ritorto su se stesso e avvolto con fili di ferro e rame, ha subito un bagno in acido cloridrico diluito in ac-qua. Dopo circa 35min in ammollo, è stato tolto e lasciato ad asciugare all’aria aperta per circa una settimana. In questo modo l’ossidazione dei metalli (ferro e rame), che è stata accellerata dall’utilizzo dell’acido, rilascia su tes-suto i residui giallognoli per il ferro e rosati, verdastri per il rame. Sette giorni è il periodo minimo per fars si che i “resti” del processo corrosivo si imprimano nella stoffa; più tempo il tessuto viene lasciato a “macerare”, diversi sono gli effetti che si possono ottenere.
Dopo aver effettuato 100 lavaggi ciò che rimane è soltan-to il filo in poliestere. Dopo 30 lavaggi riusciamo ancora a definire la presenza del textile.
M O O D -
B O A R D
Moodboard è sinonimo di ispirazione. Collage di immagini che evocano scenari, immaginari, atmosfere e gamme cromatiche dell’intera collezione. Centrale, in questo mood, è la re-altà industriale abbandonata al suo destino. Il lento scorrere del tempo, il decadimento, la corrosione dei materiali, una natura che silente si appropria dello spazio, atmosfe-re che evocano una dolce tristezza legata all’idea del “panta rei”. Tutto scorre, e noi da attenti osservatori guardiamo la ciclicità del tempo in tutte le sue sfumature. Nell’incuria, nel deterioramento dei luoghi e delle atmo-sfere fiorisce una decadente bellezza.
L I F E
S T Y L E
Il Lifestyle è lo stile di vita a cui faccia-mo riferimento. Tramite l’uso di oggetti, ambienti e look definiamo la donna che indosserà la nostra collezione. Abbia-mo stabilito che il target di riferimento oscilla dai 28 ai 40 anni, raccontiamo di una persona che abita la città, abbiamo uno skyline metropolitano che incornicia e definisce il nostro lifestyle, una don-na di cultura e sapere, con la passione per l’arte e il design. Ci riferiamo ad una persona calma, riflessiva, zen, spirituale e meditativa, legata alla natura e al suo rapporto con essa.
D E S I -
G N E R S ' I N S P I R A -T I O N
Designers’ inspiration è la ricerca e l’analisi di colle-zioni che trattano lo stesso tema di riferimento, e dal quale vengono presi gli spunti per la creazione della collezione. Le collezioni di riferimento hanno dei tagli geometrici e lineari, volumi definiti e morbidezze co-struite.
C A R T E L -L A
M AT E R I A -L I
La cartella materiali definisce l’orientamento materico dell’intera collezione. Notiamo che la collezione è compo-sta da lane, cotone in mischia e acrilico.
C A R T E L -
L A
C O LO R I
La cartella colori è composta dai toni e dalle tin-te scelte. Nel caso in questione abbiamo preso i colori di riferimento direttamente dal moodboard, come possiamo notare dal parallelismo utilizzato. La scelta del colore è di fondamentale importan-za, evoca il nostro scenario.
Il Concept definisce i concetti principali che verranno sviluppati nella progettazione. Utilizziamo delle parole chiave per defini-re i margini entro i quali lavoriamo, nel nostro caso abbiamo definito due tipologie di riferimento (giacche e pantaloni) e ciò che caratterizzerà la nostra collezione sarà la presenza di ge-ometrie, dettagli sportivi e la presenza di un profilo industriale, che marca volutamente i concetti espressi nel mood.
c o n c e p t
Pantaloni
Volumi ampiForme ovali
Giacche
Bermuda
Profilo Industriale
Colli alti
Geometrie
Asimmetrie
G I A C C H E
P A N T A L O N I
G E O M E T R I E
A S I M M E T R I E
D E T T A G L I S P O R T I V I
P R O F I L O I N D U S T R I A L E
T AV O L A
M E R C E O -LO G I C A
La tavola merceologica è una bibliografia realizzata con le immagini. Essa esprime la merce, definisce i dettagli e gli aspetti tecnici che verranno sviluppati nelle succes-sive fasi. Le immagini raccontano la nostra storia, nel primo caso, (img 01, da sx verso dx) abbiamo due tessuti accoppiati insieme che si diversificano per tipologie e colore. È evidente la necessità di uno stacco netto. Nel terzo caso (img 03, da sx verso dx) siamo interessati al gioco dei pantaloni, alla sovrapposizione e al taglio net-to, ma nel quarto caso evidenziamo quale sarà il modo in cui andremmo a sovrapporre i due tessuti insieme. Non avremmo quindi la libertà di movimento del panta-lone in figura 03 ma manteniamo le stesse geometrie.
O U T F I T
L’outfit è la tavola che raccoglie tutte le specifi-che necessarie per la realizzazione del prodot-to. Abbiamo la rappresentazione dell’outfit che nel nostro caso è un racconto emozionale, i ma-teriali scelti per l’outfit in questione, e il disegno tecnico (plat) di tutti i capi componenti l’outfit. Il fashion sketch è l’esagerazione dell’outfit; for-mato da un’esplosione di fiori, rappresentazio-ne del pattern, delle geometrie portate al limite nella costruzione della giacca, e realizzate con una texture dura per dare un idea di rigidità e formalità.
P L AT
Il plat è un disegno tecnico, si potrebbe definire la rappre-sentazione in piatto del capo non indossato. Steso su una superficie orizzontale, è come se venisse contornato al fine di rappresentare tagli, costruzio-ni e dettagli.
p h o t o -s h o o -t i n g
Lo shooting è la parte conclusiva del nostro progetto moda. Dopo aver realizzato i capi, li fotografiamo al fine di poter presentare la nostra collezione. L’ambiente scelto per gli scatti non è casuale, abbiamo optato per un sito industriale abbandonato al fine di rimar-care maggiormente il nostro concetto inizia-le.
T AV O L A
M E R C E O -LO G I C A
La tavola merceologica è una bibliografia realizzata con le immagini. Essa esprime la merce, definisce i dettagli e gli aspetti tecnici che verranno sviluppati nelle succes-sive fasi. Le immagini raccontano la nostra storia, nel secondo caso (img 02 da sx verso dx), abbiamo scelto un bomber dal taglio sportivo ma realizzato con un tessuto che lo eleva ad un contesto più elegante, così nella terza immagine (img 03 da sx verso dx) la scelta di tre panta-loni sovrapposti non è casuale, nella nostra collezione abbiamo un maxi bermuda sovrapposto ad un paio di shorts.
O U T F I T
L’outfit è la tavola che raccoglie tutte le specifi-che necessarie per la realizzazione del prodot-to. Abbiamo la rappresentazione dell’outfit che nel nostro caso è un racconto emozionale, i ma-teriali scelti per l’outfit in questione, e il disegno tecnico (plat) di tutti i capi componenti l’outfit. Nella realizzazione del secondo outfit abbiamo puntato ad un racconto emozionale che unisse la realtà industriale a quella naturale. Il fumo passa dai toni del bianco a quelli del grigio in ricordo delle industrie in attività, il pantalone è realizzato con immagini di natura incontaminata e siti industriali, a confermare l’unione delle due realtà.
P L AT
Il plat è un disegno tecnico, si potrebbe definire la rappre-sentazione in piatto del capo non indossato. Steso su una superficie orizzontale, è come se venisse contornato al fine di rappresentare tagli, costruzio-ni e dettagli.
P H O T O
S H O O -T I N G
Lo shooting è la parte conclusiva del nostro progetto moda. Dopo aver realizzato i capi, li fotografiamo al fine di poter presentare la nostra collezione. L’ambiente scelto per gli scatti non è casuale, abbiamo optato per un sito industriale abbandonato al fine di rimar-care maggiormente il nostro concetto inizia-le.
T AV O L A M E R C E O -LO G I C A
La tavola merceologica è una bibliografia realizzata con le immagini. Essa esprime la merce, definisce i dettagli e gli aspetti tecnici che verranno sviluppati nelle successi-ve fasi. Le immagini raccontano la nostra storia, la prima immagine (img 01 da sx verso dx) definisce la presenza di un elemento grafico che si ripete, la seconda immagine (img 02 da sx verso dx) dichiara un taglio asimmetrico, mentre invece l’ultima immagine (img 04 da sx verso dx) stabilisce la presenza di una vita alta.
O U T F I T
L’outfit è la tavola che raccoglie tutte le spe-cifiche necessarie per la realizzazione del pro-dotto. Abbiamo la rappresentazione dell’outfit che nel nostro caso è un racconto emozionale, i materiali scelti per l’outfit in questione, e il dise-gno tecnico (plat) di tutti i capi componenti l’out-fit. L’ultimo sketch è sinonimo di industria. Così il deterioramento, l’abbandono, il degrado sono i protagonisti dell’outfit, così i toni del grigio, il blu ardesia e il carta da zucchero sono i colori dominanti. E nella presenza dei fiori, e quindi del pattern, si evince un ritorno allo “stato di natu-ra”.
P L AT
Il plat è un disegno tecnico, si potrebbe definire la rappre-sentazione in piatto del capo non indossato. Steso su una superficie orizzontale, è come se venisse contornato al fine di rappresentare tagli, costruzio-ni e dettagli.
P H O T O S H O O -T I N G
Lo shooting è la parte conclusiva del pro-getto moda. Dopo aver realizzato i capi, li fotografiamo, al fine di poter presentare la collezione. L’ambiente scelto per gli scatti non è casuale, abbiamo optato per un sito industriale abbandonato al fine di rimarcare maggiormente il concetto iniziale.
R I N -G R A Z I A -M E N T I
Vorrei ringraziare i miei genitori e i miei nonni che mi hanno dato la possibilità di continuare il mio percorso scolastico, zio Gianno che c’ è sempre, come un orologio, a ricordare le sca-denze, Cristina, che nei momenti peggiori ha sempre creduto in me e con me ha dato sen-so a molte cose che non lo avevano, Proty e le fontanelle, che mi ha aiutato nei lavori più noiosi rendendoli divertenti con quel suo sguardo da bambino nei confronti del mondo, le mie coinquiline, Elenia e Luciana, che hanno convissuto con manichini e possibili esplosioni, il mio amico Chi Naski che mi ha fatto saltare qualche sessione ma vivere delle belle emo-zioni, il mio “amore” Angelo e l’amico Porco che hanno sofferto i rigidi inverni per realizzare il mio shooting, la mia amica Francesca che incoraggia le mie estrosità, la professoressa Leoni, che mi ha sopportato e supportato nelle mie insicurezze, le “piselline preferite” che mi fanno fare sempre na risata, Blitz, “il fratellino mio”, le gemelle, la mia sartina, la profes-soressa di antropologia, l’amore per l’arte e tutti quelli che ho dimenticato. Grazie!